Seconda edizione: aprile 2007
Pensiero e azione n. 8
Alfredo M. Bonanno
La dimensione anarchica
Seconda edizione riveduta e corretta
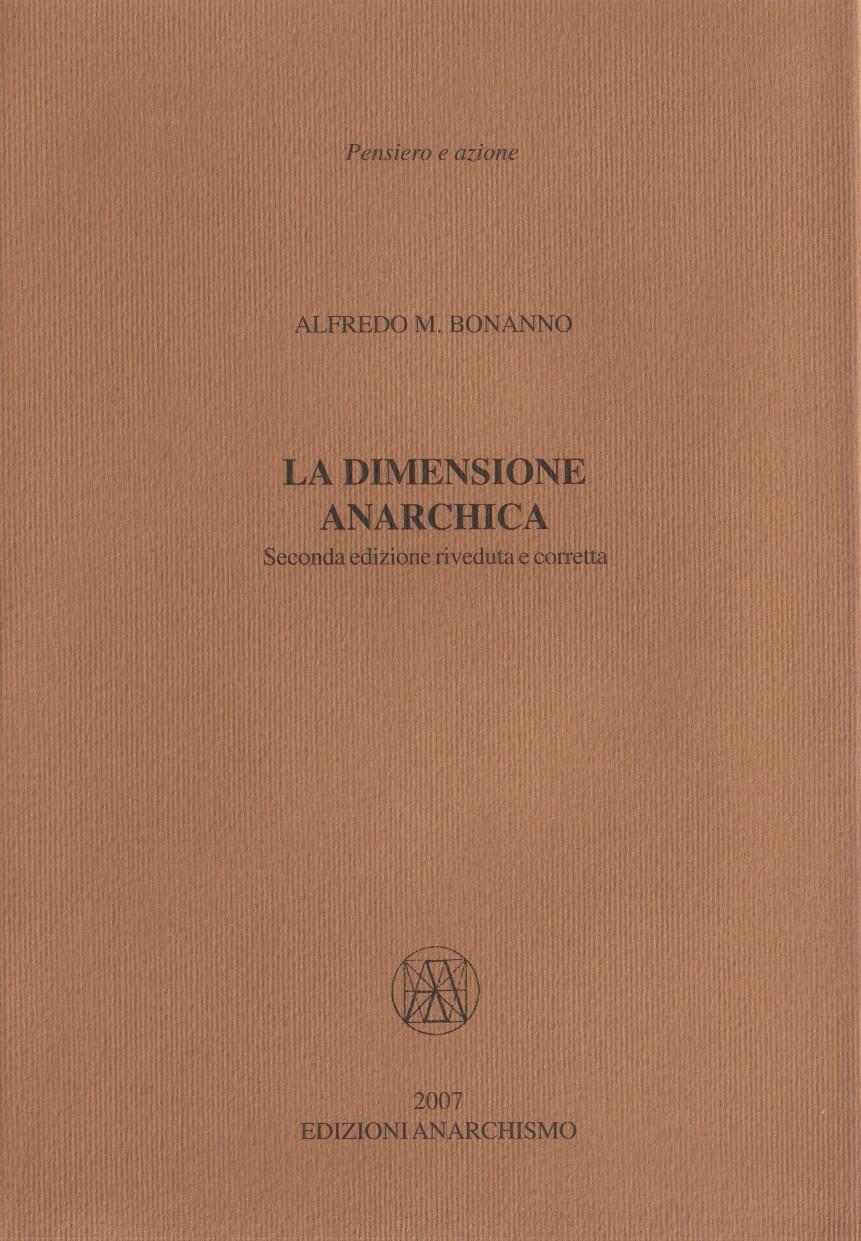
Introduzione alla seconda edizione
Introduzione alla prima edizione
Meccanizzazione operaia e intellettuale
L’eccezionalità come problema sociale
I pericoli dell’analogia nelle scienze sociali
L’impostazione filosofica dell’analogia
L’analogia interna: i dubbi di Pareto
L’analogia interna: biologia e razzismo
Il linguaggio e gli aspetti sociali della comunicazione
L’organizzazione come legge naturale
L’organizzazione come grado di coesione
L’organizzazione come grado di riferibilità dei singoli fattori all’aggregato nel suo complesso
L’organizzazione come razionalità
L’organizzazione come punto di equilibrio
L’organizzazione come finalità ideologica
L’organizzazione come superamento dell’individualità
Insufficienze del tipo di definizioni considerate
La ricerca di un tipo di definizione priva di giustificazioni estrinseche
Le principali categorie dello strutturalismo del sistema
La distruzione necessaria: risposta all’“Avanti!”
La scienza delle conclusioni affrettate
La condanna delle macchinazioni contro il movimento operaio
Considerazioni sull’“intellighentia”
La distruzione necessaria: risposta a Luigi Giusso
Il conservatorismo di Luigi Giusso
Il compito dell’“intellighentia”
La morale del costruibile e la nuova società
Violenza privata e violenza rivoluzionaria
La rivoluzione permanente personale è davvero possibile?
Contributo al concetto di violenza rivoluzionaria
È davvero possibile parlare di nonviolenza?
Nota redatta nel dicembre 1970
A che servono i teatri lirici?
Elementi, correnti, prospettive
Due studi su L’anarchia di Errico Malatesta
Malatesta e l’anarchismo alla luce degli avvenimenti più recenti
Introduzione alla seconda edizione de L’anarchia, Ragusa 1973
Discorso rivoluzionario e discorso apologetico
Dall’apologia alla inutilità delle formule pseudo-analitiche
Note a L’anarchia di Errico Malatesta (seconda edizione, Ragusa 1973)
Rivoluzione, violenza, antiautoritarismo
L’alternativa tra violenza e nonviolenza
L’alternativa tra autorità e libertà
La comunicazione rivoluzionaria
Il concetto di comunicazione rivoluzionaria
Le ristampe dei classici rivoluzionari
Il dialogo con le singole persone
Ricerca sui precursori dell’anarchismo. Possibilità e limiti
Dimensione estetica e dimensione politica
Rinascita del movimento libertario
Comunismo e individualismo anarchici
Il concetto di espropriazione rivoluzionaria
Analisi del concetto di proprietà
Nota a Lo spirito di ribellione di Kropotkin
Nota a La fine dell’anarchismo? di Galleani
La teoria del sabotaggio di Emile Pouget
Analisi antigruppo ed estetica libertaria
Tra contadini. Dialogo sull’anarchia
Un’analisi nuova per la strategia di sempre
Severino Di Giovanni. L’idealista della violenza
Alcune considerazioni sul problema dell’organizzazione anarchica
Il movimento anarchico italiano e le differenti strade di un suo possibile sviluppo
Introduzione alla seconda edizione
L’amorevole insistenza di un compagno mi ha convinto a rimettere le mani su questo mio libro ormai esaurito da alcuni decenni.
Rileggendolo mi sono sovvenuti due ordini di ricordi, i miei studi degli anni Cinquanta e Sessanta, lontani ma non estranei alle ricerche attuali, sebbene ai miei pochi lettori non direbbero nulla, e a partire dal 1968 la mia situazione personale. Erano gli anni che si affacciavano sui grandi avvenimenti del periodo 1970-1975 e io non potevo continuare ad abitare due pianeti diversi. Dirigente industriale e militante rivoluzionario. La precaria clandestinità in cui svolgevo questa seconda attività poteva saltare da un momento all’altro e la cosa sarebbe sembrata senz’altro strana ai tanti miei detrattori che pure non sapendo quello che in effetti stavo facendo si chiedevano, con la malignità dei poveri di spirito, chi avessero davanti.
Il libro, in tre note redatte nel 1968, nel 1970 e nel 1972, dà conto di questa mia situazione come può darla la limitatezza di una nota fatta di parole e non materiata di sangue e sofferenza.
Ricordo qui che mentre questo libro vedeva la luce a Catania, nel maggio 1974, la mia compagna Jean Weir veniva a Parigi incriminata del sequestro Suarez e arrestata insieme ad altri compagni. Il momento non poteva essere più difficile. Chi conosce la storia di questo sequestro sa che gli imbrogli della polizia francese e le sue connessioni segrete con l’allora franchista polizia spagnola, con relativi scambi di favori, fecero scoppiare uno scandalo a livello mondiale e i compagni arrestati, dopo circa un anno di carcere, vennero tutti rilasciati.
Non essendo uno storico non mi interesso di questi fatti, pure importanti, che altri più documentati di me hanno indagato e pubblicato.
Restano i testi. Alcuni di loro, specialmente quelli della prima parte, documentano la mia evoluzione dall’ipoteca esistenzialista e crociana a quella neopositivista. La matematica come ciambella di salvataggio per uscire fuori dalle delusioni subite all’università di Torino. Abbagnano era persona gradevole, come spesso accade con i meridionali, ma non certo all’altezza della sua fama. I testi della seconda parte accolgono le polemiche mie con Alberto Jacometti e con Luigi Giusso che avevano scritto recensioni abbastanza approfondite del mio libro La distruzione necessaria. Il problema della violenza venne in questa occasione approfondito. La terza parte è caratterizzata dagli studi su Kropotkin fatti in occasione della mia traduzione de L’Etica e per preparare l’edizione critica de L’anarchia di Malatesta. Da notare che in questo torno di tempo riprendo gli studi sul darwinismo sociale stimolati dalla polemica contro il famismo di Gino Raya e approfondisco per la prima volta le teorie insurrezionaliste di Malatesta. La quarta parte è, com’è logico, la più importante. Mi stacco progressivamente dai miei impegni intellettuali puri e semplici con l’Antigruppo e puntualizzo una posizione diversa da quella che questo raggruppamento professava, particolarmente riguardo all’estetica, operazione di chiarimento che culminerà nel mio successivo lavoro su L’estetica dell’anarchismo. Nel frattempo sono importanti per me la traduzione e l’introduzione del libro di Antonio Tellez su Sabaté, gli studi su Pouget per l’edizione critica del libro sul Sabotaggio, e l’analisi del libro di Osvaldo Bayer su Severino Di Giovanni da cui successivamente verrà tratta l’Introduzione all’edizione inglese del 1986. Infine una critica approfondita delle tesi di Gino Cerrito sull’organizzazione anarchica seguita da un’analisi a tutto campo sul movimento anarchico italiano e le differenti strade di un suo possibile sviluppo. Questi ultimi studi, come il lettore attento non mancherà di notare, non vennero pubblicati ma restarono allo stato di dattiloscritti. La considerazione è importante. Le mie posizioni andavano trovando sempre maggiori ostacoli all’interno del movimento anarchico e le porte dei vari giornali anarchici mi vennero a poco a poco chiuse.
Ognuno dei pezzi qui presentati – non certamente come capitoli di un libro ma come testimonianze di un’evoluzione e di una presa di coscienza rivoluzionaria – è un mondo in continua produzione che non può essere considerato completo, anche se qui viene presentato a partire da un punto del discorso per finire in un altro, generalmente come se quest’ultimo punto fosse un approdo. Non è mai stato questo il modo in cui sono riuscito a fare funzionare nel bene come nel male il mio cervello. Tale constatazione è falsamente evidente perché la sua approssimazione non è legata a una questione di mancanza quantitativa ma a una deficienza qualitativa, la quale non appartiene al meccanismo stesso nella sua incompletezza. Questa insufficienza è una sua condizione di parziale libertà, quella che la volontà lascia che sia lo spazio ristretto dentro il quale mi muovo per avere l’impressione di scegliere su mia decisione. In effetti sono costretto a queste decisioni di cui sono in una certa misura prigioniero. È di questa volontà che devo andare in cerca per stanarla e circoscriverla, per arrivare ad aggirarla e andare oltre. Non c’è necessità alcuna in questa ricerca, non posso decidere di farla o non farla e non prende mai la stessa forma in me come in tutti. Ci sono momenti in cui la strada verso la diversità si apre, ma non sono momenti di particolare solennità, e momenti in cui la superstizione del fare mi attanaglia più che mai. Sono i primi, questi sprazzi di intuizione, che mi vengono a visitare e che mi si concedono spesso senza specifiche sollecitazioni. A volte la stessa ragionevolezza mi aiuta a scavare camminamenti negativi che distaccano porzioni di quantità lasciandomi sgomento. Questo libro è pertanto un Bildungsroman, un romanzo di formazione, se non altro per quel che riguarda il mio modo di scrivere, oltre che il mio modo di fare i conti con i concetti di efficienza e di acquisizione. Non è stata facile questa lotta, condotta dentro me stesso senza esclusione di colpi. La distruzione dei miti dell’efficienza delle élite, del ruolo guida degli intellettuali, della funzione militare all’interno dell’accadimento rivoluzionario, è stata lunga e faticosa. Parallela, in ogni caso, alla ritrosia a dichiararmi partecipe di un simbolo, di una bandiera, sia pure quella anarchica che, per definizione, dovrebbe essere aliena da connotazioni sclerotizzate.
Questo per me.
Per gli altri ogni singolo apporto può rivestire i panni dell’avventura. Spesso nel gruppo delle regole (storiche e linguistiche), che danno alcune diritture di comprensione, ci sono diverse rarefazioni suggerite dal particolare modularsi della prospettiva esteriore. In compenso queste condizioni intensificano la prospettiva interiore. All’aspetto puramente formale queste regole del dire non dipendono dalla volontà di chi la impone, vicina o remota che sia questa costituzione, ma sono le regole più efficaci e quindi le più perniciose. A esempio, la chiarezza è una di queste. Senza chiarezza non c’è quel tipo di conoscenza a cui siamo abituati da sempre, conoscenza che rifiuta le regole della saggezza per accettare i pochi spiccioli del cambiamento immediato. Dietro l’oscurità di tanti riferimenti il lettore non frettoloso troverà una trasformazione nascosta, a volte espressamente nascosta come un gioiello non comune, che gli permetterà di agire. Aizzarsi da se medesimo contro la difficoltà improvvisa, sorta come un guerriero armato di tutto punto a difesa del comprensibile, di quello che il lettore pensa sia un suo diretto possedere senza combattere, è cattivo disporsi alla lotta e quindi anche alla comprensione. La mia follia è senza nome, non ha conoscenza perché non conosce paura, è al di là.
Ho imparato per tempo questa sorta di esperienza marginale. Dopo tutto la vita è meno complicata della fantasia, ma i miei giovani anni, con la loro ansia di imparare le difficoltà del dire, non potevano saperlo. Ora che sono vecchio mi riporto nella condizione di capire la parola e di conoscerla, ed è la parola con la quale parla anche il destino all’origine di tutto, e questa voce del destino è uguale al silenzio che ho udito la notte nel deserto quando il vento della morte esce a visitare i moribondi.
Testi e ostacoli trattano della difficoltà. Ma quali sono le difficoltà, signori e maestri che mi leggete, se non le vostre proprie tentazioni? Prime fra tutte quelle che vi suggeriscono di tenere questo libro in mano nella nuova edizione (splendida, se paragonata a quella vecchia) per portare qualcosa a casa.
Pensate che sia veramente sentimento di uomini degni di agire, bramare oggetti che costituiscono un godimento chiusi in se stessi, concepiti nella loro stucchevole pienezza, finalmente conosciuti, posseduti, ridotti così ingenuamente a un comune denominatore, corrotti per teste glabre, per schiavi del ben servito?
Che ve ne fate di questo nuovo genere di conquista? Avete solo messo in tasca qualcosa che vi ha resi inferiori a quello che siete, cioè convinti di possedere un tesoro mentre non avete in tasca che un pugno di polvere. Certo, quella poca polvere, le poche idee contenute in questo libro, avrebbero potuto fruttare abbastanza per rendere degna la vostra fatica di essere sopportata fino in fondo, ma non l’avete voluto, vi siete inchinati di fronti alle prime difficoltà, sminuendovi al livello di lettori di opinioni non di idee. E in questo libro ci sono idee, poche, ma ci sono.
Se vi siete fatti prendere dal panico, adesso non vi resta che disprezzare la poca sostanza della vostra gloria conoscitiva. Solo i ribelli valgono uno sforzo in più.
La parola dentro cui penetravo qui come altrove non è la stessa dentro cui la conoscenza si rispecchia. Quella era una forma piena di contenuto, di senso, un intero mondo vociante la riempiva e debordava da essa, questa è spesso un vuoto assoluto che riflette il silenzio e la desolazione di un’idea. Un contenitore simile all’aspetto polveroso del dio dei sacrifici cruenti che si rotola nella cenere dei cadaveri, ecco la saggezza, niente l’attira, niente ha misura davanti a lei, niente esprime un possesso degno di questo nome. L’approfondimento è un’apertura della parola che permette alla saggezza di scoprire nuovi livelli della sua profondità, non è una richiesta di chiarimenti. La saggezza è se stessa e l’altro non è simbolo delle due contrastanti versioni, essa non accetta una qualsiasi di quelle corrispondenze che sono di solito chiamate contraddizioni. La parola e la saggezza non hanno possibilità di mediazione. L’apertura dei diversi livelli della prima toglie via la seconda, e viceversa. Eppure si fronteggiano coraggiosamente una verso l’altra. Mediate dal destino.
Più di trentacinque anni sono tanti per un libro, ma non per il libro di un anarchico. La mia non è presunzione pura e semplice, è qualcosa di più. C’è, nei libri degli anarchici (attenzione notate che non sto parlando di libri anarchici ma di libri degli anarchici), un’aria di attualità che sorvola il tempo e le contingenze che la storia attanaglia digerendole come dati di fatto. C’è, nei libri degli anarchici, una costante freschezza perché essi sono parte della loro vita e non un escremento qualsiasi della capacità più o meno accettabile di sporcare un certo quantitativo di carta. Questo libro ha trentacinque anni suonati, il suo autore ne ha quasi settanta, eppure rileggendolo mi sono sentito battere il cuore come quando mi accingevo a trasformare il mondo con tutto il mio coraggio e la mia forza intatti.
Una nota editoriale necessaria. Ho tolto le pagine 82-101 tratte da La distruzione necessaria e le pagine 243-261 tratte da Potere e contropotere della vecchia edizione perché questi libri sono stati pubblicati per intero, con tutti i lavori preparatori che li riguardavano, in questa stessa collana “Pensiero e azione”.
Va, e non temer bufere.
Trieste, 12 novembre 2006
Alfredo M. Bonanno
Introduzione alla prima edizione
Questo è un libro particolare. Significa molte cose e nello stesso tempo ha la pretesa di non volere dimostrare niente. Un oggetto preciso è qualcosa che costringe il lettore a selezionare l’attenzione. È un libro evolutivo, un libro che cerca di dare un’indicazione, un segno verso un certo tipo di ricerca sociale e politica. E, nello stesso tempo, è un contributo a una visione matura dell’anarchismo, non calata dall’alto o trovata per caso, ma sofferta e costruita giorno per giorno, ostacolo per ostacolo, in un processo che dalle nebulose premesse dottrinali diventa un viaggio verso la chiarezza. Questo libro è la documentazione di tale itinerario.
Nella struttura esteriore esso si divide in quattro parti. La prima comprende scritti che vanno dal 1955 al 1967. Si tratta della parte più remota, riguardante la produzione di un periodo in cui mi interessavo di problemi filosofici ed economici. È il periodo degli studi sull’esistenzialismo, del corso di studi in filosofia poi interrotto e della laurea in economia. Un periodo particolarmente importante per la mia formazione di fondo. Erano anni in cui non si avevano ancora le idee sufficientemente chiare. In filosofia la media non si era sbarazzata del tutto dell’ipoteca crociana, mentre i migliori non andavano al di là dell’esistenzialismo. Avevo ascoltato le lezioni di Abbagnano a Torino ricavandone una grande impressione, ben presto sfumata una volta resomi conto della grossa limitazione che si trovava dietro tutta quella impalcatura fumosa. Poi gli studi per la laurea e la tesi sul pensiero economico antico, le proposte della carriera universitaria (regolarmente rifiutate), l’abbandono progressivo di questo campo di studi. Troppa freddezza e troppe difficoltà a liberarsi di uno strato di inutile erudizione.
Seconda parte. Gli scritti dal 1967 al 1968. Anni decisivi. Esperienze fondamentali per tutti non solo per me. Sviluppo i concetti di fondo del mio pensiero: critica dell’autorità, riduzione dell’autorità al concetto di autorità funzionale, studio il problema dell’organizzazione. Scrivo un breve libro: La distruzione necessaria che raggiunge in poco tempo le settemila copie vendute. Non serve. Non sono contento dello sviluppo delle mie tesi. Alcune mi paiono mal capite e quel che è peggio mal dette. Mi accorgo dopo che nessuno ha tenuto conto dei limiti del mio lavoro. Troppe cose urgono davanti a me: la necessità di rispondere alle critiche, quella di fare chiarezza a me stesso, l’incalzare dei problemi concreti, propri di una realtà che mi ospita in prima persona. Altro fatto non trascurabile, il mio stesso lavoro (sono dirigente amministrativo di una media industria) mi chiama a rispondere in prima persona ai quesiti che mi pongo in sede teorica. È questo un periodo in cui scrivo relativamente poco (ancora qualcosa di storia della filosofia, un libro sul problema filosofico del concetto fisico d’indeterminazione, alcuni saggi sul neopositivismo) ma rifletto molto.
Terza parte. Un più nutrito gruppo di scritti. Primo problema: la critica del vecchio concetto di “intellighentia”, gli intellettuali mi preoccupano. Studio tutti i momenti storici in cui essi hanno fatto qualcosa (per esempio durante la Comune) e ne rimango terrorizzato. Mi pongo anche il problema dell’arte (che per me resta fondamentale) e quelli più specifici della violenza e dell’inglobazione. Questi due filoni di riflessione mi portano un’altra volta a rivedere i vecchi concetti esposti ne La distruzione necessaria. Incomincio le ricerche sull’anarchismo: Kropotkin e Malatesta. Le note a L’anarchia sono un esempio tipico del mio modo di pensare in questi anni, una ricerca collocata tra il mondo dottrinale del passato (del “mio” passato) e una verifica delle dottrine anarchiche. Rivedo e pubblico su “Volontà” i saggi sull’ateismo, poi riuniti in volume.
Quarta parte. Gli scritti fino agli inizi del 1974. Vi si trovano quasi tutti, tranne alcuni che non si sono potuti includere per motivi particolari o perché non reperibili. Adesione all’anarchismo. Tentativi di trovare una strada verso un anarchismo che non sia faccenda dottrinale soltanto. Importanza dei concetti anarchici di organizzazione non autoritaria, rivoluzione libertaria, violenza liberatrice, ecc. Polemica con un anarchismo revisionista e conservatore, umanitarista e pacifista che vede solo l’aspetto “distaccato” della lotta rivoluzionaria e non anche l’aspetto “impegnato”, globale. Esame dei concetti di proprietà e di espropriazione. La dimensione anarchica come perenne visione critica di se stessi e del mondo. Visione complessiva e non parziale che dall’umanitarismo di base sa ripiegare su se stessa fino al riconoscimento della lotta violenta per la liberazione, della lotta giusta anche se parziale e destinata alla sconfitta, della lotta che si programma non tanto una meta quanto un modello interpretativo della realtà. Lascio il lavoro nell’industria. Vengo arrestato come responsabile del numero unico “Sinistra libertaria” e condannato a due anni e due mesi. Esco di prigione dopo tre mesi in libertà provvisoria in attesa del processo di appello. Continuo i miei studi e mi laureo anche in filosofia con una tesi su Stirner e l’anarchismo.
Questo il libro. Qualcosa di intrinsecamente legato alla mia vita e alle mie esperienze, qualcosa che segue dal lato dottrinale lo sviluppo fisico e intellettuale come un sismografo può seguire l’andamento di un fatto tellurico.
Mi chiedo adesso quali potrebbero essere i luoghi positivi di una lettura e ciò allo scopo di indicarne un modello a priori che possa facilitarne la fruizione. Certo esiste sempre il modello esteriorizzante, quello che pretende una lettura dei testi per ciò che essi sono e nell’ordine in cui sono. Ma non mi sembra questo il modello che preferisco. Accanto al mio lavoro teorico esiste sempre qualcosa di più che potrebbe aiutare quello, ma che non sempre può giungere fino a rivelarsi attraverso di quello. Ed è proprio quest’ultimo lavoro quello più interessante che dovrebbe essere tenuto presente. Come teorico e come militante non posso abitare due regioni diverse.
Catania, 12 febbraio 1974
Alfredo M. Bonanno
PARTE PRIMA (1955-1966)
Meccanizzazione operaia e intellettuale
Una entità complessa diretta alla produzione su scala meccanizzata nella società contemporanea necessita di una organizzazione che deve modificare continuamente le entità eterogenee che entrano a far parte del ciclo lavorativo fino ad ottenere una uniformità capace di garantire la prevedibilità di funzionamento dell’entità stessa. E ciò nasce dalla prima necessità di ogni struttura organica, la sopravvivenza.
Per arrivare a questa pianificazione deve agire sul lavoro onde ottenere un giusto equilibrio tra qualità e quantità, equilibrio che, una volta dissolto, minaccerebbe di mettere in crisi in un senso o nell’altro l’economia dell’entità complessa. La tecnica è venuta incontro a questo problema proponendo la soluzione della divisione del lavoro. Così si viene a limitare l’orizzonte qualitativo del lavoratore a un ideale, mentre si incrementa al massimo il risultato quantitativo. Anche a volere prescindere da questioni di carattere tecnico, come potrebbero essere quelle inerenti a un conteggio operazionista dei movimenti dei lavoratori, si deve tenere presente un altro fattore di ordine psicologico. Il lavoratore inserito in una produzione divisa avverte la propria posizione d’ingranaggio e in breve modifica il proprio orizzonte intellettuale, costringendosi in limiti che trovano origine dalla specifica mansione che occupa. Un operaio sconosce il prodotto compiuto che esce dall’industria dove lavora: questo lo porta a disinteressarsi completamente della conoscenza dei procedimenti che conducono al prodotto finito. Donde si apre la strada ad una considerazione puramente utilitaristica del lavoro, come mezzo per ottenere una retribuzione.
Come si vede la situazione spirituale del lavoratore è quanto di più negativo sia dato trovare. Va bene che esso è venuto fuori dalla schiavitù dei calli alle mani, va bene che adesso può lavorare otto ore giornaliere, contro le dodici che un tempo lo soffocavano, ma contemporaneamente ha perduto l’amore al proprio lavoro, la diretta sensazione di partecipare alla creazione di qualcosa, di un oggetto che una volta in circolazione porti una impronta personale ed inconfondibile.
Lo stesso pericolo, e in forma più accentuata, gravita sulla situazione dell’intellettuale.
Sostanzialmente tutta la società contemporanea è diretta alla meccanizzazione dei procedimenti che la reggono e la costituiscono e, conseguentemente, alla meccanizzazione dell’uomo stesso. Ovviamente non si deve intendere che presto si arriverà a una sostituzione dell’uomo con i robot: questo è un programma gradito solo alla fantascienza. Il pericolo, secondo noi, consiste invece in una modellazione dell’impiego dell’uomo, nei processi organizzativi della società, con gli stessi schemi e gli stessi presupposti che vengono utilizzati nell’impiego delle macchine.
Gli intellettuali, non potendo reggersi in stratificazioni dissociate, sono costretti a dipendere, in un modo o nell’altro, da schemi successivi che li vincolano ad opinioni estranee e pianificatrici. In loro il condizionamento avviene per concetti anziché per operazioni, concetti che nella loro apparenza intellettiva nascondono una particolare tecnica operazionista. La società provvede alla modellazione di questi intellettuali da ingranaggio condizionandoli fino dai banchi di scuola, segue la loro formazione fino al momento dell’applicazione in seno a un settore sociale, vieta accuratamente qualsiasi possibilità di sviluppo in senso critico e quando si manifesta qualche preoccupante tendenza del genere il soggetto viene tenuto subito in pessima considerazione perché un preordinato metodo di vedere le cose in un certo senso sconvolge i piani prestabiliti.
Quindi è giusto che cadano le illusioni di quanti si credono liberi ed attori del proprio progresso mentale solo perché appartenenti alla schiera degli intellettuali. Il loro camice, le loro mezze maniche, come pure i loro lunghi anni di università o di specializzazione, non li distinguono sufficientemente dalla schiera degli operai più da vicino legati al dramma opprimente della macchina.
Un giovane di media cultura, provvisto di titolo di studio a carattere universitario, d’intelligenza media, al termine dei suoi corsi di studio viene innestato in un settore sociale. La prima impressione che prova nella sua nuova veste di lavoratore è quella di sentire vincolate di colpo le sue possibilità e le sue aspirazioni. In effetti non è così. Il condizionamento che crede di subire in quel momento è un processo di già in corso, tutta la sua vita precedente di studi è stata pazientemente diretta a questo scopo con la sola differenza che, mentre in sede preparatoria si aveva un condizionamento generale, adesso se ne ha uno specifico. Lo scopo si è ristretto alla sola sopravvivenza del nuovo organismo di cui il giovane fa parte. Ma questo organismo gli è estraneo, per lui si compendia in un tavolo, dei moduli da riempire, dei conteggi da sviluppare, dei disegni da completare, delle lezioni da ripetere, delle misure da catalogare, dei sintomi da rinvenire, tutt’al più in un ufficio, in un palazzo, in un nome, in alcune persone che gli sono direttamente vicine o superiori, in un’etichetta, un marchio di fabbrica, una ragione sociale.
Anche la grande ricerca scientifica, o gli sforzi massimi di compendiare la natura e l’essere, l’uomo e le sue possibilità, hanno ceduto il passo alle ricerche organizzate sistematicamente, divise in settori e branche, in sezioni sempre più minute e specializzate, e l’attesa di una mente così estesa che riesca ad infondere unità e significato alla mole impressionante dei risultati conseguiti, è attesa non di un uomo ma di una macchina più complessa e più perfetta, di un cervello elettronico talmente completo da riuscire dove l’uomo non può più cercare di riuscire.
Quindi conclusioni amare dettate più che altro dalla consapevolezza delle difficoltà che sorgerebbero nel volere programmare uno schema di modificazione. In questa sede ci basta avere dato qualche cenno sui pericoli che covano sotto il roseo aspetto del lavoro come è inteso negli anni che viviamo, per le soluzioni ci si rivolga pure agli utopisti o ai taumaturghi.
[1955] [“Meccanizzazione operaia e intellettuale”, pubblicato su “L’Agitazione del Sud”, novembre 1967]
Lavoro e personalità
Una delle tendenze più facilmente riconoscibili nella società contemporanea è quella diretta alla meccanizzazione dei procedimenti che la reggono e la costituiscono. Al di là di questa tendenza, che potremmo definire esteriore, ne esiste una nascosta e solo sperata, ma non meno pregnante, che tende alla meccanizzazione dell’uomo stesso.
Ovviamente quest’ultima non deve intendersi come una semplice sostituzione della macchina all’uomo, l’era dei robot non è ancora arrivata e i tentativi che la cibernetica ha condotto in questo senso non lasciano temere che sia molto vicina. Il pericolo secondo noi consiste invece in una modellazione dell’impiego dell’uomo nei processi organizzativi della società con gli stessi schemi e gli stessi presupposti che vengono utilizzati nell’impiego delle macchine. E questo avviene nella civiltà borghese. Lo scopo originario del lavoro come unica possibilità di modificazione della natura viene ad essere distorto dallo sfruttamento sistematico che riesce a disperdere lo scopo del lavoro in una mera necessità di sopravvivenza.
Mettendo da parte la fase iniziale dell’umanità, quando il lavoro costituiva la sola soluzione positiva, ci resta l’esame della fase media, quella in cui seppe imporsi la figura del “signore”, eccezione alla necessità comune del lavoro. L’esame dei motivi che causarono la nascita del “signore” esulano da questo scritto e pertanto ci occuperemo della posizione del “servo”.
Molto si è scritto sulla figura sociale del “servo”, e il più delle volte lo si è voluto inquadrare nelle stereotipate figurazioni medievali di annullamento di iniziativa e di personalità. Ma questo non è del tutto vero e la riprova della falsità che sta sotto questa etichetta ci è stata data dall’esame dell’evoluzione sociale dell’uomo. Se il “servo” fosse stato veramente un uomo alienato da ogni patrimonio umano, non avrebbe potuto dare vita alla figura dell’“artigiano” prima e del “borghese” dopo. Si sarebbe arenato nella sua fossile configurazione servile e avrebbe fatto di tutto per cristallizzare lo stato delle cose. Invece questo non è avvenuto. Gli sforzi che condussero alla trasformazione del mondo medievale non vennero dalle stanze riccamente addobbate del “signore”, ma dai miseri tuguri del “servo”. E non giova dire che solo chi si trova in una situazione infelice tende al miglioramento, mentre chi si trova in pieno agio e ricchezza è conservatore di natura. Per tendere al miglioramento, per trovare le forze e le speranze di una nuova lotta, non solo ci si deve trovare in una situazione presente – in cui si avverte il bisogno di modificazione – ma si deve possedere. una vera autocoscienza di uomo. Se i valori superiori dello spirito, se il culto del bello, della creatività, dell’avvenire, sono scomparsi, l’uomo non arriverà nemmeno a pensare a una soluzione diversa da quella in cui continua a vivere, anche se quest’ultima è la peggiore di tutte le soluzioni possibili.
Quindi riteniamo valida l’interpretazione che tende a riscontrare nella figura del “servo” un residuo intatto di umanità e di valore. Ma quali potrebbero mai essere i motivi che causarono la persistenza di tanta spiritualità in uomini che appartenevano non solo in corpo ma anche in anima al proprio padrone? I motivi sono parecchi ma si possono compendiare per toni diversi in un motivo centrale. Il “servo” svolgeva la propria attività lavorativa al servizio del “signore” impiegando in questa tutte le risorse della propria intelligenza e della propria creatività. Il “signore” vincolava diritti di ordine diverso da quelli immediatamente inerenti allo svolgimento del lavoro e, quando scendeva per motivi particolari a questioni di ordine tecnico, veniva lo stesso accettato in pieno perché non si giustificava altrimenti l’iniziativa modificatrice della volontà direttiva. Il “servo” vedeva in questo modo una trascendenza dei propri valori spirituali nella figura del “signore”, che tutti li compendiava in se stesso e a sua volontà sapeva trasfonderli nella “cosa-servo”. Come a dire che la figura del “signore” era necessaria alla sopravvivenza spirituale del “servo”.
Quando cause economiche, non sempre in relazione con delle contingenze sociali, seppero preparare il terreno alla nuova figura dell’“artigiano” il bagaglio spirituale del servo fu intatto e pronto ad essere utilizzato in un ordine di trascendenza indipendente dalla figura del “signore”.
Allora si ebbe il periodo più produttivo del lavoro. Per l’“artigiano” il motivo della sopravvivenza divenne un succedaneo a quello della creazione. Forte dell’esperienza economica acquisita nell’assistere al tramonto del “signore”, l’ex “servo” avvertì la necessità di salvaguardare quel patrimonio spirituale di cui fino ad allora era stato tenutario inconsapevole il “signore”. E questa conservazione divenne possibile solo con l’annullamento progressivo della lotta per la sopravvivenza economica ed il successivo subentro della creazione modificatrice.
Tuttavia lo stimolo creativo caratteristico del periodo artigianale non poteva durare in eterno. Principalmente per due motivi, primo perché l’ingigantirsi del fenomeno della produzione richiese in breve una diversa organizzazione, fino alle forme più complesse del periodo industriale, secondo perché ogni sforzo creativo, una volta che si concretizza come tale, se non vuole disperdersi deve trovare forma e consistenza ben definite, quindi riscontrabili in quantità. Da cui si assistette al passaggio dalla fase qualitativa (artigianale) a quella quantitativa (industriale).
In quest’ultima modificazione l’uomo trova una radicale alienazione dei valori spirituali, mai interamente scomparsi nemmeno durante i secoli medievali.
Dalla figura dell’“artigiano”, in seguito alle crescenti richieste della produzione, si concretizzarono le figure dell’“operaio” e del “capitalista”. Vediamo adesso come si produssero queste modificazioni. Come abbiamo visto, allo sforzo creativo deve necessariamente succedere il periodo quantitativo, cioè un periodo nel quale trova ordine e forma una produzione sistematica di quello che nel precedente periodo creativo si aveva semplicemente in forma artistica e quindi asistematica. Questo fenomeno riesce a polarizzare le forze mediocri della mano d’opera. Queste forze costituiscono in breve la figura dell’“operaio”. Per un altro verso l’“artigiano” viene a trasformarsi in “capitalista” una volta che per sopperire alle sempre crescenti necessità dell’aumento della produzione è costretto a servirsi del lavoro degli “operai” e quindi a godere dei vantaggi che ne ricava.
Ed ecco nascere il primo dramma operaio della storia dell’uomo. Mai in precedenza il lavoratore ebbe a soffrire tanto in conseguenza del proprio lavoro. Nemmeno al tempo della situazione servile del Medioevo. E questa sofferenza è tanto maggiore quanto più viene posta accanto all’altrui guadagno e all’altrui libertà. Se nel “signore” il “servo” si immedesimava e quasi riusciva a sublimare la propria opera, nel “capitalista” l’“operaio” vede la negazione della libertà che già fu sua ed è un furto ineliminabile e continuo.
Gli operai del Settecento e dell’Ottocento dovevano lavorare più di sedici ore al giorno, non godevano di nessuna assistenza medica, non percepivano assegni per i familiari, non avevano ferie. D’altro canto non si potevano porre alternative di nessun genere. I rari casi che la storia è riuscita a tramandarci di operai che hanno saputo valicare il baratro che li divideva – in questi periodi – dal progressivo accumularsi del capitale sono per lo più imputabili a eventi estranei, difficilmente ripetibili.
Questa situazione, protrattasi fino ai primi decenni dell’Ottocento, trovò sbocco e modificazioni in lotte sindacali e politiche che esulano dalla nostra trattazione. Ci interessa invece puntualizzare lo svolgimento, sempre sul piano lavorativo, che subirono le classi privilegiate degli intellettuali.
L’arco che abbiamo tracciato dalla figura del “servo” a quella dell’“operaio”, attraverso la parentesi artigianale, trova riscontro nel progressivo modificarsi dell’atteggiamento della classe intellettuale più elevata. L’intellettuale si limita a vivere all’ombra del “signore” facendo parte della ristretta corte di quest’ultimo e non avendo sostanziale differenza dalla posizione del “servo” ignorante. Ovviamente, malgrado l’esteriore legame con gli uomini del principe, intimamente l’intellettuale lotta per salvaguardare il patrimonio letterario ed artistico che una millenaria tradizione gli ha tramandato. Difatti quando dal “servo” esce la figura dell’“artigiano”, dal letterato di corte viene fuori lo scienziato e l’artista della nuova era.
Ma la ruota pesante del progresso parve non gradire l’avvento della qualità quando tutto chiedeva sempre maggiore quantità. E come un vaso che lentamente si riempie goccia a goccia fino all’estremo limite, fino al traboccare irrimediabile, il progresso chiese ed ottenne di impiegare per fini propri e molto differenti da quelli originari le nuove forze della scienza e dell’arte. Le porte dell’era meccanica si erano ormai spalancate.
[1958] [“Lavoro e personalità”, pubblicato su “Proserpina”, 1963, pp. 9-14]
L’eccezionalità come problema sociale
Uno dei maggiori pericoli che minacciano la società contemporanea è costituito dal progressivo appiattimento della spiritualità. Anche gli estremi nuclei di concentrazione dei valori superiori – la scienza, l’arte, la religione – hanno ormai aperto le porte alla pianificazione, permettendo una indegna mistificazione dei loro prodotti. Eppure il fenomeno non è nuovo nella storia dell’uomo. Sebbene in forme molto più rarefatte, esso si è presentato puntualmente in passato e altrettanto puntualmente è stato cancellato dall’azione di un pugno di uomini che possiamo definire “eccezionali”.
Quale potrebbe essere la formula che ci consente di scoprire i sintomi della eccezionalità negli uomini che attualmente accentrano le nostre attenzioni? Ci si può accontentare di un esame immediato di quello che hanno saputo fare, specie quando la loro azione è in corso di svolgimento? Non si corre il rischio così facendo di risultare frettolosi e imprecisi per mancanza di prospettiva storica, dando credito a voci di piazza? Queste e altre le domande che un attento osservatore non manca di porsi.
Ora se il compito d’indagatori manifesta difficoltà così grandi è bene fidare sull’esistenza di questi uomini “eccezionali”, quando anche si devolva ai posteri l’ingrato compito di valutare la loro opera. Ma fidarsi delle risorse infinite dell’uomo non vuole dire addormentarsi su pretese leggi storiche che presiedono alla direzione delle sorti. L’uomo deve agire per difendere e coltivare l’eccezionalità. Solo in questo modo potrà garantire alla civiltà un futuro svincolato dalla volgarità e dalla monotonia. E questo compito è tanto più grave quanto più standardizzata diventa la mentalità media giudicatrice.
Il primo pericolo che si presenta nella tortuosa strada dell’“uomo eccezionale” è di ordine intimo, psicologico, personale. Il progresso umano è stato puntualizzato dall’opera di questi individui eccezionali, i quali una volta che si prescinda da preconcetti esoterici hanno dovuto compiere il primo grande sforzo proprio per convincersi della propria eccezionalità. Un gran numero di uomini potenzialmente eccezionali non è riuscito a superare questa fase di pericolo iniziale, venendo a bruciare le possibilità di un futuro modificatore. I motivi che causano questa inibizione a priori si possono raggruppare per grandi linee in due ordini distinti, il primo si traduce in una mancanza di equilibrio per un grande amore verso la conoscenza, il secondo assume veste opposta concretizzandosi in una paura quasi ascetica della conoscenza medesima. Il primo difetto conduce irrimediabilmente al di là delle cose, in quella zona della conoscenza che sebbene si mantenga troppo al di qua della totalità è un passo appena oltre il limite degli umani valori. Da qui un processo di disfacimento della complessità univoca del rapporto cosale con la sostituzione di una serie infinita di rapporti minori, frazionati in continui ricorsi all’infinito dell’indivisibilità. Il secondo difetto cristallizza l’uomo eccezionale in un’ascetica attesa della conoscenza, come se l’azione fosse avulsa dalle possibilità effettive del pensante. Da qui la formazione di una zona netta, al di qua del rapporto cosale, ma parimenti lontana dalla totalità. Non possiamo dire che quest’ultimo sia un difetto di carenza, perché non ci è dato affermare con certezza dove risiede la verità, però possiamo dire che difetto rimane lo stesso e tanto più grave quanto più tradisce il compito primo dell’eccezionalità, l’altruismo.
L’autoeducazione all’eccezionalità non credo si possa mettere in relazione produttiva con l’ambiente. Il primo passo se avviene è troppo intimo per potere instaurare un legame chiaro con quel complesso di fattori che costituiscono la realtà cosale, se rapporti esistono sono troppo nascosti psicologicamente per poterne trattare in questa sede. Pertanto ho parlato di autoeducazione. È il primo momento della grande solitudine, quando la fisionomia degli altri ci è troppo cara o troppo inutile. Il cammino successivo, una volta posto l’equilibrio di partenza, fa della solitudine un simbolo ma pure una concretezza. La rottura iniziale invece tenderà in continuazione questa corda, fino ai limiti della sopportazione patologica. Il volersi addentrare nella essenza più intima degli altri, o di noi stessi, non ci potrà mai liberare dalla solitudine. Solo nel giusto riconoscimento di un punto di compromesso l’irrimediabilmente puro, come l’irrimediabilmente dannato, troverà il suo effettivo modo d’essere.
Superato questo ostacolo iniziale, che come abbiamo visto funge da prima sgrossatura nell’individuazione dell’eccezionalità, si palesa immediata l’ingerenza dell’ambiente sociale. Avendosi come unica soluzione possibile dell’eccezionalità l’azione di modifica sull’ambiente sociale, è logico dedurne una strutturazione preventiva trovante origine dalle richieste di mancanza dello stesso ambiente. Da ciò si potrebbe dedurre una influenza favorevole, da parte dell’ambiente, sullo sviluppo e sull’incremento dell’eccezionalità del singolo. Ciò è vero solo in parte. Se l’ambiente sociale fosse costituito da un insieme di rapporti passivi generanti delle combinazioni preordinate, e indifferenti all’andamento dei valori spirituali, dai suoi componenti si avrebbe una reazione prevedibile dell’eccezionalità davanti ai risultati più o meno negativi. In altri termini non si correrebbe il rischio di trovarsi dinanzi a delle richieste non catalogabili in schemi prestabiliti. Ora la presenza di questo rischio dipendente dall’essere i rapporti dell’ambiente sociale di carattere attivo e differente determina una ulteriore selezione dell’eccezionalità. Le comunità sociali dell’età della pietra ad esempio vennero a programmarsi un dato numero di uomini eccezionali in base alle loro esigenze di difetto, ma il numero effettivo di uomini eccezionali che agì e modificò lo stato di cose dovette essere necessariamente differente da quello che quelle comunità sociali richiedevano. E la differenza è da valutarsi in senso negativo per quanto riguarda una linea di eccezionalità che potremmo chiamare ordinaria, invece su di un piano qualitativo superiore la differenza diventa nettamente positiva. Per tornare all’esempio dell’età della pietra possiamo dirci certi che lo stato primitivo dell’ambiente sociale, con tutta l’imprevedibilità attiva che nascondeva, sia riuscito a ridurre al minimo la comparsa dell’eccezionalità favorendo d’altro canto un aumento d’intensità qualitativa dell’eccezionalità residua.
Naturalmente l’ingerenza dell’ambiente sociale non si esaurisce in quello che abbiamo esposto. Una volta saldato il debito con l’autoeducazione all’eccezionalità e una volta superato il pericolo di una rottura di equilibrio iniziale, l’uomo eccezionale è pronto ad intrattenere il vero e proprio colloquio con il mondo, colloquio che compendia e concretizza le estreme risultanze dell’eccezionalità. Tuttavia mentre la relazione precedente tra mondo esterno e uomo eccezionale si poneva su di un piano di spontaneità, per quanto riguardava il comportamento dell’ambiente adesso, in conseguenza dell’apertura del rapporto colloquiale, si assiste a una vera e propria presa di posizione. Potrebbe sembrare logico che l’atteggiamento della comunità organizzata sia favorevole all’azione dell’uomo eccezionale. Eppure non è così. L’ambiente sociale è restio per natura a subire modificazioni di qualsiasi sorta, in modo particolare se il campo in discussione è quello delle idee. Il mondo è conservatore per tendenza naturale. Ma nello stesso tempo è desideroso della novità, talmente desideroso da essere incapace di manifestare un grado di giudizio appropriato. Da qui la necessità per la schematizzazione dell’autorità sociale, artistica o religiosa di mantenere una dirittura chiara, difficilmente modificabile, adatta a salvaguardare qualsiasi provvisoria imbarcata. In questo modo la società innalza una barriera contro l’eccezionalità a difesa di determinati concetti ormai rinsecchiti e resi invalidi dall’uso e dagli anni, ma proprio per questo più facilmente utilizzabili dalla pianificazione degli spiriti.
Il problema dell’arte è estremamente esemplificativo. Vi fu un tempo, ormai definitivamente scomparso, in cui l’artista ebbe un posto socialmente preminente. Anche non volendo scomodare le età preistoriche, data la scarsità di notizie che ci sono pervenute, nelle età greca, romana e medievale sappiamo con certezza che gli artisti erano qualche cosa di più che semplici parassiti di corte, sempre pronti a dedicare un’ode o una ballata al proprio signore o alla dama dei loro sogni. Un Omero, un Virgilio, i poeti del ciclo della Tavola Rotonda, delle gesta di Orlando, erano il simbolo delle glorie delle loro genti, e più che un simbolo ne erano la viva rappresentazione. Poi l’immeschinirsi delle aspirazioni fece piccoli i signori e striminzì le gloriose epopee. Gli artisti veramente eccezionali avvertirono il pericolo del ristagnare di modelli. ormai invecchiati e tentarono per l’ultima volta di fare battere le antiche corde con un nuovo ritmo. Nel frattempo il mondo aveva provveduto a cristallizzare schemi più forti di loro. Dante, Ariosto, Tasso, Shakespeare, e poi l’amara ironia di un Tassoni. Il ciclo glorioso dell’arte sociale si concludeva per sempre. Restavano i canti della solitudine, l’altra strada per l’accesso a una vena non ancora scoperta. Ed ecco risorgere le grandi eccezionalità. Ecco i grandi artisti dell’Ottocento, Leopardi, Rimbaud, Wagner, Cézanne. Ma questa volta la società si era preparata in precedenza. La pianificazione organizzativa, nata da necessità non artistiche, venne immediatamente elevata a concezione strutturalizzante per rimettere in piedi proprio quelle costruzioni che nel passato erano state negate in modo categorico. Quello che adesso si rimprovera all’arte è la mancanza di corrispondenza sociale, quando è stata la stessa società nel passato a rendere impossibile questa corrispondenza e a rinchiudere l’arte nell’intraducibile regno della solitudine. È un male gravissimo per le sorti dell’umanità, quando gli uomini eccezionali sono costretti a lavorare per se stessi, quando si rende intraducibile ed estraneo il loro linguaggio, quando si cerca in tutti i modi di isolarli e di svalutarli.
Come è facile dedurre, il comportamento dell’ambiente sociale è stato deleterio allo sviluppo dell’arte. In ogni caso sarebbe altrettanto inutile e dannoso ora un tentativo condotto nella speranza di socializzare l’arte con una presa di posizione dall’esterno. L’artista, come strutturazione più libera dell’eccezionalità, è proprio quello che più di tutti soffre e si distorce in schemi e pianificazioni. Concetto che sarà sperimentato con molta probabilità dall’arte russa contemporanea, se l’ambiente sociale di quello Stato continuerà nell’impresa di condizionarla in base a dottrine prestabilite e a rigide concezioni.
Ed allora si deve abbandonare ogni speranza sul futuro dell’arte? Ci si deve rassegnare davanti a una produzione che non riesce a superare l’ostacolo della solitudine imbastendo un discorso valido soltanto per metà? Oppure c’è qualche cosa da fare? Si è in tempo ad agire per modificare uno stato di cose apparentemente ineluttabile, ma in effetti debole perché privo di pensiero attivo e produttivo.
Alla prima domanda: si deve abbandonare ogni speranza sul futuro dell’arte? la risposta è difficile e amara. Certo è sempre scomodo fare i profeti, però gettati due dadi sul tappeto verde le combinazioni possono essere moltissime ma non infinite. Ciò significa che considerato lo stato presente dell’arte vi possono essere molti elementi la cui valutazione oggi è impossibile, però resta chiaramente definita l’esistenza di limiti insormontabili anche a soluzioni esplosive e imprevedibili. Uno di questi limiti è l’individualismo. Il punto di rottura di questa vena artistica è l’incomunicabilità del linguaggio con relativa retrocessione dei rapporti interpretativi in zone nebulose ed equivoche. Questo limite comporta l’avvento della mediocrità accanto all’eccezionalità, onde non è più possibile, per lo meno in sede di esame privo di prospettiva storica, distinguerle e valutarle. In questo modo si favorisce l’avvilirsi dell’eccezionalità fino all’appiattimento dei valori dello spirito, precludendo ogni possibile sviluppo in senso positivo.
Alla seconda domanda è lecito rassegnarsi a una produzione artistica incomunicabile? La risposta non può essere che negativa. Ma agire in questo campo non significa dettare volumi di norme estetiche, con la dolce illusione di vedere l’arte ragguagliarsi in breve su quegli schemi come se fossero una medicina o un unguento miracoloso. La filosofia giunge all’arte quando quest’ultima ha messo definitivamente da parte l’ubriacatura individualista per respirare orizzonti più vasti e armonici. Lasciando da parte le discussioni sul compito dell’arte, è giusto affermare la parzialità e l’infantilismo del narcisismo artistico. La filosofia non è in grado di tradurre questo concetto dell’arte. La forma accademica, nel suo piglio contemporaneo, finisce poi per bloccare in modo conclusivo tutte le possibilità residue di un colloquio diretto. Non resta quindi che la soluzione indiretta. L’uomo deve tornare ad apprendere il gusto per le piccole cose scordando questa macchina mostruosa che si chiama progresso, o quanto meno sfrondandola di tutte le schematizzazioni e gli avvenimenti che si nascondono sotto le sue luci sfavillanti.
Malgrado l’indubbia utilità in tutti i sensi che l’ingerenza dell’eccezionalità causa, essa viene sempre ostacolata perché vista come principio sovvertitore e rivoluzionario. E il problema dell’arte ci ha fornito un valido esempio di questo processo di cristallizzazione preventiva. Ma il nostro scopo non è soltanto quello di indicare i pericoli per l’eccezionalità, così facendo si presuppone come data una consequenzialità di produzione che non è affatto necessaria. Vorremmo piuttosto studiare un sistema che ci metta in grado, anche se per grandi linee, data la particolare indole del lavoro che ci siamo proposti, di percepire l’eccezionalità al di là degli schemi e degli appiattimenti.
Per iniziare questo lavoro occorre avere un’idea degli schemi su cui l’eccezionalità si troverà ad agire e da cui come abbiamo visto viene condizionata e prodotta. Questi schemi sono di tre tipi: sociali, religiosi, scientifici.
Gli schemi sociali reggono l’impalcatura organizzativa esterna della società, stabilendo i limiti d’ingerenza di comportamento dell’uomo ed il confine di demarcazione tra uomo e cittadino. Ovviamente questi schemi sono di varia composizione e variamente dotati di rigidezza, a seconda che dalle società democratiche si passi a quelle totalitarie. Infatti il viaggio in questo senso è seguito da una modificazione sempre crescente del concetto uomo-cittadino, dallo strato iniziale di estrema separazione a quello finale di estrema identificazione. Una eccezionalità che si trovi a lottare contro questo continuo altalenare tra una soluzione e l’altra decide in un senso o nell’altro (non si discute qui la bontà della dottrina ma solo astrattamente la constatazione della sua esistenza), perché rifugge come prima ed essenziale mistificazione dalla mancanza di stabilità. Evidentemente non si può pretendere che questa decisione iniziale, tendente più che altro ad analizzare un processo in corso e quindi da valutarsi come metodo di indagine più che come costume di vita, sia la migliore possibile. Sarà quella che forze contingenti hanno governato con una relativa ingerenza della volontà di decisione. Da questo momento s’inizia l’opera di modificazione degli schemi. Non potendo modificare la posizione di partenza, l’eccezionalità si adopera a modificare gli schemi fino a farli aderire alla sua posizione e in questo svolge il compito per cui è nata, compito voluto da un puro calcolo statistico ma lo stesso considerabile come l’antico destino della civiltà. Ora bisogna tenere presente che lo schematismo sociale si differenzia dagli altri per una sua particolare caratteristica, non si propone la necessità d’imposizione di una verità. La forza di una dottrina valida universalmente, al di là di particolari situazioni politiche o economiche, gli è estranea, il suo mondo si muove dentro il cerchio di un rapporto insanabile tra l’unità del singolo e l’unità dello Stato. Questo principio, anzi questa mancanza di princìpi, mette in grave repentaglio lo schematismo sociale continuamente costretto a difendersi ora da un estremismo, ora da un altro.
Gli schemi religiosi costituiscono di gran lunga l’ostacolo più duro e nello stesso tempo più importante della eccezionalità. Questa particolare delicatezza si è venuta determinando in epoca remota, fin da quando la religione smise di servire da semplice apparato esterno, da semplice motivo di coesione del popolo per diventare consapevole della propria indipendenza e assumere la facoltà di discutere problemi propri e di formulare un principio proprio. Appunto qui possiamo indirizzare le nostre attenzioni. I guai cominciano quando si circonfusero di astrattezza tutti quegli schemi che, come nel caso dello schematismo sociale, dovevano mantenere la loro caratteristica di estrinsecità. Necessariamente l’eccezionalità, inserendosi in un problema di principio, non può prendere posizione contro questo principio stesso in virtù del fatto che la prima e fondamentale legge dell’eccezionalità è la libertà. Tenendo presente che il principio è lo schematismo portato alle più assurde conseguenze, non si può vedere altra soluzione possibile che una lotta alla religione sia nel suo nucleo centrale di teorie sia nella estrinsecazione pratica di queste teorie. Onde ben si consideri i rinnovellatori della religione e della morale sono sempre stati sovvertitori degli schemi religiosi precedenti, sovvertitori perché riconoscevano in essi la negazione del significato più alto di religione la quale prima di essere schema deve essere morale e prima di essere obbligo deve essere passione e sentimento. E la prova più convincente di quanto sia lontana la religione che ogni giorno ci viene propinata da tanti pulpiti e dai templi dorati, dalla vera religione dell’animo e dello spirito, ci è data dalla amara constatazione che malgrado l’esempio di uomini come Gesù, Buddha, Maometto, il mondo di oggi cova forze negative pericolosamente compresse ma pronte a scatenarsi in maniera imprevedibile. Si è sconfitta la schiavitù ma qualcosa di più terribile è sorto dalle sue ceneri, le macchine e il lavoro senza scopo e senza speranza. Si è sancito il rispetto della vita per i prigionieri di guerra ma non si è riusciti ad evitare che durante l’ultima guerra immani massacri siano stati perpetrati, alcuni conosciuti, altri meno conosciuti ma non per questo meno dolorosi. Si è anatemizzato contro le teorie razziste dei Tedeschi, ma ciò non impedisce che oggi, dopo l’amara esperienza di milioni di morti, gli Stati Uniti diano una prova vergognosa di quanto debole sia la barriera alzata contro i soprusi e le partigianerie. Non vedo come l’eccezionalità si possa dirigere verso schematismi di questo genere. Donde possiamo dirci sufficientemente certi della nostra precedente distinzione che la poneva contro la religione costituita. E la cosa non deve affatto meravigliare se si pone mente che uomini come Leibniz, Kant o Goethe sono stati considerati pagani. Purtroppo il momento attuale, malgrado il suo aspetto esteriore di libero pensiero, è tra i più restii a fare fermentare un’eccezionalità che fermamente si ponga contro la religione. E la verità di questa considerazione salta più chiaramente agli occhi se si getta uno sguardo alla nostra situazione. L’Italia è un paese cattolico e la religione cattolica è un mostruoso apparato di schemi e di assurdità, forse più che ogni altra religione. Pertanto parlare di argomenti di religione con quella libertà che da sola può trascendere la pericolosa manifestabilità del linguaggio non è sempre comodo. Eppure mai come ora è stato tanto necessario denunziare l’ignobile viltà di quanti, pure essendo uomini di cultura, restano abbarbicati a posizioni rituali anacronistiche per amore della tranquillità e del compromesso, quando non sia per amore dello stipendio o della carriera. Non si può restare uomini responsabili e continuare nel gioco alterno del conformismo sociale. Altri paesi hanno raggiunto una maturità di spirito e di problemi che dovrebbero farci invidia. Gli Inglesi trattano il problema religione-scienza alla ribalta della cronaca mentre in Italia esso resta sepolto nella migliore delle ipotesi nei libri di dottrina e di pensiero, che come si sa non vanno in mano a tutti. L’assurda imposizione dei dogmi (tra cui veramente straordinario quello dell’assunzione corporea della Madonna in Paradiso), il patetico ripetersi di vecchi motivi difesi strenuamente da quella pseudo-speculazione che è la teologia, il giornaliero arrampicarsi su terreni che per tanti secoli sono stati oggetto di desiderio non sempre saputo contenere, la tendenza anticulturale e antiprogressista nascosta con accortezza e tenacia dietro subdoli discorsi a doppia interpretazione, tutti motivi che dovrebbero riportarci alla vera realtà delle cose. La religione cattolica – e con essa in misura minore ma sempre sufficiente ogni altra religione – si riduce a rito, quindi a schema. Ora non avendosi l’esistenza di una organizzazione che si indirizzi all’autodistruzione, il rito non può sacrificare lo schematismo ma lo deve proteggere e consolidare. Speriamo che la buona volontà degli studiosi italiani saprà trovare la strada per svincolarsi da questa stagnante presenzialità cattolica. Lo stesso futuro dell’Italia, le sorti del nostro pensiero, il mantenimento della nostra tradizione anticlericale sono in gioco. Non ci resta che sperare in una schiettezza d’idee, sulla sostanza siamo sufficientemente certi.
Il terzo tipo di schema da esaminare è quello scientifico. Anche su di esso con il diffondersi delle idee positiviste è piombata l’ipoteca dell’assolutismo e del razionalismo. Da quasi quarant’anni siamo definitivamente usciti da questa ipoteca, sebbene in un certo senso ne stiamo ancora pagando gli interessi. Infatti il sogno utopista di un mondo regolato da leggi fisse e quindi prevedibili in base a un accertamento approfondito delle condizioni presenti, si è trasformato dopo le due scosse della teoria quantistica e della teoria dell’indeterminazione nel sogno della tecnica. Caduto lo schema scientifico del determinismo si è fatto posto per costruirne un altro, sebbene non si riesca del tutto a nascondere il grave passo che intercorre tra scienza e tecnica. La vera ricerca scientifica invece si è resa pienamente conto dell’indeterminismo della scienza e della necessità di evitare ogni illusione di grandezza e di dominio. Eppure anche se gli scienziati sono tutti d’accordo nell’attizzare le fiamme che distrussero la comica impalcatura delle infatuazioni ottocentesche, non sono parimenti d’accordo nel ridimensionamento dello sviluppo tecnico attuale. L’azione di una eccezionalità pertanto non riusciamo a vederla fuori di questa sfera d’azione. È troppo pietoso lo spettacolo giornaliero di scienziati che plaudono alle iniziative delle teorie indeterministe e contemporaneamente si riscaldano il cuore ai sogni futuristi della cibernetica e dell’elettronica. Evidentemente non è possibile stabilire con esattezza il limite di demarcazione tra scienza e tecnica. In questa sede possiamo dire che la tecnica si sostituisce alla scienza quando a quest’ultima viene a mancare la costituente d’incertezza generata dall’intervento diretto dell’osservatore e da tutta una serie di altre perturbazioni di ordine non sempre precisabile. Naturalmente questa mancanza può anche presentarsi come semplice affievolimento o come scarsezza di precisione nella misurazione o infine come indifferenza pratica alla rilevazione di queste perturbazioni. Una volta consentito il focalizzarsi di una tecnica, l’osservatore sposta l’azione della propria ricerca dal punto centrale, a cui prima era indirizzata, a quelli marginali che mirano a modificare sempre di più l’entità di perturbazione della ricerca stessa, agendo in questo modo allo scopo di pervenire a una perfezione operativa non conseguibile in sede scientifica. Da questo deriva che lo scienziato si sente autorizzato a credere nella determinabilità dell’opera a cui lavora, mentre non è più in grado di scorgere la differenza che corre tra l’analisi scientifica e il perfezionamento tecnico.
Riassumendo possiamo intravedere una linea continuativa di valutazione dell’eccezionalità. Innanzitutto ci appare chiaro come lo schematismo sociale si ponga in una sfera più disancorata da una scelta determinata di posizione, cosa che invece è possibile per la religione e la scienza. Ma non bisogna scordare che l’uomo, nel proporsi il problema religioso e quello scientifico, deve contemporaneamente proporsi quello sociale in quanto volendo mantenere una indifferenza assoluta finisce per affievolire le possibilità di risoluzione del problema religioso e per tagliare di netto le possibilità del problema scientifico. La figura del teologo o dello scienziato, tutti perduti nelle loro speculazioni e ricerche, oggi fanno un poco sorridere.
[1957] [“L’eccezionalità come problema sociale”, pubblicato su “Proserpina”, 1963, pp. 26-29 e pp. 42-47]
I pericoli dell’analogia nelle scienze sociali
Nella ricerca teorica si utilizzano princìpi e procedimenti che consentono una più o meno approssimata comprensione di quelle condizioni che reggono i fenomeni reali. Niente che giunga dall’esterno può fare variare il carattere teorico di questo tipo di ragionamento. Eppure la vita e la realtà non sono mai logiche, nel senso strettamente scientifico della parola. Sempre risultano come dati di fatto la cui ineliminabile presenzialità finisce per arrecare disturbo e confusione all’analisi teorica.
Ma la ricerca, lo sforzo della ragione diretto a superare l’ostacolo della conoscenza in armonia con la tecnica logica, non si esaurisce mai. L’uomo è consapevole della propria fallibilità e parzialità, per cui non smette mai di porre a riprova concreta le sue teorie. Da questo continuo lavoro di costruzione e revisione sorge la scienza.
Metodo deduttivo e metodo induttivo si equivalgono nel momento della focalizzazione tra teoria e realtà, tra dato che deve essere verificato teoricamente e teoria che deve essere verificata con le risultanze dell’osservazione.
Ed in questo lavoro la collaborazione tra i vari settori della ricerca è una delle condizioni essenziali del progresso e del miglioramento dei risultati. Siamo ormai molto lontani da quel desiderio di specializzazione, intesa come isolamento, per essere arrivati al concetto di cooperazione. Naturalmente nell’àmbito dei princìpi di ordine generale, che sarebbe assurdo mantenere nel ristretto àmbito di una sola branca scientifica, in quanto per il lavoro tecnico oggi meno di ieri ci si può scordare della specializzazione.
Le scienze sociali e la filosofa sono tra le più interessate alla collaborazione. L’economista, il sociologo, il filosofo non potranno mai essere degli specialisti. Trattando di ogni singolo problema, dovranno tenere conto dello svolgimento di quel problema nelle altre scienze, non mancando di inquadrarlo in un sistema generale che lo giustifichi e lo renda valido. Una specie di questa collaborazione è l’analogia.
Che cos’è l’analogia
L’analogia è un accorgimento metodologico il cui uso nella ricerca scientifica è del tutto naturale.
Questo accorgimento si fonda sul fatto che fenomeni, deducibili in linea logica direttamente o indirettamente da altri fenomeni e immessi in una ben identificata sintesi scientifica, chiariscono la formazione di altri fenomeni lasciando la possibilità all’osservatore di ricavare degli indici di comportamento. Ma quanto precede è incompleto. Bisogna tenere presente che la soluzione di un problema, nel suo vasto ed armonico complesso di proposizione, scelta, deduzione, induzione, esposizione e risultato, tiene conto di superare lo scoglio che si era prefisso, ma soltanto come prima analisi, in quanto ogni problema che non vuole essere fine a se stesso, mera esercitazione dottrinale, dove superare questo stadio immediato e ripresentarsi col proprio contributo alla formazione di un problema più vasto, di respiro talmente ampio da superare il più delle volte gli interessi di una modificazione nel nostro precedente concetto di analogia.
Lo studioso può porre la propria attenzione sul problema base stabilendo raccordi analogici col problema che viene trattando e utilizzando la soluzione del primo problema come soluzione del secondo, oppure può lasciarsi affascinare dalla prospettiva teleologica del problema base e utilizzarla come soluzione del proprio problema.
Ad esempio, le difficoltà incontrate in fisica nella determinazione della posizione di un elettrone hanno condotto al principio d’indeterminazione, soluzione di quel problema particolare ma contemporaneamente contributo a un problema d’indole più vasta, quello concernente l’impossibilità di conoscere specificatamente il presente.
Non è nemmeno il caso di insistere che il merito e l’importanza di questo principio sono stati valutati, e ancora di più lo saranno in seguito, sul metro del contributo al problema successivo più che sul metro della soluzione del problema precedente.
Da quanto precede risultano evidenti due tipi di analogia, quella esterna o di puro rivestimento e quella interna o sostanziale.
L’impostazione filosofica dell’analogia
Nel presente lavoro la trattazione dell’analogia è posta su di un piano molto vicino alla realtà, così come entra di volta in volta nei casi di applicazione dell’economia e della sociologia, nei limiti della definizione che dell’analogia stessa abbiamo dato. Ma il problema va posto pure sul piano filosofico. In questo infatti viene spesso associato e confuso con l’altro molto più pregnante e difficoltoso di causa ed effetto. Dai difetti e dalle imprecisioni nella elaborazione di quest’ultimo, unitamente alle sue intrinseche limitazioni, scaturiscono situazioni paradossali in alcune scienze, specie alla luce dei profondi rivolgimenti che oggi ci pervengono dalla epistemologia.
In Kant il problema si pone in modo generico diretto a realizzare un’armonia vastissima di concatenazioni logiche. “Analogie della esperienza, il principio di esse è l’esperienza possibile solo mediante la rappresentazione di una connessione necessaria delle percezioni”.
Ai nostri giorni la categoria della relazione ha posto avanti le sue pretese. Scegliamo la concezione di Enzo Paci, tra le tante che più o meno sembrano equivalersi: “La necessità dell’irreversibile non implica la necessità di svolgimento verso una data nuova totalità che dipenda dalla prima come un effetto necessariamente dipendente dalla sua causa. Inteso in tal modo il rapporto di causa ed effetto si risolve in identità. Se nell’evento c’è sempre qualcosa di emergente, vuol dire che nel cosiddetto effetto c’è sempre qualcosa di nuovo rispetto alla cosiddetta causa”. Questo potrebbe chiarirci il motivo del presentarsi della prospettiva teleologica e potrebbe nello stesso tempo giustificare l’applicazione dell’analogia anche al di là di una stretta rispondenza dei termini formali del problema.
In effetti le conclusioni non sono così rosee. La prospettiva teleologica se esiste esiste per una utilizzabilità intrinseca della formula risolutiva del problema o della soluzione stessa, non perché dall’esterno ci giunge un canone metodologico che la crea o ce la indica di volta in volta. Nell’affermare che nel cosiddetto effetto c’è sempre qualcosa di nuovo rispetto alla cosiddetta causa, è implicito il riconoscimento di una possibilità parziale di conoscimento dell’effetto, possibilità parziale che ci fa apparire diverso l’effetto dalla causa ma che non ci prova affatto l’esistenza di questa diversità al di là della limitatezza dei nostri mezzi conoscitivi. Cade quindi anche l’altra illusione di un’applicazione dell’analogia fuori dalla stretta rispondenza dei termini formali del problema.
In altri termini anche al cadere completo della legge di causa ed effetto non consegue necessariamente una più libera utilizzazione delle analogie. Esse diventano legittime solo davanti a una piena rispondenza dei due estremi del raffronto analogico, mentre l’impiego della prospettiva teleologica diventa legittimo soltanto quando si abbia una cosciente visione della nuova prospettiva teleologica e quando le due prospettive possono assumere piena rispondenza.
Alcuni parlano dell’affinità dei campi di appartenenza dei problemi posti a confronto sostenendo che più essi sono affini, più l’analogia assume significato e valore dimostrativo. Questa tesi, sostenuta tra gli altri anche da Corrado Gini, manca del presupposto da noi ammesso in precedenza della possibilità di utilizzazione della prospettiva teleologica. Se ci si ferma all’esame scheletrico della soluzione (apparente) del problema base, allora non si può fare a meno di concordare con questi studiosi che l’affinità dei campi di applicazione comporta un miglioramento della utilizzazione e dei risultati. Ma tenendo presente la prospettiva teleologica si deve ammettere che un’analogia si può porre anche tra problemi quanto mai disparati e ciononostante dare ottimi frutti se le due prospettive teleologiche, quella del problema base e quella del nuovo problema, assumono piena rispondenza.
I pericoli dell’analogia
C’è un passo del Cours di Vilfredo Pareto che meriterebbe maggiore attenzione di quanta crediamo non abbia ricevuto fino a oggi. È dedicato ai pericoli di una inesatta utilizzazione delle analogie. “Nei ragionamenti per analogia vi ha però uno scoglio che importa evitare. Il loro impiego è legittimo fin che si tratta solo di delucidare il senso di una proposizione, tali ragionamenti potrebbero però fare incorrere in gravi errori se si pretendesse valersene per dimostrare la proposizione stessa o soltanto per stabilire una presunzione in suo favore. Gli esempi, le analogie, devono servire soltanto a far ben comprendere l’enunciato di una proposizione. Compreso che si sia bene il senso di tale enunciato, solo i fatti, esclusivamente i fatti valgono a decidere se la proposizione stessa è vera o erronea”.
Vedremo tra poco come lo stesso Pareto abbia tenuto poco conto di queste sue prudenti parole. Per adesso ci occorre schematizzare due categorie di pericoli:
1) Pericolo di difettosa impostazione del problema, presente solo nel caso d’impiego dell’analogia esterna.
2) Pericolo di attuazione di una prospettiva teleologica non adatta, presente solo nel caso d’impiego dell’analogia interna o sostanziale.
È facile accorgersi della differente entità dei due pericoli che precedono. Il primo ha un campo d’azione abbastanza modesto, non andando al di là dell’àmbito del problema imposto in forma analogica. Nel pieno della sua recrudescenza non può causare che una soluzione errata per difetto metodologico. Il secondo invece assume entità più ampie. Il problema che viene impostato in forma analogica può ricevere una soluzione esatta e risultare lo stesso del tutto falso nel momento del suo presentarsi come problema di un contesto più vasto, e ciò nel momento dell’innesto di quella prospettiva teleologica che risulta al contrario difettosa o non adatta.
L’analogia esterna
Sterminato il campo d’indagine relativo alle analogie esterne. Esempi classici, ma che non possiamo prendere in considerazione in questa sede, come l’Etica di Spinoza, ci consentono di valutare l’analogia esterna come uno degli strumenti metodologici più usati nella storia della cultura, sebbene non ci possono illuminare sull’utilità del loro impiego.
In armonia con i limiti del presente lavoro, che si riferisce a problemi di scienza sociale, tratteremo in modo più esauriente di alcune analogie esterne adottate da economisti.
Nella Patologia Economica di Corrado Gini (V ed., Torino 1954), il lavoro si svolge su di un terreno strettamente canonico della dottrina economica, o per lo meno tale ci sembra oggi se nel 1924 Luigi Amoroso considerava quest’opera come una “economia non euclidea”.
Il parallelo è posto tra organismo e società e si sviluppa attraverso la loro possibilità di raggiungere e mantenere un equilibrio. Da ciò l’esame dei vari tipi di equilibrio e della facoltà di autoriequilibrazione con particolare riguardo all’equilibrio dinamico, caratteristico per l’appunto dell’organismo e della concezione economica di Gini. Conseguentemente un rifiuto dell’analogia con la meccanica perché strettamente legata ai concetti di statica (cfr. pp. 96-97).
Viene poi introdotto il concetto di patologia economica (pp. 99-100). «Ora l’Economia politica tradizionale considera di preferenza se non esclusivamente le condizioni normali della società che si possono mantenere indefinitamente, e questa tendenza si è manifestata come abbiamo visto anche nella teoria della crisi che si è gradualmente trasformata nella teoria dei cicli economici. L’Economia politica tradizionale consiste dunque propriamente in una Fisiologia economica, e da tale punta di vista si contrappone a quella parte che è in formazione dell’Economia politica, la quale studia la struttura e il funzionamento della società economica nei periodi di squilibrio, nonché le cause di tali squilibri e che noi chiamiamo Patologia economica». (Ib., p. 100).
Il resto è un comune trattato di economia con particolare riguardo ai meccanismi di autoriequilibrazione, all’inflazione e ai suoi correttivi, alla speculazione in periodi anormali, ai calmieri, all’equilibrio dei cambi, al commercio internazionale controllato, alla disoccupazione, ecc.
La stessa distinzione tra analogia descrittiva e analogia euristica (pp. 57-77) non consente a Gini di utilizzare lo strumento metodologico di cui entra in possesso in tutte le sue possibilità d’impiego. Egli precisa: «Perché l’analogia organicista possa avere un valore euristico bisogna cominciare col ricercare quali sono le caratteristiche essenziali dell’organismo e verificare poi se esse si riscontrano nella società» (ib., p. 77), ma non si accorge della necessità che un’analogia per dirsi euristica (o interna come abbiamo proposto noi) debba agire sul problema a cui viene rapportata, ed agire nel senso di consentire un innesto della prospettiva teleologica, indipendentemente da uno svolgimento determinato sul medesimo schema analogico.
Partendo dall’ipotesi dell’equilibrio economico e rapportandola all’equilibrio organico, non si è costituita che una semplice analogia esteriore. Viceversa sarebbe stata una vera analogia sostanziale (o euristica) se non si fosse partiti dall’ipotesi dell’equilibrio ma da una serie di fenomeni necessitanti di una loro regola logica, e per la costruzione di quest’ultima (poniamo lo stesso equilibrio) si utilizzasse per l’appunto l’equilibrio organico.
Altro esempio di analogia esterna ci è dato da Luigi Amoroso nel volume Le leggi naturali dell’Economia Politica (Torino 1961). Questo studioso pone un’analogia tra la vita economica e lo svolgimento di un dramma per cui parla di un vero e proprio dramma economico. Retroscena sono le pareti domestiche, scena il mercato, attori sono l’imprenditore, il proprietario, il prestatore di capitali, il prestatore d’opera, il consumatore. Quello che manca è il copione in quanto le varie scene vengono recitate creandole direttamente, sull’unica trama del «criterio di ricavare nei limiti delle possibilità la massima soddisfazione» (p. 15). Non manca invece la critica data dai giornali quotidiani, riviste, opere letterarie e scientifiche, cattedre universitarie, tribune parlamentari, ecc. (p. 19).
Anche in questo caso l’analogia costituisce una sovrastruttura pesante e inutile che comunque viene ad essere posta in atto dall’autore per motivi estranei al proprio fondamento metodologico di ricerca. Ben diversa sarebbe stata la situazione se Amoroso si fosse servito della sua analogia per sottolineare una eventuale drammaticità nell’andamento del fenomeno economico, o ancora di più se avesse fatto dipendere lo svolgimento dello stesso da quell’imprevedibilità che è tipica delle azioni umane legate ai sentimenti. Ora non potendosi presumere che le leggi economiche si stabiliscano sul sentimento, anziché sulla ragione, se ne desume che l’analogia sopra esaminata ha solo un valore descrittivo, servendo da semplice guida alla trattazione del problema.
La tendenza a utilizzare analogie del genere, specie meccaniche o biologiche, è diffusissima negli scrittori di economia e sociologia. Essa si mantiene in genere nei limiti dell’analogia esterna, diventando il più delle volte un atteggiamento e una moda, per altro ormai in disuso. Non mette conto produrre parecchi esempi, per cui ci limiteremo all’analogia proposta da Alfred Marshall. Nella Prefazione alla VIII edizione dei Principles si legge: «La Mecca dell’economista sta piuttosto nella biologia economica che nella dinamica economica. Ma i concetti biologici sono più complessi di quelli della meccanica, un volume sui fondamenti deve dare quindi un posto relativamente largo alle analogie meccaniche e sarà fatto uso frequentemente della parola “equilibrio”, che suggerisce qualcosa di un’analogia statica». Come a suo tempo aveva fatto John Stuart Mill l’autorità di queste analogie viene accettata e proposta come un fatto assolutamente esterno. E ciò appare ancora più chiaro nella Appendice C dove Marshall si intrattiene sul metodo in economia, in fisica e in biologia. L’analogia meccanica viene svalutata come rappresentante massima del metodo deduttivo, come pure l’analogia chimica. La prima perché in economia gli elementi non si combinano con quella semplice regolarità caratteristica della meccanica, la seconda perché in economia la materia di trattazione varia continuamente nel tempo e non rimane sempre identica come in chimica. Né il fatto che il chimico quando tratta creature vive è spesso costretto ad avventurarsi in terreni non corroborati dalla teoria per sviluppare esperimenti che si possono tradurre in risultati imprevedibili può giovare all’utilizzazione di questa analogia. La storia di alcuni fenomeni economici, come la lotta sindacale o il credito, ecc., ci insegna che identiche misure hanno dato risultati differenti in situazioni contingenti diverse. Marshall si avventura in spiegazioni tortuose di questo fenomeno dimenticando l’essenza intima della storia e sognando di una teoria assoluta disturbata soltanto da forze agenti in senso contrario e più o meno difficilmente determinabili. Comunque il senso dell’analogia chimica è ben lungi dal rendere valido il problema proposto da Marshall, tanto da sembrare estraneo e superfluo. Resta l’analogia biologica che in ogni caso non viene usata in modo ortodosso. Marshall dice: «Per il nostro scopo attuale è più importante l’elasticità della razza che quella dell’individuo. È vero che il carattere individuale cambia in parte in modo apparentemente arbitrario e in parte secondo regole ben note. È vero ad esempio che l’età media degli operai impiegati in un conflitto del lavoro è un elemento importante per ogni previsione sulla sorte di questo conflitto, ma siccome generalmente parlando giovani e vecchi, temperamenti emotivi e temperamenti epatici, si trovano pressoché nella stessa proporzione in tutti i luoghi ed in tutti i tempi, così le peculiarità individuali e i mutamenti del carattere oppongono all’applicazione generale del metodo deduttivo un ostacolo meno grave di quello che a prima vista appaia. Così mediante una paziente interrogazione della natura e mediante il progresso dell’analisi si portano sotto il dominio della legge nuovi campi, sia nella terapeutica che nell’economia, e va diventando possibile qualche sorta di previsione indipendente dall’esperienza specifica sull’azione separata o congiunta di un numero sempre maggiore di fattori». Indiscussamente qui non è l’analogia biologica a produrre questa conclusione cauta e azzardata nello stesso tempo. La biologia gioca un ruolo importante ma non un ruolo analogico. Ed è questo il motivo per cui abbiamo considerato questo passo di Marshall come facente parte dei contributi alle analogie esterne. Non è nemmeno l’elemento teleologico a produrre un simile risultato, in quanto non è caratteristica della biologia la determinabilità prospettica degli sviluppi teorici dei presupposti attuali e non lo era nemmeno ai tempi di Marshall. Più semplicemente si ha una trasposizione del problema economico in biologia. Qualcosa che oggi molto più appropriatamente la psicologia o meglio il behaviorismo ha fatto proprio. Naturalmente Marshall non perviene a questo livello di chiarificazione cosciente, per lui si tratta di problemi che si pongono via via e dei quali intravede una soluzione attraverso il fascinoso mondo della biologia.
Prima di concludere questo paragrafo sull’analogia esterna desideriamo accennare all’analogia proposta da Pasquale Jannaccone all’inizio del suo lavoro ormai classico sul Costo di produzione: «Una teoria scientifica, cioè un gruppo organico d’idee intorno a un dato soggetto, si forma con processo non dissimile da quello che seguono nella loro formazione i corpi viventi. In principio sta un nucleo, un’idea vaga, spesso nascosta nelle convoluzioni d’una dottrina preesistente la quale a poco a poco si va poi evolvendo e differenziando. A un punto appaiono, sulla massa informe dell’idea primitiva, i visibili segni di una distinzione di parti». L’analogia di Jannaccone si pone in un problema metodologico, anzi sul problema essenziale della metodologia, il processo di formazione di una teoria logicamente valida. Eppure resta lo stesso all’esterno. L’induzione e la deduzione operano nel modo consueto che soltanto in parte somiglia alla formazione degli organismi viventi, tanto è vero che Jannaccone a un certo punto vede necessario duplicare l’analogia e ricorrere alla formazione non più naturale ma artificiale, cioè alla produzione.
Potrebbe essere interessante notare che l’idea precedente avrebbe assunto aspetti e sviluppi notevolmente diversi se l’analogia avesse estrinsecato i suoi effetti all’interno. Ad esempio non è chiaro come compaiono sul nucleo primitivo i segni di qualche cosa di differente, cioè se appaiono per effetto di qualche forza intrinseca al nucleo stesso o per l’influsso proveniente da un’azione esterna di agenti estranei. Limitarsi ad asserire che a un certo momento appaiono differenziazioni nel nucleo dell’idea originaria basterebbe in una fase semplicemente descrittiva del fenomeno, successivamente occorre rendersi conto delle cause del processo logico onde non incorrere in errori di valutazione imputabili alla difettosa impostazione di partenza. In questo modo l’analogia non produce azione alcuna sul problema a cui viene rapportata, costituendo solo un appesantimento.
L’analogia interna: i dubbi di Pareto
Abbiamo visto prima come Pareto avesse coscienza dei pericoli dell’analogia. Ciò non toglie che nella stessa pagina da noi citata s’ingegni a produrre una elaborata analogia tra fenomeno meccanico e sociale, curando ovviamente che “le analogie non valgano come dimostrazione d’alcun genere. Valgano solo a chiarire certe concezioni che dovranno poi essere sottoposte al vaglio dell’esperienza”.
Ma i dubbi che a lui provenivano dallo stato embrionale delle teorie walrasiane, dubbi che matureranno dopo il 1897 nel Sunto di alcuni capitoli di un nuovo trattato di economia pura e che culmineranno nel Manuale, lo costringono ad accettare la meravigliosa occasione di un sostegno quanto mai valido sia alla teoria dell’equilibrio come a quella della dinamica economica. È il determinismo scientifico nella sua più schietta manifestazione concreta, quella della meccanica, che gli mette nelle mani gli strumenti per un’analogia pericolosa. Infatti quelle poche impostazioni non mirano altro che a gettare le basi di un determinismo economico, con cui ancora oggi l’economia continua a baloccarsi.
Eccoci ai postulati deterministi. L’esame della produzione e dello scambio deve fondarsi sull’astrazione di tutte le altre circostanze, così come si studia l’equilibrio ed il movimento dei corpi, facendo astrazione delle altre loro proprietà. Si configura la sintesi concreta delle forze economiche nell’ideale homo economicus, così come in meccanica dai punti e dai rapporti si costruisce la scienza dell’equilibrio e del movimento, cioè la meccanica razionale. L’economia applicata considera l’azione di esseri che assomigliano più da vicino alla realtà, così come in meccanica l’esame dei corpi elastici, degli attriti, ecc., costruisce quel ramo della meccanica che prende il nome di meccanica applicata.
Eppure questo materiale non riesce a convincerlo, la sua stessa posizione nella polemica con Croce sul “Principio economico” non risulta chiara nel suo volere essere fin troppo chiara. Difatti ha buon gioco Croce sostenendo la natura non meccanica del principio economico: “…nel fatto economico si nota un carattere che ripugna affatto a quello meccanico. Al fatto economico sono applicabili parole che suonano approvazione o disapprovazione. L’uomo si conduce economicamente bene o male, con vantaggio o con. danno, con convenienza o senza convenienza, si conduce insomma economicamente o antieconomicamente. Il fatto economico è perciò fatto di valutazione (positiva o negativa) laddove il fatto meccanico è concepito come mero fatto bruto, cui non si possono attribuire aggettivi di lode o di biasimo, se non per metafora”.
In definitiva si può parlare di un dualismo. In Pareto è possibile scoprire contemporaneamente la certezza che “…la scienza non ha dogmi quindi non può e non deve ammettere a priori il determinismo” e la necessità di dare ordine e senso allo studio economico rapportandolo ai canoni fino a quel momento ben poco discussi della meccanica. Più tardi (1917) manifesterà ufficialmente il bisogno “…di ricercare la realtà sperimentale applicando alle scienze sociali i metodi impiegati nella fisica, nella chimica, nell’astronomia, nella biologia e in altre scienze analoghe”, ma il gran passo dalla economia alla sociologia era stato di già compiuto.
Con questo cambiamento d’indirizzo speculativo si allarga il campo d’impiego delle analogie. Il terreno su cui si trova a lavorare è troppo mobile e in via di formazione. La sociologia non presentava allora, come per alcuni punti non presenta nemmeno adesso, quella forma metodologicamente definitiva che invece era tipica dell’economia politica. Da ciò la necessità per Pareto di intensificare quelle testimonianze che gli erano state utili in economia, accettando anche quella della biologia, che lo vedevano piuttosto dubbioso all’epoca del Cours (Libro II, p. 30).
Ed è proprio in dipendenza di questa definitiva impostazione sociologica della sua teoria economica che non pervenne mai a una conclusiva chiarificazione sul rifiuto o sulla accettazione della tesi determinista avanzata con l’analogia meccanica. Se Pareto fosse rimasto soltanto un economista, l’uso successivo delle analogie biologiche, chimiche, fisiche, ecc., avrebbe finito per rendere paradossale la falsa compattezza dell’analogia meccanica. Invece l’uso di queste analogie in sociologia ottenne soltanto l’effetto di sostenere metodologicamente una scienza che ancora non riusciva a trovare la propria strada di ricerca.
L’analogia interna: biologia e razzismo
Nella ricerca scientifica il ricorso all’analogia organica costituisce un accorgimento metodologico del tutto naturale. Nelle scienze sociali le teorie filosofiche vengono usate di frequente per giustificare il fondamento strutturale della ricerca, si può dire con la stessa frequenza con cui vengono impiegati almeno da una certa categoria di studiosi le analogie meccaniche.
Uno degli esempi più evidenti dei pericoli di degenerazione logica cui può condurre un impiego sconsiderato dell’analogia interna, in questo caso dell’analogia organica, è dato dagli sviluppi della teoria della razza così come è stata formulata da Joseph-Arthur de Gobineau e dai successivi ideologi nazisti.
In realtà bisognerebbe risalire nientemeno che a Menenio Agrippa e al suo apologo per averne il primo esempio. Successivamente è possibile notare in Edmund Burke il germe di uno sviluppo dinamico dell’analogia organica, ma è nei princìpi ideologici della nuova classe borghese, nata dopo la rivoluzione francese, che è possibile scorgere una prima definitiva teoria della razza.
Con Gobineau si fonda chiaramente l’idea della fondamentale ineguaglianza degli uomini e della fatale decadenza della civiltà a causa della mescolanza delle razze, ma non in forma parascientifica come accadrà più tardi nei successori (Houston Stewart Chamberlain, Hitler, Alfred Rosenberg, ecc.). Comunque Gobineau resta legato a una analogia organica del tutto superficiale. Il suo rifacimento della storia universale è puramente intuitivo e irrazionale, specialmente nei punti dove spaccia per provati e certi quei passaggi e quegli anelli di congiunzione che non sono affatto provati e certi. E questo sarà il punto che maggiormente verrà attaccato dagli studiosi successivi della teoria della razza.
Ma la forma mistica ed ispirata dell’opera di Gobineau non avrebbe potuto avere una grande influenza sullo spirito europeo, così permeato di scientificità positivista. Infatti il Saggio sulla ineguaglianza delle razze venne passato sotto silenzio in Francia, mentre suscitava notevole interesse negli Stati Uniti del Sud, dove incontrava appunto un terreno adatto nella mentalità dei grandi piantatori schiavisti.
La definitiva veste scientifica, la teoria della razza la ricevette dall’incontro con il darwinismo. In effetti alla base di questa fusione è da porsi il distacco intervenuto tra economia e sociologia. La prima, differenziatasi dalla corrente classica, sosteneva le dottrine dell’armonia, la seconda, necessitando di un fondamento metodologico, venuto meno quello che in precedenza le era fornito dall’economia, si rivolgeva alla biologia.
Va da sé che questa ripartizione non ha soltanto delle giustificazioni metodologiche, l’economia si stacca dalla corrente classica per un netto rifiuto dell’apriorismo schematico di quest’ultima, mentre la sociologia si stacca dall’economia per una pretesa di obiettività delle sue leggi e per una illusione determinista che la conduce sempre di più verso i canoni tipici delle scienze naturali.
Ma i risultati concreti furono diversi dalle speranze. La dottrina dell’armonia si trovò presto a mal partito insieme alla dottrina dello sviluppo organico, pretesa della sociologia biologica nel fare fronte alle contraddizioni sempre più gravi del capitalismo e alla lotta di classe.
Ora questa posizione negativa poteva essere superata soltanto irrazionalmente, utilizzando non come punto di arrivo ma come base le stesse contraddizioni del capitalismo e la stessa ineguaglianza delle classi. Per fare ciò si rese necessaria una modificazione considerevole delle teorie darwiniane, il tutto si ridusse a una semplice formula, a uno slogan: “struggle for life”.
È in questo clima che sorge e si afferma l’opera di Nietzsche, sebbene non possa ricondursi nettamente alle trame ideologiche che abbiamo tracciato. In certi punti della sua opera si notano analogie biologiche, per quanto non si sollevino mai dall’atmosfera del mito, comunque è importante indicare che esse servirono a consolidare la contingenza che stava alla base dei pretesti intellettuali della nuova classe dirigente. Nietzsche combatte le dottrine materialiste in uno con le dottrine spiritualiste contrapponendovi una teoria biologico-nichilista.
A questo punto ci appaiono due motivi chiave della teoria della razza, così come venne diffusa nella Germania nazista. Da un canto l’autorità di Nietzsche, il suo posto solitario nella storia del pensiero filosofico, l’originalità della sua figura, dall’altro la scomparsa in sociologia di ogni sorta di categorie, così care ai neokantiani, e la nascita della lotta fra le razze. L’ineguaglianza, l’oppressione, lo sfruttamento, diventano “fatti naturali”, ineliminabili. Da ciò le gravi mancanze del sistema capitalista risultano del tutto naturali.
Su questo terreno si diffusero le idee di un inglese nazionalizzato tedesco e di suo suocero Richard Wagner. È il mito dell’arianesimo. Ma l’espressione più chiara di questo estremo irrazionalismo, il massimo compimento d’una intellettualità preconcetta e maligna si ha nel Mein Kampf di Hitler. Al di là di questi fondamenti teorici, la vecchia analogia organica produrrà soltanto sadismo e sangue.
Quest’ultima fase della teoria nazista della razza si può così riassumere: primo, ogni progresso sociale si concretizza attraverso una “lotta per la vita” in cui i più capaci emergono mentre i deboli vengono eliminati. Questa lotta avviene all’interno di una razza dando vita a una élite naturale. Secondo, la commistione di più razze causa una degenere ibridazione, ma questa fase deleteria può superarsi con una eliminazione degli ibridi. Terzo, tutte le maggiori civiltà e le più alte manifestazioni della cultura, pur potendo appartenere a razze diverse, sono l’espressione di una sola razza superiore. Da questo punto di vista le razze si dividono in razze creatrici di cultura, come la razza ariana, razze portatrici di cultura, che la possono trasmettere ma non creare, razze distruttrici di cultura, come la razza ebraica.
Concludendo possiamo dire che la teoria della razza deve il suo sviluppo, così tragicamente concluso, alla prospettiva teleologica fornita dall’analogia organica.
[1963] [“I pericoli dell’analogia nelle scienze sociali”, pubblicato su “Quaderni di cultura contemporanea”, 1968, pp. 47-61]
Il linguaggio e gli aspetti sociali della comunicazione
Uno degli aspetti più interessanti della moderna psicologia sociale è l’esame della possibilità di comunicazione fra gli individui. Ovviamente questo problema assume aspetti differenti a seguito di differenti composizioni sociali. In comunità fondate su rigide stratificazioni tale possibilità è diversa di quella riscontrabile in comunità con gerarchie meno rigide.
È regola generale che la comunicazione tra appartenenti a una comunità sociale avvenga in base a schemi fissi, nati per garantire la sopravvivenza della comunità stessa e quindi incapaci di avvertire il movente privato al di là di una astratta idea di benessere medio.
L’uomo singolo acconsente allo schema perché unità sociale, ma come unità psicologica è in grado di valutare criticamente i lati positivi e quelli negativi, se non in vista del troppo largo orizzonte della comunità per lo meno in relazione ai propri personali bisogni. Per altro il singolo inserito in una collettività priva di schemi è semplice utopia. Se mancano gli schemi della collaborazione, esisteranno quelli della forza e del terrore. La libertà assoluta come il nulla è un semplice concetto metafisico.
Pertanto abbiamo sempre la necessità da parte del singolo della revisione degli schemi collettivi, necessità che si ripresenta sempre anche nei casi di stratificazioni sociali meno rigide.
Da quanto precede risulta chiara la tendenza “antisociale” dell’uomo, appunto perché la revisione degli schemi viene condotta al fine di sviluppare le condizioni necessarie all’avvantaggiarsi della singola personalità sul resto amorfo della comunità.
Vediamo adesso come avviene l’inserimento della personalità del singolo nello schematismo della collettività. Il processo nella sua complessa articolazione non riesce a nascondere una grave antisocialità di carattere generale, tanto più elevata quanto più rigido è lo schema da rivoluzionare. Lo strumento utilizzato per operare questa modificazione, che può considerarsi il fondamento unico di tutto il processo, è il linguaggio. Solo attraverso il linguaggio viene rotta l’unità del singolo, trascendendo l’aspetto solipsista per arrivare a una istanza psicologica e filosofica di valore universale.
Ma il linguaggio manifesta immediatamente difetti grandissimi che lo rendono difficilmente utilizzabile in modo perfetto per la soluzione di problemi di rottura sociale.
In linea teorica tutto questo non dovrebbe assumere l’aspetto dell’avventura fantastica e senza eccessive speranze. L’inserimento di una proposizione di rottura dovrebbe costituire la normale strada da seguire per giungere a una tranquilla e progressiva sostituzione degli schemi. Anzi sarebbe auspicabile un’organizzazione “ufficiale” di revisione degli schemi sociali, alla quale una eventuale rottura dovuta al singolo possa giungere normalmente, essere ricevuta, catalogata e valutata nella efficienza del suo contenuto, per essere al momento opportuno reperita insieme ai risultati di altre rotture.
Tutto questo non avviene per svariati motivi d’indole contingente e per un motivo – fondamentale – d’indole tecnica. I primi costituiscono difetti, quando che sia superabili, il più delle volte dovuti all’impossibilità di reperire in tempo – cioè prima che diventino automaticamente superati – tutte le proposizioni di rottura. In questo senso bisognerebbe prestare maggiore attenzione a quanto hanno fatto i governi totalitari a stratificazione rigida per i quali è questione essenziale non lasciarsi sfuggire nessuna delle proposizioni di rottura. Continuare su quella strada non per stroncare le varie proposizioni di rottura ma per tenerle presenti per operare una migliore e progressiva revisione degli schemi è la soluzione più appropriata.
Il motivo d’indole tecnica è inerente al linguaggio, in quanto mezzo di comunicazione. L’esame del linguaggio è uno dei più importanti punti di partenza di ogni filosofia.
Il linguaggio di estrinsecazione, cioè il linguaggio con cui l’uomo cerca di penetrare nello schema per operarne la rottura in senso antisocialmente utile, si contrappone al linguaggio di manifestazione, cioè il linguaggio con cui l’uomo elabora una esposizione dello schema utilizzabile in senso socialmente utile. Infine è il linguaggio della logica che procede oltre, verso la costruzione d’una nuova misura e d’una migliore realtà.
[1966] [“Il linguaggio e gli aspetti sociali della comunicazione”, pubblicato su “Quaderni di cultura contemporanea”, 1968, pp. 12-14]
Nota redatta nell’agosto 1968
Gli avvenimenti di quest’anno ci dovrebbero fare riflettere profondamente. Che cosa ci attendiamo dal futuro? Perché l’esperienza francese e la cosiddetta contestazione ci portano davanti a problemi per noi quasi sconosciuti? Qual è veramente il rapporto tra situazione personale e situazione collettiva?
Un’analisi del mio lavoro di ricerca, arrestandosi poniamo al 1966, anno in cui portai a compimento gli studi sul pensiero economico antico, non può dirsi certo in grado di rispondere a queste domande.
Rileggendo ancora quei risultati, in particolare il saggio che li riassume, pubblicato sulla rivista “Il Dialogo” e sulla rivista “Labor”, mi chiedo che cosa significano. Sono partito alla ricerca delle leggi dell’economia, leggi che dovevano trovarsi anche nel mondo antico e nella teorizzazione sui fatti economici che esso seppe produrre. Che cosa ho ottenuto? Un fallimento. Quelle leggi non le ho trovate, ho trovato spunti similari, scritti che potevano fare pensare a teoremi (come ad esempio un passo di Aristofane e il teorema di Gresham), ma in sostanza quella continuità che cercavo non l’ho trovata. Non l’ho trovata perché essa non esiste e quindi non potevo trovarla.
Ho invece trovato le origini di una illusione, l’illusione borghese dell’eternità dell’economia e delle sue leggi, che poi dovrebbe risultare qualche cosa di simile all’eternità del capitalismo e delle sue leggi di sfruttamento.
Tutti questi lavori sono stati pubblicati in massima parte su “Studi e ricerche”, la rivista da me diretta, mentre qualcuno è uscito su altre riviste come “Essere”.
Accanto a questo lavoro, per me centrale, ho sviluppato altre ricerche derivanti dalla mia duplice lettura di Hegel e Marx. Esse sono uscite sulla Rivista “Proserpina” e riguardano il rapporto tra padrone e servo e il concetto del lavoro alienante.
La lettura di Marx per la verità mi è risultata molto ostica. Non sono d’accordo con alcune sue formulazioni, come ad esempio quella relativa alla dialettica e alle sue leggi, ma mi sembra che le vecchie critiche di Pareto non si possano accettare in blocco. Certo molto ebbe a influire su Pareto la scarsa conoscenza, da lui stesso vantata (sic!), del pensiero di Marx.
In definitiva quello che ha attirato la mia attenzione è l’alienazione dell’uomo determinata dal lavoro. Questo processo di reificazione che finisce per distruggere le qualità essenziali dell’individuo: intelletto e libertà.
Ho cercato, specie nei saggi pubblicati su “Proserpina”, di dare conto di esperienze di carattere personale derivanti dalla mia stessa vita, dai miei lunghi anni di lavoro presso un istituto di credito, lavoro allucinante e terribile che ha duramente segnato la mia capacità di resistenza alla lotta spirituale. Fortunatamente adesso, da quasi due anni, ho lasciato quell’orribile lavoro per un altro altrettanto orribile ma almeno più leggero, la direzione di una media industria. In questa mia nuova attività mi trovo davanti a problemi diversi, forse più gravi ma che almeno non intaccano direttamente il mio fisico. Forse non potrò resistere a lungo nemmeno a queste condizioni di lavoro, per altri gradevolissime, ma spero di durare il più possibile. Sicuramente la posizione di comando non è fatta per me.
Ho come programma di lavoro immediato una breve trattazione del problema della violenza rivoluzionaria, uno scritto che non voglio assuma aspetti dottrinali ma quelli di una semplice discussione tra amici. Per questo motivo ho pensato di scriverlo in ufficio approfittando del fatto che mi trovo in una stanza da solo (per la prima volta nella mia vita lavorativa) e quindi ho un poco di pace. Non consulterò nessun libro o roba del genere.
Fino ad oggi il lavoro più importante mi sembra quella ricerca sui pericoli dell’analogia biologica nelle scienze sociali, preparata in vista di un lavoro più ampio di metodologia socioeconomica da farsi sempre per l’Università di Catania, Facoltà di Economia e Commercio. In essa appaiono chiare le interpretazioni del vitalismo in senso negativo, con riferimento alla linea Cassirer-Lukács della Storia della filosofia moderna e della Distruzione della ragione. Non è da sottovalutare la grande influenza che la lettura di quest’ultima opera di filosofia ha avuto su di me, fino dal 1959, proprio nel momento in cui mi andavo liberando della problematica esistenzialista che avevo recepito quasi totalmente all’Università di Torino.
Certo è stato assai difficile segnare una linea chiara di demarcazione tra le mie vecchie preoccupazioni filosofiche, sviluppate ad esempio intorno agli anni 1958-1959 in una trentina di articoli sull’esistenzialismo pubblicati dal “Corriere di Sicilia”, preoccupazioni coagulatesi in parte nel libro I fondamenti di una teoria filosofica dell’indeterminazione, apparso quest’anno ma riproducente ricerche vecchie ormai di quasi un decennio e le mie nuove prospettive di intensificazione della ricerca nel campo dei problemi sociali. È per questo che adesso, fra le tante cose scritte, mi sembrano così poche e insignificanti le cose riguardanti la problematica sociale. Sono sicuro che in futuro il rapporto sarà fortemente diverso.
PARTE SECONDA (1966-1969)
Sull’organizzazione
L’organizzazione come legge naturale
La comunità umana presenta notevoli punti di riferimento con certe relazioni biologiche. Questa scoperta ha talmente affascinato gli studiosi da impedire loro per molti decenni ogni possibilità di critica e di discriminazione.
Non è qui il posto per indicare a quale scuola sociologica ci vogliamo riferire, essendo il nostro discorso di carattere più che altro tecnico, comunque il lettore non farà fatica alcuna a rintracciare il riferimento.
Questo tipo di ragionamento ha inteso quasi sempre imporre l’uso di un’analogia incondizionatamente accettata per buona a priori, limitandosi a catalogare i punti di concordanza, esplodendo in grandi manifestazioni di giubilo quando se ne rinveniva uno nuovo o scarsamente lumeggiato in passato. Si ripeteva in forma più acutizzata, perché più dettagliatamente scientifica, la sorte fortunata del famoso discorsetto di Menenio Agrippa che tutti abbiamo imparato a scuola.
Però bisogna notare che l’interpretazione dell’organizzazione come legge naturale venne a un certo punto della gloriosa imbarcata positivistico-evoluzionista messa da canto come cosa superata perché tacitamente entrata nel novero delle indiscusse “verità” della scienza. Ciò causò il rallentarsi delle frequenti considerazioni generalizzanti sull’argomento e il lavoro venne indirizzato verso i problemi di dettaglio. In altri termini si ebbe la fortunata combinazione che, essendosi data per scontata l’impostazione metodologica del concetto di organizzazione, non lo si contaminò più con altre discussioni parametafisiche traenti origine dalla dottrina evoluzionista.
Per questo motivo oggi posso tagliare di netto questo particolare concetto che potremmo definire “organico” di organizzazione e procedere direttamente oltre.
Prima occorre però aggiungere un’ultima cosa. Non sono pochi coloro che oggi, a causa di una non perfettamente diffusa conoscenza dello stato attuale della ricerca biologica, credono sussistente ancora lo stato di cose che dette origine alle teorie ottocentesche dell’evoluzionismo. Di conseguenza non sono pochi gli scrittori di scienza dell’organizzazione che parlano di paragonabilità della struttura interna di una comunità specifica con la struttura del mondo fisico, organico o inorganico. A sostegno di questa tesi viene ancora oggi, nell’epoca che si affaccia alla soglia del duemila, avanzata la giustificazione che il mondo strutturale inorganico è retto da leggi eterne e immutabili che dettano le procedure di un comportamento automatico senza possibili errori o imprevisti. Altrettanto genere di ricorso si fa verso il mondo organico e alla sua grandiosa legge evoluzionista. Tutto questo non può mancare di rendere insostituibile nella struttura dell’organismo sociale la presenza di una legge, altrimenti non solo tutto cadrebbe nel gratuito e nel futile, ma verrebbe a mancare quella relazionabilità al mondo chimico fisico e biologico che in buona fede si crede ancora patente indiscussa di “verità”.
L’organizzazione come forza
Questa interpretazione riduce il concetto di organizzazione a quel tipo particolare di “forza”, per il momento non meglio identificata, che rende possibile l’intrinseca coesione dei singoli fattori dell’aggregato.
Qui non si prende evidentemente in considerazione né il grado di coesione dei singoli fattori né il grado di riferibilità di questi all’aggregato nel suo complesso. Tutti questi altri lati del problema sono altrettante tesi sull’interpretazione del concetto di organizzazione.
È facilmente individuabile il fatto che intendendo l’organizzazione come forza non si fa nessuna affermazione di ordine “reale”. Caso mai si propone uno spostamento dell’interpretazione utilizzabile in modo immediato, allo scopo di rendere possibile una coordinazione di quell’insieme di azioni che altrimenti resterebbero slegate tra di loro e fatalmente sottomettibili a qualsiasi tendenza disgregativa. Si tratta di un’affermazione “di margine”, che è caratteristica di una determinata mentalità filosofica, come la precedente affermazione dell’organizzazione come legge naturale era caratteristica di una determinata mentalità scientifica. Il guaio è che tutte e due queste affermazioni sono superate come le rispettive mentalità.
L’impossibilita di giungere a determinare, con quella certezza tipica delle leggi macrocosmiche della vecchia fisica, il tipo di “giustificazione” che fonda la caratteristica persistenza del progresso delle organizzazioni, sembrava legittimare la presenza di un ordine particolare di considerazioni, la presenza di un fascio d’azione o di una forza non meglio identificata. Che questa forza estrinsecasse la sua attività coordinatrice in seno alla frammentarietà dell’aggregato, non potevano esserci dubbi visto che solo attraverso una diversa valutazione di questa forza era possibile giungere a individuare gradazioni qualitativamente differenti di organizzazione.
Quest’ultima tesi trovava sostegno nella scarsa conoscenza dei rapporti quantità-qualità e nella restia abitudine di tanti studiosi a non servirsi degli strumenti della statistica metodologica. Infatti spesse volte la gradualità qualitativa non veniva più attribuita ai singoli aggregati, o a quella posizione specifica che via via essi venivano assumendo all’interno della organizzazione, bensì a qualche cosa di metafisicamente superiore, a una forza di coesione e di condensazione. Si aveva in questo modo l’esatta duplicazione dell’organizzazione, da un lato, generalmente di ordine qualitativo inferiore, si collocavano i singoli aggregati e la disposizione peculiare da essi assunta, dall’altro, in un grado qualitativo superiore, si collocava la forza coordinatrice.
L’organizzazione come grado di coesione
Siamo davanti a un criterio meramente empirico, dettato dal “semplice buon senso”, e proprio per questo non rifiutabile teoricamente a priori. Infatti rigettando questo criterio, senza avere prima indicato le basi metodologiche difettose che lo reggono, si farebbe opera vana e facilmente ridimensionabile.
L’organizzazione intesa nel senso di un maggiore o minore grado di coesione dei singoli aggregati che compongono un qualsiasi “sistema” ha come difetto principale la quasi assoluta mancanza di riferibilità a un criterio conduttore di sano fondamento oggettivo. Un maggiore grado di coesione è valutabile nei confronti di un grado di coesione minore solo soggettivamente. Una volta che si tenta in fase preventiva di fornire un criterio schematico, utilizzabile in casi diversi e in tempi diversi, si finisce irrimediabilmente nel dare un banale elenco di casi e soluzioni particolari. Nessuna legge sociologica si può basare sul caso per caso ma deve potere giungere alla tendenza probabile, e questa viene misurata soltanto dalla generalizzazione statistica. Da ciò risulta evidente che questo criterio empirico ha bisogno di un termine di paragone per potere, dalle singole notizie concrete, ricavare la tendenza probabile. Questo termine di paragone può essere fornito da elementi diversi: redditività, distruttività, proselitismo, ecc. Comunque tutti termini estranei alla natura del concetto di organizzazione come grado di coesione.
Senza dubbio si può dire che questo criterio riesce a fornire uno schema di condotta sia pure. macroscopico comunque rispondente a molti problemi della vita pratica, però non soddisfa le ricerche della teoria dell’organizzazione proprio perché insufficiente da per se stesso a reggere il grave peso della validità oggettiva.
Non si tratta di una fine questione di legittimità filosofica, donde sembra derivare la non cittadinanza del concetto che stiamo esaminando nel regno affollato dei concetti costruiti per interpretare il fenomeno dell’organizzazione, tutt’altro, questo genere di concetto risulta inadeguato non solo nella valutazione di strutture organizzative quasi uguali, ma anche nella valutazione di strutture con notevole differenza.
Infine non bisogna dimenticare che stiamo approfondendo solo un punto della questione concernente la negatività del concetto che ci occupa, e precisamente l’impossibilità di ottenere un criterio oggettivo di valutazione. A questo bisogna aggiungere che non è neppure possibile individuare la differente composizione degli aggregati all’interno del sistema, in quanto il grado di coesione può essere – per così dire – alto sebbene sia in atto una distribuzione degli aggregati tutt’altro che buona. Viceversa una distribuzione buona o ottima può essere in atto contemporaneamente a uno scarso grado di coesione.
Se a questo si aggiunge che la coesione non è assolutamente riferibile alle condizioni di relazionabilità esterna, si comprenderà senza bisogno di scendere più oltre la scarsa utilizzabilità dello strumento anche da un punto di vista strettamente empirico. Concludiamo questo paragrafo confermando che l’organizzazione può essere spiegata con il concetto di “grado di coesione” solo in pochi casi empirici di ordine macroscopico, quei casi cioè dove l’evidenza in base ad altri elementi – redditività, ecc. – è tale da rendere poco probabile che il grado X di coesione in atto abbia con la propria influenza Y causato azioni di ordine solamente negativo.
L’organizzazione come grado di riferibilità dei singoli fattori all’aggregato nel suo complesso
L’indole di questo concetto è decisamente più complessa e presenta implicazioni di ordine strettamente filosofico e metodologico. Non siamo davanti a un criterio meramente empirico ma a una formulazione teorica utilizzabile, di volta in volta nella pratica, con le debite correzioni.
Innanzitutto bisogna ricordare che cosa si deve intendere per rapporto di “coesistenza” tra fattore e aggregato. Ogni fattore ha una sua propria individualità e oggettività indipendente o meno, qui ha scarsa importanza, dalla individualità e oggettività dell’aggregato. Non è possibile parlare, come è stato fatto in passato, dell’individualità dell’aggregato come somma delle singole individualità dei fattori. Ciò può soltanto servire come schema limite di condotta pratica, suscettibile di volta in volta di opportune rettifiche dettate dalla singola cultura e preparazione del soggetto.
La tesi che veniamo discutendo propone, invero molto sottilmente, l’interpretazione del concetto di organizzazione come grado di riferibilità dei singoli fattori all’aggregato nel suo complesso. In questo modo si supera il momento frammentario dell’individualità dei singoli fattori che vengono ritrovati intatti, ma plurimi, nell’individualità sempre risorgente dell’aggregato.
Per prima cosa si può obiettare in che modo, senza parlare di grado e quindi della susseguente graduazione, è possibile intendere il processo logico della “riferibilità”. In altri termini, anche volendo prescindere dal giudizio di valore, in che modo si può giungere a collocare il fattore in un rapporto di correlazione con l’aggregato. La risposta purtroppo è una sola: impiegando un modello di razionalità precostituito e ritenuto esatto a priori. Il cassetto costituisce uno dei fattori (elementi) del tavolo sebbene, sia il cassetto come il tavolo, singolarmente posseggano una propria individualità sufficientemente definita, però non è possibile giustificare dal punto di vista organizzativo la presenza del cassetto in un tavolo se non tenendo conto del concetto precostituito che un tavolo con il cassetto – per motivi di funzionalità, ecc. – è “razionale”. Evidentemente si tratta di un esempio che non si adatta perfettamente al nostro problema dell’organizzazione, in quanto questo investe momenti di ordine prevalentemente sociale e non fisico, però rende lo stesso la struttura metodologica del nostro ragionamento e ci aiuta a passare all’esempio seguente, più aderente alla nostra problematica. Ogni organizzazione ha una struttura verticale culminante in un campo dal quale si dipartiscono le disposizioni di comportamento che vengono poste in atto dagli altri fattori (organi) subordinati. Questa affermazione si presta a molte critiche, ed essenzialmente il nostro lavoro è tutto diretto a dimostrare errata questa forma di vedere il problema dell’organizzazione in atto. I vari punti (strutturalità verticale, presenza del capo indiscusso e supremo, perfetta aderenza dei fattori agli ordini ricevuti, meccanismo di dipartizione degli ordini, ecc.) saranno discussi e affrontati a tempo debito. Per il momento ci preme esaminare l’esempio di organizzazione sociale che ci siamo proposti. Sia l’estrema punta della struttura in esame, sia le diramazioni, hanno una loro individualità sufficientemente definita in grado di estrinsecare rapporti e determinazioni differenti, e certe volte contrastanti in seno alla struttura, però ricevono una ulteriore qualificazione. Viceversa la struttura ha vita e determinazione solo a seguito della nuova specificazione che ricevono le singole componenti, in assenza o limitazione di questa specificazione la struttura non può sussistere.
In questo modo però possiamo costruire una graduazione duplicativa: da un lato abbiamo la struttura che nella sua omogeneità può intendersi riferita all’esterno, ora come azione modificatrice in atto, ora come semplice posizione di un rapporto di esistenza e di eliminazione, dall’altro abbiamo l’interno della struttura che conosciamo, fondato su una tecnica piramidale. Niente ci è invece detto in merito alla “riferibilità” dei singoli fattori all’aggregato nel suo complesso.
Volendo notizie in questo senso dobbiamo abbandonare il terreno della piramidalità, come pure quello della relazionabilità a qualche situazione modificante di ordine esterno. Infatti così facendo possiamo trovarci di fronte a strutture che giustificano individualità, altrimenti esistenti su piani diversi, e fattori che giustificano strutture altrimenti inesistenti in assoluto, e nello stesso tempo riferire una possibilità di concreto riferimento progressuale ma limitativo. In altri termini un fattore concorre alla determinazione della struttura – naturalmente in sede teorica in quanto praticamente non è sempre agevole o possibile separare questa realtà in azione – fino al punto in cui la sua attività non viene fatta “esplodere” dalla struttura stessa, che non ammette più la determinazione partitiva e invece vuole affermare una sua particolare determinazione che possiamo definire “globalitaria”. In questo modo abbiamo identificato un nuovo punto di “riferibilità”, la limitazione autonoma dell’azione del fattore, punto al quale fa ovviamente riscontro l’attività passiva della struttura. Quando quest’ultima capovolge invece la situazione imponendo una propria dimensione e una propria “riferibilità”, viene a cessare la “riferibilità” del fattore.
Tutto ciò non può ricavarsi dalla teoria tradizionale, che propone l’organizzazione nel senso che veniamo esaminando in questo paragrafo.
L’organizzazione come razionalità
È la definizione più comune in sede pratica avendo avuto cura, coloro che l’hanno propugnata, di non approfondire eccessivamente il lato filosofico.
Infatti il significato stesso di razionalità, così discusso in sede filosofica, non influisce minimamente sul comportamento di coloro che sbandierano questa definizione come la più efficace possibile del concetto di organizzazione.
Noi non possiamo comportarci allo stesso modo, visto il particolare compito che ci siamo assunti.
Il concetto di razionalità non è direttamente oggettivabile. Poiché esso necessita di una oggettivazione quale che sia, dovendosi presentare come modello di comportamento, si è fatto ricorso in passato ad escogitazioni linguistiche – solo apparentemente speculative – di diversa abilità. Da Descartes in poi si può dire che non ci sia stato filosofo o scienziato che non abbia voluto interessarsi della questione. Il risultato è stato assai deludente. Non si è potuto fondare oggettivamente, in forma diretta, la razionalità. Pur trattando di un modello, lo si è mantenuto in piedi con l’ausilio di un altro modello, il comportamento comune. In altri termini è razionale tutto ciò che non differisce eccessivamente dal concetto comune che si possiede di una determina realtà.
Ad esempio la teoria copernicana fu dichiarata irrazionale dalla Chiesa per tanto tempo, perché contrastante con il concetto comunemente accettato dalla teologia, che presentava la tesi opposta. Vico fu giudicato press’a poco irrazionale dai suoi contemporanei. Nietzsche, Dostoevskij e Kafka lo sono sotto certi aspetti anche per noi. Il futurismo fu irrazionale per coloro che ne constatarono la nascita, come la pop art lo è per molti di noi.
Tutti questi giudizi sono sempre condotti sul modello della razionalità, ma questo modello è adagiato su di un altro modello, quello del giudizio comune.
Affermare quindi che l’organizzazione è razionalità equivale ad impiegare una tautologia, nascondendola sotto le parole. Significa infatti dire che l’organizzazione è il giudizio comune.
Abbiamo accennato ai difetti di questa particolare concezione, dobbiamo ora fare menzione dei lati utili. Non bisogna dimenticare che il problema organizzativo è prima di tutto un problema di praxi. Come tale tiene conto dell’apparato speculativo solo in via preventiva e metodologica. In pratica esistono organizzazioni che si avvicinano ai concetti esposti nel presente lavoro – sebbene tutti egualmente riprovabili – senza che siano state costruite appositamente sulle teorie che in un certo senso esse affermano con la loro stessa esistenza. Ad esempio un’organizzazione industriale o commerciale tiene conto della redditività, una organizzazione militare o religiosa del grado di coesione, una organizzazione familiare della presunta legge naturale, ecc. Una organizzazione tiene conto della razionalità che a lei proviene dal contesto socioeconomico in cui si trova ad esistere e ad estrinsecare la propria attività. In questo modo essa utilizza un modello di comportamento fondato sulla generalità di alcune norme, nient’altro. Ciò presenta molti lati negativi che si possono riassumere, come per parecchi altri casi, nell’intervento della struttura come individualità sui singoli fattori, allo scopo di rendere possibili determinati fini non specificamente previsti. In questo modo un preconcetto razionale diventa patrimonio dei fattori dell’aggregato senza che la penetrazione sia avvenuta dall’interno ma con una semplice sovrapposizione dall’esterno.
L’organizzazione come punto di equilibrio
Questa definizione ammette in partenza e teoricamente l’esistenza di una molteplicità di parametri significanti all’interno del concetto di organizzazione. In particolare non si pone problemi di graduazione tra questi parametri, dando per scontata la necessità che questa graduazione venga posta in atto concretamente dall’esistenza stessa delle funzioni. Il problema invece che si pone è il raggiungimento di un punto di equilibrio. Il mantenimento di questo punto di equilibrio è il compito principale dell’organizzazione.
È ovvio poi che dal compito si passi alla sostanza, da cui la definizione dell’organizzazione come punto di equilibrio.
Ancora una volta ci troviamo davanti a una definizione che tenta l’oggettivazione ricorrendo agli strumenti messi a disposizione dalla ricerca psicologica motivazionale e scientifica in genere. Purtroppo questi strumenti sono utilizzati unilateralmente, in vista di benefici eminentemente pratici.
Ancora una volta ricordiamo che della scienza dell’organizzazione si sono interessati uomini di pratica e non uomini di scienza, salvo casi molto rari. A questo si deve aggiungere che quando gli uomini di pratica si sono posti al lavoro hanno fatto uno studio intorno al problema di come riuscire a raggiungere meglio e prima i propri scopi di ordine produttivistico. Da parte loro gli uomini di scienza, quando si sono posti al lavoro, hanno cercato di risolvere il problema di come vestire di addobbo scientifico i concetti striminziti e disadorni della pratica. Tutto ciò quando non è puerile è delittuoso.
Il punto di equilibrio è un’illusione teorica, sebbene abbia le sue conseguenze pratiche. Non è infrequente il caso di uomini di governo, in seno ad organizzazioni di ordine e tendenze quanto mai vari, che affermano l’urgenza di riforme e di modifiche. Ciò non significa che queste riforme e queste modifiche sono alle porte, come non significa che il punto di equilibrio è in fase di rottura. Tutt’altro. Il più delle volte significa che quel perentorio richiamo alla necessità della riforma è un elemento del gioco eterno del sistema.
La ricerca dell’equilibrio dei fattori di un aggregato non può confondersi con una ricerca della migliore soluzione organizzativa. Infatti maschera la mancanza dell’oggettivazione dei parametri con la presenza di una finalità estrinseca all’aggregato stesso. Così l’equilibrio non potrà mai dirsi intrinseco all’aggregato se non commisurandolo a una situazione di fatto esterna all’aggregato stesso.
Ancora una volta, per porre in atto un sistema di misurazione si ha bisogno di un intervento dall’esterno.
L’organizzazione come finalità ideologica
Precisamente la finalità ideologica non può definirsi come un’interpretazione particolare del significato di organizzazione. Si tratta caso mai di un allargamento suppletivo. Quello però che comunemente – in particolar modo la scuola americana – vuole intendere è la struttura dei concetti e delle convinzioni (cfr. F. Roethlisberger, An Industrial Organization as a Social System, Harvard 1939), nei quali vengono personificati i valori dell’organizzazione stessa.
Naturalmente questo complesso di concetti e convinzioni si presenta spesso come un tutto omogeneo difficilmente sezionabile e ancora più difficilmente riportabile a sezioni di altri complessi ideologici a carattere sistematico.
Sono proprio questi concetti e queste convinzioni, o sentimenti che dir si voglia, seguendo altra terminologia, che determinano in massima parte l’azione all’interno dell’organizzazione. Si ponga mente all’importanza dei sentimenti patriottici in un esercito o all’importanza del sentimento campanilista in una squadra di calcio. Che l’organizzazione possa ridursi allo studio e alla catalogazione scientifica di questi concetti e convinzioni è cosa assai dubbia, ma che questi esercitino una grande influenza all’interno dell’organizzazione è cosa certissima.
Questa interpretazione può quindi presentare due limitazioni, una prima riguarda le convinzioni nella loro globalità relativamente a una determinata organizzazione. Queste convinzioni tendono a disegnare uno stato ideale dell’organizzazione ma sono sempre suscettibili a penetrazioni dall’esterno sia a seguito di pressioni esercitate da altre ideologie, come pure a seguito di pressioni esercitate da eventi concreti (fattori economici, politici, fisici, ecc.). Ad esempio, l’insieme di convinzioni che si possono riassumere sotto il nome generico di “comunismo” contribuiscono a rendere omogenea l’organizzazione dei paesi a regime comunista, ciò non toglie però che questa omogeneità può essere soggetta a sollecitazioni tali che finiscono per frantumarla, sollecitazioni che giungendo dall’esterno impongono la loro origine ideale o concreta modificando la compattezza della struttura ideologica su cui agiscono. La seconda limitazione dell’interpretazione di cui veniamo discutendo riguarda la posizione dei singoli fattori all’interno dell’aggregato. Ciascun fattore vede attraverso una sua personale rielaborazione l’individualità ideologica dell’aggregato. Infatti concorrono a determinare questa particolare visualizzazione il grado di specializzazione del fattore e la sua maggiore o minore capacità di astrarsi fino a una visione generalizzante. Ad esempio, uno specialista in acquisti di materie sussidiarie in un’azienda industriale non comprenderà mai pienamente l’ideologia di fondo dell’azienda in cui si trova ad operare, in quanto anteporrà prima di ogni altra considerazione la particolare ideologia degli acquisti e per giunta di materie sussidiarie. Ciò concorre a determinare una ben caratteristica differenziazione tra specialista in acquisti di materie sussidiarie e specialista in acquisti di materie prime. Può darsi che man mano che si sale nella scala della burocratizzazione aumenti la possibilità di giungere a una valutazione delle finalità ideologiche, e quindi dell’organizzazione nel suo complesso, ma su questo punto i dubbi sono legittimi.
I sostenitori di questa tesi hanno notato, invero con un certo acume, che la stessa impossibilità di giungere a una visione ideologica globalizzante, da parte dello specialista di settore, deve intendersi come una prova aggiuntiva del fatto che l’organizzazione può considerarsi idealmente come la finalità ideologica da conseguire e praticamente come la struttura atta a tale conseguimento, infatti lo specialista di settore per definizione non può essere in grado di valutare il problema organizzativo nel suo complesso come viceversa lo specialista di organizzazione non può rinchiudersi nella qualifica di “specialista di settore”.
Tutto ciò ha ovviamente i suoi lati positivi e interessanti, comunque, dal nostro particolare punto di vista della ricerca di un fondamento oggettivo al concetto di organizzazione, non sposta la questione verso un risultato conclusivo.
L’organizzazione come forma
È la definizione più semplice e più cara ai pratici. Nello stesso tempo è la definizione che ha conseguito il maggior numero di critiche fondate e infondate da parte dei teorici e degli idealisti.
Un sistema si presenta sempre come una forma in atto. Questo non è negabile. Tutto sta a stabilire in che modo questa forma è determinata dalla volontà del sistema inteso in termini di aggregato individuale e che relazione ha questa determinazione con l’azione dei singoli fattori, sia come singole individualità agenti all’interno dell’aggregato, sia come singole componenti dell’aggregato stesso.
Un sistema è composto di regola da un certo numero di strati e di livelli. Il numero può essere limitato (aziende commerciali, complessi industriali di piccole dimensioni, ecc.) o grandissimo (Stato, organizzazioni politico-sindacali, ecc.). La forma che questi strati o livelli assumono può essere verticalizzata o a diffusione orizzontale. In ogni caso è importante per la comprensione della nostra analisi sapere che la riduzione della forma dell’organizzazione alla sostanza è soltanto uno fra i tanti modi di giungere a una interpretazione del fenomeno organizzativo.
Non bisogna dimenticare che questa distribuzione formale non ha significato alcuno se non è legata strettamente alla distribuzione ideologica. Infatti sarebbe privo di significato, anche formale, il fatto che il dirigente ha il tavolo diverso da quello degli impiegati, o sta seduto in una poltrona, se poi non si riveste la differenza del tavolo e la presenza della poltrona di una realtà ideologica sostanziale. Abbiamo quindi individuato qual è il difetto di questa interpretazione. Ancora una volta non è possibile giungere all’oggettivazione del concetto di organizzazione senza fare ricorso a qualche cosa di estraneo al concetto stesso e di determinante. In questo caso si è fatto ricorso a un’altra definizione del concetto in questione.
L’organizzazione come superamento dell’individualità
Come in tutte le definizioni che abbiamo considerato, dove in misura minore e dove in misura maggiore, esiste anche qui una certa dose di buon senso pratico. Il ragionamento è semplice: poiché l’aggregato è il prodotto dell’unione di un insieme di fattori e poiché questi hanno la tendenza logica a permanere nella loro individualità, si corre il rischio che questo aggregato diventi la fusione poco raccomandabile di una moltitudine di individualità ma non giunga mai a costruire una individualità propria e identificabile con facilità.
Tutto ciò è giusto, solo che la definizione non può considerarsi completamente soddisfacente o nel migliore dei casi rispondente in pieno al vero significato di organizzazione. In teoria anche l’aggregato costituito dai fattori più eterogenei e individualistici ha una propria individualità. Ad esempio la “fossa dei serpenti” in un manicomio è popolata spesso da persone malate di mente, quindi da persone eminentemente dissociate e con tendenze paranoiche, eppure non possiamo negare che si tratta di un aggregato che possiede una propria individualità, sommamente spiacevole, d’altro canto non si potrà assegnare alle mura che circondano la “fossa” il significato di “struttura organizzativa”. Ciò dimostra che quel significato va cercato altrove con maggiore efficacia e penetrazione.
Insufficienze del tipo di definizioni considerate
Ci siamo dilungati a sufficienza nel prendere in esame le differenti possibilità di giungere alla individuazione di un concetto di organizzazione. Tutte le volte però si è dovuto concludere per l’inadeguatezza dei vari tentativi.
I motivi di questa inadeguatezza sono stati di volta in volta studiati, per cui in questa sede ci rimane solo l’obbligo di individuare il nesso centrale che rendeva inapplicabili tutte le suddette definizioni.
Questo nesso possiamo individuarlo nella necessità, per ciascun tentativo, di ricorrere a entità di determinazione residenti all’esterno del concetto stesso. In altri termini ciascuna definizione non era considerabile nei termini caratteristici della definizione valida in quanto abbisognante di riferimenti a situazioni di fatto o ad azioni esterne al complesso di valutazioni prese in esame.
Questo modo di procedere rende plausibile qualsiasi genere di affermazione, proponendo l’autorità di entità non agenti all’interno dell’affermazione stessa e utilizzando queste entità nella veste di superaffermazioni comprovanti. Ciò costituisce un processo di verificazione fondamentalmente errato ma assai comune, specie nel campo delle scienze sociali e dell’uomo in genere.
La ricerca di un tipo di definizione priva di giustificazioni estrinseche
È nostra intenzione giungere ad individuare una definizione del genere indicato nel presente paragrafo. Prima di procedere oltre occorre però che venga chiarito il processo logico di ricerca che impiegheremo.
Innanzi tutto l’indagine sulla realtà organizzativa in atto può paragonarsi a un’indagine condotta da uno studioso di anatomia invece che su di un organismo sano su di un organismo malato o abnorme. Non è strettamente compito dell’anatomista studiare lo stato di anormalità dell’organismo malato in quanto questo è piuttosto compito di altri specialisti (patologi), invece il compito del primo studioso è quello di esaminare e individuare la funzionalità media dell’organismo, possibilmente prendendo in esame un esemplare con accentuate caratteristiche di normalità o comunque presentante un indice di anormalità tale da essere facilmente riportabile al concetto standardizzato di normalità. È ovvio che i risultati delle osservazioni condotte sull’organismo malato hanno un grande valore per il patologo, ma richiedono all’anatomista un grande sforzo di correzione per giungere a identificare le “funzionalità normali o medie”. Allo stesso modo, nell’esaminare l’organizzazione in atto sarebbe auspicabile che noi avessimo un organismo medio o normale capace di consentire un rapporto di conoscenza scevro da complicanze riportabili alla particolare situazione della sua anormalità. Tutto ciò è palesemente utopico. La “normalità” nel campo degli organismi sociali è un fenomeno puramente teorico.
Lo scopo stesso della nostra ricerca contribuisce a delimitarla e a caratterizzarla. Noi intendiamo ricercare la normalità del concetto di organizzazione considerando in questo modo soddisfatte tutte le pretese iniziali di ricerca della giustificabilità intrinseca della definizione stessa.
Ecco perché il nostro sforzo assumerà la forma esteriore di una analisi puramente teorica. Però sarà la sua lettura che consentirà di potere applicare via via ai casi concreti un processo di risoluzione non più teorico ma pratico, anzi tecnico.
La prima caratteristica della definizione che andiamo cercando è quella di rifarsi a concetti non immediatamente riconducibili a una matrice unitaria. Ciò non toglie però, come vedremo, che sia possibile l’individuazione di questa unità di origine.
L’unità di origine della matrice concettuale giustificante un concetto di organizzazione relazionista-funzionale
Diamo per scontato che il nostro concetto di organizzazione sia essenzialmente di ordine relazionista-funzionale.
L’embrione del principio di relazione si pone come semplice contrapposizione logica al tradizionale concetto derivante dal vecchissimo principio di causa ed effetto. Non è questo il luogo per rendere edotto il lettore della storia particolarissima di questo contrasto. Il concetto di relazione non si pone questioni di priorità o di supremazia, ma soltanto questioni di giustificabilità relazionale, cioè questioni di interdipendenza spaziale e temporale. Tutto ciò causa una fondamentale modificazione nel giudizio scientifico, oltre che nella dislocazione dello stesso materiale di ricerca che risulta essere condizionato in modo decisivo dal nuovo punto di vista metodologico.
Mentre il precedente principio di causa ed effetto assumeva prima o poi una determinante assolutista, per quella sua implicita ricerca del movente necessario e a priori, il principio di relazione ammette una pluralità paritetica di moventi e di cosiddette cause. In altri termini, mentre il principio di causa ed effetto poteva contribuire a giustificare l’esistenza dell’“essere”, quello di relazione contribuisce di regola a giustificare solo l’esistenza della “forma”. Ciò non toglie ovviamente che possano verificarsi storture metafisiche capaci di cambiare le reali possibilità del principio logico di relazione, comunque qui in linea preventiva possiamo concludere per una necessaria rapportabilità del principio di relazione al pluralismo.
[1966]
Le principali categorie dello strutturalismo del sistema
L’intellettuale non sfugge alla ferrea legge dell’integrazione, anzi ne subisce con maggiore precisione e forza i tentativi e i colpi.
Questa affermazione non presenta possibilità di eccezioni. Ai primordi della civiltà tecnologica il rapporto dialettico padrone-servo assicurava un contrasto “visibile”, da cui era sempre facile risalire chiaramente a un rapporto di repressione e di violenza della libertà. Oggi, abbandonata quella forma verticale, il rapporto ne ha assunto una circolare, donde i cosiddetti padroni sono a loro volta servi di un ingranaggio ormai sfuggito alle deboli mani dei costruttori.
Gli intellettuali che si assumono i1 gravoso campito della programmazione dell’integrazione, in definitiva l’élite governativa o direzionale, non sfuggono all’influenza di norme e prescrizioni ben lontane da quelle “ufficiali” affidate al Codice o alle raccolte di leggi. Si tratta di “ordini” sotterranei, non sempre documentabili ma dagli effetti sicuri. La fonte di questi ordini è la vera origine della forza vitale degli Stati moderni: la produzione industriale. Dal canto suo questo immane meccanismo è condizionato dalle leggi ferree dell’economia produttivista.
Dando per scontata l’integrazione degli stessi operatori dell’integrazione, diventa molto più semplice capire l’estensione e la profondità del grado di integrazione degli altri intellettuali.
La prima categoria dello strutturalismo del sistema è il cosiddetto principio di conservazione. Ogni movimento di chiarificazione, ogni forza estranea alla struttura, ogni tentativo di decongestionamento, ogni aria di libertà assoluta dettata magari dall’insofferenza e sia pure dalla stessa ignoranza della forza contro cui si contrasta, viene immediatamente inglobato. L’impressione più immediata ed efficace che se ne riceve è quella di lottare contro un corpo morbido che non respinge i colpi ma si limita ad attutirli fino al punto di renderli innocui e paralizzati.
Che il principio di conservazione sia riscontrabile in tutti gli organismi sociali è un fatto riconosciuto da tempo dalla ricerca scientifica del settore. Quello che invece non è ancora chiaro – o almeno non è ancora stato affrontato con la rettitudine mentale che confina con la chiarezza – è il modo con cui è attuato il rigetto di tutte le istanze contrarie al sistema. È proprio quella forma gelatinosa di resistenza che mette paura e che ci fa per certi aspetti quasi preferire la franca e robusta resistenza del rigetto tradizionale delle forme dittatoriali assolute del passato antico e recente.
Nella lotta vivace e continua lo spirito del vero combattente si anima e si rafforza, nella schermaglia monotona e sottile, nelle scaramucce delle piccole operazioni di trincea, anche i migliori combattenti finiscono per avere la peggio.
L’altra grande categoria dello strutturalismo del sistema è costituita dal processo di sviluppo produttivista. Ogni struttura, per il solo fatto che esiste, non può permanere ma deve evolversi, deve ingigantirsi, deve espandersi, conquistare, sottomettere, adeguare una realtà estranea e nemica ai propri programmi e ai propri bisogni di vita. Ogni struttura è un vero e proprio processo di distruzione in atto, distruzione di una realtà esterna che avendo una sua logica intrinseca, diversa da quella della struttura, finisce per diventare illogica e paradossale, donde la legittimità della distruzione in nome del progresso e del miglioramento.
I grandi nomi del glorioso passato americano, i Padri fondatori, tollerarono la schiavitù degli Stati del Sud, tollerarono la pirateria, favorirono e programmarono il genocidio delle popolazioni originarie, viceversa predicarono l’isolazionismo del grande Stato americano, cioè la non ingerenza nella realtà europea, perché questo poteva significare la fine precoce degli Stati Uniti.
I grandi nomi del glorioso passato francese, gli enciclopedisti, programmarono la morte di Dio ma si dettero da fare a farlo rivivere sugli altari di una divinità scarnificata dalle prerogative infinite e rivestita da quelle tradizionalmente affidate all’uomo. Tutto ciò portò a un gonfiarsi delle pretese del piccolo uomo e alla costruzione dei grandi complessi architettonici della metafisica posteriore. Davanti alle nuove strutture le vecchie finivano per diventare illogiche e sorpassate, la loro fine registrò molto sangue ma poco stupore o meraviglia.
I grandi nomi del nostro glorioso passato, i cosiddetti nostri Padri fondatori, finirono per sovrapporre la realtà ipotetica di una unità nazionale alle singole realtà effettive di unità parziali. Questa realtà finì lo stesso per rendere paradossali le precedenti che vennero distrutte tra l’attonito stupore di coloro che avendole vissute non le trovavano tanto da buttare via, mentre di lì a poco le avrebbero rimpiante.
L’elenco potrebbe continuare ancora.
Come si vede non si tratta altro che di una copertura ideologica posta a giustificazione di un comportamento distruttivo. Quello che viene sacrificato è l’ostacolo al meccanismo produttivista posto in atto dal vincitore.
Non bisogna però illudersi che questo processo distruttivo sia arrestato subito dopo l’affermazione dell’ideologia vincitrice e il conseguente inizio del processo di sviluppo produttivista. Questo processo deve essere costantemente difeso e perfezionato. Da ciò l’individuazione di una terza categoria dello strutturalismo del sistema: la manutenzione dell’ideologia vincitrice, il che in termini diversi significa la possibilità di fare permanere il processo integrante di sviluppo.
Questa è categoria assai vicina a quella del principio di conservazione ma più squisitamente intellettuale. In ogni fase della sua attuazione questa categoria richiede l’impegno degli intellettuali, cioè richiede la loro continua prostituzione, la loro continua dedizione al compromesso e rassegnazione alla mediocrità. Mentre il sistema tecnico del processo conservativo – indiscutibilmente dovuto all’attività degli intellettuali – può essere mantenuto in vita anche per lungo tempo senza l’intervento della “classe”, la manutenzione dell’ideologia vincitrice pretende la costante attività di tutta la “classe”.
Caratteristica di questa attività di manutenzione è quella di qualificare ogni spunto concreto di rivolta parziale che si manifesta all’interno del sistema. La qualificazione avviene ovviamente in senso negativo indirettamente attraverso i “concetti” programmati per tempo dalla classe intellettuale dedicata a questo compito. Un posto di preminenza occupa il “concetto” della “nonviolenza”. Il nonviolento può mantenersi in una fase di dissenso solo per un tempo – lungo quanto si vuole – determinato. Infatti il sistema ha dalla sua il favore dell’attesa. Il sistema può attendere che il dissenso platonico del nonviolento si spenga da solo per mancanza di alimentazione. Viceversa deve correre ai ripari di fronte alla violenza, scoprire le proprie tattiche e le proprie ideologie. Quanti tra i radicali che oggi si affannano a predicare la nonviolenza si accorgono di essere loro stessi i primi portavoce del sistema? Purtroppo pochi. Costoro non capiscono che la posizione di nonviolenti non potrà mai concorrere a determinare una politica di nonviolenza del sistema. Infatti quando questo riterrà inopportuna una tale politica, loro si troveranno automaticamente “fuorilegge” e si darà inizio a una integrazione nel senso della violenza, con la forza (ridiventata di moda) o con l’astuzia. Se i contestatari nonviolenti di oggi credono – in buona fede – che la loro posizione sia in contrasto al sistema essi vogliono chiudere gli occhi alla realtà.
Altra notevole categoria dello strutturalismo del sistema è quella che si potrebbe definire dell’antisolamento. I portavoce del sistema predicano che l’uomo non è portato per la solitudine, che è un “animale politico”, che lo stesso concetto di “uomo faber” cadrebbe nel nulla se venisse predicata una dottrina del valore della solitudine.
Perché viene condannata la solitudine? Il motivo è semplice: la solitudine è l’anticamera della riflessione, del ragionamento, della chiarificazione, della scoperta, del rifiuto, della rivolta, della rivoluzione. Il crescendo non è facilmente arrestabile, una volta posto in atto il processo di liberazione delle idee. Niente di più dannoso al sistema.
Il lavoro di manutenzione dell’ideologia vincitrice si svolge quindi nella direzione contraria alla solitudine. Anche la religione, che un tempo aveva scoperto – ancora prima delle moderne teorie psicologiche – l’importanza della solitudine, abbandona questo concetto per quello dell’antisolamento. I motivi che hanno contribuito a questo cambiamento di indirizzo non sono facilmente individuabili, comunque è presente il fatto che la religione essendo una parte della complessa struttura del sistema ne avverte le necessità e le fa proprie. Oggi la figura del monaco, dell’anacoreta, il valore della clausura, della penitenza in solitudine, il valore della stessa preghiera, del rapporto ascetico con la divinità, vengono subordinati al valore dell’azione sociale, dell’azione concreta nel mondo, anche se rivissute in funzione di una particolare prospettiva teleologica.
Sorvolando sul merito di questa modificazione della politica religiosa – per altro da noi affrontato in sede più adatta – qui ci preme chiarire come il grande valore della solitudine sia in via di definitiva distruzione a opera del sistema e quindi a opera anche della religione.
L’antisolamento è una delle categorie fondamentali del sistema perché lavora all’annullamento dell’individualità rendendo compatto il campione su cui operare le tecniche dell’integrazione. È indiscutibile il fatto che una massa abituata alla riflessione solitaria, al ragionamento, ecc., anche se non facilmente giunge alle estreme e logiche conseguenze rivoluzionarie, si sottopone difficilmente al processo integrativo, avanzando continue remore ed eccezioni.
[1967]
L’etica della rivoluzione
I vari problemi sociali messi sul tappeto dalle recenti iniziative studentesche sono stati variamente esposti e studiati. Sul piano di una immediata ingerenza pratica, i quotidiani hanno fatto un buon lavoro portando a conoscenza di larghe fasce di lettori, altrimenti non raggiungibili, l’urgenza e la contestualità di certe situazioni di carenza istituzionale. Sul piano teorico il lavoro è rimasto leggermente indietro. Una miriade di articoli (sempre su quotidiani) a firma dei vari Guido Calogero, Norberto Bobbio, Aldo Visalberghi, Giannino Bassetti, Francesco Alberoni, ecc., partono da un intendimento teorico, ma necessariamente giungono a valutare assai nebulosamente soltanto le implicanze pratiche.
Restano gli articoli sulle riviste: “Questitalia”, “Corrispondenza socialista”, “Adesso”, “L’astrolabio”, “Rinascita”, “Riforma della scuola”, “La discussione”, “Tempo presente”, “Critica sociale”, “Mondo nuovo”, “Nuova tribuna”, “Mondo operaio”, “La fiera letteraria”, “Ricerca”, “Dibattito sindacale”, “Politica”, “Resistenza”, “Giustizia e libertà”. Molto importante tra le altre iniziative quella di “Tempi moderni” che dedica l’intero n. 33 al tema “Rivolta o rivoluzione?”.
Il prospetto che presentiamo, ricavato da un ampio e documentato studio pubblicato appunto da “Tempi moderni”, dà una visione molto appropriata dei tentativi fatti dalla stampa quotidiana (del mattino e politica), a mezzo dei maggiori rappresentanti nazionali nel senso della tiratura, per portare a contatto del grande pubblico i problemi del movimento studentesco.
Bisogna tenere presenti alcune precisazioni, che la stessa fonte da noi utilizzata ha paura di segnalare. La tiratura è ricavata da Italia 1969. Annuario dell’economia della politica e della cultura, EtasKompass, bozze di stampa.
Le presenze andrebbero osservate nello svolgimento attraverso i singoli mesi che vanno dal novembre 1968 al marzo 1969, ciò non risulta possibile nel prospetto da noi rielaborato, ma il lettore che voglia approfondire l’argomento può ricorrere al citato numero di “Tempi moderni”. Per quanto riguarda le presenze in prima pagina e le titolazioni bisogna tenere presente la diversa impostazione dei giornali. Il “Corriere della sera” e “La Stampa” dedicano la prima pagina di regola a fatti politici interni o internazionali, mentre quotidiani come “Il Messaggero” dedicano la prima pagina, con una certa preponderanza, a fatti di cronaca. Lo stesso dicasi per i quotidiani di partito che inseriscono in prima pagina notizie magari limitate, come universalità di interesse, ma di particolare momento per gli appartenenti al partito.
Dalla titolazione può emergere una mimetizzazione dei fatti da parte di veicoli come il “Corriere della sera” o “Il Popolo”, mentre “L’Unità” sembra avere dato molto rilievo al movimento e ai suoi problemi. Basta pensare ai dieci casi di titolazione a piena pagina.
Gli editoriali e l’elevato numero di fotografie confermano l’alto interesse per gli avvenimenti del periodo in considerazione.
Fatta questa breve escursione delle forze scese in campo ci resta da chiarire: si è davvero detto tutto? Almeno in campo teorico, no. La stantia distinzione tra morale protestante o industriale e morale orientale o intimista mi pare si regga ogni giorno di meno e sempre con maggiori difficoltà.
Tutta questa storia, da Max Weber in poi, incomincia a fare puzza di rinchiuso, di libresco. Qui si corre il rischio di ripetere sempre le stesse cose giustapponendole al volgere imprevedibile degli eventi, illudendosi che possano aprire la magica porta in ogni caso e per sempre.
Ma l’azione concreta nelle piazze e nelle strade, nei corridoi delle università e nelle austere aule tradizionali, se ne infischia di tutto questo. Distrugge distinzioni e spiegazioni dottrinali, passa come un turbine sulle loro rovine, si lancia con tutta la foga delle “cose fatte” verso un futuro ancora più incognito del già sufficientemente incognito presente.
Ecco che i “teorici”, quelli che lavoriamo dietro un tavolo sommersi dalla tremenda presenzialità della nostra cultura, dei nostri sofismi, della nostra scienza, delle nostre “certezze”, restiamo tagliati fuori e rischiamo di non comprendere più la realtà.
Un rimedio? Certo che non può considerarsi come proposta di un rimedio questo breve scritto che abbiamo sentito l’urgenza di premettere al normale lavoro di “Studi e ricerche”. Tutt’al più può considerarsi come l’invito a un esame di coscienza e a una maggiore serietà di documentazione nell’affrontare un problema come quello che oggi ci viene proposto dai fermenti studenteschi, tanto importante e tanto lontano dal cliché che solitamente teniamo nel cassetto.
Riprendiamo la distinzione già detta tra etica protestante o etica del progresso materiale ed etica del rifiuto della società opulenta.
Notiamo, come prima cosa, che l’etica del rifiuto non appare più come invece appariva chiaramente in passato riconducibile a modelli di vita orientali. Larghe rappresentanze degli appartenenti alla civiltà opulenta (generalizzabile con l’ambiguo termine di occidentale) ne attuano un’applicazione sempre più vasta. L’uso strettamente ortodosso della differenziazione vista prima ingenera quindi non poche confusioni.
Un’etica immediatamente identificabile come etica del costruito, comprendente anche quel tipo particolare di etica che l’indagine weberiana faceva risalire alla preponderante influenza protestante nello sviluppo dell’industrialismo contemporaneo, ci pare categoria talmente ampia e di agevole collocazione da invitarci a un suo definitivo impiego.
È naturale che un’etica del costruito finisca per comprendere anche l’istanza di rivolta, se quest’ultima si presenta nel suo aspetto parziale di insofferenza nei confronti di un processo di integrazione in corso.
Sotto questo aspetto i movimenti studenteschi, di cui abbiamo fatto cenno, rientrano in un’etica del costruito. A dimostrazione di questo apparente paradosso stanno due fatti di grande importanza: primo, il sistema prevede e regola questo genere di rivolta parziale, a dire il vero con norme quanto mai contraddittorie e strane, come ad esempio quelle che regolano l’occupazione delle università, comunque un certo apparato esiste ed è adatto, sia pure all’ingrosso, a contenere e regolare nei limiti dell’integrazione ogni stimolo di rivolta parziale. Il secondo fatto è in relazione non col mondo della rivolta parziale ma col contenuto dell’istanza che lo giustifica. In un processo integrativo globale nessuna richiesta può farsi se non nel senso e nei limiti fissati dallo stesso processo. Si tratta di accelerazioni, mai di rotture.
Per la verità l’iniziale istanza programmatica, intesa nei limiti di un miglioramento puramente interno alle faccende studentesche, si è estesa man mano fino ad assumere il contenuto della contestazione globale ma rimanendo, nella forma, sempre allo stato di rivolta parziale.
La contraddizione di quest’ultima posizione è evidente. La rivolta parziale appartiene a un’etica del costruito, come abbiamo detto, proprio per quella sua parzialità, donde non può giustificarsi una rivolta parziale che pretenda di assumere il contenuto della contestazione globale.
E allora che cosa possiamo contrapporre veramente all’etica del costruito? Non già quella del costruibile, in quanto – sia pure come semplice esercitazione accademica – per potersi giustificare come tale e sfuggire all’accusa di utopia, deve partire dal filo logico segnato dall’etica del costruito e programmarsi come semplice continuazione ed estensione di quest’ultima.
Resta soltanto l’etica della rivoluzione.
Esistono molti atteggiamenti nell’ampio giardino zoologico che racchiude i diversi tipi di umanità che possono a tutta prima essere scambiati per atteggiamenti rivoluzionari. Di fatto queste confusioni sono assai frequenti e finiscono per rendere nebuloso e difficilmente identificabile il concetto di “rivoluzione”. Il rifiuto parziale (vedremo più oltre come questo rifiuto non può mai essere totale, solo che in un caso) dei modi usuali di vita e delle regole morali fissate dall’uso o dalle convenzioni legali non è “rivoluzione”. I moderni beat, hyppie, provo, hypster, ecc., non sono in uno stato di rivoluzione ma semplicemente di rivolta contro alcune regole del gioco. Ad esempio – tanto per farne uno – non possono sottrarsi alla regola principale della società che si fonda sulla morale del costruito: produrre. Anche costoro producono. Anche nei casi estremi, quando siamo davanti a soggetti che non lavorano ma che sollecitano con forme sia pure garbate la carità di un passante allo scopo di superare la loro giornata, anche questi non hanno rotto che parzialmente il loro legame, infatti la moneta che ricevono in cambio di un’attività (il mendicare) si può considerare alla stessa stregua di una comune retribuzione per lavoro prestato.
Le altre correnti, sia di vita pratica che di pensiero, le quali propongono una rivalutazione dei valori della vita “vicino alla natura”, dei concetti cari all’irrazionalismo europeo del finire dell’Ottocento, della meditazione ad alto potenziale di concentrazione sul modello fornito dalle filosofie orientali, non sono portatrici di stimoli rivoluzionari o almeno non lo sono nel significato che intendiamo noi.
Le differenti posizioni dei vari partiti, anche le più estreme ed arrischiate, non sono posizioni rivoluzionarie. Questa affermazione è facilmente controllabile. Basta pensare al fatto che tutte le forze politiche militanti in parlamento sono di carattere istituzionale, quindi operanti nell’ossequio del sistema che rende possibile la loro stessa esistenza.
L’anarchismo oggi non è rivoluzionario nel nostro senso. A prescindere dalle ferite che hanno sempre travagliato, e che più che mai travagliano il movimento anarchico, esso si pone come aspirazione libertaria più che come concretizzazione libertaria. Infatti il pomo della discordia è stato sempre la distinzione tra individualismo anarchico (corrente tradizionale e romantica che affonda le proprie radici nel nichilismo) e tendenza organizzativa (corrente che cerca di dare forza e penetrazione al principio libertario raggruppando in una federazione tutti gli anarchici ed agendo con i sistemi tipici di tutte le organizzazioni). Per la verità siamo qui davanti a un’organizzazione di tipo particolare, ma che in ogni caso si propone di agire nel sistema subendo le vie istituzionali tra le quali tipiche quelle sindacali. L’anarchismo ci offre il curioso caso di una grave contraddizione. La forma individualista si avvicina più di tutte al tipo di rivoluzione “pura”, ma rifiutando l’organizzazione cade nel difetto di utopia di cui si è detto prima, la forma organizzativa è concretamente lontana dal predetto tipo di rivoluzione, pure avendo a disposizione i mezzi strutturali per una eventuale attuazione del momento rivoluzionario.
Veniamo adesso alla chiarificazione di che cosa è possibile intendere per etica della rivoluzione.
Innanzi tutto bisogna tenere presente che la situazione rivoluzionaria si identifica nella rivolta totale. Abbiamo detto che il rifiuto del processo integrativo è sempre parziale. Diventa totale solo se il rifiuto travalica nella rivoluzione.
Ma come avviene questo passaggio? È possibile ancora giustificarlo con i vecchi schemi della lotta di classe? Oppure bisogna guardare altrove, verso categorie nuove e non del tutto ben localizzate dalla ricerca sociologica militante?
Di per se stessa una morale del costruito non può essere eterna. In un certo senso possiamo quindi aspettarci una trasformazione, come pure con un poco di buona volontà una sostituzione totale. Ma il processo integrativo ritarda la trasformazione e rende impossibile la sostituzione totale.
Lo schema caratteristico del meccanismo rivoluzionario, così come è stato studiato, poniamo, da Marx e da Engels, trova oggi forti remore nel particolare grado di integrazione raggiunto dai sistemi chiave della politica internazionale. Non ci troviamo più davanti alla possibilità di una rivoluzione del risentimento, oggi solo una rivoluzione dal chiaro fondamento filosofico è possibile. D’altro canto finché questo non sarà fornito all’azione, questa ultima risulterà inutile e inefficace.
È la categoria della rivolta parziale che deve essere rivista e modificata. Una rivolta parziale non potendosi sganciare dalla morale del costruito è sempre sconsigliabile, se non altro perché colloca coloro che la attuano in una situazione di maggiore integrazione (arresti, segnalazioni, condanne, ecc.). Non resta che la rivoluzione generale.
Quest’ultima, non potendo trovare fondamento sulla morale del costruito, nemmeno su quella del costruibile, in quanto ricavata dal costruito, fa diventare immediatamente utopista ogni pensiero, ogni azione, diretti alla rivoluzione.
Quello che necessita è quindi un’etica della rivoluzione. I canoni fondamentali di quest’etica non possono farsi rientrare nell’ampia zona delimitata dal costruito. Essi sono sospensione del giudizio, analisi critica dei sistemi in atto, unificazione di coscienza privata e coscienza pubblica.
La sospensione del giudizio elimina i tabù della tradizione che vengono in questo modo non distrutti ma messi “tra parentesi”, l’analisi critica dei sistemi in atto consente di cogliere i punti deboli senza tuttavia scendere a posizioni di partito e ciò in considerazione della precedente sospensione del giudizio, l’unificazione di coscienza privata e coscienza pubblica elimina il diaframma tra individuo e società preludendo a un livellamento dei valori solitamente contrastanti di classe, di nucleo, di status, ecc.
L’etica della rivoluzione è dunque un’etica di preparazione alla distruzione in quanto, ancora prima dell’azione diretta generale e risolutiva, propone una rottura insanabile con l’etica del costruito.
[“L’etica della rivoluzione”, pubblicato su “Studi e Ricerche”, 1968, pp. 593-599]
La distruzione necessaria: risposta all’“Avanti!”
Riprendo dopo parecchio tempo la difesa della tesi rivoluzionaria esposta nel mio libro La distruzione necessaria per puntualizzare la critica ingiusta e speciosa che Alberto Jacometti ha formulato nelle pagine dell’ “Avanti!” (“I limiti di certi tipi di contestazione. La distruzione necessaria” pubblicato su “Avanti!” 10 dicembre 1969). L’articolo in questione era stato pubblicato quasi da un anno, ma non era stato da me ritenuto degno di una risposta congrua e dettagliata. Oggi i termini del problema si sono forse modificati, l’urgenza di chiarire determinate posizioni di quelle sedicenti forze di sinistra che manipolano il potere è diventata improrogabile. Ecco perché ritengo che una rilettura di quell’articolo, e una puntualizzazione di quella critica alle mie tesi, può tornare utile.
L’arte delle deduzioni
Iniziamo il nostro esame della tecnica stessa usata da Jacometti per lavorare intorno a un libretto di poche pagine (ottanta per la precisione), per poi passare alle conclusioni che legittimamente si possono ricavare dalla critica del nostro articolista. Evidentemente siamo davanti a un individuo eccezionale capace di ricavare l’età delle persone dalle righe di un libro, con la stessa disinvoltura con cui la chiromante la ricava dalle linee della mano. Leggiamo infatti: «L’autore è certamente un giovane Alfredo M. Bonanno d’estrazione pare anarchica ma d’una specie d’anarchia assai singolare che dopo Bakunin, Malatesta, Kropotkin, Reclus e gli altri, sembra ritornare a Stirner, che comunque non crede nelle masse ma nelle élite, che egli ravvisa nell’intellighentia». Con quali mezzi poi abbia veramente ottenuto queste deduzioni non lo sappiamo. Infatti i giovani purtroppo ormai non considerano lo scrivente un giovane come loro, anche se questo ad onor del vero non costituisce motivo di gioia per il sottoscritto. Comunque, a prescindere da questo particolare di scarsa importanza, resta il fatto delle etichette. Come tutte le persone limitate intellettualmente dalla routine politico-istituzionale, Jacometti viaggia a forza di etichette. Per lui il mondo deve essere qualcosa di prefissato, di preventivamente catalogato in tanti scomparti ben visibili: lo scomparto degli anarchici, quello dei comunisti, quello dei socialisti, ecc. Da ciò si deduce naturalmente che all’interno di ciascuno scomparto sia possibile identificare tanti piccoli cassettini dove trovano posto le sottoclassificazioni degli scomparti, per gli anarchici i nomi di Bakunin, Malatesta, Kropotkin, Reclus (citati in blocco e senza alcun senso di cosciente valutazione delle loro idee) equivalgono a tanti cassettini dove si andranno a situare tutti gli scrittori e i militanti anarchici con quelle specifiche tendenze o ideologia (ma quali poi?). È ovvio che tutto ciò non solo non corrisponde alla realtà, ma è il prodotto più caratteristico di una specie di astigmatismo dottrinale molto diffuso in seno alle correnti parlamentari.
Tentare delle deduzioni da questi presupposti è non solo azzardato ma puerile. L’uomo non è mai rinchiudibile all’interno di una etichetta, ancora meno quando il fondamento del discorso è quello politico ed investe, come in pratica accade, interessi sia pratici che teorici. D’altro canto non impiegare questa etichettazione iniziale significa affrontare una tesi veramente dal di dentro: riflettere, puntualizzare riferimenti e presenze letterarie, escogitare nuovi temi di contrapposizione fuori da quelli prefissati dalla tecnica tradizionale, insomma tutto un lavoro che un qualsiasi articolista non può permettersi, specie se travolto dalla tentazione di buttare giù quattro righe tanto per trovare il pretesto a proprie elucubrazioni personali, a proprie idee accarezzate da tempo e sempre volentieri messe sul tappeto.
In questo modo le deduzioni sorgono gratuite e si mantengono per quella strana virtù di buona parte delle deduzioni nel campo delle scienze sociali: l’inconsistenza dottrinale di base. Infatti il campo delle scienze sociali è il più accessibile a quanti privi in modo assoluto, o largamente deficienti di preparazione tecnica dottrinale, intendano lo stesso con la sicumera degli incoscienti e degli sprovveduti dire la loro. Ora questo non è naturalmente il caso del nostro Jacometti, uomo di valore oltre che di penna, ma l’infelice suo modo di porre mano alla questione ci ha fatto sovvenire quei tizi che agiscono come si è detto.
Che cosa può mai volere dire “…non crede nelle masse ma nelle élite?”. Forse che la credenza in qualcosa resta valida a seconda dell’oggetto in cui la credenza stessa è riposta? Come dire che una persona non crede in Cristo ma in Maometto, pretendendo con ciò di avere puntualizzato l’erroneità della posizione di quella persona. Il fatto di credere in Maometto e non in Cristo è altrettanto erroneo dell’eventualità inversa, come il fatto di credere nelle élite è altrettanto erroneo di credere nelle masse e viceversa, il punto importante non è quindi nell’oggetto della credenza ma nella credenza stessa. La vicenda rivoluzionaria dovrà essere vissuta integralmente nell’armonica fusione delle varie funzioni, ciò non permetterà la presenza di “credenze” vane, in quanto le credenze non prevedono la possibilità che il fattore discriminante, detto “funzione”, possa essere posto in atto, infatti le credenze consentono solo l’uso del fattore discriminante mistico o irrazionale. In quest’ultimo modo la vicenda rivoluzionaria non viene vissuta dalle masse ma solo subita, nel primo modo invece le masse vivono la rivoluzione anche se sono sempre le “intellighentie” a svolgere la “funzione” di guida. Se questa tesi è in contrasto con Bakunin (fino a che punto?), con Malatesta, con Kropotkin, con Reclus, la cosa ci lascia del tutto indifferenti, in quanto questi pensatori e rivoluzionari non hanno mai costituito per lo scrivente altro che compagni di riflessione e di lavoro, mai simboli o modelli da imitare, e lo stesso dicasi per i vari Marx, Lenin, Mao, ecc., semplicemente compagni di cammino nella lunga strada che le sinistre devono ancora percorrere.
La scienza delle conclusioni affrettate
Dopo l’arte delle deduzioni, la scienza delle conclusioni affrettate. Se nella prima Jacometti si è rivelato maestro, nella seconda è assurto al grado di docente e di luminare. Una brevissima sintesi del mio lavoro a uso di un tipo particolare di lettore costituisce il resto dell’articolo prima dello sfogo finale – che poi occupa più di metà del testo – in cui l’autore mette in mostra la sua vasta erudizione e il suo altrettanto vasto inglobamento.
Questa delle conclusioni affrettate è malattia cronica del giornalismo del nostro tempo, acuita da due tipi di terreno fertile, uno costituito dal foglio politico, l’altro dal compito stesso dell’articolista. I fogli politici sono per indole e disposizione centrale eminentemente diretti a fornire schemi di condotta e di interpretazione. Questo è il loro compito, quindi non c’è niente di strano a vederli agire in tal senso. Per altro anche la cosiddetta stampa di informazione libera ha moventi assai simili, sebbene – di regola – meglio camuffati. Quello invece che muove non tanto lo sdegno quanto la meraviglia è la faccia tosta degli articolisti che pretendono sfuggire – solo loro – alle regole del gioco. L’altro punto, l’altro terreno fertile, è dato dal mestiere stesso di scrivere recensioni, mestiere ingrato che, se fatto con scarso senso della rettitudine, finisce per degenerare malamente.
Nella scienza delle conclusioni affrettate non è possibile rinvenire non solo la “verità” ma anche la più semplice delle cosiddette “verità di prassi”. La struttura stessa del discorso finisce per scadere nel vano soliloquio o nell’inutile preziosismo. È proprio da queste premesse “scientifiche” che l’articolista finisce per accusarmi di saccenteria, in uno con tutta la nuova generazione, alla quale, e di questo lo ringrazio vivamente, mi costringe a fare parte. “Quasi che la Verità fosse stata scoperta dall’ultima generazione tutt’intera e nuda e messa al forno con la solita accusa contro tutto e tutti...”. In pratica quale che sia il nostro debito verso questa “ultima generazione” è certo che esso è di tale dimensione che non potremo mai pagarlo. Quello che questi giovani ci hanno fatto capire è il valore della libertà, l’obsolescenza delle istituzioni, la degenerazione del potere, il decadimento delle tradizionali armi di lotta dei lavoratori, ecc., sono state vere e proprie lezioni salutari, non solo per la vecchia generazione, ma anche per quella di mezzo vissuta e cresciuta durante la guerra, imbevuta di una falsa retorica che si protrasse per quasi un decennio intatta nelle scuole, dopo che l’antifascismo aveva finalmente avuto partita vinta. Ora se il discorso è stato salutare per noi della generazione di mezzo, molto di più lo dovrebbe essere stato per la vecchia generazione, se l’atavica chiusura mentale dei vecchi e il preconcetto rifiuto della novità non avessero smussato i lati positivi della ventata di giovanile rifiuto del sistema e ridotto la profonda lezione che dai giovani ci viene assieme a un messaggio incomprensibile e curioso.
Niente di più che le solite battute degli integrati elogiatori del sistema, chiusi nella patina dorata del loro stipendio, per piccolo che sia, e nella cerchia irreversibile dei loro compromessi, omuncoli che non possono vedere lontano perché hanno barattato il loro intrinseco valore di uomini con l’estrinseca apparenza del partito, della setta, della gang. Non sarebbe stato utile per noi, e ancora meno per i nostri pochi lettori, analizzare in dettaglio l’articolo che ci occupa se Jacometti non avesse creduto opportuno concludere con alcune riflessioni di grande valore dimostrativo non solo di una mentalità coartata, ma anche di una disposizione a interpretare la realtà in modo paradossale ed equivoco.
La condanna delle macchinazioni contro il movimento operaio
Lasciamo stare caro Jacometti questi benedetti nomi che corrono sulla bocca di tutti. Che l’accusa formulata nel mio libro contro la soluzione sindacale come soluzione di lotta sia stata presa a prestito da Adorno e Marcuse è assolutamente gratuito, come affermare che la terra gira attorno al sole, e aggiungere che questa affermazione è presa a prestito da Copernico, è quanto meno ridicolo. Il guaio è che se i giovani non hanno letto Marcuse (ma come è mai possibile fare affermazioni di questo genere?), nemmeno i vecchi articolisti lo hanno letto. Ma non avere letto Marcuse o Adorno non costituisce peccato mortale, una volta che si siano affrontati i problemi sociali che il mondo moderno continuamente mette sul tappeto con l’ausilio di quei testi che via via gli studiosi vanno elaborando. Il guaio – sempre quello – è che siamo abituati a citare a vanvera, senza sapere quello che diciamo, a ripetere nomi e titoli appresi da altri di seconda mano, nomi e titoli che finiscono per andare in circolazione con più credito di quanto in effetti meritano.
La vecchia funzione del sindacato si è ormai svilita in forma definitiva. Una vera e propria macchinazione è stata condotta ai danni del movimento operaio. I dirigenti sindacali hanno costituito una burocrazia che, retta dalle stesse leggi sociali che reggono tutte le burocrazie, non ha nulla da invidiare alla burocrazia statale. In questo modo il sindacato, nato dalla lotta e dal sacrificio personale del lavoratore, è diventato, senza che quest’ultimo quasi se ne sia accorto, strumento del capitalismo. È infatti attraverso il sindacato che il capitalista riesce ad impedire che l’operaio venga completamente stritolato dalla smania di arricchimento che finisce per diventare una forza difficilmente controllabile anche da parte del capitalista stesso, oppure si lanci perdutamente in una lunga lotta contro il capitale, lotta senza speranza, e ne esca definitivamente indebolito risultando non più disponibile come forza lavoratrice. Questa possibilità di impiego del sindacato è stata vista nella sua giusta luce da quei grandi complessi industriali che costituiscono la massima espressione del capitale nelle nazioni più avanzate. Infatti se al piccolo imprenditore il suddetto meccanismo può sembrare stranamente specioso, al grande capitalista, assistito dal vasto complesso della sua attrezzatura tecnico-finanziaria, risulta semplicissimo.
L’articolo che ci occupa è stato scritto nel centro del cosiddetto autunno caldo. Adesso, a un certo tempo di distanza, i lettori potranno dedurre con calma se la mia affermazione riguardo alla perfetta integrazione del sindacato, e l’inutilità degli sforzi sostenuti dai lavoratori attraverso gli scioperi, siano lungi dalla realtà oppure se il discorso contorto del nostro articolista sia stato fatto soltanto per contribuire a indorare la pillola per il piccolo e a ingrossare la polpetta per il grande.
Rivoluzione o riforma?
“È finito il tempo di Blanqui”. Giustissimo. Il tempo di un determinato tipo di rivoluzione è finito. Ma non è finito il tempo delle rivoluzioni. Tanto è vero che l’articolista ci rimprovera di non sapere parlare a sufficienza di “rivoluzione di massa” e di parlare di “rivoluzione di élite”. Ma allora, ci chiediamo con costernazione, se il tempo della rivoluzione è sempre alle porte che senso ha parlare di modifiche, di correzioni. Oppure un senso c’è l’ha ed è il senso che hanno le cose dette dagli ignoranti. La riforma prende in considerazioni la norma, la rivoluzione il valore. Su questa formulazione istituzionale di natura sociologica non possono essere avanzati dubbi. Volendo riformare i partiti si parla appunto di riforma, non di rivoluzione. Un partito, per il solo fatto di esistere, di consentire ai propri rappresentanti di sedere sugli scranni del Parlamento, non è un partito rivoluzionario. Prendendo in considerazione il valore si entra nel vivo delle cose, ed è proprio quello che i giovani hanno fatto, la lezione che hanno dato e che stanno continuando a dare al mondo intero. Nel caso dei partiti ci si chiede se il “valore” del partito non sia ormai del tutto snaturato, nel caso dei sindacati ci si chiede se il “valore” del sindacato non sia del tutto sorpassato e se non ci sia bisogno di nuovi strumenti di lotta, questo è un discorso rivoluzionario per il semplice fatto di essere un discorso distruttivo.
Non volere comprendere la distinzione che passa tra riforma e rivoluzione è l’atteggiamento tipico del conservatore borghese, esausto delle passate scaramucce e desideroso soltanto di apportare opportune modifiche allo stato di cose che bene o male lo soddisfa. Siamo forse alle porte di un nuovo tipo di conservatorismo di sinistra, forse più pericoloso del vecchio rimbecillito conservatorismo pacioccone. Non sarà facile accorgersi del trucco, non sarà facile per gli operai, non sarà facile per nessuno, forse soltanto i giovani se ne stanno accorgendo con profonda chiarezza, e a misura che la loro visione diventa più ampia e dettagliata, il tutto si traduce in una negazione di fiducia ai vecchi schemi rimasti rivoluzionari soltanto sulla carta.
[“La distruzione necessaria. Risposta all’“Avanti!”, pubblicato su “Studi e Ricerche”, 1970, pp. 849-954. L’articolo di A. Jacometti si intitola: “I limiti di certi tipi di contestazione. La distruzione necessaria”, pubblicato su “Avanti!”, 10 dicembre 1969]
Considerazioni sull’“intellighentia”
Mi è stata più volte indirizzata l’accusa, dopo la pubblicazione del mio più recente lavoro (La distruzione necessaria, Catania 1968), di tentare una sorta di nuova strumentalizzazione dell’“intellighentia”, nascondendola sotto le spoglie di un nuovo compito di illuminazione e guida.
Tra gli altri in alcuni “appunti polemici” di imminente pubblicazione Luigi Giusso avanza il dubbio: “…così stando le cose l’‘intellighentia’ si pone come insieme di ‘privilegiati’ (che interpretano, guidano, usano la violenza in certe direzioni e non in altre eccetera)”.
Lasciando da parte l’approfondimento di questa particolare chiusura dell’azione della élite intellettuale, problema che affronteremo in altra sede più esaurientemente, ci pare opportuno svolgere il raffronto tra i limiti tradizionali, che si sono sempre sovrapposti ai compiti concreti dell’“intellighentia”, e le prospettive determinate da una nuova dinamica delle attuali forze storiche.
La conoscenza di queste prospettive è quanto mai utile volendo avere un’idea di ciò che intendo per “possibilità rivoluzionaria” e per “disintegrazione delle masse”.
Generico e vastissimo è stato in passato il compito degli intellettuali. Ogni Weltanschauung ne presupponeva uno sufficientemente circoscritto e reclamizzato. Ogni generalizzazione scientifica, che dal mondo del vago amava procedere a quello tangibile della società, ne descriveva uno, a volte anche più di uno.
Come risultato si aveva un accavallarsi di compiti, tutti diversi, sebbene tutti diretti a fissare i termini del predominio della massa intellettuale, eletta al rango di classe detentrice e custode della cultura.
Un’etica particolare lavorava indefessamente a costruire compartimenti stagni al fine di rendere impenetrabili i distretti d’azione di ogni singola attività culturale. La stessa collaborazione tecnica veniva spesso ostacolata, con la scusa della necessità della specializzazione. Ogni tentativo di superamento incontrava sempre l’accusa del “pressappochismo”, del “dilettantismo”.
Strumento validissimo di questa “chiusura” sono state le istituzioni culturali, università in testa. Animate da uno spirito di parte, per non dire di feudo, le ricerche condotte da queste istituzioni risultano quasi sempre riducibili al rango di attività “occasionaliste”, di scarsa incidenza sulla realtà culturale.
D’altro canto la scarsa incidenza dal punto di vista della ricerca istituzionale non deve considerarsi un difetto, ma un pregio. Un lavoro che non turba i sogni della scala piramidale degli studiosi del settore è sempre “un lavoro ben fatto”, per non parlare poi di quei lavori che si prefiggono la manutenzione pura e semplice della struttura.
L’intellettuale radicale risultava quindi un disinserito, un outsider, e come tale impossibilitato materialmente a svolgere un’azione qualsiasi.
Questo quadro si colloca assai difficilmente in un tempo determinato. La strumentalizzazione della cultura ad opera della “classe” intellettuale è un fenomeno che si ripresenta parecchie volte nella storia. Il fatto poi che l’ingerenza del radicalismo non sia così ben determinabile come compatta azione ordinatrice dell’intellettualismo dominante, contribuisce a rendere confuso il processo di sviluppo temporale del fenomeno.
Senza dubbio una ricerca storica in questo senso si tradurrebbe immediatamente in una storia delle ideologie, visto che queste coperture della realtà non nascono come i funghi ma sono coltivate e volute proprio dalla classe che conosce il meccanismo della loro nascita e della loro sopravvivenza. Per altro l’insegnamento che se ne ricaverebbe non farebbe rimpiangere del tutto il tempo perduto.
Ma quello che ci preme in questa sede è dare conto di un fenomeno contingente: la presa di coscienza dell’intellettuale di fronte alle responsabilità che oggi gli sono proprie. Sia pure a titolo di eccezione, oggi si può parlare di un’apertura agli interessi sociali in senso lato, interessi quindi non di classe ma di umanità.
Non che questo si traduca in un banale pianto sul latte versato, cosa che da sempre è stata fatta dagli “intellettuali del sistema” e che deve considerarsi come la pantomima conclusiva del processo di restaurazione della struttura, in altri termini una forma di lasciapassare per l’ingenuo continente del radicalismo teorico e metafisico.
Oggi una posizione del genere farebbe ridere, quando non muoverebbe allo sdegno.
In definitiva la presa di contatto con le nuove (o antiche?) responsabilità gli intellettuali la fanno senza meravigliarsi dei fenomeni del contingente sociale, senza accampare giustificazioni o interrogazioni giustificative. È in ogni caso un viaggio in un mondo nuovo, affascinante ma pericoloso, capace di attirare gli “ospiti del sistema”, cioè coloro che nel sistema stanno “scomodi”, che ne avvertono continuamente le contrazioni e gli stimoli. La nuova figura di intellettuale responsabile è diversa dalla tradizionale figura del “radicale”. La differenza si basa su di un rifiuto del contesto metafisico, rifiuto successivo al riconoscimento che il dilemma dell’accettazione della metafisica non doveva essere risolto necessariamente in modo inverso a quanto il sistema aveva decretato (rifiuto della metafisica) solo perché in quel modo era possibile contrastare o differenziarsi dal sistema stesso. Infatti non occorre molta fantasia per capire come una posizione del genere equivale a quella dello struzzo che nasconde la testa sotto la sabbia davanti al pericolo.
Nel rifiuto della metafisica non si ha un avvicinamento al sistema, malgrado che questo propone lo stesso genere di rifiuto, ma una posizione equidistante in vista del raggiungimento di fini ben diversi.
Esploratore però non significa sognatore, almeno non necessariamente. Esploratore significa sempre scienziato e scienziato significa anche metodologo. L’apologista, quando anche alberghi sotto sotto, quando anche volesse riaffiorare allo scopo di dettare i termini dell’esaltazione del nuovo compito, deve essere messo a tacere.
[1968] [“Considerazioni sull’intellighentia”, pubblicato su “Azione socialista”, Marzo 1969]
La distruzione necessaria: risposta a Luigi Giusso
Ritorno volentieri sui problemi affrontati ne La distruzione necessaria cogliendo l’occasione dagli Appunti polemici pubblicati da Giusso su questa stesso periodico (“Studi e ricerche”, 1969, pp. 807-817).
La mia non vuole essere una controdeduzione polemica, quanto un semplice chiarimento in linea con i frequenti articoli che in questi ultimi tempi ho dovuto scrivere sulla stampa periodica e quotidiana in difesa del mio lavoro.
Il conservatorismo di Luigi Giusso
È per nostra guida che Giusso, fin dall’inizio del suo articolo, ci indica i tratti schematici di un conservatorismo che condanna a priori qualsiasi «proposta di distruzione degli ordinamenti sociali esistenti». In questo modo ogni dubbio sui limiti del nostro critico è fugato fin dal principio.
Solo che questa chiusura conservatrice non ha fondamento valido al di là di quello che in effetti possiede a profusione: l’impossibilità o la cattiva volontà di autocostringersi a pensare il non pensato. Per sua natura il conservatorismo è legato all’ordine esistente, ma di questo suo legame non può dare spiegazione migliore di quanto il radicalismo può dare della sua necessità di rompere l’ordine stesso.
Ecco infatti che Giusso, nel tentativo di localizzare il punto debole di una proposta risolvente lo stato attuale dell’organizzazione sociale, è costretto per la natura stessa della sua posizione di pensatore a fermarsi sul presunto “perfezionismo” della mia tesi rivoluzionaria, affermando impossibile un “ordine sociale moralmente perfetto”. Ma nessuno mai si è sognato di ammettere una cosa simile. Sarebbe in altri termini come volere sostituire l’assoluto negativo della società attuale con l’assoluto altrettanto negativo di una società costruibile solo sui fioriti sentieri dell’utopia. Attribuire smanie perfezioniste è stato sempre facile nei riguardi di ogni tentativo radicale di riforma sociale. Inutile precisare che anche il cristianesimo, fino ai chiarimenti agostiniani, ebbe frequentemente accuse di questo genere.
L’ordine sociale non può essere per sua natura perfetto, per il semplice fatto che è fenomeno relativo all’uomo e alla sua storia. Volergli dare una forma definitiva, conclusiva, significherebbe fermare la storia e la vicenda umana considerare conclusa, in senso costruttivo, o abortita (questo non avrebbe importanza), in funzione di una tematica astratta spacciata per superiore. Tutto ciò è molto lontano dalla nostra concezione. Noi abbiamo individuato alcuni mali che affliggono la società contemporanea nelle sue forme più complesse e sviluppate a fondamento consumista, abbiamo valutato le radici di questi mali, li abbiamo ritenuti incurabili con le solite procedure riformiste, ne abbiamo tratto la conclusione di una cura più radicale: quella della rivoluzione e della distruzione. Da questo ad auspicare una società perfetta, crediamo che la differenza non sia trascurabile.
Un punto della premessa di Giusso ad uso del lettore ci è parso errato, sebbene anch’esso concorra a determinare la caratteristica conservatrice della sua posizione. Egli dice: “Chi scrive non crede alla possibilità di sistemi sociali totalmente diversi da quelli storicamente sperimentati”. Ma questa affermazione è straordinaria. In questo modo si corre il rischio di lasciarsi passare sotto il naso la realtà storica aspettando che riceva il crisma della validità che solo dal passato può derivare. Ma gli uomini la pensano diversamente. La vita è dinamismo, collisione, lotta, tentativo, fallimento, vittoria. La vita è metodologicamente pragmatica e se ne infischia di tutti gli idealismi e storicismi di buona memoria. Ragionando in questo modo il sistema sociale romano, fondato sempre sulla guerra ma anche sui commerci, non avrebbe dovuto avere diritto di cittadinanza. Nel mondo ellenico il passaggio dalla economia naturale a quella monetaria non avrebbe dovuto mai esserci, l’avvento dell’era industriale dovrebbe essere tutt’ora un grosso punto interrogativo per gli storici. Il fatto è che le forme sociali si evolvono continuamente, tanto da potere con grandi difficoltà e per grosse linee identificare le caratteristiche di una determinata forma. Spesso si deve ricorrere a partizioni di tempo e di luogo frazionatissime per cogliere l’essenza di un sistema sociale, che studiato nella sua vasta generalizzazione rischia di risultare troppo vago e impreciso. Una partizione, poniamo tra sistemi sociali capitalisti e sistemi sociali collettivisti, è tanto vaga da restare inoperante. Le differenze tra il capitalismo americano e quello italiano o quello spagnolo sono tante che lasciano perplesso lo studioso e fanno dubitare della validità operativa di simili partizioni. Le differenze tra il sistema sociale italiano attuale e quello di appena dieci anni fa sono tali da stupire lo studioso che per poco ci si soffermi. Il semplice permanere di istituzioni non è guida sufficiente per l’identificazione di una statica sociale. Al di dentro delle istituzioni una dinamica complessa di trasformazioni è sempre in atto.
A prescindere delle perplessità che la premessa di Giusso ci ha fatto sorgere, perplessità di cui abbiamo or ora dato conto al lettore, è doveroso aggiungere che la posizione da assumere nei confronti dell’ordine esistente deve essere sempre di natura critica. I motivi che rendono valida questa affermazione sono quanto mai evidenti. Uno studioso disinteressato non indirizza la propria attività a catalogare i lati positivi del sistema e a illustrarli.
Infatti è legge sociologica fondamentale che l’istituzione sociale ha come prima preoccupazione la propria sopravvivenza, per cui un minimo di positività deve essere posta in atto dalla sua azione allo scopo di fronteggiare la parte negativa, e questa positività sarà fatta passare attraverso le larghe maglie della propaganda politica o quelle strette della coercizione poliziesca. Lo studioso di problemi sociali deve indirizzare la propria attenzione sulla parte negativa, svolgendo una critica al sistema che consenta di denunciare i mezzi di prevaricazione e di sopruso in atto, per mezzo dei quali da una indiscutibile positività parziale si passa a una fantomatica positività totale. E questo dovere è pienamente avvertito da Giusso, anche se nelle note che veniamo esaminando non ne dà la giusta misura al lettore.
Il compito dell’“intellighentia”
Una valida obiezione ci viene mossa quando Giusso denuncia la possibilità che l’“intellighentia” tradisca il suo compito di “guida” per ritornare ad assumere il compito tradizionale di “comando e di potere”. Tutto ciò è molto giusto e si tratta di una possibilità concreta e non solo teorica. Fissare a priori il compito dell’“intellighentia” e limitarlo a quello di “guida” non significa eliminare la possibilità che alcuni componenti questa élite facciano prevalere il loro istinto di rapina e di dominio. Dare per scontata una eventualità del genere significherebbe dettare un’affermazione utopistica senza validità scientifica. Ma il nostro problema non era così semplice. Quando parlammo nel nostro lavoro del compito dell’“intellighentia” parlammo pure della necessità di una disintegrazione di questa élite, cioè di una separazione del processo integrativo e globalizzante posto in atto dal sistema. Solo a queste condizioni si può programmare un compito di guida per evitare il pericolo di un ritorno ai precedenti moduli autoritari. Come di fatto questo possa avvenire è problema di situazioni di fatto, tali che impediscono la nascita e lo sviluppo di questa irrefrenabile tendenza. Queste situazioni di fatto grosso modo si possono riassumere in sede non analitica in una sostituzione del tradizionale sistema autoritario con un sistema funzionale. In altri termini all’autorità riconosciuta brutalmente in base a generici attestati di appartenenza a un determinato gruppo – donde situazioni di fatto irrimediabilmente legate alla cecità di un simile procedimento discriminatorio – andrebbe sostituita la “funzione su delega dei singoli gruppi” – da cui situazioni di fatto legate al controllo dei vari gruppi e difficilmente attaccabili dalla megalomania del singolo individuo.
Ecco perché proponemmo come necessaria la disintegrazione dell’“intellighentia” in quanto, senza questo processo preventivo di rottura e con i procedimenti cari al sistema di autorità e di brutale adesione alla categoria e alla classe, diventa illogico pensare a una sia pure futura sostituzione dell’attuale processo autoritario di risoluzione delle situazioni di fatto con un processo libertario fondato sulla funzione e sulla delega.
Una questione di terminologia
Altra accusa di Giusso mossa al nostro lavoro nel suo complesso ed in particolare al nuovo stato di cose da fondarsi sull’uguaglianza, sulla giustizia e sull’equità, è basata sul fatto che questo nuovo ordine non sarebbe definito con precisione, mentre solo con grande “vaghezza” si fa riferimento a una “morale del costruibile” da collocarsi al di là della generale distruzione. Qui il discorso minaccia di complicarsi per questioni d’indole terminologica e non sostanziale. Aggireremo l’ostacolo preferendo specificare il significato delle parole “uguaglianza”, “giustizia”, “equità”, che non sono affatto parole – come afferma Giusso – alludenti a concetti «vaghi e forse mai definibili univocamente».
Col termine uguaglianza s’intende, nel senso della teoria sociale, condizione di uomini aventi uguali diritti e uguali doveri. È ovvio che questa definizione finisce per diventare meramente teorica, sia nel più ampio grado della vita economica che nel più ristretto e tradizionalmente legato al concetto di uguaglianza della vita giuridica di un popolo. Che cosa significhi avere uguali diritti e uguali doveri non è ben chiaro, quando non si pone in evidenza in che modo la condizione di fatto – ed in modo particolare la condizione di partenza – renda possibile l’esercizio dei propri diritti e lo strano connubio con i propri doveri. È palesemente chiaro che le condizioni di fatto in cui è stato giudicato un Bazan non possono considerarsi uguali a quelle in cui viene giudicato un qualsiasi ladruncolo sorpreso a rubare frutta. Se validi dubbi restano in quella che è stata considerata da sempre (almeno dal momento della prevalenza del regime democratico e delle teorie illuministiche) come la roccaforte dell’uguaglianza, cioè nell’applicazione concreta delle leggi penali, quanti saranno i dubbi negli altri settori? Quanti in quello economico?
È ovvio che un eufemismo come quello contenuto nella nostra Costituzione, con il quale si assegna allo Stato il compito di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e la eguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana”, rende ancora più nebuloso sia il processo per mezzo del quale questa condizione di uguaglianza deve essere posta in atto, come la stessa natura di questa uguaglianza.
Cullarsi sulle parole che in una democrazia libera ognuno deve avere la possibilità di sviluppare la propria personalità fino a giungere all’esercizio di funzioni direttive e di governo, fino a superare gli ostacoli della classe d’origine, sorpassando gli eventuali residui della casta o del censo, diventa pura retorica. In pratica tutto ciò non è possibile. Lo stesso meccanismo che garantisce la sopravvivenza delle classi, che cura il perpetuarsi della condizione di privilegio della élite governante, contribuisce a mantenere i livelli e le gradualità. Se qualcuno sfugge per particolari doti personali di costanza, di fede, di intelligenza, si tratta di una osmosi talmente esigua da non destare preoccupazioni.
Le strutture istituzionali di uno Stato democratico rendono impossibile il raggiungimento di una condizione di fatto di vera uguaglianza tra gli uomini per carenza di autorità. In altri termini la struttura democratica non possiede la sufficiente forza coercitiva per consentire dall’alto dell’istituzione di stabilire una vera uguaglianza di fatto tra gli uomini. Ma un potere coercitivo del genere, quando anche riuscisse a mantenere per lungo tempo l’uguaglianza raggiunta con la forza, non sarebbe tirannia? Ed allora l’alternativa sembra senza via di uscita. Da un lato la debolezza delle situazioni “democratiche” che non possono, per loro stessa intima costituzione, eliminare la diseguaglianza e i frazionamenti classisti, dall’altro l’eccessiva forza delle istituzioni totalitarie che – nel caso volessero stabilire veramente un regime di uguaglianza – finirebbero per creare dei “sistemi mostri”, negati a ogni possibilità di progresso.
Chi ci ha seguito fin qui avrà ormai capito che l’impossibilità di cui si parla non è tanto quella di giungere a una vera uguaglianza di fatto, quanto quella di giungerci attraverso le normali strade istituzionali. Sostenere che l’uomo è naturalmente diseguale, perché dotato in modo diseguale di possibilità fisiche e intellettuali, è una semplice constatazione, ma sostenere questa tesi per giustificare la persistenza della disuguaglianza nell’àmbito del processo sociale è una vera e propria stortura ragionativa. È logico che la dottrina dell’uguaglianza sociale non vuole trasformare gli uomini in automi prodotti in serie, vuole solo che le discriminazioni, le gradualità, le chiusure classiste, le rivalità antinomiche, in una parola tutto ciò che suona “inferiore” e che si paga nella moneta sonante della sofferenza e dell’afflizione, della schiavitù e del dominio dell’uomo sull’uomo, venga abolito. Ogni altra differenza culturale, intellettuale, fisica, non solo non deve essere eliminata ma deve considerarsi come base di ogni possibile società, in quanto nella società diversi e di diverso livello d’impegno sono i compiti di ciascuno.
Con il termine “giustizia” si intende comunemente la virtù morale in forza della quale si giudica rettamente riconoscendo l’altrui diritto. Ma questa è. una definizione di ordine pragmatico e non ci dice nulla in merito alla vera sostanza del concetto di giustizia. Da ciò trova origine la confusione corrente tra giustizia in senso formale e giustizia in senso materiale. Il problema così ben centrato da Max Weber e da Charles Horton Cooley è purtroppo oggi di nuovo sottovalutato nelle sue immediate implicazioni rivoluzionarie. Il concetto di giustizia sostanzialmente si presenta come sinonimo di uguaglianza in senso proudhoniano. Mentre con il termine di uguaglianza intendiamo una condizione di fatto, con il termine giustizia intendiamo una condizione di diritto. In entrambi i casi la fattispecie è identica, solo che si presta ad essere considerata sotto due aspetti diversi, ed è proprio per valutarla in questi due modi che correntemente si usano i due termini di cui sopra come denuncianti una effettiva differenza sostanziale. La saggezza dell’antica definizione justum aequale est injustum inaequale non può essere facilmente messa in dubbio. Da ciò deriva la caratteristica indipendenza del concetto di giustizia da quello di morale, concedendo solo l’appartenenza dell’idea di giustizia all’àmbito generico delle idee etiche. Quindi nessuna origine di ordine trascendentale, nessuna relazione con una presunta “bontà intrinseca” dell’uomo o con una presunta “socialità intrinseca”, solo e semplicemente una diretta dipendenza con il “senso dell’uguaglianza”, con la “coscienza del diritto”, che sono componenti determinanti della nostra vita sociale.
In questo modo il concetto di giustizia esce dal vago in cui purtroppo, come giustamente nota Giusso, spesse volte l’uso sconsiderato l’ha ricacciato e può essere utilizzato nel senso efficacemente produttivo di uguaglianza.
Con il termine “equità” si intende l’essere giusto, l’essere moderato ed equilibrato. Il significato che questo termine assume nel campo degli studi sociali è assai vicino al primitivo concetto di uguaglianza, con un accento maggiore per quanto riguarda il momento distributivo. Mentre il termine uguaglianza indicava una situazione di fatto concretizzatasi, ed il termine giustizia una situazione di diritto concretizzata o da concretizzarsi, il termine equità indica processo distributivo da seguire per ottenere quella situazione di fatto di uguaglianza nell’àmbito della più generale situazione di diritto.
Visto sotto questo aspetto particolare, anche il termine equità cessa di risultare vago per diventare concretamente accessibile a una valutazione empirica. Se nel processo che determina la situazione di fatto non si verifica una sostanziale uguaglianza, il risultato non potrà essere miracolosamente una uguaglianza terminale, ma sarà una differenziazione di classe, la qual cosa non potrà rientrare, se non a forza e in piena contraddizione, nel principio generale di giustizia egualitaria.
La morale del costruibile e la nuova società
Giusso nota come in accompagnamento alla generale imprecisione riguardo al nuovo “ordine sociale” si associ una imprecisione non minore nel definire che cosa si debba intendere per “morale del costruibile”. Infatti continua: “pensare a fondo un nuovo ordine è cosa difficilissima”, per cui occorre sottoporre al banco di prova di ciò che si vuole costruire ogni proposta rivoluzionaria.
Vediamo di fermarci per un attimo a queste notazioni critiche, per chiarire un punto di partenza che riteniamo essenziale. Il nostro saggio, come ormai dovrebbe essere chiaro a tutti i lettori, non si poneva problemi relativi al momento costruttivo, solo problemi relativi al momento distruttivo. Questa affermazione è tanto difficile da tenere presente per chiunque affronti le non molte pagine del nostro lavoro? Alle domande poste dai problemi costruttivi il nostro saggio non risponde, se non con brevi riferimenti che si possono intendere a titolo di personale supposizione, ma che non possono avere in alcun modo valore costitutivo. Quando lo scrivente usa il termine “morale del costruibile” non si riferisce a una particolare morale da porsi in contrapposizione di sostanza con la morale della distruzione. La morale è sempre un tutt’uno, e quindi inscindibile, si tratta di una posizione particolare della morale nei confronti dei valori che la fondano. Mentre nella morale del costruibile vengono tenuti presenti determinati valori, nella morale della distruzione sono altri valori a essere ritenuti validi. Volendo determinare in concreto che cosa si intende per morale del costruibile, avremmo dovuto indagare sui valori del momento costituente e dettare quindi i termini effettivi di quel nuovo ordine sociale cui la distruzione serve da anticamera. Ma questo ci avrebbe portato fuori dal nostro compito esclusivamente introduttivo.
Da ciò deriva che quando Giusso ci rimprovera due ordini di imprecisioni, riguardo alla genericità del nostro concetto di morale del costruibile e riguardo l’assenza della nostra idea di nuovo ordine sociale, possiamo rispondere che l’imprecisione è una sola, e che non si tratta di imprecisione ma di limitazione del compito assegnatoci nel nostro lavoro.
L’ultimo punto dell’affermazione di Giusso non ci trova consenzienti. Non è affatto vero che l’unico banco di prova di ogni proposta rivoluzionaria è dato dall’esame del nuovo ordine che si intende costituire. Se la cosa si pone in questi termini non esiste proposta rivoluzionaria, per quanto dettagliata e utopisticamente sicura del nuovo ordine propagandato, che non finisca per cadere nell’assurdo e nel ridicolo. L’assurdità e la comicità gli perverranno attraverso il contrasto che il nuovo ordine avrà con il vecchio, così contamineranno la potenza distruttiva della proposta rivoluzionaria, la getteranno in pasto ai sofismi e alle argomentazioni letterarie invece di mantenerla pura, nel grado più elevato dell’azione concreta.
La proposta rivoluzionaria del cristianesimo diventa cosa assai comica e assurda se viene brutalmente messo a confronto il mondo romano con l’ideale di vita cristiano. Quello che nel primo era virtù, nel secondo è considerato barbarie e viceversa. In questo modo non c’è soluzione al problema di individuare una vera sostanza di costruibilità, restando al di qua nell’àmbito delle vecchie strutture. Ogni sguardo che viene lanciato sul nuovo ordine sociale presume di trovare la continuità di quelle strutture ritenute in buona fede di impossibile sostituzione.
Tirannia o libertà
Partendo dal dato di fatto, a nostro avviso indiscutibile, che il presente ordine di cose deve andare distrutto, resta da esaminare il metodo più agevole e plausibile di operare questa distruzione. Questo metodo l’abbiamo individuato nella collaborazione di tutti i gruppi, indipendentemente dalle ideologie di sostegno che abbiano interesse a non perpetuare una tradizione di soprusi e di privilegi.
Una volta ammesso ciò è ovvio dedurre che questi gruppi dovranno, al termine della distruzione, affrontare il problema concreto del momento costituente, dovranno cioè dare prova di essere in grado di dettare un ordine nuovo e differentemente impostato dal precedente. È inutile illudersi che questo momento costituente venga affrontato con calma, dato anche che non sarà un momento che potrà prolungarsi per molto tempo, le decisioni andranno prese subito e senza eccessive riflessioni. Da queste premesse di disordine e di distruzione, per eliminare quelle forze reazionarie residue intrufolatesi nei gruppi rivoluzionari, come pure per chiarire le effettive proposte dei singoli gruppi, non è illogico presupporre un prolungamento della lotta.
Tutto questo discorso non mi sembra affatto l’anticamera di una proposta di tirannia definitiva, mentre debbo condividere che ha molti aspetti del classico colpo di Stato, sebbene risultino evidenti le sostanziali differenze presentandosi non come movimento di élite militaresca o di destra ma come generale movimento popolare di sinistra.
Se il presente è decisamente antisociale e tirannico, se la distruzione ci appare veramente necessaria, un futuro che presenti sia pure delle probabilità di riuscire più libero, malgrado non possa prospettarci delle “certezze” di libertà, ci pare auspicabile.
Violenza privata e violenza rivoluzionaria
La rivoluzione non deve collocarsi nell’àmbito di una “morale del costruito”, altrimenti rischia di cadere nella condanna etica, così come tutti i sommovimenti popolari, dalla grande rivoluzione francese a quella russa, a quelle di minore ampiezza dei nostri giorni, possono essere severamente criticati dal punto di vista del reazionario seduto sulla sua calda poltrona. Ragionando in termini consumisti (tanto per dare l’idea di una mentalità più che di una data situazione economica), non si può parlare di rivoluzione senza cadere nel ridicolo dell’utopia. Ecco perché la violenza privata è “delitto”, mentre la violenza rivoluzionaria è giusta azione rivendicatrice dei propri diritti.
Basta che per un momento si interrompa il rapporto tra morale della distruzione e rivoluzione, basta che al primo termine del rapporto si sostituisca la morale del costruito, perché un solo delitto anche con tutte lo migliori intenzioni può arrivare a squalificare tutta una rivoluzione. La violenza privata è condannabile perché intacca i valori che fondano la morale del costruito restando nell’àmbito della stessa morale. La violenza rivoluzionaria, pur intaccando gli stessi valori, non è condannabile perché si mantiene nell’àmbito di una morale diversa, quella della distruzione.
La rivoluzione permanente personale è davvero possibile?
L’obiezione di Giusso coglie uno dei punti critici dello sviluppo del momento rivoluzionario. La preparazione alla lotta definitiva e conclusiva contro il sistema diventa possibile solo se portata a termine dal singolo nel ristretto àmbito delle sue possibilità personali come “rivoluzione permanente personale”. Che questa disposizione di coscienza sia di una certa difficoltà di attuazione non ce lo nascondiamo, che occorrano individui eccezionali per illuminare gli altri sulla necessità di questa preparazione e sui risultati positivi che da essa ci si deve aspettare, è cosa ovvia trattandosi del naturale momento didattico di ogni dottrina, ma che tutto questo implichi la conseguenza che questa disposizione di coscienza diventi patrimonio di una élite particolarmente dotata mi sembra eccessivo. In questo modo non si tiene sufficientemente conto della forza diffusiva delle normali vie di comunicazione di massa. Tanto per fare un esempio, in quei paesi dove è ammessa la propaganda antireligiosa, come in Russia, gli atei ufficialmente accertati raggiungono una cifra censita nel 1955 di oltre venti milioni di persone. (Cfr. Introduzione al volume La religione nell’U.R.S.S., Milano 1961). Certo non si possono considerare una élite una massa di 20 milioni di persone, mentre dal canto suo la posizione dichiaratamente atea, specie in paesi di antiche tradizioni religiose, come la Russia, prevede una notevole profondità di senso critico e di autocontrollo morale.
La rivoluzione deve essere necessariamente un movimento di masse. Il tempo della rivoluzione di élite è ormai definitivamente trascorso. È naturale che le masse devono essere portate al proprio risveglio con una accurata opera di propaganda e di penetrazione, opera che potrà essere condotta a buon fine solo attraverso l’intermediazione dell’“intellighentia”. Ma questa intermediazione non deve acquistare il senso autoritario della presa di potere, ma solo quello ben altrimenti efficiente della attuazione di una funzione.
Il singolo componente dell’élite deve rendersi conto che le sue particolari condizioni di preparazione personale lo rendono adatto, o per lo meno più adatto di altre persone con minore preparazione professionale, a svolgere un determinato compito nell’arco generale delle necessità rivoluzionarie. Questa sua posizione non è affatto una posizione privilegiata ma solo una posizione differente nella scala delle funzioni. È ovvio che se il movimento rivoluzionario dovrà condurre a termine un piano distruttivo, questa azione dovrà essere diretta dai tecnici della distruzione cioè da specialisti provenienti o dalle scuole militari del sistema o dalle organizzazioni rivoluzionarie di preparazione alla guerriglia. D’altro canto, poiché queste ultime il più delle volte – data la scarsa possibilità di movimento all’interno del sistema lasciata alle forze rivoluzionarie – esistono solo sulla carta, non resta altro che la prima soluzione: affidare il compito predetto a specialisti provenienti dalle scuole militari del sistema, come dire ad appartenenti all’esercito.
Questo grave problema è tipico di tutta l’impostazione rivoluzionaria, ed è spesso sottovalutato da tutti i teorici. Non possiamo illuderci di attuare una rivoluzione non violenta. Ammettendo la necessità della rivoluzione violenta, dobbiamo ammettere pure la necessità di fare ricorso all’opera di questi tecnici e ai metodi autoritari che questi tecnici sono abituati a mettere in atto. Anche una rivoluzione estremamente libertaria, se non anarchica come il movimento machnovista, venne impostata sulla formazione di un esercito vero e proprio condotto da un tecnico della guerriglia: Machno. I risultati che si ebbero in Ucraina, sebbene solo parziali, possono servirci da utile guida. Immense regioni vennero destatalizzate, organizzazioni libertarie dei lavoratori presero il posto della burocrazia locale, tutte le strutture del regime precedente vennero distrutte, ma la presenza di quell’esercito era sempre un pericolo costante. Il risultato definitivo fu la vittoria dell’Armata Rossa, sia pure raggiunta tramite l’inganno e il tradimento, comunque possiamo dirci certi che si sarebbe avuta una terribile “coda rivoluzionaria” in caso di vittoria definitiva del movimento machnovista per stabilire il nuovo ordine delle cose.
Teoricamente l’incaricato della funzione di attuare il piano distruttivo deve essere sempre in grado di riconoscere i limiti del proprio incarico di fronte ai rappresentanti della comunità incaricante, i quali a loro volta devono dare conto della funzione svolta in seno al proprio mandato di rappresentanza temporanea. Ma questo problema del rapporto funzione-autorità, del punto in cui la funzione travalica nell’autorità, è ancora insufficientemente sviluppato e forse non potrà mai essere chiarito in modo tale da evitare brutte sorprese in avvenire al momento concreto della rivoluzione. È proprio per questo che abbiamo parlato di “coda rivoluzionaria”, in vista di una constatazione pratica piuttosto che di una conseguenza teorica.
Certo la rivoluzione permanente personale può contribuire molto a rendere chiare le idee dei limiti della funzione e a trasformare l’autoritarismo in libertarismo. Solo che come momento essenzialmente intimo potrebbe non dare subito i risultati che teoricamente sembrano ottenibili.
[“La distruzione necessaria. Risposta a Luigi Giusso”, pubblicato su “Studi e Ricerche”, 1969, pp. 807-817. L’articolo di L. Giusso si intitola: “Appunti polemici”]
Contributo al concetto di violenza rivoluzionaria
Abbastanza di frequente, in questi ultimi tempi, ho dovuto fare fronte a richieste di chiarimenti e risposte dirette a correggere alcune deviazioni del mio pensiero in merito al problema della contestazione.
Spesso gli attacchi mi sono venuti dalla parte che chiamerei conservatrice, intendendo stabilire un rapporto di dipendenza tra noi che, nel giusto o nell’ingiusto, andiamo avanti e coloro che si limitano a sottolineare le divergenze tra il nostro pensiero e la “santa” tradizione del diritto e dell’autorità. Contro costoro il mio compito è stato quanto mai facile, debbo convenire che oggi anche la grossa congerie del conservatorismo ha saputo adeguarsi ai tempi e alle nuove idee, ma è stato piacevole perché avevo davanti avversari che intimamente disprezzavo e mi era gradevole colpirli nei loro punti deboli e smontarli. Oggi invece mi attende un compito più difficile, il lavoro che Viola ha condotto recentemente sul mio libro La distruzione necessaria abbisogna di alcuni chiarimenti non tanto in difesa della mia posizione dottrinale, quanto per un rispetto verso il lettore che potrebbe essere messo su di una strada errata dalla lettura dell’articolo di Viola.
Premetto che Viola ha tanti punti in comune con il mio modo di affrontare i problemi della società contemporanea, non ultimo il comune apporto che da molto tempo diamo alla distruzione dell’idea religiosa e alla fondazione di un ateismo cosciente. Proprio per questo non nego il mio imbarazzo e la mia delusione nel non trovarmi vicino un uomo che so per certo si trova sulla mia stessa linea di combattimento. Comunque vediamo di chiarire alcune cose.
Io affermo, ancora una volta, sebbene ormai dovrebbe essere chiaro a tutti, che la distruzione dell’ipoteca statale può avvenire solo con l’azione rivoluzionaria violenta, diretta a colpire alle fondamenta l’impalcatura statalista e burocratica, diretta a causare il disordine più grande e deleterio alle strutture dell’organizzazione borghese, diretta a fare piombare nella disperazione le tronfie sicurezze delle attuali élite governative.
Non mi intimorisce affatto il pensare che in questa mia idea io possa “fare torto” al grande Bertrand Russell o a qualche altro pensatore della stessa portata internazionale. Pure essendomi formato alla scuola delle ricerche storiche e di erudizione, pure avendo condotto personalmente ricerche di carattere specialistico sul pensiero di molti grandi studiosi del passato, non ho mai cessato di anteporre il mio pensiero a quello degli altri, sforzandomi di impiegarlo nei modi che potessero condurre a chiarimenti e non a semplici testimonianze, che per quanto valide o autorevoli restano sempre soltanto testimonianze.
La rivoluzione non può essere che violenta. La violenza non deve farci paura, essendo il fondamento “naturale” del nostro organismo. Questa affermazione che Viola scambia per un omaggio all’analogia evoluzionista o biologica, quella stessa analogia che condusse Joseph Arthur Gobineau e gli altri a preparare il terreno ai vari Rosenberg, che più direttamente fondarono la teoria nazista, non ha niente a che spartire con quella teoria. Su questo punto ho lungamente scritto in un saggio apparso su “Quaderni di cultura contemporanea” n. 2, 1968, dal titolo “I pericoli dell’analogia nelle scienze sociali”. Ciò non toglie però che l’uomo sia fondato su di un istinto di lotta e di sopraffazione, intendendo in questo modo che l’uomo può albergare all’interno del proprioio altri istinti, quale ad esempio quello antitetico di collaborazione e di solidarietà, ma di regola è l’istinto di lotta che prevale.
Da questa premessa ricaviamo un insegnamento che ci appare molto utile: questo istinto può essere utilizzato per dirigere l’uomo verso la propria libertà, basta saperlo valutare nella pienezza delle sue possibilità, basta non farsi illusioni sulla portata degli altri istinti e sulle possibilità che davvero riescano a prevalere per spontanea germinazione sull’istinto base della violenza e della lotta. Tutto ciò non ci pare condannabile dal punto di vista libertario. Infatti per condannarlo occorrerebbe che ci si facesse carico di idee non nostre, come sembra che Viola cerchi di fare. Non è nostra l’idea di strumentalizzare questa violenza a fini demagogici, non è nostra l’idea di volere gettare le basi di una rivoluzione da élite, non è nostra l’idea di volere manovrare le masse secondo fini di potere e autoritari. Tutto ciò l’abbiamo anche potuto dire, ma per fini e in forma assai diversi. Ecco perché diventa assolutamente necessario che il lettore sereno e non prevenuto prenda contatto con il nostro lavoro prima di acconsentire pienamente alle pretese esegetiche di Viola. Se questo dovesse accadere dopo la lettura del nostro libro, anche il lettore dissenziente avrebbe incondizionatamente tutta la nostra stima.
L’errore principale della critica di Viola risiede nelle prime parole dell’articolo: “Il saggio vuole inserirsi nel vivo del fenomeno della contestazione e suggerire uno sbocco decisivo per rifare il tessuto sociale dalle fondamenta”. Ma quando mai sono state queste le nostre pretese? Se proprio in antefatto abbiamo affermato, in forma difficilmente equivocabile, che il nostro lavoro sarebbe stato un semplice colloquio tra amici, niente di scientifico e pertanto niente di completo. D’altro canto come si potrebbe pensare di giungere a conclusioni, sia pure approssimative, sul grandioso problema sociale contemporaneo in appena cento pagine?
Il nostro lavoro aveva scopi e limiti ben precisi. In particolare intendevamo chiarire una sola cosa: il momento rivoluzionario deve inserirsi in un suo particolare clima etico, quello della distruzione. Se il momento rivoluzionario si pone in raffronto con l’etica del costruito, oppure se lo si proietta nell’immensità futura dell’etica del costruibile, diventa assurdo e scade nell’utopia. Quando Viola accenna alla mia parziale marcia indietro a proposito della mia frase “un solo delitto anche se con la maggiore buona fede del mondo finirebbe per squalificare tutta una rivoluzione”, dimentica di citarmi al completo. Quella frase si inseriva nel contesto sintattico dotato di un significato più ampio, un solo delitto effettuato nell’àmbito dell’etica del costruibile squalifica una rivoluzione proprio perché permane nella figura “morale” di delitto riportato all’etica della distruzione. Tenendo presente come una particolare sospensione di giudizio interrompe il circolo chiuso colpa-pena, l’azione distruttiva non è più “delitto” ma semplice azione terapeutica. Ed è proprio questo aspetto “curativo” che ci consente di prospettare la nostra tesi della “distruzione necessaria” come un “rimedio” del male che affligge oggi la società contemporanea.
Onde facilitare il compito del lettore desidero riassumere i punti della mia tesi:
a) condanna del sistema,
b) impossibilità di giungere ad abbattere il sistema con teorie centriste,
c) indicazione dei pericoli della tecnica dell’inglobazione impiegata dal sistema: dialogo, nonviolenza, ecc.,
d) pericolo della religione,
e) compito di guida degli intellettuali,
f) tecnica del non assorbimento della integrazione,
g) rivoluzione generale come momento conclusivo delle singole rivoluzioni permanenti personali.
Desidero concludere questo breve contributo alla discussione sul grande problema della contestazione con un riferimento ai pericoli che nasconde la tecnica della nonviolenza.
L’attuale politica del sistema è riassumibile grosso modo sotto due aspetti, uno interno relativo alla struttura della sua organizzazione militare e alla struttura della mentalità nazionalista fondato sulla violenza armata, l’altro esterno relativo a ciò che il sistema pretende dagli aderenti al gioco dell’integrazione, fondato sulla nonviolenza, sul rispetto delle leggi e delle disposizioni tendenti a tutelare il dominio della proprietà e il capitale di fronte ai lavoratori e alle classi meno abbienti. Ogni tentativo violento di scuotere le masse più povere viene immediatamente catalogato dal sistema e tenuto presente nell’eventualità futura di dovere ricorrere ai mezzi forti della repressione armata. Non dobbiamo dimenticare che il sistema è il detentore della violenza istituzionalizzata. Il sistema ha la possibilità di dichiarare decaduta la “morale della nonviolenza” senza dovere rendere conto a nessuno quando la cosa non tornerà più comoda alle sue mire. Quanto alla politica attuale definita “molle” si sostituirà quella a forte influenza di destra, definibile “dura”, allora gli attuali nonviolenti di oggi, che il sistema lascia sopravvivere anche se adagiati sotto il vessillo anarchico, saranno immediatamente posti al bando, mentre a coloro che oggi affermano la validità della violenza sarà posta l’alternativa chiarificatrice: schiavitù o libertà.
A tutti coloro che in quell’occasione risponderanno libertà sarà riservata la stessa sorte dei nonviolenti di oggi, con la variante che quelli saranno preparati alla lotta e al combattimento e non si lasceranno imbrigliare facilmente perché esenti dall’attuale impecorimento dei nonviolenti di oggi.
[“Contributo al concetto di violenza rivoluzionaria”, pubblicato su “Umanità Nova”, 19 aprile 1969]
È davvero possibile parlare di nonviolenza?
L’invito a una polemica può avere molte utilità. Diverse ne ha comunque per il lettore che ha modo di prendere contatto con aspetti e tematiche, con problemi e chiarificazioni, che altrimenti resterebbero sottintesi e sconosciuti nella istituzionalizzata notizia di una breve recensione o nota critica.
Alcune di queste utilità tornano pure per gli studiosi chiamati in causa, ciascuno per conto proprio, a un’opera di revisione mesta e coscienziosa delle proprie idee e delle proprie convinzioni dottrinarie. In quest’ultimo caso gli studiosi contendenti devono avere l’onestà di dedicarsi a quest’opera di revisione e di chiarimento con costanza e dichiarata fedeltà, in caso contrario diventa tutto tempo e fatica sprecati.
Poiché sono sicuro che Viola abbia questa onestà intellettuale, sono lietissimo di dedicare il mio poco tempo alla continuazione di un dibattito che ritengo possa risultare proficuo a qualcuno.
Ammesso questo, torna utile chiarire un altro punto che chiamerei di ordine strumentale. La polemica di cui si fa cenno in queste righe viene condotta, come tutte le polemiche sono state condotte da che mondo è mondo, con le parole. Questo può dare adito a una dispersione di concetti, a un farsi prendere la mano dalla “battuta” fatta esclusivamente per la platea e contrastante in sostanza con gli interessi della ricerca. Questo “difetto”, che rende grandi alcuni polemisti (grandi ovviamente solo come polemisti e non altrettanto come studiosi), quali Voltaire o Shaw, per citare qualche nome, rende piacevole la lettura ma tradisce gli intendimenti della ricerca.
Poiché quanto detto sopra vale per tutti, almeno da parte mia cercherò di evitare, per quanto mi sarà possibile, la battuta d’effetto e la satira, ben sapendo che si rifugia in questi sottoprodotti del ragionamento chi non ha niente da dire o ha esaurito tutti i propri argomenti.
Un ultimo punto, sempre di valore propedeutico, è quello che riguarda il significato che studiosi diversi danno alla stessa parola. Purtroppo almeno il cinquanta per cento degli equivoci, dei dibattiti culturali e quindi delle stesse polemiche, si fonda su questa iniziale differenza di posizione.
La mia prima replica alla recensione di Viola del mio lavoro sui problemi dell’odierna integrazione del sistema non poteva fare sorgere dubbi su quelle che sono state, e sono tutt’ora, le mie idee in proposito.
Lo scopo eminentemente pratico del mio lavoro non poteva neppure essere frainteso. Le sostanziali necessità teoriche di una elencazione di condotta pratica non venivano a porsi per questo in contrasto con quelli che erano gli scopi del lavoro in quanto tale, non diversa era la relazione tra azione e pensiero.
Un’analisi della situazione contingentale della maggior parte dei paesi, sia nei settori di massimo sviluppo economico come in quelli dove il sottosviluppo è in fase di incrudelimento, mi ha convinto di una grave realtà: l’élite dirigenziale persiste nel proprio intendimento di prevaricare il resto della società, di vivere alle sue spalle, di sfruttarla, ecc. Tutto ciò è un dato di fatto che non può essere negato.
Come può condursi una lotta contro questo stato di cose? Benissimo, con le tecniche e le teoriche della nonviolenza mi direbbe Viola, con il dialogo parlamentare e sindacale, mi direbbero alcuni, con l’intervento sempre più massiccio dello Stato correttore economico e politico, mi direbbero altri. Benissimo, dico io, potete avere tutti ragione, in linea teorica, ma passiamo praticamente alla escussione dei vostri strumenti.
La nonviolenza. Viola mi accusa di ignorare quale sia il significato vero e proprio della teorica della nonviolenza. Posso concedergli che ha ragione, ma la cosa mi lascia del tutto indifferente, mi basta sapere che la nonviolenza esclude la «violenza come mezzo di soluzione generale e non certamente come episodio particolare di ultima ragione», come ha voluto chiarirmi Viola stesso. Un mistero del genere resterà per sempre escluso dalle mie possibilità di comprensione. Sembrerebbe che ci si trovi davanti a una esercitazione metafisica. In concreto, che cosa si potrebbe dire a un uomo che deve darsi una strada chiara e delineata per la propria azione politica diretta a “rompere” le catene del sistema? Certo non gli si potrà dire che la sua azione deve essere violenta solo se si tratta di un “episodio particolare di ultima ragione (sic!)” e non deve più esserlo quando diventa mezzo per giungere a una soluzione generale.
Concordo pienamente con Viola che la violenza non può rompere il cerchio tautologico della violenza, ma nessuno si è mai sognato di dire una cosa del genere. La vera e propria rottura come appare chiaramente dal mio lavoro non è affatto la conclusione violenta, che se eseguita senza la necessaria preparazione si potrà concludere solo con un vano ripetersi sempre degli stessi temi del passato e di cui la storia ci fornisce, come ben dice Viola, una vasta catalogazione, ma è l’esplosione distruttiva preceduta da una “rivoluzione permanente personale”.
Come mai Viola non ha fatto esauriente riferimento a questa prima parte del mio lavoro, che pure era fondamentale alla comprensione del resto? Questo resterà un mistero per me, in quanto non voglio assolutamente pensare che da parte sua ci sia stata una intenzionale mutilazione nell’esposizione diretta a chiarire al lettore il mio pensiero (in definitiva questo deve essere il compito iniziale di un recensore, sebbene possa poi non essere più quello di un polemista) richiamando l’attenzione solo sulla divergenza della mia tematica “violenta” con quella tematica della nonviolenza cui egli sembra tenacemente attaccato.
La stessa sorte dubbia che abbiamo descritto per la tecnica della nonviolenza, come strumento di rottura del sistema, secondo me è da attribuirsi al dialogo, sia esso parlamentare che sindacale. Strumento principe della regolazione delle umane cose, il dialogo resta tale fin quando le due parti in contestazione sono poste sullo stesso livello di chiarezza di intendimenti, ma quando una delle due parti, o ambedue, hanno delle riserve mentali lo strumento decade di importanza ed è da scartarsi nella lotta al sistema.
L’utilizzo del meccanismo dello Stato rafforzandolo e costringendolo a capitanare la distruzione del sistema è una tale contraddizione in termini che non vale la pena di affrontare e chiarire. Il lettore può trarre le conclusioni da solo.
A nostro parere, e la vibrante replica dell’amico Viola non potrà certo farci cambiare idea, la tecnica e la teoria della nonviolenza sono fondamentalmente sbagliate e contingentalmente svianti per l’uomo d’azione che voglia concorrere a distruggere il sistema.
Persisto nell’affermare anche in questa sede che si tratta di una vera e propria piaga che minaccia di rovinare le forze vive dell’idea libertaria, se non individuata in tempo nell’essenza che sotto la sua nebulosa superficie si nasconde. Chi rifiuta il sistema, chi si schiera contro e lo combatte, chi rigetta le formule strettamente codificate della società, non può essere un nonviolento anche se poi per ignoranza o per convinzione si dichiara tale. La sua lotta contro il sistema sarà una legittima rivolta, e come tale la sua posizione in perfetta linea con la difesa del diritto positivo non potrà dirsi in contraddizione. Caso mai sarà la violenza dello Stato quella repressiva a condannarsi, non quella difensiva o libertaria.
Non è da poco poi indicare che l’idea della nonviolenza è stata rifiutata dal cristianesimo essendo assolutamente sconosciuta nel mondo antico o rintracciabile solo in manifestazioni teoriche di trascurabilissima influenza pratica. Parto di una morale sotto certi aspetti valida, e sotto altri criticabile, la nonviolenza aveva ed ha avuto anche di recente giustificabili applicazioni.
Purtroppo il senso dell’attuale momento storico ci pare in tutta verità che rifiuti una ulteriore applicazione della teoria o della pratica della nonviolenza.
Questo è quanto vorrei che Viola meditasse con calma, senza lasciarsi prendere la mano dai. simpatici saltellanti periodi satirici, per intraprendere una migliore chiarificazione di un contesto che forse potrebbe non essere contrasto ma collaborazione e reciproco sostegno. Quello che oggi appare così distante, la mia teoria della violenza e la teoria della nonviolenza di Viola, potrebbe rivelarsi, dopo approfondita maturazione, un contrasto apparente.
Il sogno di un’organizzazione in grado di fare valere il diritto positivo, un’organizzazione libertaria e aliena dalla violenza perché fondata sulla pace ed illuminata dal benessere intellettuale e morale, può essere realtà. Ma questa realtà deve essere partorita nel dolore come tutte le cose di questo mondo, deve essere sofferta e voluta, perseguita con ostinazione e sacrificio, si deve combattere e ricorrere alla più deprecabile distruzione per costituirla.
Nessun secondo fine, nessuno scopo recondito. Quello che una volta era un sogno utopista, la costituzione di una società libera e felice, la scienza ce lo può realizzare solo che – come ha notato nel suo recente lavoro lo stesso Viola
(No! Alle armi nucleari, Genova 1968) – venisse indirizzata al bene e non alla distruzione.
Ma per ottenere questo può essere necessario ricorrere ancora una volta alla violenza, alla distruzione, alla morte. Può essere necessario farsi il cuore di pietra e sospendere qualsiasi regola morale, può essere necessario ricostruire tutto dalle fondamenta. Se questo programma disincantato stomaca qualcuno non è colpa nostra, ma della realtà che è stomachevole e difettosa.
Mi auguro che queste righe possano contribuire a chiarire nel lettore libertario l’importanza della violenza giustamente diretta, e il significato della nonviolenza giustamente interpretata. Ambedue queste teorie, in un domani forse non lontano, potranno giungere a identificarsi in una sola teoria, quella concretamente valida a distruggere il sistema e ad edificare una società fondata sulla pace e sulla felicità.
[“È davvero possibile parlare di ‘non violenza’?”, pubblicato su “Umanità Nova”, 9 agosto 1969]
Nota redatta nel dicembre 1970
A parte i lavori più recenti e quelli in corso di realizzazione, a due anni dalla sua pubblicazione il lavoro che più di tutti continua a richiamare la mia attenzione è La distruzione necessaria. Dalla data dell’uscita (giugno 1968), o meglio ancora da quella della sua redazione (febbraio 1968), molte cose sono cambiate nel mio modo di vedere il problema rivoluzionario. Ma non di tutte queste modificazioni, alcune delle quali lente e spesso poco percettibili anche a me stesso, ho potuto dare conto nei diversi interventi polemici nei quali sono stato coinvolto.
Tre tirature, settemila copie complessivamente in circolazione, una quarantina di recensioni, anche su grossi quotidiani nazionali, non sono poca cosa per un modesto libretto (appena 80 pagine), che partiva da premesse molto limitate (una discussione tra amici), senza ombra di pretese teoriche o di formulazioni esatte. Purtroppo, come sempre accade, le cose meno curate, meno attente, casualmente si imbattono in un successo che meritano solo in parte. La prima cosa che non va in quel libro è l’introduzione di Di Maria, troppo apertamente contrastante con una chiara visione del problema, per quanto redatta su discussioni fatte insieme e su di una scaletta approntata da me stesso. Ma in quell’epoca, a tanto poco tempo (e a tanta distanza fisica) dagli avvenimenti francesi, nessuno poteva avere una visione più chiara, almeno qui in Sicilia. Purtroppo molte letture sono state influenzate (come quella condotta dal critico dell’“Avanti!”) più dalla Prefazione che dal testo.
Ma veniamo ai problemi intrinseci del libro. Problemi che oggi, a distanza di due anni buoni, mi sembrano grandissimi.
Per prima cosa c’è da dire che non credo alla possibilità sistematica di una costruzione di pensiero rettilinea, il pensiero è sempre ricerca, verifica nella realtà, processo tortuoso e spesso contraddittorio, spinta ora in avanti e ora verso posizioni meno azzardate, riflessione e ipotesi, logica e utopia. In questo senso ritengo che ogni libro vada considerato come un prodotto a se stante, certo non estraneo alle responsabilità del suo autore, ma spesso scarsamente riconducibile a un discorso anteriore o posteriore. La validità del libro va ricercata in un suo messaggio intrinseco, unico e irripetibile, che ne costituisce in unica soluzione la limitazione e l’originalità. Indiscussamente il libro ha una sua pretesa originalità, come ha anche una sua obiettiva limitazione. Vediamole partitamente.
La sua originalità è costituita da un impegno etico, colto nel momento distruttivo, impegno etico che ritengo tuttora valido e che forma il nucleo centrale di un discorso che sono pronto a sottoscrivere anche oggi. La tesi era la seguente: partendo dall’etica del costruito, che tutti ci coinvolge, non è possibile parlare di rivoluzione (distruzione) ma soltanto di riforme in senso concreto o di teorie rivoluzionarie in senso astratto. La frattura netta tra una dimensione elitaria del vivere in società e una dimensione temporaneamente di sospensione della legalità (dimensione rivoluzionaria) è appunto questa sospensione del giudizio etico normale e questa instaurazione di un mondo etico altrettanto valido, fondato sulla necessità della distruzione.
Certo, approfondendo meglio il problema, cento e più obiezioni si possono sollevare ed alcune sono state sollevate. È possibile in concreto questo processo sospensivo? È possibile un’etica della distruzione? È possibile vedere la rivoluzione come qualche cosa di separato dalla costruzione successiva? È possibile interiorizzare a tal punto il processo rivoluzionario? Non si corre il rischio di staccarlo definitivamente dal contesto concreto che solo la realtà delle lotte operaie e contadine può darle?
Non vogliamo rispondere qui a queste obiezioni. Lo studio del problema sociale è estremamente complesso e vario. I risultati a cui si può arrivare sono spesso insoddisfacenti e su alcune cose ho perduto del tutto le concezioni che avevo all’epoca della redazione de La distruzione necessaria: sul ruolo degli intellettuali, sul concetto di élite rivoluzionaria, sulla funzionalità del meccanismo rivoluzionario in tutte le sue espressioni, sul valore della realtà in senso politico.
Prima di dare conto di queste modificazioni occorre precisare una cosa. Per uno come me, legato a certi schemi dottrinali ben precisi, uscire fuori, verso una visione complessiva del mondo e della lotta politica ben diversa, non era certo una cosa facile. Questi due ultimi anni mi hanno posto davanti al problema concreto della prassi politica, dell’azione politica e mi hanno avvicinato a un certo indirizzo di lotta ben più preciso di quello che pure aveva segnato un certo periodo della mia vita, cioè la lotta contro la religione. Ma adesso mi si pone il problema dell’etichetta, della corrente, del segno, della precisazione. Problema certo non estremamente difficile in se stesso, ma importante per me, da sempre contrario a questo modo di qualificare l’individuo, di ridurlo a una bottiglia con la sua brava etichettina colorata. In questi ultimi anni ho lavorato intorno al pensiero anarchico e, fatto più importante, ho riesaminato gli accostamenti delle mie diverse posizioni precedenti con i punti essenziali di questa corrente di pensiero e di azione. Ho dovuto convenire che molti punti erano vicini, anche se altri erano lontani e partivano non dal presupposto dell’autorità ma da quello dell’autorità funzionale.
In questa direzione, se non proprio dell’accettazione totale e indiscriminata del pensiero anarchico, ma dalla sua accettazione come punto di riferimento e di riflessione, va considerata questa presa di posizione verso alcune teorie accennate nel libro di cui si discute.
Abbiamo detto che una delle mie preoccupazioni costanti, risalente addirittura alle mie ricerche sul pensiero economico e a quelle sulle origini del pensiero filosofico e del concetto di verità (cfr. “Il problema della verità alle origini del pensiero filosofico”, che è un saggio del 1961, pubblicato nel 1965 su “Studi e ricerche”), era quella dell’autorità funzionale. Il primo punto di partenza delle mie ricerche in campo sociale è stato l’accettazione dell’uguaglianza degli uomini, della necessità di costruire un futuro libero e senza sfruttamento. Un punto di partenza che però non mi poteva portare direttamente a liquidare il concetto di funzionalità, concetto ad esempio centrale nel saggio sull’“organizzazione”. In effetti anche oggi non intendo affatto liquidaresu due piedi questo concetto rifacendomi a una pretesa efficienza insita nell’autorganizzarsi delle masse. Al contrario, e dentro certi limiti, mi rendo conto che la formulazione del concetto di funzionalità, come è contenuta ad esempio ne La distruzione necessaria, è assai imprecisa e presta il fianco a storte interpretazioni.
La mia mancata liquidazione delle prerogative dell’intellettualità, prerogative che riguardavano la sua sostanzialità e non la sua pretesa forma, poniamo accademica, cosa quest’ultima contro cui mi sono scagliato dall’epoca dei miei saggi su “Proserpina”, doveva determinare una collocazione positiva di queste categorie all’interno del fatto rivoluzionario, senza una chiara messa in luce della loro funzione o, come fatto indicativo e simbolico, riducendo la loro funzione a quella di guida delle masse. In effetti questa volta il concetto di funzionalità avrebbe dovuto ricevere una modifica assai importante se fosse stato da me legato all’altro concetto, quello riguardante la manipolazione degli strumenti di rivolta, pure largamente illustrato nel libro.
Lo stesso problema in scala ridotta per l’economia del libro si pone per la pretesa funzionalità dell’organizzazione militare.
In effetti, diversi critici mi fecero all’epoca notare queste limitazioni. Nella risposta a Giusso così scrivevo a proposito dell’“intellighentia”: “Quando parlammo nel nostro lavoro del compito dell’‘intellighentia’ parlammo pure della necessità di una teoria di questa élite, cioè di una separazione dal processo integrativo e globalizzante posto in atto dal sistema”.
E a proposito dell’organizzazione militare: “È ovvio che se il movimento rivoluzionario dovrà condurre a termine un piano distruttivo, questa azione dovrà essere diretta dai tecnici della distruzione, cioè da specialisti provenienti o dalle scuole militari del sistema o dalle organizzazioni rivoluzionarie di preparazione alla guerriglia”. Eppure nello stesso scritto, alla pagina precedente, avevo avuto un segno premonitore delle critiche successive, avvertendo che: “…tutto questo discorso potrebbe avere gli aspetti del classico colpo di Stato sebbene dovrebbero risultare evidenti le differenze sostanziali presentandosi non come movimento di élite militaresca di destra ma come generale movimento popolare di sinistra”. Notazione quest’ultima che ovviamente i miei facili critici non hanno creduto opportuno rilevare.
Questi i punti più in contrasto con la presente evoluzione del mio pensiero. Punti non tanto importanti nella loro specifica fattispecie, quanto per il presupposto che lasciavano aperto: la fede nell’autorità fondata sulla funzionalità. Mi rendo conto che è possibile una ricerca di tipo diverso, una ricerca sulla funzionalità fondata sulla creatività, sulla spontaneità, sulla fantasia delle masse, ma in questa direzione è ben difficile il lavoro che mi attende.
PARTE TERZA (1969-1970)
A che servono i teatri lirici?
I problemi teorici e le manovre pratiche della contestazione giovanile contemporanea sono parecchi e assai complessi. Tra l’altro oggi si pone al centro dell’attenzione l’intervento contro le masse borghesi che, procedendo impavide nel loro impecorito ménage, si rivolgono con la solita solerzia alle tradizionali manifestazioni classiche, le quali consentono tra l’altro di dare periodici e chiari riscontri delle “distanze” e dei “ranghi”.
Il teatro lirico costituisce un’occasione prelibatissima alla quale è difficile dire di no. Siamo davanti a una parte del fenomeno musicale che anacronisticamente viene negletta da tutti e da tutti snobbata fuori del sacro recinto dei teatri lirici ma che riscuote immediatamente l’attenzione dell’élite borghese, la quale fiuta la possibilità di attestare maggiormente la propria superiorità finanziaria partecipando a uno spettacolo appositamente voluto e strutturato per questo. Della musica si potrebbe fare a meno se la cosa non fosse enormemente sfacciata, comunque i periodi in cui l’orchestra fa sentire quegli strani rumori e i cantanti si ostinano a urlare le loro incomprensibili parole vengono sopportati con grande rassegnazione in vista degli intervalli. Infatti i momenti principali di queste serate liriche non sono i passi più centrali dell’opera musicale di questo o quel maestro, i quali restano incompresi, salvo che non si tratti di motivi popolarissimi e scontati, bensì l’entrata in sala e nei palchi, gli intervalli, le puntate al buffet, l’uscita. Sono proprio quelle luci, quelle gioie sfoggiate con cafonesca noncuranza di provincia, quei vestiti, quegli sguardi annoiati e da competenti che ormai ripetono una noiosa routine, che fanno “serata”, ovviamente il tutto va moltiplicato in proporzione quando questa è la “serata di gala”.
I giovani hanno contestato questo fenomeno. Lo hanno fatto a Milano e altrove, lo hanno fatto in occasione della festa di Capodanno in Versilia, dove cambiava il motivo della riunione ma gli stimoli classici del borghesismo erano senz’altro all’opera.
Qui non si vuole mettere in discussione il problema dei metodi impiegati nell’azione contestataria. Questo infatti è un discorso da mestieranti di giornali, o giornalisti che dir si voglia. Un discorso anche importante, ma che non afferisce direttamente al problema della contestazione, alla manifestazione borghese della “serata di gala”, piuttosto si pone come discorso di base in rapporto alla possibilità di condurre a compimento una manifestazione contestataria in un modo violento o nonviolento.
Purtroppo, ripetiamo, dell’argomento si sono occupate persone che sono, per mestiere, abituate alle frettolose conclusioni della cronaca. Loro compito è solo quello di trasportare i fatti, che di regola vengono narrati con una qualche parvenza di obiettività dalla cronaca in prima pagina, vestendoli della pomposa copertura del commento saccente e distaccato.
Costoro sono, è inutile negarlo, degli elementi ignoranti in materia di problemi sociologici, mentre hanno una certa bravura nel reperire e vivificare il fatto di cronaca. Ne consegue che i documenti che vengono in possesso di questa gente finiscono per risultare falsati, più o meno volontariamente, e definitivamente inutilizzabili.
I sociologi, da canto loro, sono pigri e preferiscono scrivere per riviste specializzate, capaci di fare fruttare il lavoro compiuto ai fini della “carriera”. In questo modo i veri competenti giungono a trattare l’argomento in ritardo e quando l’opinione pubblica è ormai attirata da altri fatti. Quelli che, come Bobbio o altri, hanno tentato un immediato intervento attraverso i mezzi di informazione più elementari, sono stati assai più vicini al nocciolo del problema di quanto non abbiano fatto i chilometri di colonne scritte dai giornalisti di professione.
Purtroppo i sociologi che hanno compreso la necessità di scendere alla produzione pubblicistica diretta alle masse attraverso i giornali sono assai sparuta minoranza. Il resto è ancora legato allo scranno dorato dell’accademia e dorme sogni beati.
Perché i giovani hanno contestato la “serata di gala” nei teatri lirici?
Questa è la vera domanda, almeno vera nel senso scientifico, in quanto si pone come domanda che intende giungere alla formulazione di un problema di scienza sociale. Qual è la funzione del teatro lirico nel mondo moderno?
Abbiamo quindi la possibilità di fare una prima considerazione. I giovani non hanno contestato la presenza dell’abito da sera. Le manifestazioni più evidenti della prevaricazione esercitata dalla borghesia sui ceti inferiori non può facilmente essere identificata nell’abito da sera. Farlo significherebbe disconoscere alcuni fatti della realtà sociale. L’abito da sera poteva servire a contraddistinguere la élite della società dei nostri nonni, appena forse quella dei nostri padri, ma non quella nostra. La nostra è una civiltà tecnologicamente avanzata, o almeno in stragrande maggioranza avanzata, quindi dovremmo orientarci verso la macchina, e in particolare verso l’automobile, simbolo quanto mai evidente di questa differenziazione di classe. Perché allora i lanci contro gli abiti da sera e non contro le auto più costose? La risposta è semplice. I giovani contestatori non hanno voluto colpire la differenziazione classista, assai più evidente nelle automobili, ma l’adesione, in forma classista e borghese, al suo spettacolo che essi riconoscono valido solo se diretto a fini ben diversi da quelli attuali.
Naturalmente non è possibile comprendere questa posizione giovanile se non si conoscono a fondo i temi di rinnovazione e di risveglio che i giovani stanno portando avanti da parecchio tempo in tutti i settori dell’arte teatrale e artistica in genere. Per certi aspetti è la solita storia che si presenta in molti paesi ma che in Italia ha caratteristiche particolari, trattandosi di un paese diviso tra un passato ormai languente, quasi inadatto e per certi aspetti perfino deplorevole, e un presente strano e ricco di troppi chiaroscuri per potersi identificare con chiarezza.
L’altro teatro, quello di prosa, è stato indiscutibilmente vivificato dall’azione giovanile. Nuovi temi, nuove regie, nuovi testi, nuove interpretazioni, vecchi attori che si sforzano di diventare nuovi. Al confronto il teatro lirico fa la figura del matusalemme e del retrogrado. Eppure anche il teatro lirico può essere un teatro funzionale, cioè un teatro “educativo”.
Non che i giovani, per altre vie, vogliano ripresentare le vecchie chiusure artistiche del teatro, legando quest’ultimo al dubbio carro della “necessità educativa”. Caso mai il processo appare capovolto. Il teatro, come ogni vera attività artistica, non deve restringersi a uno schema prestabilito, ma sorvolare gli schemi e programmarsi un movimento di rivolta contro le chiusure della tradizione e le melanconie. Il teatro deve disporsi come ricerca, come ricerca della duplicazione intellettiva, come ricerca di metodi di slittamento della realtà obiettiva e catalogata, come ricerca di nuovi orizzonti musicali, nuovi temi, nuove possibilità, come ricerca di concretezze raggiunte da altri e da altri sorpassate ma che per noi costituiscono soltanto lontani e simbolici traguardi. Il teatro deve essere tutto questo e, nel suo aspetto di “teatro lirico”, deve disporsi criticamente a qualcosa d’altro, a un esame di coscienza nel senso di stabilire la validità educativa di vecchie strutture, anche se consacrate in modo definitivo dalla tradizione, non limitarsi alla sola elaborazione dello scenario – forse il futuro stesso del settore è legato a questa possibilità di rinnovamento. Ma tutto ciò è sufficientemente chiaro agli specialisti? La vera realtà è che anche costoro sono legati a necessità extrartistiche che impediscono un più immediato raggiungimento degli scopi che qualsiasi uomo dotato di un minimo di cervello non può evitare di conoscere.
I giovani sono per costituzione e per situazione svincolati da questi legami e per questo vedono più chiaramente la realtà sotto le molte pieghe della sovrastruttura e della retorica. Vedono come l’attuale teatro lirico sia la negazione stessa del significato più profondo e più antico di “teatro”, quindi contestano in uno l’attuazione di simili manifestazioni e il plauso irriverente e sciocco che la borghesia pone in essere con la propria partecipazione in pompa magna alle serate cosiddette di gala.
I poteri pubblici sono quanto mai lontani da una efficace ingerenza sul problema. Gli strumenti dello Stato, magistratura e polizia, sono chiamati a un compito di sorveglianza e di giudizio, ma ovviamente non possono essere chiamati a costituire un controllo o una repressione nel funzionamento stesso del fenomeno che genera la reazione contestataria dei giovani. I partiti politici intervengono frequentemente. A Catania ho avuto l’occasione di leggere l’intervento del consigliere Alicata intorno al bilancio del teatro Massimo Bellini del luglio scorso [1968]. I fatti denunciati all’attenzione del sindaco e degli altri consiglieri mi sembrano oltremodo gravi, anche se non posso avere una competenza specifica per giudicare con tutta coscienza, eppure nonostante questa gravità a quanto mi consta non è stato ancora risolto nulla. Il Massimo Bellini continua a funzionare allo stesso modo di prima e voglia il cielo che ciò non duri in eterno.
In concreto però debbo confessare che la cosa non desta in alcun modo la mia meraviglia. Perché mai avrebbero dovuto funzionare bene le cose quando il denaro estorto con le imposizioni fiscali viene amministrato e speso da organizzazioni private? È la solita storia che ritengo si verifichi in molti teatri lirici italiani e stranieri. È sempre lo Stato che spenna l’oca grassa contribuente cercando in tutti i modi di farla strillare il meno possibile (la figura non è mia ma di Pareto), per poi impiegare il danaro incassato in iniziative che immancabilmente finiscono per utilizzare concretamente una parte soltanto di quel danaro, il resto si è fermato per strada nei gangli, nelle connessioni, nei tessuti marginali del sistema. Gli altri ne hanno ricevuto ben poco.
I partiti politici di ogni ordine e posizione sono “nel sistema”, cioè sia che concretamente favoriscano il disperdersi del pubblico danaro, sia che siano materialmente impossibilitati ad andare oltre una semplice opposizione verbale (questa è per l’appunto la conclusione cui è giunto il predetto Alicata nell’intervento al consiglio comunale di Catania del 5 aprile 1968), non vanno al di là di una compartecipazione alla struttura. Nessun partito ha vere caratteristiche rivoluzionarie, quindi nessun partito può risolvere il problema nel caso in particolare del teatro lirico.
Resta allora solo la contestazione dei giovani? A questa domanda non sappiamo bene cosa rispondere. Le parole finiscono prima o poi per perdere il loro senso e quindi la loro efficacia. I fatti invece continuano a permanere e a turbare le coscienze colpevoli allo stesso modo che contribuiscono a fare tremare le strutture capziose. E il futuro è stato sempre costruito dai fatti, le parole sono valse caso mai a confondere la nitidezza delle cose e dei sentimenti.
[1968] [“A che servono i teatri lirici?”, pubblicato su “Azione socialista”, gennaio 1969]
Il concetto di Stato
Il banco di prova di ogni dottrina politica è stato sempre il concetto di Stato. Su questo difficile argomento si sono esercitati tanti ingegni di valore e tante dottrine hanno spuntato definitivamente i loro rostri di combattimento.
Qual è il motivo di questa importanza? Chiederselo oggi, di fronte a tanti colpi contro lo Stato, può avere uno scopo ben preciso, più circoscritto e determinato di quello che tradizionalmente si assegna a questo genere di argomentazioni.
Il marxismo nega, in ultima analisi, la giustificazione sociale dello Stato, assegnandogli solo una giustificazione storica e transitoria. Eliminando la lotta di classe – dice Engels – a seguito della vittoria del proletariato, lo Stato finirà per estinguersi per autoconsunzione. Dottrina molto allettante per due motivi. Primo, perché mette a nudo le deficienze e le colpe dello Stato storico, secondo, perché circoscrive il compito dello Stato storico alla semplice catalizzazione della lotta di classe. Da questa dottrina ogni sorta di trascendentalismo è definitivamente eliminato, venendosi a gettare le basi per una migliore valutazione dei limiti del compito dello Stato sociale nei confronti dell’ingerenza dello Stato storico.
Se infine si tiene conto come il marxismo abbia sottolineato la necessità della conquista violenta del potere da parte del proletariato – rivoluzione e non revisione o riforma – si comprenderà appieno la lontananza delle pantomime pseudo-rivoluzionarie inscenate dai partiti istituzionalizzati.
Ma lo Stato può essere negato in forma più recisa, in forma più completa e definitiva. Questa è la soluzione proposta dalla maggioranza delle dottrine anarchiche. Riconosciute non valide le giustificazioni storiche alla esistenza dello Stato, l’anarchismo formula la dottrina di una struttura organizzativa eminentemente non-burocratica e non-centralizzata. La minore efficienza meccanica di questa particolare forma di organizzazione verrebbe ad essere compensata di gran lunga dalla maggiore efficienza ed agilità.
Anche questa una tesi affascinante, sebbene difficilmente perseguibile nelle estreme conseguenze di carattere individualista. Comunque ci pare notevole sottolineare l’importanza della negazione assoluta dello Stato e l’ineluttabilità che questa abolizione avvenga per la via rivoluzionaria e non attraverso le tradizionali forme istituzionalizzate del revisionismo e del riformismo.
Eppure queste due alternative, ambedue contrarie alla persistenza dello Stato storico a fondamentale struttura borghese, non tengono sufficiente conto di un problema di importanza decisiva, chi custodirà i custodi?
Vediamo di avvicinarci al nocciolo di questo problema. Lo Stato non è un’astrazione, non lo è nella sua forma storica, non lo è nella sua forma sociale ammesso che sia possibile identificare una decisa differenziazione tra queste due forme. Lo Stato è costituito da uomini, precisamente da quella élite di governo che mantiene fermi nelle sue mani i gangli principali del sistema amministrativo. Tutto ciò è molto lontano dall’astrazione teorica del diritto positivo del sovrano o del popolo, dalla scelta tra i diversi tipi di democrazia e simili questioni che hanno tacitato e frastornato per secoli la mente dell’uomo. Dietro questa immane montatura ha posto la ristretta cricca degli sfruttatori e dei loro servi sciocchi, venduti per il classico piatto di lenticchie a coloro che sfruttano il loro poco spirito e la loro scarsità di penetrazione critica. Questo è lo Stato, una realtà ben al di là della metafisica delle vane chiacchiere dei filosofi del diritto, ben al di là di Dio come della giustizia e della verità.
Ove fosse dimostrabile l’esistenza di questo qualche cosa di ideale, circoscritto nel nome tanto vago di Stato, allora sarebbe ancora onestamente argomentabile la tesi di coloro che sostengono la legittimità del diritto positivo dello Stato con tutto quello che ne consegue: ordinanze, sacralizzazioni, discriminazioni, espropriazioni, ecc. Ma quando questa tesi resta nel vago di cui si è sempre circondata, quando non è possibile cacciarla fuori dal tempio sacro alla filosofia, quando la dea metafisica continua a tenerla sotto il suo manto caritatevole, allora noi non sappiamo che farcene e possiamo in tutta coscienza indicarne la sotterranea concussione o la superficiale faciloneria.
Un’organizzazione è l’ideale struttura del vivere comunitario. Su questa affermazione non possono esistere a nostro giudizio dubbi di sorta, solo che le organizzazioni storiche non ci soddisfano per motivi diversi, tutti ugualmente riconducibili al fatto che non è possibile in alcun modo controllare, custodire, il custode. Se questo controllore, questo custode, fosse l’idea – nel senso che Hegel si è sforzato tante volte di provare – allora non sarebbe necessario il controllo e la custodia, ma poiché si tratta di uomini in carne e ossa, di uomini soggetti a tutte le debolezze degli uomini, a tutti i desideri, a tutte le passioni, allora diventa necessario il controllore, il custode, instaurandosi un processo all’infinito che rende l’organizzazione storica impossibile e difettosa.
Che fare? La risposta è forse meno difficile di quanto non sembri in apparenza. Quando una pianta, un albero, diventano troppo carichi di rami o di foglie si ricorre al giardiniere che provvede alla potatura, a liberarli dalle foglie e dai rami superflui che li appesantiscono e impediscono loro una vita rigogliosa e produttiva. Quando una macchina complessa, un cervello elettronico, diventa troppo ingombrante per svolgere un determinato lavoro analitico, si cercano, si studiano nuovi tipi di circuiti che possano occupare uno spazio minore e presentare una maggiore semplicità nei congegni di raccordo e di comunicazione. Quando una struttura burocratica, un’impresa di produzione, diventano eccessivamente grandi si cerca di operare delle scissioni tra le parti che le compongono creando divisioni per ogni settore, filiali, agenzie, un sistema come un altro per dividere il lavoro e per consentire una migliore visione dell’insieme. Questi sono princìpi generali di organizzazione fondati sul semplice buon senso e non per questo rifiutati dalla odierna scienza dell’organizzazione. Il segreto di questi princìpi è la chiarezza nel piccolo onde ovviare alla confusione nel grande.
Una prima risposta al nostro quesito potrebbe essere questa: l’organizzazione deve intendersi come ricerca della soluzione più chiara e meno confusa, intendendo come si è detto per soluzione più chiara quella meno strutturata, meno ampia, più semplice e più piccola.
A questo punto sorge il problema opposto. Quando la struttura più piccola diventa talmente meno efficiente da non giustificare più la riduzione ma rendere auspicabile l’addizione? Siamo davanti a un altro. problema di tecnica dell’organizzazione. La misura migliore è pur sempre una questione di massimizzazione, non più questa volta della efficienza in termini di profitto ma dell’efficienza in termini di “normale” riconducibilità della struttura stessa agli scopi originari che l’hanno prodotta e giustificata.
In passato si è più volte cercato di uscire fuori da questo vicolo cieco affidandosi all’allettante prospettiva evoluzionista, secondo la quale ogni struttura è diretta verso un futuro determinato e irreversibilmente accumulabile come progresso. Che questa strada verso un futuro migliore avvenga in forma diretta o in forma tortuosa, come vuole una scuola critica del biologismo contemporaneo, è faccenda secondaria, l’importante è che non può dirsi accettabile questa soluzione organizzativa che potremmo definire “naturale”. Ogni struttura raggiunge il suo punto critico o normale quando è conforme alla sua dimensione naturale. Un’affermazione del genere oggi non è più sostenibile.
Viceversa ci sembra che una strada dal semplice al complesso, dal piccolo al grande, sia identificabile con chiarezza intendendo confermato che nell’arco di questa linea progressiva si deve includere anche ciò che oggi intendiamo per “strada dell’indeterminazione”, cioè la strada dal meno certo al più certo. Ammettendo ciò e ricordando quanto dicemmo altrove, che la strada dal meno certo al più certo può percorrersi fino a un certo punto al di là del quale si riprende ad avvicinarsi nuovamente verso il meno certo, dobbiamo dire che la più piccola dimensione della struttura è la forma migliore dell’organizzazione.
Il limite negativo di questa nuova dimensione sarà di volta in volta identificabile con quell’aderenza agli scopi originari che hanno prodotto la struttura stessa. Infatti ogni prevaricazione di quegli scopi è denuncia immediata dell’ingerenza di interessi estranei alla struttura stessa e diretti a strumentalizzare la struttura per scopi esterni.
È ovvio che questo abbozzo di soluzione “oggettiva” del problema organizzativo non risolve la questione posta all’inizio di chi custodirà i custodi, o almeno non la risolve con soddisfazione di tutti. Infatti a quanto detto prima bisogna aggiungere che la dimensione “naturalmente piccola” della struttura trova giustificazione non solo in un fattore intrinseco, di maggiore elasticità e flessibilità, ma in un fattore estrinseco di maggiore aderenza al rivolgimento dei valori che giustificavano e rendevano possibile la macrostruttura. In altri termini, il momento della prevaricazione e del contemporaneo compromesso, momento che può dirsi originario della macrostruttura e che segna la morte per soffocamento della struttura “naturalmente piccola”, è contrassegnato dalla prevalenza di interessi estrinseci alla struttura stessa e determinati da “valori” mortificanti.
A questo punto il discorso si deve spostare sulla dinamica di questi valori. Ma si tratta di un discorso quasi privo di significato, almeno dal nostro punto di vista. Quello che importa sottolineare è che si tratta di valori “esterni” alla struttura organizzativa e, nello stesso tempo, esterni all’uomo che si adagiava perfettamente – quale elemento di una relazione di efficienza – sulla struttura stessa. Sono valori che nascono per distruggere in uno la struttura e l’uomo, e ciò allo scopo di consentire la nascita di una nuova struttura e di un nuovo uomo che più niente ha di umano.
Ancora una volta possiamo dire che il migliore custode del custode sarà un uomo che non avrà in se stesso e nella struttura di cui fa parte l’idea della necessità della tutela e della salvaguardia anche con forza.
[“Il concetto di Stato”, pubblicato su “L’Agitazione del Sud”, gennaio-febbraio 1969]
Violenza e nonviolenza
L’alternativa continuamente posta in discussione su tutti i terreni dell’attività pubblica è questa, durissima ma necessaria, tra violenza e nonviolenza. Il facinoroso e l’ottuso uomo di parte si pongono il problema allo stesso modo dell’onesto cittadino che non ha mai preteso di portare il proprio interesse sugli argomenti di politica oltre la lettura svogliata del quotidiano di affezione. Anche gli studiosi si pongono il problema e noi con loro cercheremo di porlo per quanto ci sarà possibile in quella luce che obiettivamente riteniamo giusta.
La violenza contro le cose e contro gli uomini, come contro le istituzioni politiche che dagli uomini sono volute e governate, è condannabile in linea teorica perché si presenta sotto l’aspetto classico di “eccedenza nella contesa”. Sempre in linea teorica ovviamente, questa volta in senso inverso, la nonviolenza è parimenti condannabile perché si presenta sotto l’aspetto altrettanto classico di “mancanza nella contesa”.
Cerchiamo di chiarire questi concetti. Interessi contrastanti portano gli uomini a combattersi per motivi opposti. Da un lato coloro che detengono il potere, l’élite di governo, pretendono imporre la propria politica di sfruttamento, dall’altro i governati, proletariato e sottoproletariato, che cercano con tutti i mezzi di resistere a questo sfruttamento e conquistare posizioni sempre migliori e più redditizie. In questo contrasto si identifica la “lotta di classe”. L’andamento storico è atto quanto mai vario e interessante, il semplice studio degli accorgimenti che la classe dominante ha posto in atto per sottomettere sempre più la classe dei lavoratori sarebbe una lettura densa di significato e di vaste scoperte per tanti “approssimisti” della penna che oggi cicalano con tanta frequenza e con burbanzosa saccenteria.
I termini di questa lotta sono fissati dal codice politico-sociale delle contese sindacali. In questo codice vengono registrati via via i limiti che ogni parte può raggiungere e i mezzi che può impiegare per attuare il proprio scopo. Anche una conoscenza approssimativa di questo codice ci direbbe subito come i limiti riservati per tradizione al proletariato si siano ingranditi a dismisura e come praticamente il processo inverso colpisca i limiti riservati alla classe dominante.
Non bisogna dimenticare però che questo stato di cose, apparentemente roseo, in pratica presenta alcuni punti deboli. La classe dominante detiene il potere nelle sue multiformi manifestazioni di potere economico, politico, militare, religioso, ecc. Con questo potere essa riesce a controbilan-ciare la maggiore libertà di movimento riservata alle classi dominate, fino a capovolgere la situazione e a riportare la bilancia in senso favorevole alla propria parte.
Eccoci pronti a chiarire il nostro assunto di partenza. In linea teorica la bilancia del contrasto tra classe dominante e classe dominata è in parità, in pratica come abbiamo detto essa pende dalla parte dei padroni. Verificandosi il caso che i lavoratori vogliano avanzare una pretesa veramente rivoluzionaria si mette immediatamente in moto la struttura istituzionalizzata del sindacato perché questa pretesa venga formulata in termini accettabili al sistema, in termini cioè traducibili con prontezza in azioni di facile inglobamento. Nella contesa l’azione dei lavoratori non deve “eccedere” i limiti assegnati loro, in quanto in questo caso possono verificarsi difficoltà nel processo di inglobamento da parte del sistema. Per amore di completezza possiamo dire che anche la nonviolenza risulta se non pericolosa almeno “noiosa” per il sistema. Proponendo una reazione “in difetto” costringe il sistema a una fagocitazione più difficoltosa e quindi da evitarsi.
L’ideale per il sistema sarebbe trovarsi di fronte una reazione sistematica, cioè presentante le caratteristiche schematiche sulle quali il sistema trova fondamento e giustificazione. Da canto loro, i partiti politici inseriti con tenace improntitudine nel vasto meccanismo globalizzante si danno da fare per giungere a standardizzare la reazione in forma accessibile al sistema. Se scopi segreti esistono all’interno di qualche partito di sinistra, se finalità veramente rivoluzionarie si perseguono con machiavellica accortezza, se davvero uomini decisi a disintegrare il sistema sono in piena attività, questi uomini devono almeno avere il coraggio davanti a se stessi di dirsi “ospiti” del sistema e quindi “ospiti” del loro stesso partito.
La reazione del sistema nel contrasto che abbiamo delineato prima non è una reazione rigida. Molte volte abbiamo illustrato questo concetto di “morbidezza” del sistema, non ci stanchiamo mai di ripeterlo, trattandosi di un concetto fondamentale per comprendere la politica di disintegrazione.
Se si fosse trattato di una reazione “dura”, allora le tesi entriste avrebbero avuto buon gioco da tempo, ma qui siamo davanti a un processo di fagocitazione mascherato abilmente dalla promettente intelaiatura del dialogo per cui esse annegano miseramente in questo mare limaccioso non riuscendo a portare avanti le iniziali mire riformiste.
Viceversa la violenza provoca la rottura del processo tolleranza-inglobazione, costringendo il sistema a smascherarsi e a utilizzare la “violenza istituzionalizzata”.
Nel conflitto tra queste due violenze vediamo la sola possibile apertura verso il cuore del sistema e verso la sua disintegrazione. Ogni altra strada ci pare come un idealistico palliativo o come un trasformismo realista, rifiutandoci di pensare a un remoto (ma possibile) demagogismo.
È interesse di tutti difendere il “diritto positivo” contro le ingiuste pretese dello Stato repressivo. Questa difesa può giungere fino al contatto violento, se l’azione di repressione risulta prolungata e pericolosamente lesiva del diritto positivo stesso.
Teoricamente lo Stato dovrebbe essere il supremo difensore del diritto positivo, il custode del tempio. In pratica esso non può essere niente di più che un contrastatore di azioni dirette a conquistare sempre più ampi spazi di libertà da parte della popolazione proletaria. Questo compito svilisce il concetto democratico di Stato e lo riporta indietro nel tempo, all’altro concetto che oggi muove lo sdegno di tanti benpensanti, allo Stato poliziesco. Ogni elucubrazione teorica cade di colpo davanti alla dolorosa concretezza di una polizia armata che spara sulla folla.
Il passaggio da Stato difensivo a Stato repressivo, sottolineato da tanti studiosi di sinistra, come indicante lo stacco tra lo Stato “buono” e quello “cattivo”, tra lo Stato da auspicare e da costruire e quello da distruggere, è solo una utopia. Lo Stato per sua intima concezione è sempre uno Stato repressivo, fondandosi sulla necessità di presiedere alla tutela degli interessi della classe dominante frastornati dalla lotta di classe. Questo principio chiaramente visto da Engels è stato poi smarrito dai comunisti e viene visto in errata prospettiva finanche dagli stessi socialisti.
L’alternativa? Solo il cittadino singolo o riunito in gruppi non istituzionalizzati. Solo da questo lato possiamo sperare una contrapposizione decisa ed efficace in difesa del diritto positivo minacciato dallo Stato.
Quando lo Stato è “fuorilegge” non solo è giustificata la “non-cooperazione ghandiana” ma anche l’opposizione violenta.
La lotta portata avanti dalle classi più povere per l’iniziale “conquista del pane” e per la successiva conquista del benessere, deve intendersi come un processo unitario e non come una serie di fenomeni separati e aventi scarse possibilità di connessione.
Frazionando questo processo si ottiene il risultato, comodo al sistema, di rendere incomprensibili, “anarchiche”, come taluno ha voluto definirle, certe manifestazioni violente di piazza, generate in occasione di semplici dimostrazioni “pacifiche” di sciopero. Infatti così facendo si puntualizza l’attenzione degli spettatori non direttamente impegnati nella lotta, sul fatto che i risultati disastrosi (vedi Avola, Battipaglia, ecc.) sono dovuti all’azione disturbatrice di elementi specificatamente addestrati alla guerriglia di piazza. Al lavoratore che sciopera viene attribuita soltanto la possibilità psicologica di portare un gran cartello indicante le platoniche richieste del suo dissenso. Tutto ciò è puerile e delittuoso.
Nell’avere riconosciuto costituzionalmente il diritto positivo dello sciopero si è data al lavoratore un’arma non solo di semplice dissenso, di semplice non-cooperazione nel senso ghandiano, ma una vera e propria arma di combattimento. La scelta del grado di combattività purtroppo non è sempre possibile effettuarla a priori, essendo importanti in questi argomenti il semplice caso, l’urlo di una bambina spaventata, lo svenimento di una vecchia signora, un colpo di fucile sparato per errore o per paura. La storia è fatta anche di queste piccole cose, come giustamente Étienne Émile Boutreaux ci ha insegnato. La contingenza ha una sua propria legge assolutamente estranea alle leggi deduttive della logica umana.
Ciò non significa però che lo studioso possa a cuor leggero osservare questi avvenimenti, come quelli recentissimi di Battipaglia, senza cercare la possibilità di un rimedio. Alzare le spalle con rassegnazione in questi casi è delittuoso.
Noi non possiamo sapere a priori, qualsiasi cosa dicano in merito i soloni della scienza reazionaria e gli stessi nostri amici nonviolenti, come andrà a finire una dimostrazione iniziatasi in forma, appunto, nonviolenta.
La psicologia umana è ancora per la maggior parte avvolta nel mistero, quella della folla – come afferma un eminente studioso di questa scienza, Erich Fromm – è ancora da costruirsi.
Eppure non sono pochi i letteratucoli che hanno impugnato la penna con severo cipiglio, pomposamente ospitati dai vari quotidiani asserviti al sistema, per rimproverare la tracotanza della folla di Battipaglia o di Avola che ha osato resistere alle “sacre forze dell’ordine”. A nessuno di questi signori è sembrato evidente un unico movente, la continuità della lotta per la conquista della libertà. Il popolo di Battipaglia, i braccianti di Avola, gli stessi detenuti che oggi scuotono le mura del carcere di Torino, nel giusto o nell’ingiusto, nella legittimità dei loro propositi o nella pura delittuosità di un desiderio di fare ancora un male maggiore, combattono per la propria libertà, perfettamente in linea con le varie concessioni – a cominciare dal diritto di sciopero e a finire alle serie molteplici dei diritti personali sanciti dalla Costituzione – fatte dallo Stato impositore, non per propria benevolenza ma perché sollecitato e spinto dagli impulsi rivoluzionari.
Non solo è possibile ma direi essenziale al compito stesso dello Stato. Tutto ciò non può avvenire curando con i mitra gli effetti di cause tanto remote e generali.
Lo Stato non ha il diritto di reprimere gli spunti di rivolta dei cittadini in quanto ha dato mostra, più volte, di essere lui stesso “fuorilegge”. In questa situazione i veri difensori del diritto positivo sono coloro che si ribellano allo Stato e denunciano, anche a costo della propria vita, la vera veste non paternalista della sua politica.
Finché il dissenso si manterrà nella forma platonica della non-collaborazione o della non-ubbidienza, in una parola finché sarà nonviolento, lo Stato avrà buon gioco inglobando tutte queste azioni con il manto del dialogo e delle concessioni. Quando invece avrà davanti la violenza dovrà scoprirsi per quello che esso è in realtà, uno Stato oppressore.
In questo modo non è assolutamente possibile che lo Stato giunga ad evitare il caos. Pertanto, siccome abbiamo detto prima che questo è il compito essenziale dello Stato, ecco che venendo a fallire in questa sua più importante incombenza lo Stato fallisce come Stato e deve essere dichiarato “fuorilegge” dal cittadino.
Questi recenti fatti di piazza, che tanto dolore e meraviglia hanno causato in tutta la nazione, debbono costituire un importante insegnamento per tutti, governanti e governati, e un insegnamento particolare per coloro che si occupano, dal punto di vista scientifico, di problemi sociali.
Non è più il tempo delle vane discussioni cattedratiche sull’essenza del movimento popolare o sugli scopi di miglioramento che lo stesso si propone. La società consumista ha tradito tutti, cominciando da coloro che la programmarono come la società industriale dell’avvenire, quella che doveva risolvere i vecchi problemi della precedente società militare. Pur nell’attuale situazione di produttività non sono molti i casi di pacifica aderenza al sistema da parte delle classi non privilegiate. L’integrazione è per tutti valida, questo non è possibile negarlo, però il senso dell’insoddisfazione, la grande differenza che passa tra desideri soddisfatti e desideri da soddisfare, l’azione stimolatrice di organismi a questo scopo istituiti per creare nuovi bisogni, tutte queste cose contribuiscono a fondare uno stato di frustrazione perenne e pericoloso. L’esplosione di questo stato patologico dell’individuo, il sentirsi per un momento facente parte di una folla in movimento diretta verso la distruzione di qualche cosa che in un modo o nell’altro rappresenta il sistema, il sentirsi protetti dalla incolumità dell’anonimato della folla, causa questi fenomeni paradossalmente sproporzionati (solo apparentemente) ai motivi generatori.
Non bisogna dare la colpa alla politica di violenza di coloro che soffrono o di coloro che aspirano a diventare “proletariato cosciente”, non è possibile condannare questi lavoratori che lasciano le proprie famiglie e il proprio pane per dirigersi verso un luogo di riunione e cercare di portare avanti le richieste di una migliore integrazione nel sistema, costoro non possono sapere i veri motivi del loro atto collettivo. Ma gli altri, quelli che spendono il loro tempo e i soldi dei cittadini, per riflettere su questi problemi, i sociologi dell’istituzione debbono saperlo ed è giusto, sulla loro coscienza di uomini e non di burattini, che chiariscano questi problemi alle masse.
[“Violenza e non violenza”, pubblicato su “L’Agitazione del Sud”, marzo-aprile 1969]
Il pericolo dell’inglobazione
La proteiforme attività inglobante del sistema non può essere combattuta a nostro avviso dall’interno. Ogni tentativo revisionista è destinato a un misero fallimento. Comunque, poiché non siamo assolutisti, possiamo concedere, in via d’analisi, la possibilità che un’azione disgregatrice interna – quale potrebbe essere quella condotta da un partito di sinistra – possa giungere a risultati positivi.
Questa azione, che in linea di principio ci vede dissenzienti, dovrebbe ammettere però l’esistenza di un grave pericolo: l’inglobamento. Il sistema non è una struttura rigida. Teniamo presente che un teorico del comunismo polacco, il filosofo Adam Schaff, ha parlato di un “dialogo molle”, per dare corpo a un comportamento politico diretto a non rigettare immediatamente e in forma dura le istanze revisioniste interne, ma solo a porre in atto un immediato – quanto platonico – piano dialogico, tendente a prorogare all’infinito le richieste o a minimizzarle.
Lo studio di queste procedure di inglobamento non è mai sufficiente. Ogni ricercatore serio, che si ponga veramente alla ricerca delle forme concrete di distruzione del sistema, deve prospettarsi il problema di come porre in guardia le forze di sinistra sulla possibilità di impantanarsi nel dialogo istituzionalizzato.
Dallo studio delle teorie del linguaggio apprendiamo che il discorso persuasivo (o propagandista-politico) è quello che generalmente si dirige a modificare determinati atteggiamenti altrui allo scopo di rendere abbastanza probabile il compimento di alcuni atti.
Non necessariamente questo genere di discorso deve avere un razionale collocamento in un universo sintattico determinato, il più delle volte anzi si tratta di discorsi che si rifanno immediatamente a “sensazioni”.
Lo studio di questi processi facenti leva sulle sensazioni non sempre apertamente identificabili conduce con sufficiente chiarezza a denunciare l’attività condizionatrice del sistema.
Naturalmente, affinché la politica di inglobazione possa avere effetti duraturi, occorre che le forze di rottura, agenti in continuazione all’esterno del sistema contro le strutture istituzionalizzate, vengano poste nella condizione di nuocere il meno possibile.
Da questa necessità deriva l’esistenza della censura e del controllo tempestivo che l’ufficio politico delle questure esercita su tutte le pubblicazioni a stampa.
Esiste poi il mezzo d’inglobazione che definiamo “decisivo” il quale, sebbene venga impiegato notoriamente in molte altre attività raffrenanti del sistema, nel campo della cultura trova la sua applicazione più particolareggiata e fruttifera. La forza di rottura viene chiamata a fare parte del sistema, a sedersi alla tavola imbandita e a partecipare al taglio della torta. Non sono in molti ad avere la forza di resistere a un invito del genere.
A questo punto il processo dell’inglobazione è quasi concluso, non resta che stilare i termini dell’accordo. L’uomo di cultura, venuto a compromesso con la propria coscienza, contro il piatto di lenticchie della gloriuzza passeggera, del conto in banca, o della cattedra, china la schiena e si pone indefessamente al lavoro per illustrare il sistema, per curare la manutenzione delle strutture, per contribuire alla persistenza e alla continuazione del dominio sull’uomo.
Con queste procedure di progressivo assorbimento il sistema costruisce quella riserva culturale cui attingere nei momenti di bisogno per fronteggiare le pressioni della cosiddetta “cultura non ufficiale”.
Innanzitutto questa lotta viene portata avanti con l’arma terribile del silenzio. La cultura istituzionalizzata, che per facilità di riferimento chiameremo “accademica”, non prende atto delle mosse della cultura non ufficiale, si limita a seguirne timorosa le idee e le iniziative, attuando, se del caso, tutte quelle inglobazioni che di volta in volta si riterranno necessarie. È la stessa tattica operata in forma ampia dal sistema che viene fatta propria dalla longa manus di quest’ultimo agente sotto la veste pseudo-culturale.
La stupidità essenziale della cultura accademica, la vuotaggine interiore, l’assoluta impossibilità di prevenire i nuovi fermenti della cultura “esterna”, la straordinaria ottusità davanti a quello che si potrebbe definire “lo spirito dei tempi”, rendono la cultura accademica del tutto incapace di bloccare in anticipo la cultura attiva che agisce all’esterno, però essa è perfettamente in grado, non appena avvertito lo stimolo, di adeguarsi alle istanze rivoluzionarie e di assorbirle.
Esattamente questo sta avvenendo oggi nel mondo. La cultura accademica è al lavoro, continuamente sollecitata dal sistema, per inglobare la rivoluzione contestataria.
Ovviamente vi è ancora chi, all’interno della cultura accademica, crede in buona fede di appartenere a una élite aristocratica della cultura e di lavorare perché venga democraticamente dispensata al volgo, ma si tratta di poche persone che, tra l’altro, hanno ormai definitivamente perduto il senso delle parole “democrazia” e “intellettualità”.
Gli scavi negli archivi, le discussioni metodologiche astratte, le fantasiose costruzioni metafisiche, le piccole monografie su autori arcinoti e ormai superati dai tempi, le valanghe di articoli e saggi su riviste specializzate che nessuno legge, le recensioni, le bibliografie complete e no, che cosa può significare tutto ciò? Se non si tiene conto di una dirittura di pensiero, se non si rivaluta tutto in funzione di una determinata visione della realtà sociale, ciò non vale nulla. Che funzione può avere una vita spesa nello studio in questo modo, anche in buona fede (per non parlare dei casi dell’aperta vendita della propria coscienza al sistema), se poi i problemi del nostro tempo, quegli stessi problemi che travagliano i nostri figli, ci restano ignoti, oppure se inconsapevolmente lavoriamo al genocidio e alla distruzione della civiltà? Davvero una gran bella conclusione la vita di uno di questi studiosi che da un canto si affannano a salvare un documento o a mettere insieme una bibliografia, mentre dall’altro contribuiscono – attivamente o passivamente – alla distruzione della cultura in generale.
A questo mondo sonnolento e ritardato si contrappone tutta una fioritura di iniziative e di polemiche culturali sulla scia di una tradizione mai interrotta ma soltanto affievolita e ostacolata, la tradizione dei “filosofi” francesi della rivoluzione, dei letterati capaci di attaccare e distruggere secoli di storture e di oscurantismi.
La figura del “filosofo libertario” oggi si identifica con l’uomo di cultura, sensibile ai problemi del suo tempo, dotato di una grande facilità nello scrivere, capace di polemizzare con tutti i ritardati mentali che abbondano nel mondo accademico, come pure di cogliere i pochi frutti buoni che le università riescono ancora a produrre. Questa attività non deve avere di mira nessuna carriera, nessun secondo fine, nessun arrivismo, il risultato deve essere, come lo era per gli enciclopedisti francesi, il miglioramento delle lettere e delle scienze, lo sviluppo della ricerca, l’ampliamento della conoscenza.
D’altro canto non bisogna dimenticare che lo stesso Kant definiva l’attività dello studioso come un’ardita conquista, donde il motto “osa conoscere!” eletto a massima di tutta la vita del ricercatore. Certamente molti cattedratici di oggi vedrebbero affluire e acconsentire i loro studenti se davvero potessero dimostrare con i fatti di aver messo in pratica l’esortazione kantiana.
Di questo fatto possiamo dirci convintissimi. La cultura oggi deve ricercarsi fuori delle università e di tutti gli enti istituzionalizzati che fanno della cultura il loro pane quotidiano e, per questo solo fatto, la scambiano per quel processo di routine che accompagna necessariamente tutte le abitudini umane.
Non è compito di un uomo di cultura interessarsi del futuro in senso stretto. Almeno non è compito suo dettare le possibilità dettagliate di un probabile ordinamento o di un probabile risultato. Però non bisogna dimenticare come in pratica non sia possibile uscire fuori dalla necessità di vivere in funzione del futuro. Noi in pratica non viviamo nel presente, ma viviamo nel futuro. Ogni nostra azione è talmente proiettata in avanti da potersi dire collocata nel presente ma fondata nel futuro. Per questo è quasi obbligatorio svolgere una determinata ricerca in funzione degli eventuali sviluppi che la stessa potrà ricevere in un contesto sociale attuabile solo in futuro.
Da questo lato non possiamo avere dubbi che il futuro è valutabile solo attraverso la demolitrice azione della libera cultura. Quella ritardata, quella chiusa nell’austerità delle università e nel contorno dorato degli scranni delle accademie, è troppo ammuffita per potere dire qualche cosa di veramente definitivo, e quando non è ammuffita generalmente è troppo specialista, troppo amante del particolare o della tecnica difficile (allo scopo di fare colpo sugli altri accademici), per pensare di snellirsi e di agire sulla realtà concreta.
Da questo lato i giovani, con le loro istanze rivoluzionarie, hanno posto il dito sulla piaga, accelerando un processo di decomposizione già in atto che accennava a durare ancora a lungo. La riforma universitaria, dal canto suo, presentandosi come rimedio peggiore del male, contribuirà ulteriormente a completare il quadro.
È naturale che il solo fatto di trovarsi fuori della cerchia universitaria non può abilitare ad essere portatori della “verità” e tanto meno a potersi definire in possesso della chiave di volta della cultura.
La responsabilità dell’intellettuale “libero” è veramente più grande di quella dell’accademico. Di fronte ai posteri e agli stessi contemporanei che, specialmente nella classe universitaria più giovane, stanno veramente aprendo gli occhi, l’uomo di cultura deve dimostrare di non essere un “lanzichenecco” della libera cultura. Questa dimostrazione può avvenire solo in un modo, dando conto della propria posizione, difendendola con gli scritti dagli attacchi – invero assai poco temibili – della cultura universitaria, diffondendo la propria idea, combattendo la posizione di coloro che da perfetti ignoranti e sprovveduti si sono intrufolati nei gruppi di cultura libera – sfruttando la possibilità dell’ingresso non selettivo – solo allo scopo di mettersi in luce per meglio collocare la loro personalità per una futura vendita politica o per un futuro compromesso di coscienza.
Tutto ciò è veramente difficile, ed è forse il pericolo peggiore contro cui dovranno combattere le libere forze culturali. Ma al di là di questa battaglia su due fronti, al di là di tanti molluschi invertebrati che oggi agitano le code nelle università o che si celano pavidi tra le folte file della libera cultura, non tarderanno ad avere la meglio i pochi che rettamente interpretano l’antico compito di avanguardia e di lotta che sempre i popoli liberi hanno attribuito alla libera cultura.
[“Il pericolo dell’inglobazione”, pubblicato su “Azione socialista”, aprile 1969]
L’Etica di Kropotkin
Elementi, correnti, prospettive
Il lavoro di Kropotkin si presenta come la prima base di un grandioso edificio, pronta a ricevere una serie di piani e adatta a sopportare un peso enorme. Tale infatti la premessa di un disegno che, nelle intenzioni dell’autore, doveva giungere fino ad abbracciare la scienza dell’Etica in tutti i singoli problemi teorici e pratici. Purtroppo la morte impedì il compimento dettagliato di questo piano. Solo il primo volume, quello che qui viene per la prima volta reso in italiano, aveva sufficiente completezza per stare in piedi da solo.
Comunque, sufficienti elementi sussistono per indicarci le intenzioni teoriche di Kropotkin, e sufficienti sviluppi sono posti in atto nella trattazione delle singole correnti di pensiero etico del passato, fino alle figure contemporanee di Charles Darwin, di Herbert Spencer e di Jean Marie Guyau.
Questi elementi sono quelli tradizionali dell’evoluzionismo, con la modifica essenziale della particolare prospettiva sociale di Kropotkin. Da questa prospettiva, con l’ausilio dell’elemento eminentemente “naturalista” della socialità animale, egli giunge nel centro del complesso edificio del darwinismo filosofico, smantellando punto per punto non poche credenze alla base di quelle volgarizzate da Thomas Henry Huxley.
Questa parte è tra le più interessanti del volume. Più volte la teoria della socialità animale è ribadita accanto alla grande premessa teorica dell’intera concezione etica dell’anarchismo e di tutte le dottrine che non si definiscono sociali solo a parole (come ad esempio il cristianesimo del fondatore), cioè la giustizia intesa nel significato originario di uguaglianza. Il sostegno di questa si è trovato nella ricerca naturalista della vita degli animali, unitamente a una stretta consequenzialità logica nel reperire via via tutte le imperfezioni e le facili credulità di coloro che si sono lasciati prendere dalle due correnti sbagliate dell’etica, quella che pone l’origine dei moventi morali nella zona dei sogni e del soprannaturale, e quella che la nega del tutto definendola una banale illusione o una interessata mistificazione.
Le prospettive si identificano con gli elementi adottati, nel fermo proponimento di ribadire il concetto della socialità e quello dell’uguaglianza in forma sia negativa, tacciando di assoluta incomprensibilità i dati scientifici forniti dai paladini della teoria della “lotta per l’esistenza”, sia positiva, sviluppando la tesi “naturalista” di una “continuazione” tra società animale e società umana, sul piano di una linea di sviluppo etico assolutamente priva di interruzioni.
A quanti, tra i lettori italiani, fosse venuta in mente, al momento stesso di leggere il titolo del presente libro, la solita elencazione di temi e problemi tipici del campo filosofico dell’etica, non mancherà, il nostro Kropotkin, di riservare una grossa sorpresa. La trattazione del rapporto io-volontà è del tutto trascurata, come pure quella relativa al funzionamento del meccanismo di valutazione. Non solo Kropotkin non ne fa che brevissimi cenni nella parte propedeutica del suo lavoro, ma non si lascia sfuggire l’occasione, nel corso della parte storico-critica, di tacciare di balordaggine tutte le trattazioni metafisiche dell’etica del passato.
Il contrasto tradizionale e scolastico, tra “libertà” e le libertà, è circoscritto da Kropotkin al contrasto “esterno” tra legge naturale e calcolo edonistico. Una sorta di capovolgimento liberatorio da schemi che risalgono addirittura all’antico epicureismo, rivissuti attraverso la lente benthamiana. Le libertà diventano in questo modo le concrete possibilità della volontà di potenza, mentre la libertà diventa la strada determinante del processo sociale verso la concretizzazione dell’istinto primordiale della comunità.
Lo stesso dicasi per il rapporto tra causa e libertà, apparentemente assente. Ma il lettore deve avere più buona volontà di quella che solitamente l’accompagna di fronte a un testo tradizionale o cattedratico. Kropotkin capovolge ancora una volta il raffronto, riguadagnando la legittimità del determinismo a dettare i termini di un nuovo metro di libertà, il progresso. Non quello solito e stantio, dagli schemi teorizzati da un Lamarck o volgarizzati da uno Spengler, ma quello dinamico, sinonimo di sviluppo. Quello che manca – e non è poca cosa lo sforzo che Kropotkin dovette fare per liberarsi da questa sovrastruttura – è la legge necessitante. Fermo restando, e non poteva essere altrimenti per quell’epoca, la dogmatica legge di causa ed effetto, il progresso diventa la vera struttura della libertà, e su di esso si adagia la specie, nella sua fede verso l’avvenire.
Altri temi metafisici banditi: il tempo e la presenza, il duplice volto del rapporto intelletto-volontà, il meccanismo dialettico in generale e in particolare il meccanismo della libertà. Tutto ciarpame hegeliano, roba da soffitta. Kropotkin non solo non ne parla, ma sembrerebbe che tutta questa roba non sia mai esistita per lui, tanto sgombra e baconiana è la sua riflessione.
Assente ogni distinzione tra attività teoretica e attività pratica. Il problema non si pone, una volta respinta l’istanza metafisica, se non come problema dichiarativo di un’azione, quella della ricerca, ed in questa come sappiamo teoria e pratica si fondono e si confondono. Ogni buona volontà da parte del lettore per individuare filoni e segmentazioni sarebbe pertanto sprecata, l’importante nocciolo della conversazione produttiva è altrove.
I classici problemi del rapporto altruismo-egoismo, del valore del presupposto eudemonico, con tutte le sue implicazioni di rigorismo intellettivo e di selettività edonistica, sono trattati con larghezza di mezzi nella parte storica, che per questo diventa qualcosa di più che una semplice digressione di teorie e di figure, per assurgere alla esatta collocazione di una serie di spunti e di occasioni per il dipanarsi di una tematica unica e consequenziale.
L’alternativa storica è rifiutata per quel tanto che l’amplesso con il relativo, e ineliminabile, storicismo avrebbe comportato. Il rifiuto comporta una concomitante ammissione della sola validità naturalista. Infatti, alle scienze della natura, in particolare alla genetica, all’antropologia, alla zoologia, con l’ausilio di una scienza dell’uomo con forti tendenze – almeno per l’epoca – positiviste, cioè la sociologia, si rivolge Kropotkin ricercando con il loro impiego le basi dell’etica. Quindi, rifiuto della collaborazione storia-filosofia e riduzione di quest’ultima a semplice gnoseologia o, come si direbbe più esattamente oggi, metodologia della conoscenza scientifica. Ciò significa anche rifiuto del problema della prassi, almeno nel senso marxista, in quanto legato intimamente all’accettazione dell’implicanza storicista.
Il problema della coercizione risente dichiaratamente dell’influenza di Guyau. Verso questo giovanissimo autore Kropotkin nutrì sempre una forte simpatia, tanto da collocarlo a conclusione della trattazione storica del suo lavoro. In effetti l’opera di Guyau, diretta a fondare una morale priva di sanzione, è molto interessante, specie per una interpretazione anarchica dell’etica. È indiscutibile però che in etica bisogna fare i conti con il problema storico della coercizione, sia in senso positivo – come ad esempio è stato considerato da quella linea di pensiero che da Thomas Hobbes conduce a Spencer – sia in senso negativo, come sostiene Kropotkin preceduto da una serie di pensatori che da Epicuro si ricollega allo stesso Guyau, e questo problema storico si ritorce sull’azione spontanea delle forze naturali in azione. La coercizione e il suo contrario, la persuasione, costituiscono due degli elementi base del discorso etico, al di là di essi non si può lavorare che sui risultati.
Restano due grandi problemi, la giustizia e la religione. Kropotkin li affronta in perfetta aderenza al pensiero anarchico. Manca, è vero, di presentare un’etica individualista, ma ciò non è affatto la sola soluzione del pensiero anarchico, caso mai sarebbe una delle soluzioni e, per giunta, nemmeno la più frequente o accettabile. Comunque il fondo della questione non è questo. La giustizia e la religione sono perfettamente valutate da Kropotkin sul piano etico ed è qui, e non altrove, che bisogna cercare il vero valore dell’opera che stiamo commentando.
La giustizia è intesa nel senso di uguaglianza. Ogni significato consimile o parallelo è da ritenersi se non dannoso almeno pericoloso. In questo senso Kropotkin rimprovera lo stesso Proudhon per essersi, alcune volte, lasciato attirare dalla duplice possibilità di considerare la giustizia, sotto l’aspetto teorico, nel senso appunto di uguaglianza, e sotto l’aspetto pratico, nel senso impiegato dalla giurisdizione e dalla giurisprudenza. È importante sottolineare che nello stabilire l’equivalenza matematica tra giustizia e uguaglianza Kropotkin chiude con perfetta simmetria il cerchio delle responsabilità ereditarie e sociali della specie, ricollegando il semplice istinto originario verso un progresso che si identifica nella libertà con una riflessione diretta a stabilire la giustizia, cioè l’uguaglianza. Ogni altro problema esula dall’orizzonte kropotkiniano. Lo stesso, grandioso, problema dello Stato è una semplice conseguenza del problema base della giustizia.
L’altro polo fondamentale della tematica di Kropotkin è il rifiuto della religione. Questo atteggiamento comporta un rifiuto della interpretazione soprannaturale dell’origine delle nozioni etiche nell’uomo. Si tratta in sostanza di una pulitura sostanziale del vecchio concetto paternalista, proveniente dalle antiche speculazioni greche dapprima ed europee successivamente. Rifiuto tanto più importante in quanto accompagnato da una contemporanea, costante e rigida denuncia contro la Chiesa cristiana. In questa azione Kropotkin è veramente magnifico. Dall’iniziale accettazione della tesi cristiana dell’uguaglianza (forse la prima formulazione della equivalenza giustizia-uguaglianza), egli passa a dimostrare la mistificazione che l’originale dottrina del Cristo subisce ad opera dei suoi continuatori e dei fondatori della Chiesa cristiana. Una precisa documentazione dei misfatti politici, economici ed etici perpetrati dalla Chiesa documenta il problema, dandogli una tale esauriente trattazione, da lasciare in una luce, eccezionalmente ben centrata, il problema inverso dell’origine puramente naturale delle basi etiche nell’uomo.
Questo il quadro generale degli elementi, delle correnti e delle prospettive in azione nell’ampio disegno del lavoro di Kropotkin.
Restano da vedere alcune cose in dettaglio e le studieremo qui di seguito in questa introduzione. Si tratta di tre punti principali, che porranno il lettore in grado di affrontare il testo con un corredo di notizie tali da potere dirimere tutti i possibili dubbi di una lettura immediata e non selezionata. Il primo di questi punti è il problema del cosiddetto “darwinismo”, che cosa significò al momento della sua entrata in scena, che cosa significava al momento in cui Kropotkin scriveva il suo lavoro, che cosa significa oggi, per noi che leggiamo il suo lavoro.
Il secondo punto è quello che ci condurrà a stabilire i rapporti effettivi che intercorrono tra il pensiero di Kropotkin e quello dell’altro grande evoluzionista, Herbert Spencer.
Il terzo e ultimo ci permetterà di stabilire in che senso si può parlare di un “Kropotkin evoluzionista”, fino dove una simile ammissione risulta legittima e il punto preciso dopo il quale quella etichetta minaccia di tradire il contenuto.
Il darwinismo
Il lettore italiano che non ha superato la sessantina e che non è né uno specialista biologo né un filosofo della scienza corre il rischio di considerare il “darwinismo” come quella generale tendenza, tipica dell’Ottocento, che considerava l’uomo diretto discendente della scimmia. È ovvio che questa semplicista conclusione può far sorridere in quanto moltissimi sanno ormai come non siano affatto queste le intenzioni delle teorie evoluzionistiche proposte per la prima volta in forma compiuta da Darwin. Comunque riteniamo che una presentazione schematizzata del “darwinismo” possa risultare molto utile.
Il lavoro di Darwin, frutto di meditazioni durate decenni e di osservazioni scientifiche condotte in tutto il mondo al seguito della crociera del vascello “Beagle”, è molto cauto e ponderato. Ogni proposta viene vagliata sotto tutti gli aspetti e formulata sempre con una notevole riserva dubitativa. Lo stesso spunto principale, la chiave della legge dell’evoluzione, così come è stata esposta nelle ultime parole della Conclusione, è chiaramente cautelativo: «Così dalla guerra della natura, dalla carestia e dalla morte, direttamente deriva il più elevato oggetto che si possa concepire, cioè la produzione degli animali superiori», è dichiaratamente coperto dalle caute parole seguenti: «Vi è qualcosa di grandioso in questa concezione della vita, con i suoi diversi poteri, originariamente impressi dal Creatore in poche forme, in una forma sola, e nel fatto che, mentre il nostro pianeta ha continuato a ruotare secondo l’immutabile legge della gravità, da un così semplice inizio innumerevoli forme, bellissime e meravigliose, si sono evolute e continuano a evolversi». (L’origine delle specie, tr. it., Torino 1959, p. 524). Ma ciò non è ancora il “darwinismo”. Quest’ultimo doveva nascere dopo e immediatamente degenerare.
Già nel 1868 Ernst Heinrich Haeckel pubblicava la Naturliche Schopfungsgeschichte, nella quale il concetto di “evoluzione” usciva dai binari della scienza per entrare in quello della cieca fede e del proselitismo a tutti i costi. Così Haeckel: “Evoluzione è, d’ora in poi, la parola magica, con la quale possiamo chiarire o per lo meno avviarci a chiarire, tutti i misteri che ci circondano”. Il teleologismo che sarà la piaga più grave dell’esasperato “darwinismo” comincia a farsi strada negli studiosi dell’epoca. Il passo verso l’animismo della natura è da considerarsi come la conclusione obbligata di questa immediata rottura dell’iniziale sistema di ricerca prospettato da Darwin.
In effetti Darwin aveva cominciato col rifiutare il lamarckismo proprio perché intendeva non valersi “né dell’azione dell’ambiente né della volontà degli organismi” per spiegare il processo evolutivo. Da ciò la necessità di tenere separato il “fatto storico dell’evoluzione” dalla “spiegazione del fenomeno”. La stessa riprova del fenomeno che le specie subiscono delle modificazioni, ottenibile con prove indirette, gli sembrava un argomento del tutto trascurabile. È la causa dell’evoluzione il fulcro principale della sua teoria, l’individuazione di questa causa nei termini di “struggle for life” e di “survival of the fittest”, in altri termini di selezione naturale. Quanta parte abbia avuto in questa vera e propria intuizione il lavoro di Thomas Robert Malthus non è facile provare, comunque è certo che alcune formulazioni del vecchio economista sono passate di peso nell’opera di Darwin.
La ricerca di Darwin è completata dallo studio del fenomeno naturale della “variabilità”, dal cui ceppo successivamente vedranno la luce quelle correnti di ricerca che oggi si riuniscono sotto il nome di genetica.
Quindi il “darwinismo” è qualche cosa di molto diverso dalla vera teoria di Darwin , lo stesso Kropotkin, pur nella sua necessità di individuare il centro dell’etica nell’istinto di “socialità”, è costretto a riconoscere che Darwin non è quello che i suoi discepoli e seguaci ci dipingono, comunque non è in modo assoluto quello che Huxley vuole fare passare per buono.
Indubbiamente fondata, quindi, la ricerca di Kropotkin diretta a ribadire il concetto di “mutuo soccorso”. Egli si rifà essenzialmente all’altro lavoro fondamentale di Darwin, L’origine dell’uomo, in cui, sebbene sussistano sempre le coperture a una manifestazione chiara e definitiva delle tendenze filosofiche dell’autore, si può vedere meglio il ruolo complementare e in definitiva decisivo giocato dall’istituto di socialità. Citiamo dall’Origine dell’uomo (tr. it., Milano 1949): «Chi abbia veduto un selvaggio nella sua terra nativa non sentirà vergogna se sarà obbligato a riconoscere che il sangue di qualche creatura più umile gli scorre nelle vene. In quanto a me, vorrei essere disceso da quell’eroica scimmietta che affrontò il suo terribile nemico per salvare la vita del suo custode o da quel vecchio babbuino che sceso dal monte strappò trionfante il suo giovane compagno a una muta attonita di cani, quanto da un selvaggio che si compiace di torturare i suoi nemici, offre sacrifici di sangue, pratica l’infanticidio senza rimorsi, tratta le sue mogli come schiave, non conosce che cosa sia la decenza ed è dominato da grossolane superstizioni». (Ib. p. 579). Si vede come Darwin sovrapponga i due concetti di mutuo soccorso e di lotta per l’esistenza, senza operare quella netta distinzione o quella gradualità di preferenza, cui invece ricorre Kropotkin, comunque l’importante è che anche il fondatore della teoria adoperi questi concetti.
Altro punto di grande interesse, che si rivela nettamente dalla lettura del brano riportato, è che Darwin opera una recisa separazione del principio etico da una presunta “necessità assoluta”, affidandolo alla consequenzialità dello sviluppo evoluzionista. Il selvaggio, di cui elenca con tanta cura i lati negativi, ha un comportamento etico, ovviamente dal suo punto di vista, in quanto aderisce perfettamente alle regole stabilite dal suo clan. Che poi questo comportamento sia dissonante con quello di un uomo “civilizzato”, è questione puramente contingentale dipendente dal grado di sviluppo del selvaggio e dalla impossibilità di comprendere determinati concetti etici. Viceversa, alcuni concetti etici, chiarissimi al selvaggio, come per l’appunto quello di uguaglianza, sono difficilmente percepibili dall’uomo “civilizzato”.
Quante volte Kropotkin abbia avuto davanti lo spettro del “darwinismo” invece di avere la vera teoria di Darwin non è possibile stabilire. In effetti non poche volte egli si preoccupa di fissare una certa divisione, non potendo racchiudere il fondatore della teoria nei viluppi confusionari e negativi di chiara impronta teologica e animista che caratterizzano gli epigoni. Comunque ci sembra determinante chiarire che la polemica kropotkiniana sia da ritenersi indirizzata più verso Huxley che verso Darwin stesso. Concludendo su questo punto possiamo pertanto così riassumere la teoria di Darwin:
1) Esistenza di variazioni organiche di lieve entità ma costanti, verificantesi in un decorso di tempo molto ampio a causa di prefissate condizioni di ambiente. Queste variazioni, la cui apparizione è interpretabile in termini di tendenza probabile, cioè di direzione valutabile solo probabilisticamente, determinano concreti vantaggi nei soggetti che le pongono in atto.
2) Lotta per la vita. Necessità per tutti gli esseri appartenenti a una determinata specie di lottare per la propria sopravvivenza e il proprio sviluppo, in forza del fatto che lo sviluppo stesso della specie è regolato dalla legge di Malthus.
Tutto il resto della teoria di Darwin si desume scientificamente, quindi con procedimento deduttivo, da questi due punti essenziali di partenza.
Vediamo adesso di riassumere la critica di Kropotkin, diretta come abbiamo detto più che alla teoria evoluzionista nel suo insieme alle eccentricità di alcune deduzioni:
1) Ammissione della tendenza evolutiva del progresso delle forme organiche. Il principio di variabilità e la forma statistica che questo principio assume in Darwin non sono sottoposti a verifica da parte di Kropotkin, almeno non nell’opera sull’Etica.
2) Lotta per la vita. È il centro della polemica di Kropotkin. La lotta viene riconosciuta, non potendosi negare come fatto storico facilmente provabile. È invece negata all’interno della specie, in quanto – secondo la formulazione del pensatore russo – questa lotta avviene fra specie e classi o gruppi in contrasto tra loro.
3) Da questa semplice correzione del principio darwiniano, correzione cui era giunto, dal canto suo, lo stesso scienziato inglese nelle sue opere successive, viene spontaneo il concetto di “mutuo soccorso”.
4) Il concetto di “socialità” rende possibile l’impiego dell’altro concetto di “mutuo soccorso”, nell’interpretazione della dinamica evolutiva delle specie.
Non bisogna dimenticare che Kropotkin e Darwin sono due studiosi validamente inseriti nel clima romantico dell’epoca, penetrato profondamente dell’idea generale del progresso dell’umanità, e a questa idea dedicano, ognuno con le proprie limitazioni e le proprie idee, tutti i loro sforzi.
Il rapporto con Spencer
Non più processo alle intenzioni o preoccupata ricerca di una intuizione nascosta in opere minori e poco note, con Spencer il nostro Kropotkin instaura un raffronto diretto con un sostanzioso pensatore, bene addestrato alle riflessioni dell’etica.
Il vero antagonista di Kropotkin, il vero protagonista del suo libro, non è quindi Darwin ma Spencer, oltre naturalmente alla grande massa dei “darwinisti” contro cui sono frequentemente lanciati gli strali del suo sarcasmo.
Il contrasto essenziale ci sembra che sia quello intorno al fondamento filosofico della posizione dei due. Contrasto su cui Kropotkin non si pronuncia, ma che non per questo appare meno evidente e determinante. La tesi di Spencer, elaborata per la prima volta nel lavoro dal titolo First Principles (1862), è basata sul fatto che la realtà, nel suo significato ultimo e definitivo, nella sua accezione miticamente assoluta e circoscritta, è “inconoscibile”. In questo Spencer si dimostra perfetto continuatore di William Hamilton, collocando il “mistero”, senza specifica distinzione, tra religione e scienza, al termine della ricerca. Ovviamente Kropotkin presenta una interpretazione nettamente diversa. In lui si pone tanto meno romanticismo avvenirista quanto più il contenuto determinante del positivismo agisce e si rafforza. Se Spencer affida un compito alla religione, quello di indagare proprio questo mistero, e quindi la solleva quasi al livello della scienza (almeno allo stesso livello di impotenza), Kropotkin sbilancia maggiormente i termini del rapporto religione-conoscenza assegnando alla prima solo un compito reazionario di distruzione e mistificazione della verità.
Altro punto di grave contrasto si individua nel differente compito assegnato dai due alla filosofia. Per Spencer l’attività filosofica presiede alle supreme generalizzazioni dell’intelletto. Al di là della ricerca scientifica e degli sforzi della religione, risiede la filosofia, che tutto coordina e regge. Proprio per questo l’attività filosofica si deve dedicare allo studio dei princìpi fondamentali, tutti di ordine strettamente naturale e non metafisico, quali la continuità del movimento, la persistenza della forza, la legge ritmica dei fenomeni, l’andamento ciclico degli stessi e, infine, il principio forse più generale di tutti, l’indistruttibilità della materia. In questo modo buona parte della metafisica residua, ospitata dai traballanti sistemi spiritualisti dell’epoca, trova modo di penetrare nelle strutture del positivismo. Ecco la definizione che Spencer dà della teoria dell’evoluzione: «L’evoluzione è una integrazione di materia e una concomitante dissipazione di movimento, durante la quale la materia passa da una omogeneità indefinita e incoerente a una eterogeneità definita e coerente, e durante la quale il movimento conservato soggiace a una trasformazione parallela». (Ib., parag. 145, London 1862).
Certo si tratta di un notevole sforzo di generalizzazione, comunque non esente dal solito punto debole, causato dal grave contrasto tra spirito e materia, che in ogni caso Spencer finisce per relegare in quella zona “inconoscibile” e quindi estranea alla trattazione strettamente filosofica.
Kropotkin non annette importanza alla ricerca filosofica condotta con il tradizionale sistema metafisico. Questa sua “paura” si traduce in una certa quale rigidità nel prendere in considerazione la procedura in tale senso tradizionale usata da Spencer, sulla linea comtiana della ripartizione dei compiti tra le scienze. Condanna quindi senza possibilità di appello quella del pensatore inglese verso ogni sorta di ripensamento filosofico o di rinvio all’infinito di questioni determinanti, come per l’appunto quelle relative alla “conoscibilità” della realtà.
Sul resto dissensi di profondo interesse, ma limitati ad argomenti particolari dell’etica. Il rapporto egoismo-altruismo non viene visto dai due allo stesso modo, non uguale è la valorizzazione dell’utilitarismo eseguita da Spencer e negata sostanzialmente da Kropotkin, sebbene in ultima analisi rivalutata sotto l’aspetto di “utilizzazione”, differente pure l’indagine sul ruolo giocato dall’eredità e dall’esperienza sensibile, differente infine la prospettiva concludente l’azione di ricerca dell’etica.
L’immobilismo di Spencer, tale che spesso fa apparire l’autore come un vero e proprio reazionario, non poteva, evidentemente, riscuotere le simpatie di Kropotkin. D’altro canto la tesi da cui partiva il pensatore inglese rendeva consequenziale questo immobilismo, lo sviluppo dell’umanità è lento ma inevitabile, allo stesso modo dello sviluppo del bambino, come non è possibile accelerare i termini di quest’ultimo sviluppo, così non è possibile farlo per il primo. Ciò comportava tutta una visione particolare dell’attività degli insegnamenti scientifici. Nessuna ricerca, nessuno sforzo di penetrazione posto in atto dalla scienza, potrà modificare il ritmo della crescita e della costituzione delle forze sociali, come nessuno stimolo potrà operare un ricambio più veloce. Anzi ogni tentativo fatto in questo senso, ad opera di visionari o di utopisti (leggasi “rivoluzionari”), finisce per sconvolgere il piano determinato dello sviluppo naturale. Da ciò la considerazione negativa in cui Spencer teneva le rivendicazioni della classe operaia, nelle quali vedeva il germe rivoluzionario del tentativo di sovvertire quel corso predeterminato degli eventi in cui fermamente credeva. Non deve sembrare strano, pertanto, che lo stesso pensatore di The Man versus the State (1884) non sia riuscito a trovare la strada verso la problematica del movimento proletario, cogliendo i sintomi di una epoca in movimento e di un futuro già in atto, un futuro interamente libertario.
Kropotkin ha presente in gran luce questi limiti e se ne avvale per una critica serrata della posizione spenceriana. Non sappiamo se i due si siano mai incontrati di persona, però, da quanto si apprende dal volume qui tradotto, Kropotkin faceva parte del gruppo che si riuniva attorno alla rivista “Nineteenty Century”, diretta da James Knowles, costituito in gran parte da scrittori cosiddetti “agnostici”, e proprio Knowles era amico personale di Spencer e con questo in grande familiarità. Ciò nonostante nessun cenno a un avvicinamento dei due.
Nella critica di Kropotkin comunque non si vede riferimento a particolari asti personali, si tratta di una indagine obiettiva e precisa. Spesso viene riconosciuto a Spencer il merito di una grande precisione e coscienziosità nella documentazione, spesso si concorda con lui in alcune conclusioni. I punti principali del dissenso sono pertanto:
-
riduzione dell’evoluzione alla sola “struggle for life”,
-
errore di partenza fatto nel considerare l’uomo primitivo non vivente in società ma isolato o, al massimo, in piccoli gruppi,
-
eccessiva manipolazione filosofico-metafisica,
-
ripresentazione dello strutturalismo comtiano, sebbene in forma aggiornata.
Kropotkin evoluzionista
Il problema evoluzionista si rinviene in filosofia fin dalla lontana epoca ionica. Solo in Aristotele, però, trova una prima trattazione in forma scientifica. Certo sarebbe un po’ curioso inserire Anassimandro nell’elenco via via sempre più numeroso degli “evoluzionisti”, come ha fatto Theodor Gomperz (Grieschische Denker, vol. I, Leipzig 1896, p. 4), ma per Aristotele si può spendere qualche parola in questo senso. Nel De generatione animalium (322 a. C.), descrive fatti e cataloga fenomeni che sono stati posti in discussione successivamente dalla moderna embriologia comparata.
Volendo prescindere dall’annosa questione riguardante William Harvey, sollevata dallo stesso Descartes, e considerando lo scopritore della circolazione del sangue come un perfetto aristotelico, non ci resta che aspettare la scoperta degli spermatozoi, avvenuta nella seconda metà del secolo XVII. Con il microscopio si apre un nuovo mondo libero dalle fantastiche rappresentazioni di un Anton van Leeuwenhoek o dalle metafisiche elucubrazioni di un Leibniz, vestite di panni scientifici.
Purtroppo la monadologia terrà banco ancora per molto tempo nel settore biologico, per spiegare un rudimentale meccanismo di sviluppo e di accrescimento. È del 1759 la teoria dell’epigenesi, di Caspar Friedrich Wolff, approvata anche da Goethe, secondo la quale l’organismo si sviluppa grazie a una forza interna.
Il fondatore della moderna embriologia è Karl Ernst von Baer, che nella sua Üeber Entwickelungsgeschichte der Thiere (Storia dell’evoluzione degli animali), arriva a riconoscere la possibilità di uno sviluppo in senso ascendente di una sequenza di organismi, sebbene non necessariamente questo sviluppo debba prendere la stessa forma in tutti gli organismi che percorrono le sue gradazioni.
Con Georges Cuvier (malgrado le sue strane spiegazioni che Kropotkin definisce “reazionarie”), con Theodor Schleiden, con Edwin Klebs, si arriva alla costruzione definitiva di una teoria dell’evoluzione biologica fondata su di un vero e proprio credo, un “rigoroso meccanicismo”. L’ultima parola sarà detta da Darwin, la più circostanziata.
Su questa linea di ragionamento si pone Kropotkin, esaminando, nel lavoro che veniamo introducendo al lettore italiano, le implicazioni etiche che una posizione scientifica di chiara impronta evoluzionista comporta.
L’istinto di socialità domina il primo stadio dello sviluppo etico dell’uomo. La scoperta di un istinto identico a questo negli animali superiori conduce immediatamente alla soluzione del vecchissimo problema dell’origine dei moventi etici dell’uomo. Da qui l’esclusione di ogni ingerenza religiosa in questo fondamentale punto oscuro e, con l’esclusione, la condanna di tutti i vecchi raggiri e di tutte le credenze nell’altro mondo e nei castighi per i cattivi. La morale deve trovare il proprio fondamento in questo mondo, non potendolo trovare nella semplice legge dell’evoluzione, intesa nel senso di lotta per la vita o di sopravvivenza del più forte, lo trova in quella della socialità, cioè di “mutuo soccorso”. Questa legge è ugualmente necessaria come legge che regola l’istinto di conservazione.
Il secondo stadio dello sviluppo etico è segnato dalla riflessione speculativa. Con questo, Kropotkin non intende riferirsi alla filosofia militante ma alle riflessioni di indole morale che nel corso dei tempi l’uomo non ha mai mancato di portare a compimento. Da un lato queste riflessioni generano determinate regole di condotta, dall’altro queste regole trovano riconferma nell’affinarsi dell’istinto primordiale della socialità. È in questa fase che si fa luce l’ultimo atto della vicenda morale dell’uomo, l’impulso che si definisce generosità, affinarsi definitivo dell’iniziale socialità e preludio alla perfettibilità morale dell’uomo.
Riguardo queste premesse Kropotkin deve considerarsi un evoluzionista. Adeguandosi strettamente al “darwinismo” imperante all’epoca in cui fu scritta l’Etica, il nostro autore non può considerarsi che un evoluzionista “fuori strada”. Infatti dalle sue premesse sulla teoria del “mutuo soccorso” e sul ruolo giocato dall’istinto di socialità, Kropotkin è portato a giungere a conclusioni implicanti la necessità di operare direttamente sulla società in favore dell’eliminazione delle differenze di classe e di ogni altro tipo di differenze, allo scopo di instaurare quel concetto di “giustizia sociale” che deve considerarsi come semplice sinonimo di uguaglianza. A queste conclusioni non giunsero i “darwinisti” cosiddetti ortodossi, come non poterono giungervi gli evoluzionisti in generale, vincolati sia alla reazionaria teoria dell’ineluttabilità della lotta di classe, quale simbolo della sempre imperante disuguaglianza della natura, sia al concetto di “sopravvivenza del migliore” non nel senso comunitario di collaborazione, ma nel senso individualista di privilegio.
Peccato veramente che la morte abbia impedito a Kropotkin di completare la seconda parte del suo lavoro. Avremmo potuto vedere tratteggiata una teoria etica, solamente abbozzata nei primi capitoli del presente libro, portante a naturale compimento i presupposti evoluzionistici dell’etica biologica tradizionale. Comunque la compiutezza dell’opera che presentiamo è più che sufficiente ad introdurre il lettore nei problemi morali e nel settore interpretativo che da tali problemi si sviluppa, settore segnato dalla prospettiva kropotkiniana.
Questo settore presenta una grande importanza per l’attuale lettore italiano, specie in un’epoca in cui il richiamo alla violenza distruttrice di ogni ordine costituito si manifesta da più parti. La lettura di un’opera di tanto respiro come l’Etica di Kropotkin può essere motivo di riflessione su questo problema centrale, inducendo molti nostri compagni di pensiero a riflettere sul fatto che non tutto l’“evoluzionismo” si identifica con la teoria della “vittoria del più forte” o della “battaglia per la sopravvivenza”. La legge della giungla applicata all’uomo è solo una parte della teoria evoluzionista, forse la più caduca e la più arretrata, il futuro è da considerarsi ancora una volta nel principio della collaborazione e dell’unione.
[1968] [Introduzione a P. Kropotkin, L’Etica, tr. it. di A. M. Bonanno e V. Di Maria, Catania 1969. Seconda edizione 1972. Terza edizione 1990, senza Introduzione]
Due studi su L’anarchia di Errico Malatesta
Il testo
Prima di svolgere il discorso preciso e delineato che ci siamo proposti è necessario avvertire il lettore sui limiti e gli scopi del libretto di Malatesta.
Il lavoro si presenta con quell’agilità che ha caratterizzato tanti altri suoi scritti divulgativi, però ha qualche cosa in più, una organicità che potrei dire unica, una sintetizzazione che giunge fino alla freddezza del manuale senza implicarne la stucchevolezza, una perfetta adesione con i diversi punti della programmatica malatestiana condotta negli anni su fronti e con mezzi pubblicistici diversi.
Il particolare indirizzo che l’autore dette al suo lavoro si traduce, per noi ora a distanza di tempo, in un grosso problema. Reperire i raccordi con gli altri scritti di Malatesta, sui vari argomenti proposti, non è stato facile né agevole, stante, tra l’altro, l’assoluta mancanza di citazioni. Di volta in volta abbiamo cercato di rilevare l’accento apologetico, sottolineando nelle note il vero limite delle singole proposte malatestiane, ma non trascurando di studiarne i riferimenti con la letteratura dell’epoca, sia strettamente scientifica che dichiaratamente pubblicistica o divulgativa.
Non intendiamo ovviamente presentare un testo critico per altro assolutamente inutile oggi come allora, quanto un testo utilizzabile per approfondire l’indagine sul pensiero di Malatesta, sia nei riguardi della cultura sociologica dell’epoca, sia nei riguardi dell’attuale momento storico.
Il testo che riportiamo annotato è quello pubblicato nel 1950 a Reggio Calabria. Riguardo all’edizione milanese del 1921 questa edizione manca della biografia di Malatesta di Luigi Fabbri, che anche noi tralasciamo di pubblicare.
Pensiero e azione
Questo classico dilemma è scritto a chiare lettere sulla porta che conduce alla comprensione del pensiero di Malatesta. Finché non si collocherà esattamente quest’uomo nella sua vera veste di agitatore e di rivoluzionario, non si comprenderà il suo pensiero, come si rimarrà stupefatti nell’apprendere che Malatesta esercitava in concreto per vivere l’attività di meccanico o, altro fatto sintomatico, che rifiutò sempre l’offerta di scrivere le sue memorie.
Ma l’azione non fu fine a se stessa. Malatesta poté giungere a una opportuna compenetrazione dei due poli del contrasto. L’attività esterna, condotta per quasi sessant’anni, che gli fece passare quasi dieci anni della sua vita in carcere in attesa di essere sottoposto a diversi giudizi, quella stessa attività che lo faceva centro delle attenzioni poco gradite delle questure di tutto il mondo, si riversava dentro di lui e nel crogiuolo del suo pensiero veniva trasformata in scritti di rara chiarezza e penetrazione.
In tal modo dall’azione concreta, dalla cospirazione e dalla attività rivoluzionaria, nasceva un curioso tipo di scrittore, ribollente, vivace, imprevedibile, ma nello stesso tempo freddamente conseguente, lucido ragionatore e padrone di una logica di mestiere.
Debbo confessare che non ho letto tutti gli scritti di Malatesta, né la cosa sarebbe stata possibile dato l’attuale grado di dispersione, comunque ho potuto prendere contatto con alcune raccolte di giornali anarchici e con quasi tutte le pubblicazioni in volume che hanno trattato dell’uomo e del pensatore. Però, anche di fronte a una tale frammentaria possibilità di informazione, posso dirmi abbastanza sicuro dell’indagine che ho condotto e che mi accingo ad esporre.
L’apologetica
Il titolo di questo paragrafo non deve trarre in inganno. Intendo usare questo termine quasi come un sinonimo di propagandistica. Ho detto “quasi” e ne spiego il motivo. Il discorso apologetico di Malatesta e con lui, in grado molto più elevato, degli anarchici “vecchia maniera”, è pur sempre un discorso propagandista ma è anche un discorso generalizzante. Tende a fornire una visione d’insieme assolutamente perfetta della formula anarchica, per poi proporre delle interpretazioni in senso negativo di una realtà che ottusamente persiste nel rigettare la soluzione dettata dall’anarchismo.
Evidentemente un discorso del genere, valido dal punto di vista divulgativo, non lo è più dal punto di vista scientifico. La sociologia ha studiato le categorie della società, ha notevolmente approfondito i problemi del vivere comunitario, si è avvicinata in molti punti a quei concetti proposti dall’anarchismo tanti anni prima in un’atmosfera di generale sbalordimento.
Oggi viviamo in un clima di continua messa in crisi dei “valori della tradizione”. Mai in passato si è assistito a un atteggiamento tanto generale e tanto profondamente rivoluzionario. Oggi l’antico discorso apologetico dell’anarchismo ci sembra scaduto. L’altro discorso, quello programmatico, è invece vivo e vitale quanto mai, purtroppo non è stato sufficientemente rinvigorito.
È apologetico il lavoro che presentiamo di Malatesta? In un certo senso lo è, e in questo modo siamo arrivati, a nostro avviso, a fissare i limiti negativi di una ricerca onesta e senza fronzoli inutili. Mi si potrà rispondere che, data la mia premessa sulla “quasi” uguaglianza di significato tra i termini “propaganda” e “apologetica” e dato che lo scritto studiato è uno scritto eminentemente propagandista, diventi scontato che finisca per travalicare nell’apologetica, o almeno in quel tipo di apologetica che intendo qui. Ma è proprio questo il problema della pubblicistica anarchica. Dovendosi comunque fare della propaganda è necessario, nell’interesse della verità scientifica in generale e della ricerca sociologica in particolare, che questa venga fatta in forma critica.
Prendiamo un esempio che ritengo di grande chiarezza. Nei primi secoli dell’era cristiana gli scrittori della nuova setta si dettero un gran da fare per attirare quanta più acqua al loro mulino. Gli scritti di propaganda si moltiplicarono a migliaia. Basta pensare che soltanto quelli che sono giunti fino a noi occupano un buon terzo (nelle due lingue, latina e greca) della gigantesca raccolta di Jacques-Paul Migne. Questa produzione viene indicata col nome generico di “apologetica”. Essa cessa per autoconsunzione quando la nuova setta riceve il crisma del riconoscimento politico, quando finisce per conquistare il potere. Qui, ovviamente, non si fanno questioni di merito, ma si discute sulla metodologia impiegata nella propaganda apologetica. Già ai tempi di Tertulliano doveva essere in atto una notevole corruzione dei costumi all’interno stesso della setta cristiana, se poco tempo dopo (qualche decina di anni), ma in un clima tanto diverso perché improntato alla sicurezza della raggiunta autorità, Cipriano poteva permettersi di iniziare una critica costruttiva della struttura sociale delle comunità cristiane.
Personalmente non penso che Tertulliano sia stato in malafede nel magnificare la vita comunitaria dei cristiani del suo tempo e nel minimizzare i difetti che, per ragioni imprescindibili, lo stesso sistema centrista del cristianesimo doveva causare. Piuttosto penso che egli era trascinato sia dalla sua foga di polemista sia dalla necessità di difendere il principio per cui lottava. Infatti, non può esserci dubbio che la critica diventa possibile quando esiste un minimo di sicurezza fondamentale sui princìpi che vengono sottoposti a critica. Ora ai tempi di Tertulliano questa sicurezza, con le persecuzioni in atto, non poteva esserci, ma ai tempi di Cipriano essa c’era e produsse gli spiriti e gli scritti critici.
La stessa cosa può dirsi del pensiero e del movimento anarchico. Sottoposto alla dura legge delle prescrizioni, dell’esilio, del carcere, delle condanne, delle confische, è logico che il movimento doveva sviluppare una pubblicistica apologetica, a volte caotica, infantile, ingenua. Lo stesso Malatesta si lamentava (“Pensiero e Volontà”, 16 novembre 1925) che tanti compagni dedicassero il proprio tempo e il proprio danaro alla redazione e alla pubblicazione di scritti di argomento scientifico e sociologico sull’anarchia, per poi giustificare con la propria incompetenza gli scarsi risultati ottenuti.
Oggi siamo decisamente fuori del periodo descritto sopra. I tempi sono immensamente più maturi. Anche se gli anarchici non sono riusciti a costituire un esempio del loro modo di intendere il vivere comunitario, anche se per il momento il loro pensiero è rimasto allo stato teorico, le conquiste ottenute sono state forse più grandi e più significative. Oggi l’atmosfera che si respira è decisamente anarchica. Lo spirito di rivoluzione che sta dando sostegno ai movimenti studenteschi è anarchico, gli studi sociologici innovatori delle vecchie strutture tradizionali sono anarchici, lo stesso movimento marxista risente dell’influenza dei princìpi anarchici. Basta pensare al successo di Herbert Marcuse per rendersi conto della popolarità del pensiero anarchico oggi. Finché questo studioso rimase legato ai vecchi schemi della ricerca filosofica e sociologica restò chiuso nella cerchia degli specialisti, ma quando innestò nella speculazione del passato il vivificante rigetto di tutti i princìpi, anche se questo innesto è avvenuto per fini specifici che non sono assolutamente di carattere anarchico, la semplice sovrapposizione è valsa a decretare la sua fama e la sua capillare popolarità.
Oggi quindi possiamo dire che il pensiero anarchico “ha conquistato il potere”, e questa conquista è stata più una conquista delle coscienze che una conquista di un certo territorio o di un certo quantitativo di ricchezza materiale. Ecco perché l’anarchismo non può più soffermarsi all’apologetica, ma deve passare alla critica. (A conclusioni assai simili è giunto Domenico Demma in un recente articolo comparso su “Volontà” n. 11-12, 1963, p. 625, e lo stesso Vernon Richards, annotatore del volume Malatesta. Life and Ideas).
Apologetico è il tono con cui è trattato il grande tema della “solidarietà” intesa in termini di legge che governa il progresso dell’umanità. Ci sono fondati motivi di credere, e nelle note ne abbiamo dato conto, che Malatesta dubitava in fondo della esistenza di questo “principio assoluto”, in forza di quel buon senso pragmatico che non lo abbandonò mai durante tutta la vita, comunque il testo che affrontiamo, nella sua forma letterale, non ammette dubbi. Ecco quindi legittimata la conclusione apologetica.
In altra sede (“Pensiero e Volontà”, 15 settembre 1924), Malatesta ha avvertito che ogni cosa deve essere ammessa solo in via provvisoria e soltanto dopo che una prova decisamente irrefutabile l’abbia dichiarata sufficientemente certa. Ma questa legge di solidarietà non viene sottoposta ad indagine critica, viene data dogmaticamente, perché molto utile quale ascendente sui lettori, cioè a fini chiaramente apologetici.
Un punto che lascia prevalere questo tono particolare è quello in cui vengono indagate e ribattute le classiche obiezioni contro la dottrina anarchica. È ovvio che non tutte queste obiezioni sono infondate, alcune non trovano soddisfacente risposta nell’affrettata puntualizzazione di Malatesta, ma l’indirizzo stesso dello scritto non prevedeva un risultato differente. Non si può tacere che l’obiezione principale resta quella indirizzata al concetto di valore. D’altro canto la possibilità stessa di un discorso dichiaratamente rivoluzionario è fondata sulla interpretazione del concetto di valore.
È naturale che la misura dell’azione umana attualmente in corso debba dichiararsi scaduta in una società anarchica, al che aggiungiamo noi che la stessa apertura di un discorso distruttivo della interpretazione sistematica implica una svalutazione decisiva della misura dell’attività umana in atto. Quindi la necessità di un nuovo metro di paragone. Concediamo pure che questa nuova unità di misura possa adeguarsi alla ipotetica assenza di ogni unità di misura, visto che può nascondersi dietro di essa, così apparentemente innocente, una sottile prevaricazione o un subdolo tranello sistematico. Ma questa nuova atmosfera di valori non può essere costruita fondandosi sui residui della precedente distruzione, allo stesso modo che non può parlarsi del suo possibile funzionamento facendo ipotesi che partano da moventi tipici della unità di misura in corso nel mondo del sistema. Tutto ciò sul piano strettamente sociologico, ma su quello apologetico no. Infatti quando Malatesta dice: “È dimostrato che l’interesse privato è il gran movente di tutte le attività, ebbene, quando l’interesse di tutti sarà l’interesse di ciascuno (e lo sarà necessariamente se non esiste la proprietà individuale) allora tutti agiranno, e se le cose si fanno adesso che interessano a pochi, tanto più e tanto meglio si faranno quando interesseranno a tutti”. Indubbiamente è un passo di grande effetto ma non tiene conto di una cosa della massima importanza. Noi non sappiamo come in concreto potrà estrinsecarsi “l’interesse del singolo” in un contesto sociale fondato sui princìpi dell’anarchia. Quello che sappiamo è come si estrinseca in un contesto sociale fondato sulla proprietà privata o sulla collettivizzazione. Tutto qui. Il resto se non vuole essere utopia deve seguire la falsariga della ricerca sociologica ed evitare conclusioni facili e allettanti.
La critica
Il lavoro che veniamo studiando è essenzialmente malatestiano in tutti i suoi punti. Per questo, escludendo la parte apologetica, resta una sostanza critica improntata a un comune buon senso, tanto difficile a reperirsi tra i riformatori sociali.
Il primo degli aspetti critici è quello che concerne la particolare trattazione del concetto di Stato. Apparentemente il rifiuto dello Stato non si differenzia da quello classico di tutta la dottrina anarchica, inteso in termini di rifiuto dell’autoritarismo. Ma a differenza degli altri scrittori anarchici Malatesta, sia per la sua particolare preparazione pragmatica, sia per la sua origine non aristocratica, evita lo scoglio della metafisicizzazione che conduce inevitabilmente all’incomprensione del fenomeno storico dell’autoritarismo. In Bakunin, in Kropotkin, per non ricorrere ai testi classici di Godwin, Stirner e Proudhon, si trova un rifiuto dello Stato o una fede assoluta nella autodegenerazione dello Stato e di conseguenza nella sua scomparsa. Più precisamente, Godwin ritenne lo Stato nocivo per tutti e quindi da escludersi a priori, Stirner lo ritenne attivamente diretto al male dell’individuo, Proudhon lo identifica come un’organizzazione fondata sulla differenza sociale e sull’ingiustizia. Bakunin e Kropotkin credettero, sulla base della stretta applicazione della legge evoluzionista, che lo Stato sarebbe scomparso da sé, per autodistruzione. Ma qui si tratta dello Stato ideale, non di questo o quello Stato concreto, nell’organizzazione autoritaria della sua struttura, perché allora la stessa parola “Stato” può essere usata con difficoltà ed è meglio che venga sostituita, come suggerisce Malatesta, dalla parola “governo”.
Qui non siamo davanti a una banale questione linguistica. Malatesta scopre la radice dell’autoritarismo, sfugge alle lusinghe filosofiche di un rifiuto dell’assoluto statale, e detta i termini per cui si può agevolmente identificare l’essenza dello Stato. La riduzione critica operata consente di giungere alla élite governativa e di valutarne in pieno le responsabilità storiche, stornando su di essa quelle che tradizionalmente venivano imputate, dalla riflessione anarchica, al mitico e proteiforme autogenerarsi dello Stato. Malatesta dice: “Per noi, il governo è la collettività dei governanti, ed i governanti – re, presidenti, ministri, deputati, ecc. – sono coloro che hanno la facoltà, in grado più o meno elevato, di servirsi della forza sociale, cioè della forza fisica, intellettuale ed economica di tutti, per obbligare tutti a fare quello che vogliono essi. E questa facoltà costituisce, a parer nostro, il principio governativo, il principio di autorità”. L’astrazione viene superata e l’attacco critico viene diretto contro l’élite di governo. Ovviamente sulla stessa linea di contrasto, e ben oltre, si trovano le tesi marxiste, dove l’astrazione dello Stato è spinta al massimo grado. Engels scrive: «Lo Stato non è affatto una forza imposta dal di fuori alla società. Né, come pretende Hegel, “la realtà dell’Idea morale”, “l’immagine e la realtà della ragione”. Lo Stato costituisce la confessione che questa società si è irretita in una contraddizione insanabile con se stessa, che è venuta a trovarsi divisa da antagonismi inconciliabili di cui non può liberarsi. Ma perché questi antagonismi, queste classi con interessi economici contraddittori, non si divorino l’un l’altro e non divorino in una sterile lotta la società, s’è resa necessaria una forza, in apparenza al di sopra della società, incaricata di moderare il conflitto, di mantenerlo nei limiti dell’ordine. Questa forza, uscita dalla società ma che si pone al di sopra di essa e se ne allontana sempre più, è lo Stato». (L’origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato, pp. 177-178 della VI ed. tedesca. Citiamo dall’opera di Lenin, Stato e rivoluzione, tr. it., Milano 1968, p. 52). Quale sia il “genere” di questo prodotto automatico della società, in che modo sia possibile giungere a localizzarlo via via nel tempo e nello spazio, Engels non lo dice. Egli si limita a dire che lo Stato è la “confessione della contraddizione della società”, definizione, come ognuno vede molto vaga e troppo letteraria per potersi assumere in un contesto scientifico. Malatesta dimostra come questa “forza uscita dalla società” in effetti non ha mai intrapreso nessun viaggio. Lo Stato è nella società in quanto è il governo e il governo non è altro che l’insieme di coloro che detengono una qualsiasi forma di potere.
In armonia con quanto precede Malatesta colloca questa élite in seno alla società, sebbene gravante con tutta la forza e “contro la volontà di ciascuno”. Engels specifica invece che “i funzionari, come organi della società, sono posti al di sopra della società”, contrapponendoli con amara ironia all’autorità spontanea di cui erano fatti depositari gli antichi patriarchi del clan.
Ma l’azione malatestiana di critica alla tradizionale posizione anarchica, o se si vuole di riformulazione in termini più realistici, non si ferma qui. Egli rifiuta di riversare la colpa del morbo autoritario sullo “Stato” in senso astratto, il suo ritorno costante sugli uomini si spinge a volte fino alla monotonia ma è assai salutare. Per uno Stirner che idealizza lo Stato nell’atto stesso di sacralizzazione compiuto dall’individuo, Malatesta interviene tirando fuori la polemica dal vuoto metafisico in cui minacciava di adagiarsi, per un Tolstoj che nella rivoluzionaria dottrina del cristianesimo vede l’aperta negazione dello Stato, Malatesta interviene a chiarire che quella dottrina è una semplice astrazione, mentre l’applicazione concreta voluta e mantenuta dagli uomini è tutt’altro che rivoluzionaria e antistatalista.
Così Vernon Richards identifica questa posizione critica e metodologica di Malatesta: «Il suo modo di affrontare i problemi, anche nella nuova era scientifica in cui viviamo, è ancora raccomandabile. È non solo nei confronti dei “cannoni e grano” che i suoi argomenti hanno quel suono di realismo. Io sostengo che in tutti i suoi scritti questo metodo è applicato ad ognuno dei problemi più importanti. Per sessant’anni Malatesta fu anarchico perché ciò “corrisponde meglio di ogni altro sistema di vita sociale al mio desiderio del bene per tutti, alle mie aspirazioni per una società che riconcili la libertà di tutti con la cooperazione e l’amore fra gli uomini, e non perché l’anarchismo sia una verità scientifica e una legge naturale”. E per la maggior parte di quei sessant’anni, senza mai abbandonare questi sentimenti, i suoi piedi rimasero solidamente piantati in terra. Insurrezione, sciopero generale, rivoluzione, anarchia – sì, ma in ognuno dei suoi scritti teorici e di agitazione ricorre sempre l’ammonimento che “la comunità deve continuare a mangiare ogni giorno, quali che siano i sollevamenti politici”». (Cfr. Malatesta, vita e idee, tr. it., Catania 1968, pp. 334-335). Finché non si comprenderà bene questa particolare posizione speculativa di Malatesta si faranno gravi errori di interpretazione e si prolungheranno inutili polemiche.
Leggiamo ancora. Come si opprimono gli uomini: “in due modi o direttamente colla forza brutale, colla violenza fisica, o indirettamente sottraendo loro i mezzi di sussistenza e riducendoli a discrezione”. Oggi la moderna ricerca motivazionale ci ha istruiti profondamente sui mezzi di manipolazione delle masse, ma non dimenticando il momento storico delle riflessioni che ci occupano, ed evitando di peccare di superbia, non si può non riconoscere che esse sono ben fondate e lasciano il campo a tutta una serie di deduzioni pratiche assai convincenti.
“Ogni volta che, con l’invasione o con qualsiasi impresa militare, la violenza fisica, brutale ha preso il disopra di una società, i vincitori hanno mostrato tendenza a concentrare nelle proprie mani governo e proprietà”. In questo modo Malatesta apre la strada alle considerazioni sul ruolo storico della violenza, sfocando nel lettore ogni ricordo a base dei fumosi scrittori tedeschi di miscugli idealisti.
E la citazione di queste massime di riflessione pragmatica potrebbe continuare ancora per un pezzo. Un altro elemento però che vogliamo sottolineare a sostegno di questa base critica nella metodologia di ricerca di Malatesta è quello che le citazioni di teorici sospetti per indulgenze verso la metafisica del pensiero, come Kropotkin, sono limitate – almeno per quanto concerne l’opera che abbiamo in esame – ad argomenti assai vicini alla particolare visione critica del testo. In un certo senso assistiamo a un processo di demistificazione delle costruzioni idealistiche che l’anarchismo aveva eretto nell’intento, sia pure lodevole, di contribuire all’annientamento di quanto suonava scontato e artificioso. Purtroppo è assai frequente questo fenomeno che qualche cosa di scontato venga distrutta a forza con un altro qualche cosa di altrettanto scontato.
Demma ha scritto recentemente: «La critica alla ipostatizzazione anarchica dello Stato è stata fatta da diverse dottrine, salvo poi a cadere esse stesse nell’errore criticato, come, non ultimo, il sessualismo reichiano, il quale, ponendosi ancora l’assillo del circolo vizioso, di trovare il motivo per cui l’uomo fosse autoritario, ha invertito i termini anarchici, e ha detto, lo Stato non è causa, è effetto, la causa è la repressione sessuale! Altra asserzione metafisica, altra ipostatizzazione, perché la repressione sessuale era quella che spiegava tutto, ma niente poteva spiegare questa repressione originaria. Il succo di tutto questo? La denunzia di tutte le possibili repressioni deve essere fatta propria da una vera teoria libertaria, non devono esserci ipostatizzazioni, facili esemplificazioni, la denunzia delle repressioni deve essere accettata come denunzia di un sintomo del male, non come la causa prima, o tutt’al più come causa ed effetto insieme. Il problema della libertà, degli strumenti della libertà, della sua realizzazione, resta ancora oggi, in tutta la sua difficoltà». (“L’anarchismo da Godwin a Cohn-Bendit”, in “Volontà”, n. 11-12, 1968, p. 624).
Questa è, sebbene in termini ridimensionabili storicamente, la posizione di Malatesta, ed è attraverso questo suggerimento di Demma che continuiamo la nostra ricerca intorno al nuovo concetto di “strada verso la libertà”.
Elementi essenziali
Nei limiti che abbiamo già individuato, il lavoro di Malatesta sull’anarchia si può strutturare in diverse parti, tutte corrispondenti a veri e propri elementi essenziali di qualsiasi dottrina rivoluzionaria e specificatamente libertaria.
a) Lo Stato. In pieno contrasto con la tesi marxista Malatesta propone una individuazione dello Stato nel concreto privilegio della élite di governo. Lo Stato non è un’astrazione – come vogliono anche alcune correnti anarchiche – ma è una concretezza, come tale non può considerarsi in alcun modo una fase di transizione, un “regolatore della lotta di classe” (confrontare le tesi di Marx), ma deve considerarsi un’oppressione continua e ineliminabile se non con l’intervento della violenza rivoluzionaria, senza gradi intermedi e senza fasi transitorie.
b) L’autoritarismo. L’analisi di questo fenomeno è circoscritta essenzialmente nei limiti pragmatici di una ricerca della realtà effettuale. Ogni giustificazione aprioristica è accantonata con disgusto. L’iniziale tirata contro la metafisica in generale è opportunamente usata allo scopo di indirizzare il lettore sui binari della giusta comprensione.
La sociologia ci ha avvezzati a diverse analisi sul “potere”. Ad esempio quella di B. Russell (Il potere. Una analisi sociale, tr. it., Milano 1967) è una delle più complete e agili, comunque – malgrado la preparazione prettamente scientifica dell’autore – non ci pare molto convincente. Quello che importa considerare, e che Malatesta affronta in pieno, è l’ineluttabilità dell’autoritarismo quando esiste qualche cosa da difendere a titolo di privilegio, come per l’appunto la proprietà privata. In questi casi l’origine e la solidificazione delle tecniche autoritarie, siano esse la dittatura dell’uno o dei molti, è assicurata. Che poi questo autoritarismo prenda la forma sacerdotale, la forma economica, la forma politica tradizionale o qualsiasi altra forma, la cosa ha scarsa importanza, visto che il risultato è sempre quello, Malatesta preferisce lasciare ad altri questo genere di analisi, riservando per sé quella più specificatamente diretta ad analizzare i modi di rompere la cerchia autoritaria.
c) Il fatalismo libertario. Si tratta di un concetto che ha risentito, in tutta la pubblicistica anarchica che potremmo definire classica, l’influenza del positivismo evoluzionista.
Malatesta non poteva sottrarsi al clima, non poteva perché non sarebbe stato in grado di reperire sul momento gli strumenti logici necessari per condurre la ricerca su di un piano non più evoluzionista ma particolarmente storico relazionista. “Se davvero gli interessi degli uomini dovessero essere contrari gli uni agli altri – egli dice –, se davvero la lotta fra gli uomini fosse legge necessaria delle società umane... allora l’umanità sarebbe destinata a perire, o a dibattersi perennemente tra la tirannide dei vincitori e la ribellione dei vinti. Ma per fortuna più sorridente è l’avvenire dell’umanità, perché più mite è la legge che la governa”. Siamo davanti a un processo di reperimento del generale, dopo un’analisi accurata e, come abbiamo detto, assai convincente del particolare.
Il lavoro viene fatto a favore di una concezione libertaria della struttura sociale, ma il risultato da un punto di vista logico è altrettanto gratuito che se l’analisi avesse avuto mire di carattere demagogico. Sostanzialmente affidandosi alla legge, allora indiscutibile, dell’evoluzione progressiva, Malatesta cerca di affidare a un fondamento oggettivo il suo istinto verso l’uguaglianza e verso la giustizia, soltanto che questa volta il fondamento non è del tutto solido. Nessuna ricerca scientifica, e tanto meno una ricerca che parte dalla biologia, può fornire una struttura ontologica capace di garantire l’efficienza conclusiva della posizione libertaria. Malatesta cerca di fondare positivamente un motivo logico che possa farci credere oggettivamente valido un mondo libertario. Però il fatto notevole è che la stessa ricerca sociologica e lo stesso genere di fondamento hanno fallito in pieno nel tentativo inverso, cioè in quello di farci credere oggettivamente valido un mondo illiberale.
Oggi questa posizione anacronistica dell’anarchismo vecchio stampo è facilmente identificabile. Basta rivedere il processo di dissolvimento del darwinismo, per averne una specie di storia rovesciata.
Scrive Ernst Cassirer: «La lotta per il darwinismo come concezione dell’universo, che fu combattuta per tanto tempo col più estremo accanimento, è oggi cessata. Nessuno si ripromette più che il darwinismo possa risolvere, d’un sol colpo, tutti i problemi della biologia , ancora meno si vede in esso la chiave che ci dovrebbe aprire le porte della metafisica, avviandoci alla soluzione di tutti i “problemi dell’universo”. Al posto dell’effusione entusiastica con la quale fu salutato, al suo apparire, dai suoi primi apostoli, ed al posto della veemente opposizione che incontrò, è subentrata da lungo tempo una critica pacata. Questa critica si sforza di fare una distinzione tra il contenuto della tesi darwinista e la sua forma, dipendente dall’epoca nella quale essa fu enunciata per la prima volta, perché necessario considerare soprattutto il lato metodico del problema». (Storia della filosofia moderna, vol. IV, tr. it., Torino 1961, p. 252).
Per avere una idea più chiara di questo genere di ambiente, lo stesso in cui si trovava a riflettere il Malatesta, bisogna scorrere gli scritti di uno scienziato, zoologo all’Università di Jena, Ernst Haeckel, dove predomina un andamento di ricerca del tutto arbitrario e dogmatico, stranamente compatibile con la mentalità di uno scienziato. Questi scritti non sono quelli che Haeckel scrisse nella materia di sua competenza, bensì quelli su argomenti di carattere sociologico. Rappresentativo in sommo grado il volume Die Welträtsel (Gli enigmi del mondo), edito nel 1899. Ebbe una grandissima diffusione prima del 1920 (più di 400.000 copie vendute, indica Abbagnano), dopo quella data fu però abbandonato all’oblio. Lo stesso dicasi per i lavori del filosofo francese Félix Le Dantec o dell’italiano Cesare Lombroso.
Il fatalismo libertario conduce Malatesta, fortunatamente, a una sospensione dell’attesa, a una traduzione in termini eminentemente dialettici della necessità comportamentista dell’attore storico. È comprensibile come questo sia di grande aiuto alla dinamica del movimento anarchico che, in caso contrario, avrebbe in breve perduto, per autodistruzione, l’opera concreta di uno dei più grandi agitatori rivoluzionari. L’avvenire dell’umanità è sorridente, il futuro anarchico è indiscussamente assicurato, la legge di solidarietà agisce inesorabilmente, però è necessario lo stesso darsi da fare, in quanto l’umanità e stata per troppo tempo tenuta in stato di schiavitù per potere di propria iniziativa salire i gradini della scala ripida che conduce alla libertà. È sempre Malatesta a dire: “Il sentimento di solidarietà è lungi dall’essere dominante tra gli uomini attuali...”. In questo modo la forma scientifica del liberalismo, quella stessa forma che seguendo una moda d’epoca finiva per sboccare nell’utopia e nel fatalismo libertario, grazie all’innato senso comune di Malatesta, si conclude con una concreta presa di conoscenza dei fatti, e questi parlano chiaro: schiavitù, tirannia, oppressione, privilegio. Questi gli elementi del sistema. La solidarietà è soltanto sullo sfondo di un processo che si presuppone, solo si presuppone, irreversibilmente diretto alla felicità.
Un fenomeno assai simile a quello che abbiamo rilevato in Malatesta avviene in Galleani. Citiamo a caso la seguente parte dello scritto La fine dell’anarchismo? (Cesena 1966, p. 78): «Non meno sofistica la tendenza di coloro i quali sotto il comodo ombrello dell’individualismo anarchico vorrebbero dare ospitalità al concetto di dominio. Estendendo oltre il suo equo confine la divisa del vecchio Rabelais, fais ce que veux!, dimenticando che egli non ha suggerito il suo giocondo “fa’ quel che vuoi!” a mezza dozzina di privilegiati o di sfaccendati, ma a tutti indistintamente, certo che dal libero gioco delle volontà, delle iniziative, delle attitudini e delle energie multiformi non può risultare se non cooperazione ed armonia (la stessa libera coesione per cui le cellule di qualunque organismo, senz’altro imperativo che non si connetta alla loro costituzione chimica, assolvono con attività febbrile, incessante la loro specifica funzione di alimentare e rinnovare tessuti ed organi tenendo così accesa la fiaccola della vita), gli araldi del dominio presumono esercitarlo, in nome del proprio io, sull’io altrui obbediente o rassegnato, o inerte». La dichiarazione aperta al fascinoso mondo biologico è innegabile. Galleani non si accorge del trabocchetto logico in cui pone la tesi libertaria, comunque la cosa non lo interessa poi tanto, si tratta solo di un ricorso alla moda del tempo, a quella dottrina biologica di cui abbiamo fatto cenno prima. Il pensiero è come sempre rivolto all’azione, il fatto migliora il presupposto, chiarisce le difficoltà, progetta il futuro.
Concludendo si deve notare come il libertarismo anarchico trovi solo nell’impulso dell’azione la sua giustificazione. Una ricerca sociologica su questa giustificazione non può che trasformarsi in una catalogazione di limiti prima e in una esclusione di prospettive poi.
In altri termini il libertarismo anarchico è inesorabilmente destinato al fallimento, e questo sarà tanto più sicuro quanto più solitario sarà il fondamento ontologico procurato fittiziamente. Viceversa il suo avvenire sarà prospero e il suo sviluppo costante se potrà fondarsi sugli uomini che “hanno fiducia nel metodo della libertà” e che si dichiarano disposti “a tentare e ritentare”.
La libertà non è niente di più che un metodo. Essa non può confondersi con l’essenza intrinsecamente indeterminata del reale. Abbandonando il suo significato originario di modalità la libertà perde la struttura di strumento per assumere quella circolare di tautologia. (Cfr. A. M. Bonanno, I fondamenti di una teoria filosofica della indeterminazione, Catania 1968, pp. 164-166).
d) La violenza rivoluzionaria. Il problema non viene affrontato direttamente nel testo. Malatesta preferisce sottintenderlo anche perché l’indole eminentemente introduttiva del lavoro e il fatto che lo stesso andava indirizzato a persone non sempre del tutto disancorate dai preconcetti borghesi non rendeva consigliabile un’esposizione ampiamente dettagliata.
Egli scrive, “La rivoluzione, abolendo il governo e la proprietà individuale, non creerà forze che non esistono, ma lascerà libero campo all’esplicazione di tutte le forze, di tutte le capacità esistenti, distruggerà ogni classe interessata a mantenere le masse nell’abbrutimento...”, la rottura iniziale di carattere violento è implicita.
Bisogna precisare che questo genere di violenza è implicita anche nella tesi marxista. Engels nell’Anti-Dühring scriveva la celebre frase: «Il proletariato si impadronisce del potere statale e trasforma i mezzi di produzione innanzi tutto in proprietà dello Stato. Ma con ciò esso sopprime se stesso come proletariato, sopprime tutte le differenze e tutti gli antagonismi di classe, e in pari tempo anche lo Stato in quanto Stato» (p. 302, III ed. tedesca, cfr. Lenin, op. cit., p. 61). Anche qui il presupposto è la violenza rivoluzionaria, bisogna studiare i motivi che giustificano le differenze di prospettiva.
Una differenza per il momento secondaria è quella che riguarda la persistenza dello Stato fino alla sua automatica distruzione causata dalla mancanza della lotta di classe, secondo la tesi marxista. Gli anarchici sono stati sempre contrari a questa bella tesi, giudicandola quanto meno fantastica e lontana dalla realtà. I fatti hanno dato ragione a loro. Lo Stato – come si è detto – non è una creazione metafisica ma è una realtà offensiva. Da ciò scaturisce la differenza primaria: gli anarchici vogliono una distruzione immediata e totale dello Stato, i marxisti un cambiamento di potere dalle mani delle persone a quelle dello Stato stesso, infatti il potere non è altro che una conseguenza diretta del possesso indiscusso dei mezzi di produzione. Come questo avvenga, senza che nel mezzo ci stiano delle persone in carne e ossa, è cosa che la dottrina marxista non precisa bene, ma che la pratica comunista ha denunciato per inammissibile.
L’anticamera è comune: la violenza rivoluzionaria. Le dimensioni di questa anticamera sono diverse. I marxisti la vogliono ristretta, limitata a un passaggio di proprietà il che, almeno teoricamente, potrebbe avvenire pure per le vie cosiddette legali. Va bene che Marx ha definito la violenza “la levatrice di ogni vecchia società gravida di una società nuova”, ma la tecnica del trasferimento dei mezzi di produzione dai vecchi proprietari allo Stato ad opera dell’azione rivoluzionaria del proletario è soltanto una visione parziale di una esplosione rivoluzionaria violenta.
L’anarchismo ha teorizzato invece qualche cosa di più completo. La distruzione assoluta, totale, immediata dello Stato. Nessuna illusione che un sia pure minimo residuo statale possa automaticamente scomparire per inedia. Nei confronti del confratello marxismo, l’anarchismo si dimostra ancora una volta più vicino alla realtà.
Malatesta è contrario alla violenza. Ma questo istinto di repulsione per tutto ciò che è prevaricazione, soperchieria, abuso, non si estende alla violenza liberatrice. Egli scrive testualmente: «Lo schiavo è sempre in istato di legittima difesa e quindi la sua violenza contro il padrone, contro l’oppressore, è sempre moralmente giustificabile e deve essere regolata solo dal criterio dell’utilità e dell’economia dello sforzo umano e delle sofferenze umane». (Cfr. “Umanità Nova”, 25 agosto 1921).
E altrove: «... perché due vivano in pace bisogna che tutti e due vogliano la pace, ché se uno dei due si ostina a volere colla forza obbligare l’altro a lavorare per lui ed a servirlo, l’altro se vuol conservare dignità di uomo e non essere ridotto alla più abietta schiavitù, malgrado tutto il suo amore per la pace ed il buon accordo, sarà ben obbligato a resistere alla forza con mezzi adeguati». (Cfr. “Pensiero e Volontà”, 1 settembre 1924).
«È necessario prepararsi moralmente e materialmente perché allo scoppio della lotta violenta la vittoria resti al popolo». (Cfr. Programma anarchico, Bologna 1920).
«La borghesia non si farà espropriare di buona grazia e si dovrà sempre addivenire al colpo di forza, alla violazione dell’ordine legale con mezzi illegali». (Cfr. “Umanità Nova”, 9 settembre 1921).
«La violenza è purtroppo necessaria per resistere alla violenza avversaria, e noi dobbiamo predicarla e prepararla se non vogliamo che l’attuale condizione di schiavitù larvata, in cui si trova la grande maggioranza dell’umanità perduri e peggiori». (Cfr. “Umanità Nova”, 21 ottobre 1922).
Bisogna collocare Malatesta nella sua giusta posizione rispetto alla grave e determinata questione dell’impiego di mezzi di sovversione violenta. Tre le tante preoccupazioni sue vi era anche quella di non lasciare che il quietismo tolstoiano prendesse piede tra gli anarchici, in nome di una malintesa questione di principio.
La teoria della nonviolenza fece il suo ingresso nella dottrina anarchica attraverso la grande opera di uomo e di scrittore di Tolstoj. Purtroppo con questa teoria alcuni dei presupposti del cristianesimo riuscirono a filtrare. Tra gli altri il principio della “sofferenza come riscatto”. A tale proposito Malatesta scriveva: «Un uomo può, se è molto... cristiano, soffrire pazientemente ogni sorta di angherie senza difendersi con tutti i mezzi possibili, e restare forse un uomo morale. Ma non sarebbe egli, in pratica e quantunque senza volerlo, un terribile egoista, se lasciasse opprimere gli altri senza tentare di difenderli? se, per esempio, preferisse che una classe fosse ridotta alla miseria, che un popolo fosse calpestato dall’invasore, che un uomo fosse offeso nella vita o nella libertà, piuttosto che ammaccare la pelle dell’oppressore?». (Cfr. “Anarchia”, Numero unico, Londra, agosto 1896).
Naturalmente il fatto stesso che una dottrina si presentasse con tali implicazioni mistiche e, specialmente, di impronta cristiana, avrebbe dovuto richiamare l’attenzione sulla pericolosità di una diffusione. Ma l’importanza del nome di Tolstoj era troppo ampia per impedire a cuor leggero la sua inclusione tra i fondatori dell’anarchismo. Lo stesso Malatesta non sa decidersi a prendere una posizione chiaramente contraria. Comunque sulla questione della violenza non possono esserci dubbi, “io violerei tutti i princìpi del mondo pur di salvare un uomo”, egli dice, e la sua vita di strenuo difensore dell’interpretazione realista dei fatti sociali è tutta una testimonianza.
Oggi, a distanza di quasi mezzo secolo, con tante esperienze accumulate, con una visione del decorso storico dell’avventura anarchica, con tutte le prospettive che le tecniche moderne mettono a disposizione dell’uomo, il problema della violenza rivoluzionaria si pone ancora, sebbene in termini differenti.
Innanzi tutto non è possibile parlare di una rivoluzione del risentimento. Il grado di integrazione raggiunto anche dalle classi più povere è tale da non giustificare più questo termine. La stessa propaganda sovversiva deve prendere indirizzi diversi, se non vuole restare inascoltata e sommersa dalle voci reboanti della politica consumista. Non pochi sommovimenti oggi sono dettati dalle richieste pressanti, convogliate dagli organi istituzionalizzati della rivolta operaia, per una migliore integrazione. Scioperi, dimostrazioni, sabotaggi, ecc., sono all’ordine del giorno ma hanno lo scopo di richiedere qualche cosa al sistema, non hanno il benché minimo desiderio di richiedere qualche cosa “contro il sistema”.
Quello che è cambiato profondamente è il metodo di risposta alle richieste modificatrici di una situazione di fatto. Se prima il datore di lavoro si irrigidiva e, eventualmente, richiedeva l’intervento del deputato amico per fare arrivare al prefetto l’ordine di porre le debite misure in atto per costringere gli operai ad accettare le condizioni imposte, ora nessun deputato si sognerebbe di raccogliere una richiesta del genere, i suoi colleghi sindacalisti lo farebbero saltare in aria prima di due giorni. D’altro canto lo stesso datore di lavoro ha capito l’antifona ed agisce diversamente, discute, dialoga, procrastina, concede piccole briciole e lascia passare il tempo, finché il grosso strumento istituzionalizzato che risponde al nome di sindacato non decide un’azione qualsiasi in un determinato senso, da quel momento il datore di lavoro conosce tutti i termini della partita e, tramite i suoi rappresentanti, sindacalisti pure loro, concorda i termini, della resa (apparente), trasferendo sugli ignari consumatori i nuovi oneri.
Tutto questo meccanismo è messo in moto da forze sotterrane, tutto avviene con il sorriso sulle labbra, con grandi pacche sulle spalle, in un clima natalizio di giornata del perdono.
Nessuno si irrigidisce, nessuno alza la voce, tutti “dialogano”, tutti tengono “bene in vista gli interessi della classe lavoratrice”, tutti segretamente studiano il modo di ottenere il massimo risultato politico con il minimo sforzo economico.
Ovviamente il lavoratore non sa tutto ciò, la facciata esteriore, quella dei sorrisi e delle pacche sulle spalle, lo colpisce profondamente e lo affascina. Poi, quando le cose vanno a rotoli, quando stringendo il pugno si accorge di avere soltanto una misera briciola, quando il tale aumento si riduce ad appena qualche migliaio di lire mentre il livello dei prezzi subisce un contraccolpo decisamente superiore, quando tutto ciò avviene, allora cerca una soluzione diversa, allora sorprende magari la nazione sedendosi sullo stradale di Avola a farsi ammaccare e ad ammazzare se occorre.
Questa tragedia non ha nome, è un conflitto tra forze che non denunciano apertamente la propria posizione e fisionomia. Proprio per questo è più sconcertante e più difficile a interpretarsi dal punto di vista sociologico. Malatesta non affrontava problemi del genere, ma l’anarchismo che vuole sopravvivere, se vuole approfittare dell’ondata di interesse che oggi suscita, deve poterli affrontare, se occorre facendo tesoro anche delle riflessioni dello stesso Malatesta, ma ammodernandole e studiando le implicazioni eventuali con i problemi di oggi.
Non bisogna dimenticare che la classe degli oppressi, malgrado che oggi sia in possesso dei frigoriferi, dei televisori e delle automobili, come la classe degli oppressori, è sempre disponibile per la lotta, come ai tempi di Malatesta. Solo bisogna programmare questa lotta, darle un’adeguatezza da tempi nuovi, una nuova logica, quella della distruzione.
Ovviamente questo genere di lavoro non potrà avvenire dall’interno del sistema istituzionale, come non potrà avvenire in forma riformista. Sono questi i due problemi che condizionano l’attuale stato della contestazione sociale. Sono problemi che Malatesta ebbe ad affrontare e che cercò di risolvere con il solito mezzo, tanto spesso da lui impiegato con successo, della riflessione pacata e realista.
Nel 1923 scriveva, a proposito dei movimenti fascisti: «... le molteplici organizzazioni dei rivoluzionari faranno opera rivoluzionaria se serviranno a liberare il popolo e ad impedire ogni costituzione di governo autoritario, saranno invece strumento di reazione e distruggeranno la stessa opera loro se vorranno servire ad imporre un dato tipo di organizzazione sociale, il programma di un dato partito...». (Cfr. “Fede”, 25 novembre 1925). La strada istituzionale è preclusa alla vera rivoluzione. Un partito eminentemente rivoluzionario, come si pone sulla carta il partito comunista, non è altro che un partito borghese, una volta che entra a fare parte dell’istituzione e del complesso meccanismo parlamentare. La tecnica entrista, teoricamente condannabile, si è fortunatamente rivelata disastrosa anche nella pratica, riuscendo a convincere della sua inutilizzabilità anche i più ferventi assertori dell’entrismo che furono, per molto tempo, le estreme sinistre dello stesso partito comunista, oggi rappresentate sulla carta politica mondiale dalle tendenze filocinesi.
La tesi entrista classica, così come venne formulata da Lev Trotskij nel 1938, in occasione della fondazione della IV Internazionale, voleva giungere a minare dall’interno il nuovo male del movimento proletario, la classe dei “gestori dello Stato”. Evidentemente la frattura tra masse e potere è palese, in special modo nei paesi a regime comunista, ed era proprio questo l’obiettivo della critica di Trotskij. Successivamente questa malattia venne efficacemente descritta col nome generico di “stalinismo”. Oggi parlando di “stalinismo” ci si riferisce all’oggetto della critica di Trotskij e alla negazione del marxismo rivoluzionario, come pure al tradimento perpetrato dai detentori del potere nei confronti della spontanea meccanica di eliminazione dello Stato.
L’errore teorico della tesi entrista risiede nel fatto che sconosce il movimento delle élite, ormai patrimonio conseguito dalla ricerca sociologica. Nella struttura interna di questo movimento si rinviene il principio di assorbimento delle élite che agisce sulle forze di penetrazione prima che possano estrinsecare tutto il loro potere di sovversione. L’errore pratico lo ha identificato il corso degli avvenimenti.
In Italia abbiamo esempi notevoli che possiamo citare perché in possesso di dati sicuri. «I Gruppi comunisti rivoluzionari (cioè la sezione italiana della IV Internazionale) si organizzano su base provinciale, ogni due anni un congresso nazionale elegge un comitato centrale, da cui viene nominato un comitato esecutivo. Il loro giornale è “Bandiera Rossa” a cui si affianca la rivista “IV Internazionale”. Nel 1962 una frazione intransigente e contraria all’entrismo, guidata da Piero Leone, si stacca dalla “Quarta” e fonda il partito comunista rivoluzionario (trotzkista), che si unisce alla IV Internazionale dissidente di Posadas (la quale controlla forti gruppi operai dell’America Latina). L’anno successivo nasce a Milano, nella sede del Circolo Luxemburg, il gruppo “Falce e Martello”, anch’esso contrario all’entrismo. Leader del gruppo è Aldo Brandirali, ex dirigente della FIGC. “Falce e Martello” si estenderà a Torino e Reggio Emilia. Nel biennio 1967-1968 sarà alla testa delle manifestazioni “antimperialistiche” e delle lotte studentesche di Milano. Ben presto questo gruppo entrerà in crisi, e Brandirali si sposterà su posizioni filocinesi. Ma per reagire a questa serie di scissioni s’era formato all’interno della IV Internazionale (ufficiale, di Maitan) il gruppo “La Tendenza” che aveva fatto una politica “entrista” cercando di manovrare, senza successo, all’interno del PCI e del PSIUP. In seguito a questo fallimento nascono nel 1968 due gruppi che promuovono la lotta a diretto contatto con gli operai piuttosto che all’interno dei partiti tradizionali». (Cfr. R. Costa, Più rossi di Mao. Rapporto sui movimenti di estrema sinistra in Italia, “L’Espresso”, 15 dicembre 1968).
Dimostrata l’occlusione della tesi entrista non resta altro che l’azione violenta rivoluzionaria generale. In questo modo l’uomo riprende contatto con il suo ambiente naturale, ritrova fratelli che divisioni settarie e cavillose avevano fatto allontanare, si fortifica nella previsione del pericolo e del rischio. Se la lotta non è il migliore sottofondo per uno sviluppo armonico della società, come ha anche notato Malatesta, è però il migliore presupposto per la nascita di nuovi germogli, di nuove forze vitali, di nuove prospettive, di nuove aperture di pensiero. Si tratta di un passaggio obbligato verso il traguardo dell’uguaglianza e dell’ordine.
È naturale che ricostruire oggi una teoria della violenza sul presupposto biologico non è più possibile. Purtroppo i marxisti, e con loro gli anarchici, non si accorgono dell’impossibilità pratica di questa costruzione. I “testi sacri” parlano continuamente di evoluzione, ma la realtà connettivale, il rapporto delle cose all’uomo, ha finito per ridimensionare tutto. Lo scientismo finisce per sentire di muffa.
In ogni modo il problema tipo, relativamente al lavoro di Malatesta, è essenzialmente quello di collocare nella sua giusta prospettiva la funzione “terapeutica” della violenza. Ogni sentimentalismo deve essere bandito. Ogni quietismo deve essere denunciato quale involontario rallentatore del progresso rivoluzionario. La riflessione sociologica non deve acquistare fardelli che difficilmente potrà buttare via. Siamo davanti a una scienza, nel senso moderno del termine, una scienza munita di una propria agguerrita metodologia di ricerca, una scienza che ha individuato per tempo una serie di problematiche sufficientemente catalogate e circoscritte. Tutto questo patrimonio, che grosso modo può farsi decorrere dallo stesso Auguste Comte all’attuale sociometria, non è indifferente e deve essere salvato dai lanzichenecchi avventurieri della penna.
e) L’organizzazione. Intimamente legato al problema della violenza rivoluzionaria è quello dell’organizzazione, inteso non in senso tecnico, come formula esplicativa di un processo ordinante, ma in senso dialettico di contrasto tra tendenza dissociativa e tendenza associativa.
Malatesta ebbe a scrivere: «... se credessimo che non vi possa essere organizzazione senza autorità, noi saremmo autoritari, perché preferiamo ancora l’autorità che inceppa ed addolora la vita, alla disorganizzazione che la rende impossibile». (Cfr. “L’Agitazione”, 4 giugno 1897).
Si tratta di una frase lapidaria, non revocabile in dubbio. L’assenteismo viene rifiutato con fermezza in vista di un’azione determinata, attraverso la quale un programma viene perseguito e posto in atto, studiando il sistema migliore per evitare che vengano ripristinati comparazioni di valore ritenute prevaricanti e oppressive.
Il rapporto con la teoria della violenza è palese. Gli anarchici individualisti combattono in uno l’organizzazione con la violenza strutturata e incanalata verso scopi distruttivi generali. L’individualismo rivendica a sé il diritto alla violenza dispersiva, alla rivolta parziale per intenderci, come rivendica a sé il diritto al rifiuto di ogni forma di organizzazione, siano pure i famosi “liberi patti”.
È pacifico che l’ideale anarchico del terrorista è ormai tramontato, tra l’altro perché l’attuale grado di integrazione sempre più ampia impedisce di vedere con chiarezza l’odierno erede della tradizionale figura del “tiranno” contro cui scagliare il “fiero colpo”. Al suo posto è intervenuta “l’istituzione”. Contro questa forma burocratizzata di organizzazione del sistema si scagliano i furori degli odierni contestatori. Il discorso ha molti lati positivi, sebbene presenti il fianco alla grave critica dell’alternativa – ancora non definita – tra rivolta e rivoluzione. Comunque anche in questa sede di violenza dispersiva si va diffondendo la concreta necessità dell’organizzazione. Il punto centrale sarà in futuro, ancora una volta, quello di identificare una zona di decomposizione del processo di ingerenza, sia della teoria dell’organizzazione, sia della pratica della burocratizzazione. Il tanto decantato “orizzonte positivo del diritto” proclamato dalla nuova corrente di rivolta contro le istituzioni, corrente che si è particolarmente segnalata in questi ultimi tempi come la estrema conseguenza del progressivo abbandono della tradizionale fiducia delle classi proletarie nelle forme di lotta regolate dall’arbitrato dei partiti, ha finito per mostrare il fianco debole. Non bisogna dimenticare, e a tale proposito una rilettura di Malatesta farebbe bene, come il detentore della “violenza istituzionale” è proprio lo Stato, per cui ogni contrasto, anche sul piano della rivolta contro la norma, nei limiti stessi del diritto positivo, non può prevedere la possibilità concreta di mantenere le fluttuazioni delle variabili che intervengono nella dinamica del processo stesso di contrasto, dentro il confine – anch’esso variabile in funzione di fattori non sempre identificabili a priori – segnato dallo stesso diritto positivo. Quello che sulle prime può sembrare un rifiuto del ricorso alla violenza, quello che vuole assumere l’aspetto della rivolta di pensiero contro la norma e non della rivoluzione d’azione contro il valore, può di colpo trovarsi davanti a una variabile determinata dall’ingerenza di un fattore non previsto nella designazione del limite di azione. In quel momento l’istituzione estrae quel tipo di violenza di cui risulta depositaria, ed è la fine del diritto positivo. Chi poteva proclamarsi “difensore del diritto”, diventa di colpo un fuorilegge, indipendentemente dall’effettivo ricorso concreto a quel genere di contrasto che solitamente siamo abituati a definire “violento”.
Questo discorso è oltremodo importante. Il concetto stesso di violenza deve essere rivissuto alla luce di fatti che sono emersi forse soltanto adesso, dalle vicende di questi ultimi due anni. In definitiva, date alcune condizioni di partenza, può aversi il caso strano che la distruzione materiale di una stazione, di un aeroporto o di una strada non vengano considerati atti di “violenza”, mentre il lancio di manifestini o il superamento di un cordone di agenti o il blocco stradale fatto con i corpi dei dimostranti venga considerato tale. Tutto dipende da quelle variabili che hanno avuto modo, per vie non sempre identiche, di influire sulla determinazione della linea di demarcazione del concetto “istituzionale” di violenza. Se il meccanismo di scatto della violenza dello Stato è posto in comunicazione con un atto di semplice dimostrazione, come per l’appunto un pacifico corteo di dimostranti, quella sarà l’occasione perché si giunga anche alla repressione armata o alle accuse di violenza contro lo Stato.
Ovviamente, poiché non è possibile, in assenza di un programma ben definito, parlare di un’azione dimostrativa qualsiasi, senza volere giungere alle azioni violente in senso più ampio e più vero del termine, si comprende benissimo come questi due concetti siano legati a filo doppio.
Malatesta e l’anarchismo alla luce degli avvenimenti più recenti
Abbiamo detto in questa stessa Introduzione come oggi l’anarchismo possa registrare al suo attivo una vera e propria vittoria. Questa affermazione non deve sembrare eccentrica, tanto più che gli scritti pubblicistici di molti anarchici oggi suonano quasi sempre come inventari fallimentari. Vediamo di chiarire i motivi programmatici e consuntivi che ci hanno fatto risolvere per questa opinione.
La realtà economica della nostra grande epoca tecnologica ci dimostra con chiarezza come il principio anarchico dell’uguaglianza assoluta, della fraternità, della mutua solidarietà, dell’abolizione delle sofferenze e della parziale penuria dei beni tradizionalmente diretti al soddisfacimento dei bisogni base, è sostanzialmente tanto lontano da potersi considerare un’utopia. Ma questa affermazione, qualcuno dirà, è in contrasto con la premessa. Costui, non vuole però seguirmi nel ragionamento.
Continuiamo. Data questa situazione di parziale insoddisfacimento, risulta evidente la necessità di effettuare un inventario non solo delle risorse materiali – cosa che è stata fatta più o meno bene, comunque è stata fatta – ma anche delle risorse psichiche della nuova società. Ora questo ultimo genere di inventario, molto difficile e problematico, anche perché non si è ancora in possesso di una vera e propria metodologia di ricerca, ma si utilizzano, via via che si rendono disponibili dal vasto crogiuolo degli studi di psicologia e di filosofia, tecniche disperatamente tendenti a una quantificazione che continua a risultare quasi chimerica, questo inventario, dicevo, fornirebbe i dati di un fenomeno molto interessante, l’anarchizzazione della nuova società.
Stiamo con quasi certezza affrontando un fascio di problemi tanto vasto e tanto poco esplorato, da risultare almeno ingenuo sperare di ottenere risultati positivi. Quello che noi vogliamo ottenere, invece, più che un risultato è una vera e propria sensazione. Il lettore farà poi da solo il lavoro ulteriore, nei limiti che ognuno crederà opportuno. Noi, in altra sede, avremo l’opportunità di approfondire l’argomento con mezzi di ricerca più ampi e informati.
L’odierno principio di bisogno e di prestazione è tanto inadeguato a spiegare la realtà economica da diventare inservibile. Il processo qualificante della massimizzazione del risultato mi sembra diventi più un mito che un vero e proprio strumento di analisi della realtà. Viceversa questo stato di sospensione del giudizio, di attesa della parola chiarificatrice, non dipende da uno stato di abbondanza per tutti. In altri termini il presupposto concreto della società anarchica non c’è, né i lunghi decenni di utilizzo distruttivo della ricchezza potevano contribuire a formarlo, quello che invece abbiamo è il substrato psichico. Ecco perché dichiaravo auspicabile quell’inventario delle risorse.
Ma sulla stessa strada tecnica del reperimento dei risultati sparsi di un tale inventario si incontra un punto chiave: è possibile uno stato di civiltà in cui i bisogni base siano soddisfatti senza che venga posto in atto il meccanismo repressivo-distruttivo dell’odierna realtà economica? Sappiamo che, almeno teoricamente, questo stato di civiltà si ritiene possibile. Un esempio storico l’abbiamo nella società primordiale, quella matriarcale per riferirci all’esempio di Marcuse, ma quella del clan potrebbe andare bene lo stesso, secondo noi. Un altro esempio dobbiamo ricavarcelo con la fantasia, ma limitando i voli pindarici, deducendo le possibili conseguenze di un impegno non repressivo delle ingenti forze tecniche oggi a disposizione dell’uomo, il risultato di una società capace su scala industriale di soddisfare i bisogni base di tutti, non è del tutto illogico.
In tutte e due i casi si avrebbe un risultato degno di nota dal punto di vista anarchico, lo sviluppo dell’istinto di solidarietà in sostituzione della ricerca repressiva per la sopravvivenza. Dare conto quantitativo di questo fenomeno, che in questa sede presupponiamo soltanto, sebbene in base a una deduzione strettamente logica, non è facile. Infatti scomparendo la repressione istituzionale, o almeno alleggerendosi, si deve necessariamente pensare che questa stessa repressione si alleggerisca sugli istinti, quindi anche su quello fondamentale della solidarietà.
Noi abbiamo usato soltanto l’involucro delle argomentazioni che la sociologia dell’istituzione ama raccogliere e distribuire gratuitamente agli adepti del sistema. Si tratta di una rivestitura che solitamente viene usata per incartare il bel concetto del “lavoro alienante”, ma che viene subito gettata via non appena il concetto centrale vede la luce e incomincia a diventare centro della discussione. Per noi non ha importanza che quella struttura sociale, definitivamente lontana dalla repressione e dal bisogno-condanna, sia resa possibile dall’assenza del lavoro alienante, tutto ciò è una conseguenza “entrista” che non ci può interessare, partendo noi sempre dall’ipotesi violenta della distruzione del sistema. In questo modo abbiamo saldato il cerchio del ragionamento. La distruzione abbatte il sistema sconvolgendone il meccanismo repressivo, il resto viene dopo, naturale conseguenza di un disinnesto della repressione.
Questa sensazione, elemento positivo dell’inventario auspicato delle risorse psichiche, è quanto ci ha confortato nella nostra affermazione iniziale.
La lettura di un testo classico della violenza antistatale, come potrebbe essere l’Anti-Dühring o qualche altro lavoro originale del marxismo ortodosso, può senz’altro definirsi utile alla preparazione delle nuove mentalità attive, in grado di agire con efficacia sulla scorza protettiva della borghesia. Un testo pragmatico come quello del Malatesta non è soltanto utile ma direi essenziale. Qui il rifiuto stesso della tecnica dell’ispirazione e della predizione – che tante volte abbonda nei lavori dei riformatori sociali – è salutare alla concretezza degli scopi che vengono proposti. Quando si abbia l’accortezza, e in questa Introduzione abbiamo cercato di fornire il codice di interpretazione, di eliminare quella esteriore tendenza al fatalismo libertario, il lavoro di Malatesta potrà assumersi quale manuale d’azione politica e sociale.
Che il processo di progressiva liberazione dell’uomo, solitamente abbinato a un simultaneo innalzamento del livello socio-economico di vita, sia affidato dalla tecnica entrista al grado di penetrazione negli organismi istituzionali da parte delle ideologie extra-gruppo, è cosa pacifica. La bontà del procedimento è, come si è detto, assai discutibile. Non solo ma tutto ciò concorre, quasi inconsapevolmente, a favorire il processo repressivo in atto. Potremo dire che l’entrismo, malgrado la sua apparenza di disturbo e di infiltrazione, è un elemento positivo dello sviluppo del sistema, in quanto conduce le nuove idee al punto necessario di fusione, dove i contrasti si appianano e le diversità scompaiono.
La rivoluzione rompe il rapporto di valore in funzione di automobili, televisori o altro, per ripristinare una differente unità di misura. Non bisogna dimenticare che rivoluzione non può essere sinonimo di lotta contro le norme ma deve intendersi nel retto significato di lotta contro i valori, nel caso contrario cadrebbe nella semplice rivolta parziale. Questo problema è stato chiarito dalla più recente riflessione sociologica e quindi non possiamo pensare di reperirlo in pieno in Malatesta, quello che invece si trova espresso con chiarezza è il momento susseguente, risoluzione che, per contrasto, l’attuale pensiero sociale persiste nel non volere comprendere bene.
Se il movimento rivoluzionario è un movimento che porta alla ribalta nuovi valori, in particolare valori di carattere antiautoritario e di autogestione, esso si pone contro l’autoritarismo e il gestionismo attuato in concreto dalla struttura statale. E questa è un’azione di guerriglia, di forza, di violenza, che può anche essere programmata e attuata in un modo o nell’altro. Il punto di difficile comprensione viene dopo. Niente pare garantire che l’iniziale contrasto con l’autoritarismo e il gestionismo statale, storicamente identificato, non finisca per adagiarsi nella pacatezza della cosa fatta, dopo il conseguimento degli scopi inizialmente proposti. Questo sarebbe l’anticamera di un nuovo autoritarismo e di un nuovo gestionismo, forse più temibili dei primi perché nati dalle loro rovine e dall’indebolimento delle forze rivoluzionarie.
Contro questa obiezione, decisamente fondata almeno sotto certi aspetti, sono stati posti due ripari. Il primo, ingenuamente diretto a proteggere il sottostante sciocco servilismo, ha proposto l’instaurazione di una sorta di “contestazione permanente”, una specie di rivoluzione istituzionalizzata, in grado di dare vita a un contropotere con tutte le carte in regola per iniziare il lungo e doloroso “braccio di ferro” con il potere nuovo che ha avuto la forza di costituirsi o che cerca in tutti i modi di costituirsi. Ovvio che questa tattica farebbe il gioco della forma nuova di potere, preparando il terreno dialogico e integrativo in cui di regola il potere delle democrazie moderne è abituato ad agire. Non vale spendere molte parole per illustrare i lati negativi e assurdi di questa proposta. Il lettore potrà rendersene conto da solo con un minimo di riflessione.
L’altro riparo è più consistente ed è stato lungamente analizzato dalla pubblicistica anarchica. Purtroppo questa analisi è avvenuta, nella maggior parte dei casi, per scopi propagandistici, quindi la forma dell’indagine non è la più adatta ad essere utilizzata per conclusioni scientifiche. Preferiamo la seguente citazione di Marcuse: «Nell’optimum delle condizioni, il peso che nella civiltà matura avrebbe la ricchezza materiale e intellettuale sarebbe tale da permettere la soddisfazione dei bisogni senza fatica, e d’altro lato il dominio non avrebbe più l’esclusiva di questa soddisfazione. In questo caso, il quantitativo di energia istintuale che dovrebbe continuare ad essere deviato verso il lavoro necessario (a sua volta completamente meccanizzato e razionalizzato) sarebbe così esiguo da far crollare un vasto settore di limitazioni e modificazioni repressive, non più sostenuto da forze esterne. Conseguentemente, il rapporto antagonista tra principio del piacere e principio della realtà verrebbe alterato in favore del primo. L’Eros e gli istinti di vita verrebbero lasciati liberi in una misura che non ha precedenti». (Eros e civiltà, tr. it., Torino 1964, pag. 165).
Ricordando come ci troviamo davanti a nuovi valori, post-rivoluzionari, il discorso diventa più comprensibile. Malatesta scriveva: «La scarsità artificiale dei prodotti è una caratteristica del sistema capitalista ed è compito della rivoluzione quello di utilizzare razionalmente la terra e tutti gli strumenti di lavoro per accrescere la produzione al punto di soddisfare largamente i bisogni di tutti». (“Umanità Nova”, 9 maggio 1920).
È naturale che il metro delle considerazioni e la dinamica dei problemi è decisamente diversa. In questa situazione anche la dinamica del potere non può che essere diversa. Ecco quindi che parlare di una lotta-collaborazione-dialogo tra potere e contropotere è una ingenuità (o peggio) in quanto non tiene conto del fatto che qui si sta discutendo di quel determinato potere “futuro” che eventualmente affaccerà le proprie pretese dopo la rivoluzione.
Appare più che giustificata l’ipotesi che, in un determinato contesto sociale libero dalla repressività del lavoro, libero dall’artificialità della limitatezza dei beni, libero dalla proprietà privata, la nascita del potere verrebbe ostacolata dal movimento stesso della libertà in seno ai singoli gruppi. La circolazione dei beni, come quella delle idee, non potrebbe subire remore che da parte di spiriti intellettualmente malati e, come tali, più bisognosi di cure mediche che di strutture di contrasto o di contropotere.
Ancora una volta il problema assume l’alternativa della distruzione o della designazione dei limiti. Noi non possiamo illuderci di distruggere i nostri limiti, ma possiamo e dobbiamo operare alla loro identificazione. E il messaggio di Malatesta, oltre il lontano sottofondo utopista, presenta il sano proposito di dare conto di questi limiti e di studiare i sistemi più idonei a renderli sempre meno pesanti e dolorosi. La libertà non diventa altro che una presa di conoscenza dei propri limiti, un progressivo apprendimento di ciò che non dovendosi più fare per costrizione, diventa naturale fare perché aderente al significato stesso del termine “uomo”.
Questo credo sia il messaggio più concreto che si possa oggi ricavare dalla lettura del lavoro di Malatesta, un risultato, se si vuole, modesto ma pieno di prospettive di riflessione.
[Introduzione alla prima edizione di E. Malatesta, L’Anarchia, Ragusa 1968]
Introduzione alla seconda edizione de L’anarchia, Ragusa 1973
Esce la seconda edizione di quest’opera, aggiornata e riveduta nelle note che l’accompagnavano nella prima edizione. Oltre a questo doveroso lavoro, nel corso del quale si è posto rimedio ad alcune sviste ed imprecisioni, si rende necessaria una nuova introduzione, per dar conto dello stato attuale della ricerca su Malatesta e delle critiche che ci sono state mosse. Un ultimo argomento decisivo sarà quello della nuova angolazione dalla quale è necessario, oggi, a distanza di quattro anni dalla prima edizione, guardare tutta l’opera e l’azione rivoluzionaria di Malatesta e L’anarchia in particolare.
Sgombriamo subito il campo di tutte le recensioni che si sono occupate favorevolmente del nostro lavoro, come quella ad esempio di Emilia Rensi (Malatesta e Anatole France: incontri e confronti, in “Umanità Nova”, 21 giugno 1969), che per altro pone un interessante raffronto tra Malatesta e Anatole France. Non parleremo di qualche critica negativa, ma decisamente fuori zona, come quella di Gino Raya (L’anarchia di Errico Malatesta, in “Gazzetta del Sud”, 7 ottobre 1969, pubblicato anche su “Biologia Culturale”, dicembre 1969, pp. 167-170. A questo articolo di Raya abbiamo risposto nel nostro lavoro, Anarchia e famismo, in “Volontà” n. 1, gennaio-febbraio 1972, pp. 41-54, qui vedi pp. 408-430).
Restano i lavori di coloro che, in questi ultimi quattro anni, si sono occupati, sia pure di scorcio, di Malatesta e che hanno fatto riferimento dichiarato o taciuto alla nostra interpretazione. L’accusa più significativa, e di cui vogliamo discutere, ci è stata rivolta da Gino Cerrito (“Il movimento anarchico internazionale nella sua struttura attuale. Lineamenti storici e bibliografia essenziale”, Comunicazione al Convegno promosso dalla Fondazione Luigi Einaudi, tenutosi a Torino nei giorni 5-6-7 dicembre 1969, ora raccolto in volume a cura della stessa fondazione, Torino 1971, p. 164. Il lavoro è stato ripubblicato nei “Quaderni dell’Antistato – Anarchismo ’70” n. 2 col titolo Geografia dell’Anarchismo, arricchito di altri scritti non contenuti nella predetta comunicazione. La parte che ci riguarda, contenuta in ambedue gli scritti suddetti si trova pure inserita in un articolo di risposta a Demma dal titolo “Accademia e utopismo”, “Umanità Nova”, 14 febbraio 1970), che ha tenuto a fissare per bene la nostra decisione di non dare conto della posizione ideologica che Malatesta assunse dopo la stesura dello scritto che pubblichiamo. In effetti L’anarchia venne redatta nel 1891 e quindi in un periodo in cui Malatesta aderiva, quasi completamente, al determinismo kropotkiniano, tutela che poi ebbe ad eliminare quasi del tutto, accelerando l’aspetto volontarista e relativista del suo pensiero.
Ma in effetti la nostra non è stata una dimenticanza. Il nostro lavoro venne redatto agli inizi del 1969, in un clima generale di meditazione e di ripensamento dei fatti francesi del Maggio precedente, in un clima di inventario delle forze presenti in campo in quel momento. L’anarchismo, tra queste forze, recitava un ruolo assai scadente, almeno riguardo all’Italia, e quindi un ruolo stranamente in contrasto con quello principale che, invece, aveva avuto proprio in Francia nel corso della “primavera calda”. Proprio per questo parlammo di necessità di accantonare il tono e la dimensione apologetica per rivolgersi all’approfondimento scientifico e alla chiarificazione ideologica e critica. Non era tanto importante mettere l’accento sull’aspetto volontarista di Malatesta, quanto spingere i lettori a rileggere l’opera criticamente, inserendola in una prospettiva storica ricavata dalla situazione della ricerca politica e sociale dell’epoca. A nostro torto, dobbiamo sottolineare che in quell’epoca credevamo ancora di lavorare a un “classico” e, come tale, trattavamo L’anarchia, come un testo del passato la cui lettura può tornare utile per comprendere certe cose del presente, un punto di riferimento in grado di consentire un’introduzione alla problematica varia e non sempre sufficientemente adeguata della letteratura anarchica.
E la critica di Cerrito, redatta agli inizi del 1970, avrebbe dovuto ben altrimenti indicarci il nostro errore o, almeno, la nostra fin troppo ovvia incapacità di prevedere il futuro.
Questo futuro si chiama Strage di Stato, si chiama “autunno caldo”, ripresa della repressione, accentuazione delle lotte, allargamento immediato e a volte non chiaramente maturato del movimento anarchico, attuazione e perfezionamento delle lotte di piazza e degli scontri armati.
Alla fine del 1969, ma ovviamente redatti prima, quasi certamente nell’estate precedente, uscivano gli articoli di Domenico Demma su “Umanità Nova” (in particolare ci riguarda direttamente: “Critica libertaria dell’anarchismo tradizionale”, in “Umanità Nova” n. 20, dicembre 1969). Demma è anche autore di un’ampia recensione del nostro lavoro apparsa su “Umanità Nova” del 15 novembre 1969, in cui veniva criticata la nostra valutazione pragmatica della concezione malatestiana dello Stato. In questo modo ci si allontanava irrimediabilmente dal problema e si permetteva a Cerrito di cogliere l’occasione per tacciare Demma di sprovvedutezza e di impreparazione. (Cfr. il citato articolo “Accademia e utopismo”).
Malatesta oggi
Nel 1897 Malatesta scriveva: «Nessuno si scusi col desiderio di più grandi cose, nessuno nasconda la propria ignavia col dire che non scende in piazza se non per mandare il mondo a soqquadro. Il poco è meglio che niente!». (“L’Agitazione», aprile 1897).
Questa la posizione già modificata riguardo a L’anarchia, ma modificata nel senso di presupporre e superare la tesi dello sviluppo organico e determinista. Presupporla nei termini in cui non c’era verso di reperire – neanche volendo – un’alternativa scientifica altrettanto valida come quella kropotkiniana, superarla nel senso di impedire quel blocco che tutto il movimento correva il rischio di attuare a seguito di un certo attendismo conseguente alla tesi determinista.
Ecco come Malatesta parla di questa posizione kropotkiniana: «Secondo il suo sistema, la volontà (potenza creatrice di cui noi non possiamo comprendere la natura e la sorgente, come del resto non comprendiamo la natura e la sorgente della “materia” e di tutti gli altri “primi princìpi”) la volontà, dico, che contribuisce poco o molto a determinare la condotta degli individui e delle società, non esiste, non è che un’illusione... Naturalmente, logicamente, se la volontà non ha alcuna potenza, se tutto è necessario e non può essere diversamente, le idee di libertà, di giustizia, di responsabilità non hanno nessun significato, non corrispondono a niente di reale». (“P. Kropotkin. Ricordi e critiche di un vecchio amico”, in “Studi Sociali”, 15 aprile 1931, riportato in V. Richards, Errico Malatesta, Vita e Idee, tr. it., Catania 1968, p. 309).
Questo non significa, a tutte lettere, che Kropotkin non era per la rivoluzione, significa solo che la considerava un momento dello svolgimento generale del processo evolutivo. Malatesta, invece, considerava l’intervento rivoluzionario, l’azione insurrezionale di preparazione, la lotta e l’organizzazione della lotta, atti dovuti alla volontà dell’uomo. Certo questa chiarezza non è presente ne L’anarchia, legata, come abbiamo detto nell’Introduzione alla prima edizione, a un fatalismo libertario vicino al determinismo ottocentesco.
Oggi, dopo le vicende degli ultimi anni, ci sembra questo l’aspetto più importante dell’opera malatestiana, la lettura della quale deve potere essere fatta alla luce della spinta verso la realizzazione di qualcosa che se non è l’anarchia in assoluto è sempre basata sui princìpi fondamentali dell’anarchia. «L’Anarchia sarà – scriveva Malatesta – quando gli interessi collettivi della società saranno organizzati, non già assolutamente senza coazione, ma, sia pure con quel po’ di coazione morale, economica o fisica che è inevitabile – senza quel potere costituito in mezzo alla società, armato di leggi e di baionette e arbitro della roba e della vita dei cittadini che si chiama governo». (“Incompatibilità”, in “L’Agitazione”, 25 aprile 1897).
L’azione rivoluzionaria, violenta se necessario, è l’aspetto conclusivo del volontarismo malatestiano, ed è conclusione del lavoro che studiamo. Ma questa azione non deve essere isolata o, peggio, condotta dall’esterno, sulla testa del popolo. Gli anarchici devono fare la rivoluzione restando anarchici prima, durante e dopo la rivoluzione. Non potranno però farla da soli. Cosa che oggi – dopo tanti anni e tante esperienze – molti compagni continuano a non capire.
È l’atto insurrezionale il primo atto della rivoluzione, l’atto capace di rompere l’involucro legale, economico e repressivo dello Stato, l’atto violento di liberazione iniziale, al quale deve seguire la fase del rafforzamento e della sistemazione post-rivoluzionaria.
Ma questi discorsi – sia chiaro, quasi tutti databili dopo L’anarchia – trovano fondamento sulle tesi contenute in questa opera. Non è altrimenti che si può indicare un mezzo se non prima si è indicato l’avversario contro cui il mezzo politico deve essere impiegato. Questa ricerca giunge a maturazione proprio con L’anarchia. Lo Stato, il governo, le classi dirigenti, l’organizzazione burocratica, vengono tutti identificati nella loro vera sostanza di sfruttamento e di repressione, le loro pseudo-funzioni vengono dichiarate inesistenti, i loro atteggiamenti produttivi smascherati.
Bisogna infatti vedere con quanta chiarezza Malatesta, pure all’interno di uno schema che poi supererà, indicava i nemici del popolo, cosa che molti anarchici oggi non riescono a fare. Quando oggi molti compagni insistono nel parlare di tecnocrazia e di capitalismo avanzato, quando indicano agli sfruttati non l’alternativa della lotta ma quella della chiusura per la realizzazione di un piccolo mondo “anarchico”, nel grande mondo borghese dello sfruttamento e della diseguaglianza, quando si utopizza questa specie di “anarchia a mezzo servizio” e la si fonda sul fatto che “il padrone non esiste più” ma la controparte è costituita da grossi complessi anonimi, contro cui l’operaio non può più combattere, non solo si tradisce la causa rivoluzionaria ma non si è capito proprio nulla delle esperienze del passato e della realtà che viviamo.
Se la lettura di Malatesta oggi ha una utilità, diversa da quella che come abbiamo detto aveva agli inizi del 1969, è perché anche leggendo L’anarchia ci si può rendere conto della chiarezza dei rapporti di contrasto, della precisione con cui egli analizza la situazione degli sfruttati dei suoi tempi. Non è più il caso di considerare questo scritto “un classico”, adesso lo possiamo considerare un “libro attuale”, da leggersi con quegli opportuni chiarimenti che ora si rendono indispensabili.
Necessità quindi del fatto educativo e propagandistico ma, anche, necessità del fatto insurrezionale, cercato con insistenza, studiato e alimentato con fede e passione, attuato anche quando non si può parlare di “rivoluzione anarchica”, come i puri vorrebbero che fosse.
Tutto ciò è presente in Malatesta, quello stesso Malatesta che oggi viene preso a bandiera e – come se non fosse una contraddizione in se stessa – a ideologo ufficiale del movimento anarchico italiano, quello stesso movimento che in molte sue organizzazioni ormai fuori del tempo e della lotta politica ha ripiegato soltanto sul fatto educazionista e propagandista, teorizzando – ma solo teorizzando – una possibile azione anarcosindacalista che resta quanto meno un sogno beato, vista l’inconcludenza e la faciloneria con cui queste organizzazioni continuano a svolgere la loro attività politica. Questi compagni farebbero bene a leggersi Malatesta, ed è anche per loro che abbiamo pubblicato questa seconda edizione con i richiami contenuti in questo scritto introduttivo assenti nella precedente.
Discorso rivoluzionario e discorso apologetico
Fine dell’apologetica. Inizio della critica e dell’analisi. Questo dicevamo davanti ai fatti di Maggio in Francia.
Tiriamo le somme di quanto è stato fatto in Italia in questi ultimi anni su questa linea di lavoro, a nostro avviso necessaria e forse indispensabile.
L’apologetica ha continuato la sua strada, legata a vecchi canovacci che camminano da soli, anche senza la diretta responsabilità di qualcuno che li spinga. Personalmente ho sentito vecchi compagni, di cui non faccio il nome per carità di patria, dire che se quella tale pubblicazione non si faceva in quel certo modo non si sarebbe fatta in alcun modo, visto che loro “avevano quella certa editrice o quella certa rivista”. Quindi produzione di scarsa importanza, ancora legata all’apologetica diremo “classica”.
L’analisi c’è stata. A volte ampia ed interessante. Si sono affrontati alcuni problemi vitali per il movimento: violenza rivoluzionaria, rapporti con gli altri gruppi rivoluzionari, rapporti con la base dei partiti della sinistra riformista parlamentare, rapporti con la reazione e altri temi. La Strage di Stato ha avuto un’influenza grandissima nell’alimentare queste analisi ma, per la maggior parte, si è vissuti a credito, cioè di quei quattro spiccioli che passava il grosso della coalizione pro-Valpreda, almeno fin quando questi non è entrato nelle liste del “Manifesto” con conseguente blocco della stampa comunista.
Le analisi più interessanti sono state di tre tipi. Un primo tipo è quella che abbiamo accennato, diretta a individuare nella tecnoburocrazia e nelle grandi società di capitali multinazionali la nuova controparte degli sfruttati, la qual cosa è come dire che questa controparte si è volatilizzata e che quindi tanto vale non continuare la lotta.
Un secondo tipo è quella diretta a capire la natura dell’azione progressiva che gli organi della repressione pongono in atto per controbattere la spinta rivoluzionaria. In ciò questo tipo di analisi non distingue se non per amore di chiarezza tra fascisti, polizia, organismi giudiziari, padroni. La lotta contro questa struttura va quindi organizzata in relazione alla situazione cui si è giunti, al limite la lotta armata diventa lo sbocco naturale del contrasto di classe.
Un terzo tipo infine, partendo dalla constatazione che l’integrazione progressiva dei gruppi extraparlamentari è un dato acquisito dalle caratteristiche di alcuni fatti come la morte di Pinelli, la Strage di Stato, l’affare Feltrinelli, fino alle morti più recenti come quelle di Serantini, di Lupo e di Franceschi, dalla inconscia tendenza al compromesso che la coabitazione col potere automaticamente causa, parla di necessità della lotta armata in vista dell’insurrezione. Quindi una differenza dalla prima analisi, non la lotta armata come sbocco finale di una situazione economica oggettivamente insostenibile con altri mezzi, ma la lotta armata come sistematica preparazione del fatto insurrezionale.
Queste tre linee di analisi hanno caratterizzato il movimento anarchico italiano degli ultimi quattro anni. Ogni ricerca, che non vuole cadere nella vana apologetica, ma intende disporsi come discorso rivoluzionario, non può fare a meno di tenere presente queste tre analisi, esaminandone naturalmente tutte le implicazioni secondarie che esse comportano.
La prima non ha per niente caratteristiche rivoluzionarie, sebbene i suoi sostenitori vogliano, giocando sull’equivoco, insistere sulla loro adesione alla violenza rivoluzionaria e alla definitiva lotta armata. Evidentemente questi compagni non colgono il grave contrasto che emerge dal fatto di volere la lotta (armata, per giunta) contro una controparte per definizione inesistente.
Dall’apologia alla inutilità delle formule pseudo-analitiche
Certo l’analisi è la necessaria premessa dell’azione. Difettando la prima, la seconda corre il rischio di cadere nel gioco del potere, di fare gli interessi della repressione, di risultare, in una parola, favorevole allo Stato. L’azione deve quindi essere regolata, indirizzata, sostenuta e, a volte, limitata dall’analisi. Ma, in nessun caso, sarà legittimo spingere alla massima raffinatezza il discorso analitico, sottilizzare sulle condizioni economiche, sociali o spirituali che siano, dimenticando che lo scopo essenziale e unico dell’anarchismo è l’azione diretta a spezzare il potere statale e tutte le sue estrinsecazioni per sostituirvi una società libera e basata sull’uguaglianza.
Malatesta ebbe ad avvertire più volte su questo pericolo (cfr. “Pensiero e Volontà”, 1 luglio 1925) e, indirettamente, il passo dell’opera che commentiamo, relativo alla lupatteria, si adatta molto a parecchi compagni che oggi restano ingenuamente legati alla coabitazione col potere e non si accorgono che il loro discorso è semplicemente il frutto di quella coabitazione trasformata ormai in ideologia.
Il primo compito di chi conduce un’analisi sociale con intendimenti rivoluzionari non è affatto quello di svolgere un’analisi completa in tutte le sue parti, degna di figurare in un manuale di sociologia, ma è quello di preparare – come abbiamo detto – l’azione. Quindi deve essere chiara, munita di valide premesse e intelligibili deduzioni, di facile presa su persone non adeguatamente preparate ad affrontare strumenti analitici raffinati. Malatesta fu maestro in questo genere di analisi, ma del suo modo di lavorare si vede che i compagni di oggi non hanno proprio per niente capito qualcosa. (Fra contadini, ad esempio, è una delle cose più chiare scritte da Malatesta e, con parole adatte a tutti, concretizza un’analisi ben precisa di certe situazioni. Cfr. l’edizione: Ragusa 1972, Collana “La Rivolta”).
Prendiamo, ad esempio, alcuni scritti recenti che ci hanno colpito per la loro assoluta incapacità di disporsi, trattandosi appunto di scritti analitici, nella giusta condizione dell’analisi preparatoria dell’azione.
Antonio Scalorbi: «Stiamo perdendo il controllo del nostro stesso sistema, per cui rischiamo di essere condannati a eseguire le decisioni che i calcolatori elaborano per noi... Nella società “tecnetronica” l’individuo non può che essere passivo, senza vita e senza sentimenti. Uno dei sistemi più chiaramente preoccupanti della nostra – che è pure un’anticipazione del futuro – economia sta nel fatto che si basa sulla produzione bellica e sul principio del massimo consumo, quindi che produciamo beni capaci di distruggerci fisicamente, che trasformiamo l’individuo in un consumatore completamente passivo e quindi insensibile, che creiamo una burocrazia a fronte della quale il singolo sia assolutamente impotente... L’anarchismo in questo discorso può essere il supporto più ideologicamente attrezzato. Esso rappresenta l’ideologia dell’antipotere in quanto contesta il principio del potere medesimo, oltre alle sue strutture, le gerarchie, i suoi metodi, le sue inefficienze e alla sua morale. Non ha quindi problemi di conservazione con cui fare i conti, ma, semmai, di conquiste da effettuare». (Materiali per un dibattito, “Quaderni dell’Antistato, Anarchismo ‘70” n. 1, Catania 1970, pp. 4-5).
In apparenza il meccanismo funziona, una prima parte destinata ad analizzare gli elementi del problema, una seconda parte per fornire gli strumenti, ma quali strumenti? quali indirizzi? quali aperture all’azione? Francamente non riusciamo a capire che senso abbia ribadire che l’anarchismo è l’ideologia dell’antipotere quando poi non si va al di là limitandosi ad affermare genericamente che l’anarchismo spinge alla formazione delle nuove basi e della nuova morale del futuro. È proprio in questo modo che l’anarchismo non solo non può conquistare nulla, perché diventato impraticabile palestra di maldestri intellettuali, ma finisce per disamorare i giovani mossi da vaghi sentimenti libertari che finiscono per adattarsi, nella loro immaturità, all’autoritarismo dei movimenti extraparlamentari di estrazione marxista, al solo scopo di “fare qualcosa”.
Dello stesso genere, abbiamo dovuto ammettere, è Amedeo Bertolo: «... le prospettive a medio termine non sono molto incoraggianti perché il processo di feudalizzazione è in fase avanzata (in Italia oltre metà dell’economia è controllata dallo Stato) e perché parallelamente si va generalizzando la tendenza ad accettare ideologie di tipo feudale. D’altro canto però resterà, almeno in teoria, un ampio spazio politico al movimento anarchico, perché l’anarchismo, con la sua coerenza libertaria ed egualitaria, resta sostanzialmente l’unica teoria che si oppone alla feudalizzazione ideologica e l’azione anarchica resta l’unica possibile opposizione alla feudalizzazione economica e politica. Tale azione deve essere caratterizzata dalla multiformità e dalla sperimentalità, cioè non deve trascurare alcuna possibilità e deve sperimentare sin d’ora strutture alternative a quelle del potere. L’azione anarchica dovrà colpire in tutte le direzioni e forme possibili (ma non in modo settoriale, specialistico, disarticolato, bensì organico e collegato), perché solo con la multiformità organica è forse possibile sottrarsi alla spaventosa capacità di neutralizzazione, di integrazione del sistema». (Ib., pp. 15-16).
Parole, inutili verbalismi, esercitazioni letterarie. In che modo si potranno utilizzare di fronte a un tentativo di serrata, contro il padrone del feudo che compra i braccianti a giornata, contro la polizia nelle manifestazioni, contro l’esercito domani nel corso di un’insurrezione? L’accenno alla multiformità e alla sperimentalità, di chiara ispirazione malatestiana (E. Malatesta, “La Rivoluzione in pratica”, “Umanità Nova”, 7 ottobre 1922, e dello stesso “Ancora sulla Rivoluzione in pratica”, “Umanità Nova”, 14 ottobre 1922. Ambedue si trovano in E. Malatesta, Scritti scelti, a cura di G. Cerrito, Roma 1970, pp. 171-180), sembrava ci desse la possibilità di una comprensione migliore del problema rivoluzionario, ma niente di tutto questo. Ancora una volta, dalla vuotaggine dell’apologia si è caduti nella vuotaggine dell’analisi fine a se stessa.
Virgilio Galassi: «Per me l’anarchia (e ho detto e ripeto questa parola con orgoglio, perché evidentemente bisogna smetterla di averne timore) questa anarchia dobbiamo sforzarci di inventarla, vedercela davanti. All’anarchia ci arriveremo quando noi tutti, singolarmente, nel nostro lavoro, contribuiremo a realizzarla. Cioè non importano i partiti politici, non importano i partitini, i gruppetti, i gruppuscoli e tutte quelle cose lì. Quello che importa è che cosa uno fa sul suo lavoro, come realizza il suo lavoro, come lo interpreta, che cosa cambia della realtà attuale, col suo lavoro, se il suo lavoro quotidiano è tale, noi costruiremo qualcosa di diverso, se no, è inutile che facciamo i gruppetti, che andiamo a fare le dimostrazioni... Adesso vorrei sottolineare che come si può dire che il maoismo è religione così l’anarchismo tradizionale è una religione... Tutti i miti politici sono religioni, e perché allora pigliarsela con i maoisti, non vedo perché, oppure con altri gruppi marxisti e simili?... Chi comanda veramente oggi è la finanza. Ed è contro di lei, e contro l’economia di consumo, che dobbiamo combattere, sono questi i due fronti. A mio parere i problemi si risolvono veramente con la programmazione, con l’organizzazione, con lo studio dei rapporti che sono anche tecnici, scientifici...». (“Quaderni dell’Antistato, Anarchismo ‘70”, n. 1, cit. pp. 44-45). Quando si arriva al punto di fare sproloquiare in questo modo una persona e inserire queste parole in libertà in una pubblicazione collettiva fatta da anarchici, una persona, per giunta, che si definisce per l’anarchia, e che ha trovato – supremo sforzo – il coraggio di dire la parola, si è veramente nel fondo. Non siamo più davanti a un’analisi fine a se stessa, siamo davanti alla prova concreta della povertà e della inutilità di una certa parte del movimento anarchico.
In questa deprimente prospettiva la lettura di un testo come L’anarchia, con tutte le sue limitazioni, ma anche con tutte le sue chiarezze, può essere molto producente. Se non altro può convincere qualcuno che il proprio atteggiamento intellettualista non ha nulla a che fare con l’anarchismo, che se la fase educazionista è una fase dell’attività anarchica, non può mai essere fine a se stessa ma deve sempre restare legata all’azione concreta rivoluzionaria, all’azione diretta a distruggere il potere.
L’insurrezione
L’anarchia presuppone il meccanismo insurrezionale. Il discorso kropotkiniano non si spinge mai tanto oltre da negare la necessità dell’insurrezione, del resto nemmeno nel suo principale assertore l’evoluzione determinista viene confusa con l’attendismo e l’ignavia. Certo il tema dello scritto non è quello dei modi e delle possibilità insurrezionali, quanto quello dei modi e delle giustificazioni che fondano la lotta allo Stato e la legittima possibilità di distruggerlo.
Malatesta è tornato molte volte sul tema insurrezionale, considerandolo l’atto primigenio del riscatto sociale. «Naturalmente bisogna principiare con l’atto insurrezionale, che spazzi via l’ostacolo materiale, le forze armate del governo, che si oppone a qualunque trasformazione sociale». (“Umanità Nova”, 12 agosto 1920). E altrove: «Noi abbiamo potuto fare, abbiamo fatto realmente, in tempi ormai remoti dei minuscoli moti insurrezionali che non avevano alcuna probabilità di successo. Ma allora eravamo davvero in quattro gatti, volevamo obbligare il pubblico a discutere ed i nostri tentativi erano semplicemente dei mezzi di propaganda. Ora non si tratta più d’insorgere per fare propaganda, ora possiamo vincere, quindi vogliamo vincere, e non facciamo tentativi se non quando ci pare di potere vincere. Naturalmente possiamo ingannarci, e, per ragione di temperamento, possiamo credere il frutto maturo quando ancora è acerbo, ma confessiamo la nostra preferenza per coloro che vogliono fare troppo presto contro quegli altri che vogliono sempre aspettare, che lasciano di proposito passare le migliori occasioni e per paura di cogliere un frutto acerbo lasciano tutto marcire». (“Umanità Nova”, 6 settembre 1921). E ancora, in un testo basilare: «L’insurrezione vittoriosa è il fatto più efficace per l’emancipazione popolare, poiché il popolo, scosso il giogo, diventa libero di darsi a quelle istituzioni che egli crede migliori, e la distanza che passa tra la legge, sempre in ritardo, ed il grado di civiltà a cui è arrivata la massa della popolazione, è varcata d’un salto. L’insurrezione determina la rivoluzione, cioè il rapido attuarsi delle forze latenti accumulate durante la precedente evoluzione. Tutto sta in ciò che il popolo è capace di volere». (Il Programma Anarchico).
Questo il vero Malatesta, quello che lega il Malatesta degli inizi, affascinato dalla figura di Bakunin e dalle teorie di Kropotkin, al Malatesta della maturità, assiduamente dedito a costruire la rivoluzione, non a giocarci attorno o a ritardarla, come fanno oggi molti compagni che, sia pure in buona fede, credono ormai sorpassata la prospettiva insurrezionale e si dedicano soltanto alla propaganda e all’analisi sterile perché non presuppone in alcun modo l’azione.
A quattro anni di distanza l’opera che ripresentiamo ai lettori conserva intatta la sua validità. Questi anni, densi di avvenimenti drammatici per il movimento anarchico mondiale e italiano in particolare, hanno segnato l’acutizzarsi della repressione e la denuncia di alcune carenze intrinseche allo schieramento rivoluzionario. L’incapacità di quest’ultimo di collocarsi a livelli di lotta superiori, a seguito dell’aumento della repressione determinato dalla sua stessa attività, ha posto in crisi la struttura e la formula del movimento stesso, ambedue nate e collaudate dopo il 1968. I prossimi anni ci diranno se queste nostre parole, scritte oggi in un momento di riflusso e di ripresa della repressione, in un momento in cui si susseguono gli omicidi sulle strade perpetrati con fredda determinazione dai servi dello Stato, sono del tutto errate, se la prospettiva insurrezionale non è altro che un miraggio causato da un’ottica analitica fondamentalmente sbagliata, oppure l’esatta collocazione delle lotte future, la giusta risposta all’intensificarsi della repressione e al sempre maggiore rifiuto dei partiti riformisti di abbandonare la strada del compromesso col potere monopolista.
[Introduzione alla seconda edizione di E. Malatesta, L’Anarchia, Ragusa 1973]
Note a L’anarchia di Errico Malatesta (seconda edizione, Ragusa 1973)
La parola anarchia era presa [una volta] universalmente nel senso di disordine, confusione.
In passato il termine “anarchia” si associava immediatamente al significato di caos e di licenza. Ai tempi di Malatesta l’anarchismo aveva finito per conquistare le simpatie di gran parte delle masse.
Ma le conclusioni non furono quelle che era logico aspettarsi. Perché? I motivi furono molteplici e alcuni poco chiari, d’altro canto non è questo il posto per elencarli. Gli anarchici che abbandonarono il movimento furono in numero abbastanza limitato, ma coloro che abbandonarono l’idea per optare a favore del Partito Socialista furono di certo innumerevoli. Agli inizi del secolo Merlino scriveva: «Io, dunque, ho detto che il partito anarchico da venti anni si dibatte ancora tra il socialismo libertario e l’individualismo amorfo, che esso non produce più né uomini né idee, che esso non opera più». (Cfr. “Intervista rilasciata da Saverio Merlino a Cesare Sombrero” e pubblicata tra l’altro su “La Stampa” di Torino. Si trova anche in L. Galleani, La fine dell’anarchismo?, Cesena 1966).
Oggi le cose non stanno poi diversamente. I giovani e, in una parola, tutto il movimento studentesco guardano con viva simpatia all’ideale anarchico. Si può dire che la moderna contestazione sia di natura prettamente anarchica. Siamo quindi di fronte a una vera e propria vittoria dell’anarchismo tradizionale? Non è facile rispondere affermativamente. Le nuove dottrine anarchiche, o meglio le nuove idee anarchiche che ancora non hanno ricevuto il battesimo dottrinale, sono fino a un certo punto la continuazione dei presupposti dei “vecchi” anarchici. Non bisogna dimenticare che altri elementi sono intervenuti: la demistificazione della lotta di classe, il ridimensionamento delle dottrine marxiste dello sviluppo economico, l’instaurazione di un processo economico di benessere, una situazione obiettiva disadatta per una politica del dissenso basata sul risentimento, il grado mai raggiunto prima di integrazione, lo sviluppo veramente eccezionale della tecnica della produzione economica e cento altri motivi che potremmo elencare.
Dunque, poiché si è creduto che il governo fosse necessario e che senza governo non si potesse avere che disordine e confusione, era naturale, era logico che anarchia, che significa assenza di governo, suonasse assenza di ordine.
Il preconcetto di cui parla Malatesta non è solo riscontrabile tra le persone poco colte. Anche studiosi di economia e scienze sociali ne sono affetti.
Il più strano è che questa mancata osservazione delle realtà sociali nelle loro componenti più recondite avviene non solo in quegli studiosi legati dalla propria visuale conservatrice al carro del potere, ma anche in alcuni che hanno rifiutato la banalità conservatrice per abbracciare la strada difficile della critica vigile e dell’analisi costruttiva.
Anche volendo prescindere dall’esaminare la posizione di studiosi precedenti al secolo XIX, in quanto l’idea anarchica si può dire che non presenti nessuna caratteristica di corposità prima di quel periodo, non è infrequente il caso di studiosi vicini all’idea anarchica rifiutanti, però, la dottrina anarchica in concreto. Questo è ad esempio il caso di Pareto che in più punti della sua immensa opera presenta spunti anarchici, come ha notato giustamente Georges Henri Bousquet, ma rigetta la tesi di Kropotkin esposta nel lavoro La conquista del pane: «Poi che l’organizzazione della giustizia è servita a coprire dei misfatti, dobbiamo abolirla del tutto. Famiglia, governo, morale, tutto dev’essere eliminato per gli stessi motivi. A loro volta, però, gli anarchici sono costretti, essi pure, ad arrestarsi a un certo punto, che, se si volesse spingere questa singolare teoria fino alle sue ultime conseguenze, bisognerebbe lasciarsi morir di fame, poiché, se se ne abusa, gli stessi alimenti possono generare ogni specie di malanni». (Corso di economia politica, tr. it. Torino 1961, p. 1066). Come si vede la critica di Pareto è assolutamente puerile e superficiale, dovendo ricorrere all’ironia che nel campo critico è la zattera della salvezza per coloro che non hanno argomenti validi da utilizzare.
Stato significa infine condizione, modo di essere, regime di vita sociale ecc., perciò noi diciamo, per esempio, che bisogna cambiare lo stato economico della classe operaia, o che lo stato anarchico è il solo stato sociale fondato sul principio di solidarietà, ed altre frasi simili, che in bocca a noi, che poi in altro senso diciamo di volere abolire lo Stato, possono a prima giunta sembrare barocche o contraddittorie.
La dottrina costituzionale insegna che lo Stato è un organismo composto. Con quale significato impieghi poi la parola “organismo” non è chiaro, comunque il concetto viene portato avanti con tale sicurezza da sembrare buono e ovvio. Un organismo, dicevamo, composto da almeno tre parti: a) popolo, b) territorio, c) governo.
Quindi il governo, differentemente dalla impostazione malatestiana, sarebbe una parte dello Stato. Precisamente sarebbe «il complesso delle istituzioni nelle quali sono organizzate le persone che esercitano il potere d’impero dello Stato. Tali istituzioni sono proprie di ogni ordinamento, in quanto in ogni società è necessario un gruppo di persone delegate a formare la sua volontà e a svolgere l’attività necessaria al conseguimento dei suoi fini». (G. Zanobini, Corso di Diritto amministrativo, vol. I, Milano 1958, p. 4).
Tutta la folgorante verità derivante dalla negazione anarchica è di colpo evidente. Il governo finisce per essere la parte di un organismo che non esiste senza questa sua parte stessa, non che non esiste in forma completa, non esiste in forma assoluta una volta venuta meno la sua parte governo. Lo Stato si fonda sulla potestà d’impero, ritenuta assurdamente originaria, ma dettata solo dalla necessità di trovare ordine e tranquillità per il privilegio che man mano andava accumulandosi nelle mani dei pochi. Ecco perché Malatesta giustamente sovrappone e quasi confonde Stato e governo.
La tendenza metafisica è una malattia della mente.
La posizione di Malatesta qui è dichiaratamente antifilosofica. Più che un antimetafisicismo, come potrebbe a tutta prima sembrare, siamo davanti a un rifiuto assoluto dell’attività speculativa, intesa come fine determinato del pensiero.
Che la metafisica venga definita “un’allucinazione” è molto importante in quanto per certi aspetti riporterebbe Malatesta al livello di tanta parte della problematica contemporanea. Purtroppo la conclusione non può essere tanto ovvia. Malatesta evidentemente non aveva chiaro il problema o, con ogni probabilità, non se lo poneva per niente.
La tirata a favore della “scienza positiva” è una riprova di quanto si è detto. Quanti furono questi colpi? Malatesta non lo dice. In effetti furono assai mal diretti, tanto male che nella maggior parte dei casi non giunsero a destinazione ma contribuirono a smantellare lo stesso l’edificio della cosiddetta “scienza positiva”. La caduta della metafisica si ebbe per effetto indiretto attraverso la metamorfosi subita dalla scienza stessa che, deposto lo scomodo scettro del comando, s’indirizzò più modestamente sulla strada della parzialità.
Si potrebbe concludere che la caduta della metafisica fu causata da quello stesso processo di liberazione che produsse la caduta della struttura metafisica nella scienza.
Lo Stato è il potere sociale astratto
Questo è uno dei punti centrali della dottrina malatestiana. La oggettivazione del “sistema” non può essere ovviamente negata, almeno nel suo significato di copertura dell’altra realtà, quella più immediatamente percepibile dalle persone che costituiscono e determinano il “sistema”.
Malatesta non chiarisce il concetto di “sistema”, almeno non nei termini in cui lo si adopera oggi, come non chiarisce il concetto sociologico di élite, limitandosi a parlare delle “persone che stanno al governo”.
Ovviamente in questo modo il contrasto sembra ancora più duro, ridotto com’è all’essenzialità del rapporto sostanza-idea. In effetti il governo, o meglio lo Stato, pretende imporre una sua etica comportamentista, determinata da quella che è la volontà media della élite che concorre in forma prevalente alla formazione dello Stato o delle norme che regolano la vita dello Stato.
Quale giustificazione è stata apportata dagli studiosi all’esistenza dello Stato? Come è stata concepita da Georg Jellinek, da Gioele Solari, da Marcel De La Bigne de Villeneuve e da altri, la forma specifica dello Stato ancora prima di imporsi come forma scientifica a carattere societario ha una sua funzionalità rispondendo a fondamentali esigenze individuali e collettive di convivenza ordinata e pacifica. Da questa funzionalità deriverebbe una contemporanea logicità nell’autodotazione di mezzi particolari – estranei o affievoliti negli altri gruppi a carattere societario – capaci di ottenere anche coattivamente l’adempimento degli ordini.
Eccoci quindi alla grande verità di Malatesta, e con lui dell’anarchismo. Una funzionalità non può giustificare la persistenza di una realtà, se non a posteriori. In altri termini l’instaurazione dello Stato ha dovuto precedere la valutazione della sua funzionalità. Donde risulta assai probabile, anche agli occhi di un non anarchico, che questa valutazione, dettata dopo l’entrata in azione dello Stato, possa essere stata influenzata da quella forza coartante posta in atto al momento della costituzione dello Stato stesso. Per altro qui siamo davanti alla solita storia delle realtà politiche che, nate dalla violenza, coprono successivamente quelle origini con una coltre ideologica e con la continua manutenzione della propria funzionalità, l’occhio vigile del poliziotto e la mano rapace del burocrate fanno a gara per mantenere efficiente la struttura.
Ma qual è la ragione d’essere del governo?
La risposta a questa domanda ha costituito sempre un grosso problema per tutti gli studiosi di scienze sociali.
Il pensiero cristiano, donde deriva la struttura delle ricerche di diritto naturale condotte dalla Scolastica, individuava la ragione d’essere dello Stato come duplicato dell’unità dello Spirito governante. Così Tertulliano: «Egli è imperatore in virtù di colui che lo ha fatto uomo prima che imperatore, il suo potere proviene da colui al quale egli deve anche la vita». (Q. S. F. Tertulliano, Apologeticus contra idolatras, cap. XXX).
Derivata da questa la concezione del “contratto” fondata sulla dottrina del diritto naturale. Originariamente l’uomo vive in uno stato di assoluta libertà e isolamento. Poi, allo scopo di meglio garantire la stessa libertà e l’uguaglianza di tutti, si accorda per costituire la “societas civilis”.
Oggi la considerazione di questi problemi è affrontata in modo assai diverso. Ecco come sintetizza Carlo Cereti: «Altre dottrine più recenti, con un ritorno all’antico, affermano invece che il gruppo sociale che costituisce il substrato dello Stato è il prodotto non di un atto volontario dei consociati, ma di un complesso di cause e di esigenze naturali e storiche che impongono agli individui di vivere in società e determinano il corso della sua evoluzione». (Diritto costituzionale italiano, Torino 1966, p. 4).
Perché abdicare nelle mani di alcuni individui la propria libertà, la propria iniziativa?
Siamo di fronte qui al grave problema dell’istituto giuridico del mandato che il pensiero anarchico critica in più occasioni e, in modo particolarmente efficace, nel campo della rappresentanza parlamentare.
Ovviamente il problema è più profondo di quanto non si possa a tutta prima dedurre dalle osservazioni pragmatiche di Malatesta. Da parte nostra sarebbe effimero il tentativo di rivangare la dottrina tradizionale sull’origine pubblicistica del mandato con rappresentanza. Oltre che cose risapute si tratta di cose di assai dubbia validità di fronte alle necessità del mondo contemporaneo.
Ed allora che cosa ci proponiamo? Qualche cosa di più semplice, una lettura tra le righe della dottrina.
Già nel Medioevo troviamo esempi notevoli di questa delega, e su di questi si è esercitata l’attività degli studiosi. Però abbiamo anche esempi di altro genere. Nella Geschichte der Schweizer di Johannes von Müller (Berna 1781) si legge come nella lotta tra il Cantone vallese e il signore di Navon o nella lotta tra la città di Lucerna e il comune di Weggis si ricorse a deleghe particolari per risolvere le contese, date per decisione popolare agli uomini più saggi e dotti. Qui la forma di rappresentanza è particolare, non cieca e distorta come nel caso della tradizionale struttura democratico-parlamentare.
Altra considerazione curiosa e che metterebbe in alquanto imbarazzo non pochi studiosi di diritto è quella che ritroviamo nell’antico lavoro di Jean Bodin, Six Livres de la République, Parigi 1576, lib. II. Non mancarono persone, ad esempio un avvocato del Parlamento di Parigi, che fecero notare come fosse il popolo ad avere effettuato una delega dei propri poteri al re. Questa tesi venne rigettata dal Parlamento e al suo propugnatore fu proibito di fare discorsi del genere e gli venne pure vietato di svolgere la sua attività davanti ai tribunali. Evidentemente la dottrina dell’origine divina era ormai diventata cosa del tutto stabile e la favola del mandato si era fatta benedire.
Ma la dottrina del potere sovrano del popolo prende il sopravvento. Oltre i famosi testi conosciuti da tutti ci sembra molto interessante la seguente citazione riportata da Liévain Bonaventure Provart in Louis XVI et ses vertus aux prises avec la perversité de son siècle, Lione 1808: «In un foglio pubblico gli indipendenti di Londra, a quelli di Charlestown che domandavano “Che cosa è il re?”, rispondevano, “Il primo suddito”. E ancora, “Che cosa è il popolo inglese?”. “Il potere sovrano?”. “A chi appartiene la corona?”. “A coloro che possono riprenderla”. In merito a ciò si potrebbe osservare che la borsa del viaggiatore appartiene ai banditi che lo assalgono» (vol. I, p. 466). La citazione è particolarmente significativa anche perché dovuta alla penna di un paladino della restaurazione del potere regio (da cui l’ironica conclusione).
È proprio dal germe del concetto della sovranità popolare che scaturirà poi quello di sovranità nazionale. Nel 1789, gli “stati generali” verranno indetti in base al principio della rappresentanza su mandato. La corruzione del primitivo concetto rousseauiano avviene nel senso idealista. Donde l’amara domanda di Malatesta, “Perché abdicare nelle mani di alcuni individui la propria libertà?”. Il perché la storia non l’ha ancora scritto, ha scritto una serie di “così-come” ma nessun vero perché.
La dottrina radicale di Rousseau che intendeva il principio di sovranità popolare come “somma delle particelle di sovranità spettanti individualmente ad ogni cittadino” viene distorta nel principio di sovranità nazionale inteso “come sovranità del corpo uno e inscindibile della nazione anche se morale e astratto”.
Sarebbe assai facile dimostrare l’origine classista di questo concetto, ma le cure e la manutenzione che per quasi due secoli la classe dirigente ha impiegato rende il compito di dubbio risultato. Nell’astrattezza del concetto di nazione (o Stato) si nascondono le mire di conquista e dominio, le speranze di sempre migliori raccolti, i sogni di perfetta integrazione della classe dirigente.
Purtroppo questo concetto mistificato era già presente nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 (art. 3): “Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella nazione. Nessun corpo, nessun individuo può esercitare un’autorità che da essa non emani espressamente”. Ma nel 1789, e meglio ancora nella Costituzione francese del 1791, si era andato sempre di più fortificando il predominio della nuova classe dirigente. Era il risultato della politica di distruzione portata avanti dagli enciclopedisti, alla quale fu fatta seguire una altrettanto determinante politica di edificazione dei nuovi miti e delle nuove religioni. Albrecht von Haller, scriveva: «L’insegnamento non appartiene più agli altri, essi [gli enciclopedisti] si sono attribuiti il privilegio esclusivo di contraddirsi, di combattersi e di divagare. Ogni mortale tanto temerario da opporsi alla loro dottrina è un imbecille, un uomo privo di testa, senza virtù, un credulone, un visionario, un persecutore, un fanatico». (“Göttingischen Gelehrten Anzeigen”, 1768, p. 952).
Quelle stesse strade che dovevano condurre alla libertà, lontano dalla tirannide di uno solo, avevano finito per sboccare nella tirannide dei pochi, altrettanto ottusa e bestiale.
“Sono essi infallibili ed incorruttibili al punto da potere affidare, con un sembiante di prudenza, la sorte di ciascuno e di tutti alla loro scienza ed alla loro bontà?”, si chiede Malatesta. La risposta non potrà essere che una sola, quella negativa. Gli enciclopedisti produssero lo sforzo forse più ampio e gigantesco della storia per abbattere il mito politico e religioso, ma la loro opera non sfuggì alla conclusione dittatoriale. Nota con acume Carl Ludwig von Haller: «Essi reclamavano a gran voce la generale e illimitata libertà di stampa, ma poi la volevano esclusivamente per sé soli, al fine di poter diffondere più facilmente e più sicuramente le proprie dottrine, essendo ancora una setta militante, cercavano d’impedire la pubblicazione di tutte le opere dei loro avversari, cercavano altresì di screditarle e farle sopprimere, ricorrendo a loro adepti ed a intrighi segreti». (La restaurazione della scienza politica, vol. I, tr. it., pp. 212-213, Torino 1963). L’affermazione di von Haller è riccamente documentabile.
Ad esempio gli enciclopedisti riuscirono a fare abolire la critica fatta da Joachim Joseph Berthier alla Encyclopédie, quella fatta da Claude Dupin, fecero ritirare le due commedie di Charles Palissot, Les Philosophes e L’Homme dangereux, come pure fecero cessare le pubblicazioni del Journal del reverendo Royau.
Queste repressioni, fatte da spiriti indiscutibilmente liberi nella fase di preparazione dottrinale, ci fanno pensare con amarezza e con ammirazione alle parole di Malatesta : «Vi sono degli individui forti, intelligenti, passionati, con grandi bisogni materiali o intellettuali, che essendo essi stati dalla sorte messi tra gli oppressi vogliono a qualunque costo emanciparsi e non ripugnano dal diventare oppressori, individui che trovandosi coartati nella società attuale prendono a disprezzare e odiare ogni società, e sentendo che sarebbe assurdo volere vivere fuori della collettività umana, vorrebbero sottoporre al loro volere, alla soddisfazione delle loro passioni, tutta la società, gli uomini tutti». (“Volontà”, 15 giugno 1913).
Gli antagonismi naturali degl’interessi e delle passioni creano la necessità del governo, e giustificano l’autorità che interviene moderatrice nella lotta sociale, e segna i limiti dei diritti e dei doveri di ciascuno.
Così Hegel: «L’essenza dello Stato moderno congiunge l’universale con la piena libertà del particolare inclusa la felicità degli individui». (Filosofia del diritto, sez. 260, aggiunta).
Questa può definirsi la formula che giustifica la rottura del sistema sulla strada sempre del totalitarismo autoritario. Già i sofisti avevano tratteggiato questa rottura con Callicle: «Ma se capita un uomo di carattere energico, scuote da sé tutti codesti impacci [le leggi], sguscia via rompendo ogni ostacolo, e calpestando le nostre scritture, gl’incantesimi, i prestigi, le leggi contro natura, insorge, e da nostro servo, lo vediamo padrone, qui rifulge il diritto di natura». (Platone, Gorgia, 480).
Ecco la suprema affermazione della necessità dell’autoritarismo in Cicerone, che compendia il pensiero greco, in particolare cinico e stoico, sull’argomento: «Lo Stato è dunque la cosa del popolo, e il popolo non è un qualsiasi gruppo di uomini, messo insieme in qualche modo, ma l’associazione di un numero considerevole di uomini, uniti da un accordo comune circa la legge e il diritto e dal desiderio di partecipare alla comune utilità». (Repubblica, I, 25).
Una cristallizzazione dell’autoritarismo avviene in tutta la tradizione romana. La sentenza di Ulpiano: «Il volere dell’imperatore ha forza di legge perché col passaggio della lex regia il popolo trasferisce a lui il suo potere e la sua autorità e ne lo investe». (Digesto, I, 4, 1). In questo modo la suprema ironia della rappresentanza prende la forma definitiva e contribuisce a consolidare la chiusura mentale dell’autoritarismo.
Da canto suo la difettosa impostazione paolina del pensiero cristiano invita all’obbedienza nell’egoistico fine di salvaguardare la nascente congrega: «Ogni anima sia sottoposta ai poteri superiori. Non v’è potere che non provenga da Dio...». (Epistola ai Romani, 13, 1).
Il colmo dell’impostura e dell’aberrazione autoritaria si ha nel medioevo con Gregorio: «Agite in modo, vi prego, santi padri e prìncipi, che tutto il mondo possa conoscere che, se avete potere di vincolare e sciogliere in cielo, avete potere di abolire o di sostenere in terra imperi, regni, principati, ducati, marche, contee ed i beni di tutti gli uomini secondo i loro meriti. Re e prìncipi del mondo imparino quanto grandi voi siate e quali poteri abbiate. Temano questi piccoli uomini di disobbedire al comando della vostra chiesa». (Concilio di Roma del 1080, cfr. G. H. Sabine, Storia delle dottrine politiche, tr. it., Milano 1962, p. 189).
Il giusnaturalismo riafferma la catastrofica idea di Hobbes che abbina, nell’umanità, il desiderio di sicurezza al desiderio di potere: «Io sostengo che è inclinazione generale di tutta l’umanità, un desiderio perpetuo e senza tregua di potere oltre il potere, che cessa soltanto con la morte. E questo non sempre perché un uomo speri una gioia più intensa di quella che ha già raggiunto, o perché non possa accontentarsi di un più modesto potere, ma perché egli non può assicurarsi il potere e i mezzi per una vita buona come quella che conduce, se non acquistando di più». (Leviathan, cap. 11). E altrove: «I patti senza la forza sono soltanto parole, e non possono dare a un uomo nessuna sicurezza». (Ib., cap 17). «I vincoli delle parole sono troppo deboli per imbrigliare l’ambizione, l’avarizia, la collera, e le altre passioni degli uomini, quando non ci sia il timore di un potere coercitivo». (Ib., cap. 14).
Il terreno era ormai pronto per l’innesto, attraverso l’elaborazione di Locke e di Rousseau, del pensiero di Hegel, il cerchio dell’autoritarismo si chiuderà definitivamente. Il futuro sarà tutto una messa sul tappeto delle formulazioni del filosofo di Stoccarda.
All’ombra del potere, per la sua protezione e complicità, e spesso a sua insaputa e per cause che sfuggono al suo controllo, si sviluppa la ricchezza privata, cioè la classe dei proprietari. E questi, concentrando a poco a poco nelle loro mani i mezzi di produzione, le fonti vere della vita: agricoltura, industria, scambi, ecc., finiscono col costituire un potere a sé.
Quella che Malatesta delinea è, in definitiva, una vera e propria schematizzazione di una teoria dello sviluppo economico. La vicinanza con la concezione marxista-leninista è evidente ma va sottolineata.
L’analisi marxista si può riassumere nei seguenti punti essenziali: 1) incremento del profitto da parte dell’imprenditore capitalista, 2) diminuzione del profitto contemporanea a una notevole accumulazione di capitale tendente a comprimere i salari attraverso una disoccupazione tecnologica di mano d’opera, 3) la produzione completa il proprio ciclo interno avviandosi al ritmo delle crisi periodiche di sopraproduzione e sottoconsumo, 4) ulteriore accumulazione capitalista (trust, fenomeni di azionariato) allo scopo di fronteggiare le crisi e difendere la struttura, 5) mancata risoluzione delle crisi, 6) scarso potere di acquisto, reso ancora più scarso dalla concentrazione del capitale, favorisce le crisi invece di reprimerle, 7) esplosione del sistema capitalista, 8) rivoluzione del proletariato.
Che cosa manca all’analisi di Marx? Innanzi tutto l’apertura verso l’esterno che ebbe a darle Lenin, ma più specificatamente il passaggio tra l’azione dei capitalisti, troppo fermamente decisi a comprimere i salariati, all’azione diretta a farli partecipi, sia pure in misura molto limitata, della propria linea politica di espansione.
Questo è visto abbastanza bene anche da Malatesta. Di fronte al moltiplicarsi degli interessi, i capitalisti non possono fare altro che allargare sempre più il raggio della loro azione, coinvolgendo il governo, quindi coinvolgendo anche quella rappresentanza del proletariato che, come succede ai nostri giorni, partecipa ma non riesce a determinare il governo stesso.
Notevole, tra gli altri esempi, quello addotto da Pareto nel porsi la domanda: “Come mai questo politicante (il ministro Depretis) figura per tanti anni come padrone della Camera e del paese?”. La risposta è preceduta da alcuni chiarimenti: «Non era il capo di un esercito vittorioso, non aveva l’eloquenza che trascina gli uomini, non l’autorità che ha origine da grandi fatti, non era imposto dal sovrano, da dove dunque veniva la sua forza? Una sola risposta è possibile, cioè, egli seppe maestrevolmente usare dei sentimenti e degli interessi che c’erano nel paese, di questi ultimi specialmente, divenendo propriamente il capo del sindacato di “speculatori” che dominava il paese, e che, in gran parte, aveva la sostanza del potere di cui egli godeva l’apparenza. Procacciò ricchezza a molti “speculatori”, colla protezione doganale, colle convenzioni ferroviarie, cogli appalti governativi in cui lo Stato era derubato, coi disordini delle Banche, che più tardi si scoprirono, mai capobanda fu tanto largo, alle sue truppe, di saccheggi e di rapine». (Trattato di sociologia generale, paragr. 2255, tr. it., Bologna 1959).
Rotschitd non ha bisogno di essere né deputato né ministro, gli basta tenere alla sua dipendenza deputati e ministri.
La frase di Malatesta, fondamentalmente giusta, deve essere aggiornata con i tempi nuovi.
Che il governo protegge il diritto dei privilegiati è cosa pacifica, come altrettanto vera è l’affermazione che i grandi possidenti rifiutano di entrare a fare parte del governo. Però oggi il governo ha finito per assumere, sotto certi aspetti, la configurazione di “possidente in proprio”. Questo è il caso, sempre più ampio, delle partecipazioni statali. In questo modo si costituiscono grandi imperi finanziari, voluti dallo Stato, ma difficilmente controllabili dallo Stato stesso. Oggi in Italia le figure dei vari Medugno, Petrilli, Cefis, ecc. rigettano ogni effettiva ingerenza del governo, anche se questo ha un proprio dicastero chiamato delle “partecipazioni statali”.
Non è solo il grande ricco isolato a rigettare l’influenza del governo in favore della propria opera di sviluppo capitalista, oggi anche lo stesso governo finisce per sdoppiarsi e rifiutare la propria dirittura politica in quella parte di se stesso che è diventata autonoma e prolifica.
Questa grossa modificazione della struttura interna del governo anticipa la modificazione complessiva e determinante della sua stessa funzione. Come abbiamo accennato nell’Introduzione oggi il governo è esso stesso uno strumento nelle mani del complesso meccanismo della produzione, mentre questo, da canto suo, è uno strumento nelle mani del fatale processo economico e delle sue leggi difficilmente eliminabili. Ecco perché oggi, ad esempio in Italia, il ministero più importante, il vero “numero uno”, non è quello degli Esteri o dell’Interno, come ai tempi di Crispi o di Giolitti, ma è quello del Tesoro.
Che la borghesia lo prevedesse o no quando per la prima volta concedeva al popolo il diritto al voto, il certo è che quel diritto si è mostrato affatto irrisorio, e buono solo a consolidare il potere della borghesia col dare alla parte più energica del proletariato la speranza illusoria di arrivare al potere.
Malatesta denuncia un fenomeno del tutto nuovo per i suoi tempi. Oggi la cosa non sorprende più, anzi costituisce la regola dei rapporti tra datori di lavoro e lavoratori.
Già Lenin aveva notato: «L’ideologia imperialista si fa strada anche nella classe operaia». (Imperialismo, fase suprema del capitalismo, tr. it., Roma 1948, p. 102).
Anche utile ricordare la posizione di Rudolf Hilferding: «Il crescere del potere dei lavoratori fa sì che il capitale intensifichi il suo sforzo diretto a estendere il potere statale per costruirsi una garanzia contro le richieste del proletario. In questo modo sulla tomba dei vecchi ideali liberali sorge l’ideologia dell’imperialismo». (Cfr. P. M. Sweezy, La teoria dello sviluppo capitalista, tr. it., Torino 1951, p. 471).
Ed infine anche Maurice Dobb nota: «Schiavi di palazzo della madrepatria, schiavi i quali, a differenza degli schiavi di piantagione alla periferia dell’Impero, sentono una parziale identità di interessi con i loro padroni e una riluttanza a turbare lo statu quo». (Economia politica e capitalismo, tr. it., Torino 1950, p. 238).
Ma ai tempi di Malatesta queste scoperte della scienza sociale non erano ancora state fatte, mentre il lavoratore osservava con un curioso disinteresse i movimenti a sfondo sociale. Leggiamo Pareto: «Così in Italia, dopo la costituzione del nuovo regno, la borghesia era abituata a rimettersi al governo per la cura dei propri interessi. Essa non aveva che una preoccupazione: impedire che il governo cadesse nelle mani dei suoi avversari, nel suo stesso seno, parecchi partiti borghesi si contendevano i favori del governo, con l’intrigo, la corruzione, talvolta il delitto (esempio, la camorra a Napoli e la mafia in Sicilia). Poi, in seguito a circostanze sulle quali è inutile qui fermarsi, fu costituito un ministero, quello dello Zanardelli-Giolitti, che volle fare alcuni tentativi di libertà. Per la prima volta, dopo molti anni, i poteri pubblici osservarono la neutralità negli scioperi. Essi si limitarono a mantenere l’ordine senza temere di ricorrere alla forza, quando fosse necessario. Nulla fu più comico a vedere, dell’impazzire dei proprietari di terre e degli industriali, lasciati soli alle prese coi lavoratori, che reclamavano un miglioramento delle loro condizioni. Essi non comprendevano nulla. In sostanza, la loro condotta era stata sempre che, quando una difficoltà di questo genere sorgesse, se ne parlava al deputato, che parlava al ministro, questi dava ordini al prefetto, e lo sciopero veniva soffocato». (I sistemi socialisti, tr. it., Torino 1954, pp. 550-551).
Quanta differenza con la situazione di oggi. Gli operai sono così integrati nel sistema capitalista o consumista che ci accade di leggere questo genere di incredibili affermazioni. Ecco come denuncia uno stato di fatto un dirigente del sindacato degli United Automobile Workers: «Molte volte ... ci riunivamo in una sala del sindacato a parlare delle vertenze che i lavoratori avevano sollevato e di quel che pensavamo di fare per portarle avanti. Quando mi era infine riuscito di combinare una riunione con la direzione per il giorno dopo, il problema era già stato risolto e il sindacato non ricavava alcun credito per aver concluso la vertenza in modo favorevole. È diventata una battaglia tra opposte fedeltà... L’azienda offre ora ai lavoratori tutte le cose per cui abbiamo combattuto. Quel che ci occorre è di trovare altre cose che il lavoratore vuole, ma che il padrone non ha voglia di dargli... Stiamo cercando». (Labor Looks. At Labor. A Conversation, Center of Study of Democratic Institutions, Santa Barbara 1963, p. 16. Cfr. H. Marcuse, L’uomo a una dimensione, tr. it., Torino 1967).
Ma per fortuna più sorridente è l’avvenire dell’umanità, perché più mite è la legge che la governa. Questa legge è la solidarietà.
Ci troviamo nel vivo della dottrina malatestiana. In aggiunta a quanto detto nell’Introduzione, è bene precisare alcune cose.
Già prima di Malatesta i sansimoniani, nel volume: Doctrine Sant-Simonienne, Exposition (Parigi 1854, p. 7), scrivevano: «Prima seduta. Questa è consacrata a fare sentire le condizioni dolorose, in cui si trova in questo momento la società europea: tutti i legami di affezione spezzati, doglianze e timori dappertutto, gioie e speranze in nessun luogo... ».
Molto simile il discorso di Charles Fourier: «Tuttavia una inquietudine universale attesta che il genere umano non è affatto ancora arrivato al termine dove la Natura vuole condurlo, e questa inquietudine sembra presagirci qualche grande avvenimento che cambierà le nostre condizioni». (Théorie des quatres mouvements, Parigi 1841, p. 23). In questi casi dall’affermazione iniziale si passa a conclusioni non suscettibili di riprova scientifica.
Non bisogna dimenticare, nel caso di Malatesta, quanto egli ebbe a scrivere: «Alla volontà di credere, che non può essere che la volontà di annullare la propria ragione, oppongo la volontà di sapere, che lascia aperto innanzi a noi il campo sterminato della ricerca e della scoperta. Io, come ho già detto, ammetto solo ciò che può essere provato in modo da soddisfare la mia ragione – e lo ammetto solo provvisoriamente, relativamente – in attesa sempre di nuovi veri, più veri di quelli finora acquisiti». (“Volontà”, 13 settembre 1924). Quindi anche il principio di solidarietà non può considerarsi alla stregua di un “principio assoluto”. Infatti esso avrà validità fin quando sarà possibile mantenere in vita un progressivo adeguamento dei valori di tolleranza, amore, simpatia, ecc., con l’eventuale ricomparsa dei corrispondenti negativi: in altri termini occorre che la solidarietà venga coltivata con cura e tempestività, occorre che vengano evitate le possibilità concrete (valori apparenti) che danno vita al desiderio di prevalere gli uni su gli altri. Se questa manutenzione del semplice meccanismo della solidarietà non viene fatta tutto finirà per ricadere nelle iniziali condizioni di partenza.
Il relativismo malatestiano finirà per prendere definitivamente il sopravvento sul concetto strettamente determinista di derivazione kropotkiniana. (Cfr. a tal proposito, S. Arcangeli, Errico Malatesta e il comunismo anarchico italiano, Milano 1972, pp. 61-67). Così questo autore scrive: «Kropotkin, come rilevò Malatesta, era troppo fidente nelle “armonie naturali”, era profondamente ottimista nella sua convinzione, che egli credeva confermata dalla scienza, che le cose un giorno o l’altro si sarebbero messe a posto da sole per naturale processo evolutivo. Non così Malatesta per il quale l’anarchia è realizzabile solo nella misura in cui gli uomini vogliono realizzarla». (Ib. p. 58).
Il riferimento all’opera colossale di Spencer non è esplicito data l’indole del lavoro e il temperamento di Malatesta, ma a nostro avviso è lo stesso evidente.
Il principio che informa la sociologia di Herbert Spencer è che lo sviluppo sociale deve essere lasciato alla forza spontanea che lo presiede e lo spinge verso il suo naturale compimento. Le presenza dello Stato è un di più e un grave ostacolo a questo sviluppo naturale. Questi concetti oltre che nel lavoro fondamentale, Princìpi di sociologia, si trovano anche in: L’uomo contro lo Stato (1884) e in Statica sociale (1892).
Ovviamente le conclusioni spenceriane sono diverse, sia dal punto di vista operativo (entrata dell’uomo nel regime industriale, per usare le stesse parole del pensatore inglese), sia dal punto di vista dottrinale (stretta aderenza a un’etica biologica, dichiaratamente di tipo positivista).
Guidato dai vantaggi che offre l’associazione e la conseguente divisione del lavoro, l’uomo evolveva verso la solidarietà, ma la sua evoluzione incontrò un ostacolo che l’ha deviata e la devia ancora dalla meta. L’uomo scoprì che poteva, almeno fino a un certo punto e per i bisogni materiali e primitivi che allora solamente sentiva, realizzare i vantaggi della cooperazione sottomettendo a sé gli altri uomini invece di associarseli.
A proposito della manutenzione ideologica di questo concetto è assai interessante lo scritto di Fred I. Kent, presidente del consiglio dell’Università di New York, già consigliere della Riserva Federale degli Stati Uniti. Questo scritto si presenta sotto forma di una lettera di risposta a un nipote (immaginario o reale non sappiamo): «Caro nipote, risponderò alle tue domande nel modo più semplice possibile. Il profitto è il risultato di un’impresa che costruisce per gli altri, oltre che per l’imprenditore. Consideriamo le conseguenze di ciò in una comunità primitiva, una comunità, mettiamo, di 100 persone, che provvedono soltanto alle prime necessità della vita, lavorando durante tutto il giorno. La nostra comunità primitiva che abita ai piedi di una montagna ha bisogno di acqua. L’acqua c’è soltanto da una sorgente presso la cima della montagna, perciò le 100 persone devono salire lassù tutti i giorni, il che richiede un’ora tra andare e venire. Gli abitanti del paese lo fanno ogni giorno, finché uno di loro s’avvede che l’acqua della sorgente scende, all’interno della montagna, nella stessa direzione che egli segue venendo giù dalla vetta. Costui ha l’idea di scavare un fosso sul fianco della montagna fino al punto dove ha la propria abitazione. Si mette al lavoro, mentre gli altri 99 abitanti non hanno neppure la curiosità di sapere che cosa faccia. Poi, un giorno, l’uomo devia una parte dell’acqua della sorgente al suo fosso e l’acqua scende in un bacino che ha preparato in basso. Dopo di ché, propone agli altri 99 abitanti, che perdono un’ora al giorno per attingere l’acqua, che, se ciascuno gli darà il prodotto di 10 minuti del proprio tempo, lui gli darà in cambio l’acqua del suo bacino. Egli riceverà così ogni giorno 990 minuti del tempo degli altri abitanti e ciò lo esimerà dal dovere lavorare 16 ore al giorno per provvedere ai propri bisogni. Il nostro uomo ricava un enorme profitto ma la sua iniziativa fa risparmiare a ogni abitante 50 minuti al giorno del suo tempo». (Cfr. Breviario di Economia per tutti, Supplemento al n. 336 di “Panorama della stampa”, 9 luglio 1965, pp. 14-15).
Accanto a questo interessante raccontino è opportuno ricordare la frase di Leone XIII: “Gli animali, i bruti, si preoccupano solo di procurarsi il sostentamento per il consumo di tutti i giorni, mentre l’uomo risparmia per l’avvenire suo, dei suoi familiari e dei suoi simili. Questo risparmio, che è sacrificio perché rappresenta una rinuncia al consumo, costituisce e giustifica il principio della proprietà privata”.
Siccome l’ipocrisia e la mistificazione possono essere scarsamente palesi in quanto precede, diamo di seguito alcuni chiarimenti per il lettore.
L’uomo che scopre l’acqua sotterranea, che lavora per incanalarla verso la propria abitazione, che impone agli altri uomini un sia pure piccolo lavoro, compie contemporaneamente all’opera meritevole un vero e proprio furto. Infatti nel momento in cui egli si era accorto che “l’acqua della sorgente scende, all’interno della montagna, nella stessa direzione che egli segue venendo giù dalla vetta”, anziché mettersi da solo al lavoro e nascondere la cosa a tutti gli altri che finiscono per guardarlo lavorare e deriderlo perché non ne comprendono lo scopo, avrebbe dovuto avvertire della scoperta la comunità, spiegare i vantaggi, contribuire personalmente con il proprio lavoro alla realizzazione collettiva dell’impresa. Il fatto poi che l’idea, tecnicamente pregevole o difficoltosa, fosse venuta a lui perché in possesso di un intelletto raziocinante superiore alla media, non può ritenersi autorizzazione sufficiente per la pretesa di una retribuzione superiore, o suppletiva, nei confronti del beneficio che ogni singolo componente la società ricava da quell’idea. Infatti l’intellettuale, il pensatore, lo scienziato, hanno un significato concreto, hanno un valore come uomini “eccezionali”, in quanto riconoscano l’inserimento in una società di uomini “uguali”, in modo che la loro eccezionalità contribuisca ad elevare il grado totale di uguaglianza. Nel caso invece che costoro impieghino la loro “eccezionalità” come elemento di prevaricazione sugli altri, questa scade di valore e diventa pericolo e anticamera dell’oppressione.
Quindi nessuna giustificazione all’opera dell’uomo che scopre l’acqua sotterranea, il suo sforzo taciturno è essenzialmente egoista e antisociale, pur pervenendo – accidentalmente – a un immediato beneficio per la comunità.
L’antisocialità di questo sforzo diventa ancora più chiara se si pone mente al fatto che il novello proprietario ha fondato tutto il suo progetto su di una supposizione valida fino a un certo punto. Infatti agli uomini che prima lavoravano un’ora (tra andata e ritorno) per recarsi a prendere l’acqua in cima alla montagna, mentre ora riducono la loro fatica a 10 minuti venendo in possesso dello stesso quantitativo d’acqua, potrà sembrare “giusto” questo stato di cose. Soltanto questo significato di giustizia potrà assicurare il funzionamento del meccanismo. Ma quando un giorno, uomini nuovi che non hanno mai fatto la fatica di un’ora di cammino per avere l’acqua, ma che solo ne hanno sentito parlare la sera davanti al fuoco, prenderanno in considerazione la “giustizia” di un ordinamento che vuole 10 minuti di lavoro obbligatorio a favore di un altro uomo per avere l’acqua necessaria alla vita, forse giungeranno alla conclusione che quell’imposizione è “ingiusta”. In quel momento sorge nell’uomo che ha trovato l’acqua sotterranea (o nei suoi successori) la necessità di creare una élite specifica in grado di difendere la continuità di quel meccanismo. Ai componenti di quella élite, che nel caso specifico hanno cambiato lavoro ma che restano sempre servitori dello stesso padrone, verrà magari data l’acqua gratuitamente. Con una piccola flessione nel profitto l’antico imprenditore giunge sempre allo stesso risultato. Tutto è ancora “pulito”, tutto è ancora “giusto”, solo che ci si è dimenticati di mettere in chiaro un piccolo particolare: è nato lo Stato, con tutto il seguito di repressioni, rapine, condanne, leggi, polizia, ecc.
Se il raccontino di Kent è una chiara mistificazione della realtà, la frase di Leone XIII è chiaramente ipocrita e contraddice allo stesso principio cristiano dell’assoluta negazione della legittimità delle ricchezze. Comunque, per noi, è importante in questa sede chiarire che anche i fautori della proprietà privata non sono d’accordo sulla origine della stessa. Nel pensiero sociale del cattolicesimo c’è quindi questa “giustizia” del risparmio, ma non si pongono in discussione i modi di costituzione e di origine dello stesso.
I governanti, abituati al comando, non vorrebbero ritornare nella folla.
Recentemente Charles Wright Mills ha notato questo fenomeno, nel suo volume: White Collar. The American Middle Classes (1951), tradotto in Italia dalla Einaudi nel 1966. Tra gli accorgimenti che possono spingere la classe privilegiata ad incrementare la sua fiducia nel governo, dice questo autore, sono: un forte aumento della spesa e dell’intervento statali, pianificazione a livello nazionale ed internazionale, un programma esteso di aiuti all’estero, piani di previdenza sociale vieppiù comprensivi, lavori pubblici su vasta scala, e forse anche forme parziali di nazionalizzazione. Come si vede anche un governo che apparentemente dovrebbe creare forze centrifughe, finisce per allettare la classe dei privilegiati che, prima o poi, si accorge che dove il pugno è più duro ivi è più facile mettere al sicuro i propri interessi. È proprio in quel momento che il patto di complicità tra governo e classe dei padroni è saldamente stretto.
Il pericolo prospettato è molto più grave. Non si può negare che oggi assistiamo a un grave conflitto tra le forze produttive da un canto e il loro impiego concreto per scopi di carattere distruttivo. Tenendo presente che questo particolare utilizzo è unicamente fondato sulla possibilità che l’oppressione delle classi più povere venga mantenuta leggermente al di sopra del sopportabile, si comprenderà come il predetto contrasto non ha che un’unica possibilità di sbocco: quella di ripresentarsi continuamente come tale, evitando le soluzioni estreme di rottura del sistema.
La persistenza della distruzione di ricchezza può però assicurarsi solo a patto che venga mantenuto costante il bisogno di comperare beni, cioè il desiderio di lavorare per comperare questi beni.
Ecco come Marcuse affronta decisamente questo problema: «Il sistema tende in tal modo sia verso forme di amministrazione totale, sia verso la totale dipendenza dall’amministrazione di parte dei maggiori enti pubblici e privati, rafforzando l’armonia prestabilita tra l’interesse delle grandi società pubbliche e private e quello dei loro clienti e servitori. Né una nazionalizzazione parziale né una diffusa partecipazione dei lavoratori alla direzione ed agli utili delle imprese basterebbe di per sé per mutare questo sistema di dominazione, fino a che gli stessi lavoratori continuano a fungere da forza di sostegno». (L’uomo a una dimensione, tr. it, Torino 1964, p. 54).
Siccome nulla si crea nel mondo che suol chiamarsi materiale, così nulla si crea in questa forma più complicata del mondo materiale che è il mondo sociale. E perciò i governanti non possono disporre che delle forze che esistono nella società.
Uno studioso non anarchico, Epicarmo Corbino, di estrazione liberale, così si esprime in merito: «La più grande illusione dei nostri tempi è lo Stato. Si crede che lo Stato possa dare senza prendere, cioè si crede che lo Stato faccia miracoli. Tutti l’invocano, tutti gli chiedono di intervenire. Ma lo Stato non ha il potere di creare la ricchezza dal nulla. Lo Stato per dare cento a un settore deve sottrarne cento a un altro e deve sottostare alla spesa occorrente per fare queste due operazioni di prendere e dare, spesa che si valuta al 7,50% per ogni verso e cioè al 15% globale. Sicché per dare cento lo Stato deve procurarsene 115». (Breviario di economia per tutti, Como 1965, p. 37).
Queste parole, di un grande studioso di problemi finanziari, dovrebbero fare riflettere tutti coloro che accusano gli anarchici di scarsa obiettività e di sentimentalismo verso una libertà puramente immaginaria.
Nel 1922 Malatesta scriveva: «Io sono comunista (libertario s’intende), sono per l’accordo e credo che con un discentramento intelligente e uno scambio continuo d’informazioni si potrebbe arrivare ad organizzare i necessari scambi di prodotti e soddisfare i bisogni di tutti senza ricorrere al simbolo moneta, che è certamente gravido d’inconvenienti e di pericoli. Io aspiro, come ogni buon comunista, all’abolizione del denaro... e di tutti i simboli di ricchezza che possono servire a vivere senza lavorare...». (“Il Risveglio”, 20 dicembre 1922). Evidentemente qui il significato di “vivere senza lavorare” non è solo quello che può racchiudersi nella figura del rentier, ma anche quello che solitamente si identifica con il peculato, la concussione, la prevaricazione, il furto pubblico.
Sul finire del secolo Malatesta aveva avuto notizia del famoso processo per il fallimento della Banca Romana. Nell’udienza del 5 maggio 1894, alla Corte di assise di Roma, il Tanlongo, direttore di quella banca, dichiarò esplicitamente che nel periodo dal 1881 al 1888, su disposizioni segrete del governo italiano, portò a compimento operazioni di borsa dirette ad aumentare il corso dei fondi pubblici italiani. Ovviamente tali operazioni causarono forti perdite alla banca, e qui il Tanlongo aggiunge che l’espediente di coprire questo deficit con degli assegni fittizi gli fu suggerito proprio dal ministro Magliani. Pareto (Cours, pp. 907-908) continua: «Quest’ultima asserzione non fu interamente provata, ma le prime sono state confermate, fuori d’ogni dubbio, da numerose testimonianze. Nell’incartamento del processo sono state inserite le lettere del direttore del Tesoro, Cantoni, che raccomandava di manovrare in modo da provocare l’aumento dei fondi pubblici. All’udienza del 30 maggio l’ex ministro Luzzatti ammise l’esistenza d’un sindacato, con a capo la Banca nazionale, costituito per queste operazioni sui fondi pubblici. Il Frascara, direttore del Credito mobiliare, dichiarò nella stessa udienza che, durante la sua gestione, due sindacati erano stati costituiti a tal fine, uno nel 1891, che fu liquidato con un piccolo utile, l’altro nel 1893, che cagionò una perdita di 1 milione e mezzo. Queste operazioni e molte altre della stessa natura hanno contribuito non poco alla rovina delle banche». Al momento in cui scrivo queste note non è ancora andata in scena la pantomima relativa al giudizio contro il direttore del Banco di Sicilia Bazan, imputato di qualche cosa come ben 22 capi d’accusa. Si vedranno i risultati, ma si farà presto a dimenticare tutto. A quattro anni di distanza [1973], correggendo queste note, posso confermare che la mia previsione era esatta. Bazan è stato dimenticato, lo scandalo attutito, di condanne vere e proprie nemmeno l’ombra.
Anzi sono appunto quelle cose in cui il governo non ha ingerenza, che camminano meglio, che danno luogo a minori contestazioni e si accomodano, per la volontà di tutti, in modo che tutti ci trovino utile e piacere.
È interessante studiare le contraddizioni dei difensori del diritto alla proprietà privata, specie in merito alla legittimità dello Stato di intervenire con una sua “programmazione” nell’economia delle singole aziende.
Giustamente Malatesta nota che “quelle cose in cui il governo non ha ingerenza camminano meglio”, si tratta di un’affermazione fatta da un anarchico che, stranamente concorda con le affermazioni fatte dai difensori della proprietà privata. Com’è questo mistero? Vediamo di chiarirlo.
Dalle Molle dice: «... attuare una programmazione significa sostituirsi a tutti i singoli e voler tracciare per ognuno di essi il lavoro di domani. Significa sostituire la volontà di una ristrettissima cerchia di governanti, alla sensibilità, all’esperienza, alla competenza di tutta una popolazione. I programmatori possono determinare il successo o il fallimento, fare aprire una fabbrica o determinarne la chiusura. Così la programmazione diventa la strada naturale dei favoritismi e delle prepotenze». Citato da Pareto (Cours, p. 909). Sembrerebbe sentire parlare un anarchico.
Il motivo è facile: i capitalisti paventano l’ingerenza dello Stato nei loro affari, pretendendo che questi mantenga fede alla sua attività originaria, puramente di carattere poliziesco e di tutela del privilegio. Da canto suo lo Stato è insofferente e pretende estendere il suo dominio in zone dell’attività umana sempre più ampie.
La possibilità dell’intervento statale di risolvere tutti i problemi economici e sociali è una pura illusione. Se ne sono accorti gli economisti a proposito del problema, strettamente tecnico se si vuole ma assai significativo, della programmazione. Così Arthur Shenfield: “... la pianificazione diventa quasi una magia. E ha il potere della magia sulla mente degli uomini e l’incapacità della magia a risolvere i loro problemi”.
Quanti esempi potremmo ricavare dalla storia, un’infinità. Ci limiteremo ai più efficaci.
In Procopio si legge del controllo statale, voluto da Giustiniano, sul commercio. «In tal modo il prefetto del Tesoro procurò forti somme all’imperatore e si appropriò segretamente di altre somme abbastanza consistenti». (Storia segreta, 26).
Nel tentativo di eliminare gli “accaparratori” lo Stato romano iniziò un controllo commerciale che si rivelò in breve assai più funesto del male che si era voluto combattere. In Livio: «Gli edili curiali… fecero pure porre nel Campidoglio dodici scudi dorati con i proventi delle ammende a cui erano stati condannati i negozianti di grano colpevoli di avere cagionato la penuria con i loro tanti accaparramenti». (XXXVIII, 35). Ma tutte le leggi che furono emesse non risolsero il grave problema dell’approvvigionamento di Roma. Le carestie e i tumulti conseguenti a questa politica annonaria sono descritti da Svetonio (Augusto, 25 e 42; Claudio, 18; Nerone, 45), da Tacito (Annali II, 87 e VI, 13), da Ammiano Marcellino (XIX, 10).
Editti calmieri, leggi granarie, sono emessi in grande quantità nel Medioevo. Ne abbiamo di Carlo Magno (nel 794 fissa il prezzo del grano, dell’avena e dell’orzo), di Filippo il Bello (del 1305), di Carlo VII (del 1439), di Francesco I (del 1539), ecc.
Wilhelm Roscher cita un caso tipico di questa insufficienza statale: «Gli è così che un tempo i coltivatori del paese di Hildesheim preferivano andare al mercato della città di Hannover anzi ché a quello della città di Hildesheim, perché nella prima città, in cui il commercio del grano era fatto dai fornai, potevano vendere rapidamente le loro derrate. Questa circostanza mantenne i prezzi di Hannover relativamente più bassi. Ancora nel 1847 sul mercato di Dresda si esibiva quel che viene detto un “Markwisch” con l’indicazione ch’era proibito a chiunque fare qualsiasi acquisto, gli acquisti essendo consentiti ai soli borghesi di Dresda acquirenti per il loro proprio consumo. Solo dopo che s’era tolto questo “Markwisch” uno straniero poteva acquistare. Che ne risultava? Pur situata in una zona fertile, sui bordi dell’Elba e nel punto centrale di un’importante rete ferroviaria, Dresda, che da sola contiene un bel numero di consumatori e deve fornire grano a una parte dell’Erzgebirge, non aveva che un mercato insignificante. Pure essendo in grado d’essere un mercato di prim’ordine, essa dovette, dice il Reuning, andare a rifornirsi al mercato d’una piccola città situata a cinque leghe di distanza». (Geschichte der National-Oekonomik in Deutschland, Berlino 1874, p. 44).
La vita quotidiana si svolge al di fuori della portata del codice ed è regolata, quasi inconsciamente, per tacito e volontario assenso di tutti.
Notevole la conclusione di Malatesta, anche perché contribuisce a determinare le condizioni che rendono possibile l’attuazione concreta di una struttura fondamentalmente libertaria.
Non è esatta, invece, l’affermazione che la “vita quotidiana si svolge al di fuori della portata del codice”. Infatti la maggioranza dei rapporti umani è fondata sulla possibilità che non si debba ricorrere tutte le volte al codice, il che finirebbe per rendere impossibile una forma qualsiasi di convivenza organizzata. Ciò non significa, però, che il codice (intendendo con questa parola le norme generali del diritto) non abbia previsto un gran numero di “fatti giuridici” che siano suscettibili di una regolamentazione (codificazione) in forza di legge.
In effetti il numero degli atti umani svincolati da un qualsiasi intervento della legge è assai piccolo (esempio: l’etichetta, l’onore, la morale, la religione tracciano una serie di atti che restano fuori del codice), il quale regolamenta tutti gli altri (la maggioranza di tutti i restanti atti che un uomo ragionevole può compiere). In pratica, e qui cade giusta l’affermazione malatestiana, tutto procede per libero accordo, l’intervento della legge è l’eccezione.
L’essenziale è questo, che si costituisca una società in cui non sia possibile lo sfruttamento e la dominazione dell’uomo sull’uomo.
Ciò è fondamentale per comprendere il pensiero anarchico in particolare e in generale qualsiasi pensiero rivoluzionario. Il programmare una nuova società, attraverso la porta stretta della distruzione di una società presente, non può avvenire sulle basi di un costruito che si vuole a tutti i costi fare permanere almeno nella struttura se non nella forma esteriore.
Questo problema è stato più volte da me affrontato nel libro La distruzione necessaria. «È indiscussa la necessità di scardinare l’attuale complesso di cose, questo sistema che minaccia il nostro futuro e che prepara con diuturna dedizione la nostra rovina. La rottura causerà, con ogni probabilità, un primo momento di grande disordine e caos, durante il quale la violenza si scatenerà nella forma bruta e difficilmente controllabile. A questo punto agirà la fase di organizzazione programmata prima che ricostruirà la società sulla nuova misura dell’uomo e dei valori delle cose. Abbiamo quindi una riduzione a forme di convivenza che viste attraverso la lente deformante dell’attuale impostazione societaria possono sembrare assurde o retrograde ma che si avvicinano maggiormente all’intendimento umanistico del valore umano». (Prima edizione, Catania 1968, pp. 43-44).
L’anarchia è il modo di convivenza sociale che solo lascia aperta la via al raggiungimento del maggior bene.
Su questa parola ci sarebbe molto da discutere. È evidente il significato complesso che Malatesta vuole darle.
Una prima parte di questo significato deve potersi assegnare al moderno significato di “benessere”. Così Kenneth J. Arrow: «Se adottiamo l’identificazione tradizionale della razionalità con qualche forma di massimizzazione, il problema di pervenire a un massimo sociale desunto dai desideri individuali è allora precisamente il problema che è stato al centro delle indagini sull’economia del benessere». (Una difficoltà nel concetto di benessere sociale, nel volume AA.VV., Saggi sulla moderna economia del benessere, Torino 1956, p. 191). Infatti è appunto una ricerca di massimizzazione delle possibilità quella proposta da Malatesta.
Oltre, ed è questo il punto che lo rende a nostro avviso più interessante ed attuale, esiste una seconda parte di significato, quella più immediatamente umana. Malatesta propone la ricerca non solo di una massimizzazione di benessere sociale ma anche di benessere umano.
Per questa via credo risulti molto più fecondo lo studio del pensiero malatestiano.
Abolire l’autorità, abolire il governo non significa distruggere le forze individuali e collettive che agiscono nell’umanità, né le influenze che gli uomini esercitano a vicenda gli uni su gli altri: questo sarebbe ridurre l’umanità allo stato di ammasso di atomi staccati ed inerti, cosa che è impossibile, e che, se mai fosse possibile, sarebbe la distruzione di ogni società, la morte dell’umanità.
Tacere le possibili implicazioni storico-metafisiche di questa affermazione sarebbe contrario al fine chiarificatore che ci siamo proposti. Malatesta sembrerebbe rifiutare l’azione di un filo conduttore nelle alterne vicende dell’umanità. Il che lo pone consequenzialmente al seguito della dottrina marginale dell’epoca in materia di storia universale.
Allo sviluppo coordinato e preciso, in vista di un fine superiore, Malatesta contrappone l’azione individuale e collettiva di una serie non definita di forze agenti sull’uomo, insieme all’influenza di ogni singolo uomo nell’andamento collettivo della socialità. È un poco la tesi meccanicista del processo sociale, non vista questa volta attraverso la veste scientifica – tanto per fare un nome di un Pareto – ma lo stesso presupponente possibilità di misurazione e di circoscrizione che l’evolversi della scienza stessa doveva definitivamente mettere a tacere.
Forse una definitiva chiarificazione del “mistero” dell’anarchismo, specie oggi davanti alle plurime sollecitazioni di un interesse per tanto tempo quasi sopito, potrebbe venire proprio attraverso questa posizione decisamente “concreta” di Malatesta.
Queste forze esistono ed è impossibile nasconderle. Queste forze si estrinsecano sulla società ed è puerile combatterle senza averle conosciute nei particolari e catalogate. Queste forze finiscono per limitare fortemente l’assoluta libertà ed è inutile continuare a discutere di metafisica.
Il caso estremo, negativo, di una possibile eliminazione di queste forze, adesso paradossalmente umoristico, significherebbe la morte della società. Ma l’estremismo di questa impossibilità concreta non è ben chiaro in coloro che amano fare di tutte le erbe un fascio – critici e apologeti dell’anarchismo – i quali hanno davanti agli occhi la classica meta della “presa nel mucchio”.
Qui viene ripresa parte della problematica di uno scrittore per tanti aspetti forse lontano da Malatesta, Giuseppe Ferrari. Specialmente nello scritto del 1851, La Filosofia della Rivoluzione, Ferrari aveva parlato di questa possibilità di superare le varie fasi rivoluzionarie, come una serie di parentesi collegate, in vista del tragitto finale che la storia compie verso l’associazione universale dell’umanità (il riferimento a Saint-Simon è dichiarato).
Così il filosofo milanese: «Una è la storia ideale eterna nella quale corrono nel tempo le storie particolari di tutte le nazioni, questa storia conduce all’umanità da tutti i punti della terra, la diversità dei culti esce dalle sue epoche, non dal clima, non per isolare, ma per associare tutti i viventi» (op. cit., p. 362).
In questo modo si verrebbe ad infrangere il diritto “finora dichiarato positivo” dei “vincitori del momento”. Sullo sfondo viene delineato un più sostanziale diritto: la stabilizzazione del regno della scienza e dell’eguaglianza.
Certamente, nello stato attuate dell’umanità, quando la grande maggioranza degli uomini, oppressa dalla miseria ed istupidita dalla superstizione, giace nell’abiezione, le sorti umane dipendono dall’azione di un numero relativamente scarso di individui.
Bisognerebbe meditare molto su questa affermazione, apparentemente semplice. Infatti sono molto frequenti le tesi di coloro che imputano alla scomparsa della tutela sulle classi inferiori, esercitata in passato in forma molto pesante da parte delle classi superiori, molti dei mali che affliggono la società contemporanea. Nel volume Les bourses du travail, Paris 1893, pp. 55-56, Gustave De Molinari scriveva: «Se gli operai fossero stati previdenti ed economi, se avessero limitato la loro riproduzione sull’esempio delle classi superiori, non mettendo al mondo che il numero di figli che avevano i mezzi di nutrire ed allevare col proprio guadagno, il prezzo del lavoro avrebbe potuto mantenersi a un livello meno distruttivo delle loro forze e della loro salute. Ma gli operai generalmente non erano al tempo della loro liberazione né previdenti né economi, e le condizioni fisiche e morali loro create dall’eccesso di lavoro e dall’insufficienza del salario non erano affatto propizie a sviluppare presso di loro la capacità di autogoverno. Il pauperismo appariva conseguenza inevitabile dell’emancipazione forse troppo precoce della classe operaia...».
Finché si troveranno studiosi che prostituiranno il loro pensiero in questo modo, finché la vera realtà delle cose verrà travisata in maniera tanto palese, la vita del pensiero rivoluzionario sarà difficile e contrastata. Un ragionamento come quello di De Molinari equivale a quello di chi resta tappato in casa per paura che uscendo possa buscarsi un malanno.
Oggi le condizioni obiettive del fenomeno sono decisamente cambiate. La possibilità modificativa del singolo nei riguardi del complesso sociale è assai limitata. Anche il grande cervello, il pensatore sommo, lo scienziato innovatore, sono costretti a lavorare in uno schema assai complesso di collaborazione. Al lavoro del singolo – immerso nel proprio laboratorio o nella propria biblioteca – si va sempre più sostituendo la figura della équipe.
Oggi non è più possibile supporre scadente la possibilità tecnica della società contemporanea di sollevarsi contro l’oppressione e costruirsi un nuovo mondo fondato sulla libertà. Quello che prima era un vero e proprio salto nel buio, quello che ai tempi di Malatesta era un sogno da utopisti, oggi è realtà possibile e raggiungibile con relativa facilità.
La tecnica presenta tali premesse che l’uomo si vede costretto a imbavagliarla, legarla, smussarla nelle intenzioni migliori e più avveniristiche. Le grandi forze che la scienza dell’atomo ha messo a disposizione dell’uomo sono state solo leggermente sfiorate – e per scopi distruttivi – invece di essere decisamente affrontate e volte al beneficio di tutti.
Il discorso di Malatesta oggi non è più necessario farlo in forma pacata e dubitativa, oggi occorre parlare con maggiore decisione e con una più consapevole conoscenza della immensa forza accumulata dall’uomo. Oggi tutti devono sapere che sono i vari Stati a indebolire questa forza o a svilupparla in funzione delle loro ristrette mire egemoniche, mentre tutto il flusso di ricerca e di studio potrebbe essere riversato a intero profitto dell’umanità.
Oggi un discorso al sistema, un discorso di distruzione e di sovversione rivoluzionaria non è soltanto un modulo di coscienza, come lo era, forse per pochi eletti, al tempo di Malatesta. Oggi un discorso del genere è un vero e proprio modulo di logica per tutti i pensatori che non vogliono correre il rischio di essere tacciati dai posteri, più vicini di noi alla definitiva chiarificazione del problema sociale, come inetti e traditori.
Per risolvere il problema sociale a favore di tutti non vi è che un mezzo, scacciare rivoluzionariamente i detentori della ricchezza sociale, mettere tutto a disposizione di tutti, e lasciare che tutte le forze, tutte le capacità, tutte le buone volontà esistenti fra gli uomini agiscano per provvedere ai bisogni di tutti.
Ancora una volta una chiara affermazione negatoria delle tecniche entriste. La parola risolutiva deve essere lasciata alla “rivoluzione”. Ogni passo avanti nella lotta contro il sistema deve essere fatto solo in vista della rivoluzione finale, non deve avere un fine immediato e risolutivo, ma solo disporsi come strumento per rendere possibile un determinato stato di cose.
Ogni revisionismo può senz’altro considerarsi un vero e proprio tradimento della classe rivoluzionaria. L’élite di governo comprende con grande chiarezza questa verità e quindi acconsente sempre – senza paura – alle istanze revisioniste, mostrando magari il ghigno disgustato ma gioendo in cuor proprio. Infatti finché il revisionismo pone in atto il suo laborioso meccanismo di patti e accordi, di dialoghi e belle parole, l’élite di governo può continuare indisturbata il proprio lauto pranzo, tanto quello che è in discussione sono soltanto le briciole, il piatto forte è ancora una volta, come sempre, assicurato.
Noi combattiamo per l’anarchia e per il socialismo, perché crediamo che l’anarchia ed il socialismo si debbano attuare subito, vale a dire che si deve nell’atto stesso della rivoluzione scacciare il governo, abolire la proprietà ed affidare i servizi pubblici, che in quel caso abbracceranno tutta la vita sociale, all’opera spontanea, libera, non ufficiale, non autorizzata di tutti gli interessati e di tutti i volenterosi.
La tesi rivoluzionaria di Malatesta si pone in contrasto con l’altra grande tesi rivoluzionaria dell’epoca, quella leninista. Nel pensiero dell’agitatore e pensatore russo c’è una ineluttabile storicità nell’azione della massa operaia che, spontaneamente, non può produrre nessuna germinazione capace di tracciare una via verso il socialismo e la libertà. Lenin dice: «Solo un partito guidato da una teoria di avanguardia può adempiere alla funzione di combattente di avanguardia». (Cfr. Opere scelte, vol. l, tr. it., Mosca 1947, p. 157). Malatesta, invece, incentrando la sua posizione sulla tradizione libertaria più assoluta, vede la possibilità concreta, per la classe operaia di giungere alla stessa abolizione del governo, della proprietà e di ogni forma di sistema politico.
La differenza non è oziosa. Fratelli e compagni di lotta, socialismo e anarchismo, finiscono per rivelare – a seguito delle lotte intestine – le differenti posizioni dottrinali. Il primo, per continuare a citare lo stesso Lenin, «è sorto da quelle teorie filosofiche, storiche, economiche che furono elaborate dai rappresentanti colti delle classi possidenti, gli intellettuali. Dal punto di vista della posizione sociale, Marx ed Engels, erano degli intellettuali borghesi». (op. cit., p. 161). Il secondo sorge nel chiuso ordine aristocratico di pochi gruppi intellettuali o di singole figure di pensatori e scienziati, ma si pone immediatamente come movimento di “singoli”, di persone che credono nella validità del concetto libertario di personalità, indipendentemente dall’insegnamento di questo o quel “gruppo”, di questo o quel personaggio.
[Note a E. Malatesta L’Anarchia. Inserite nella seconda edizione, Ragusa 1973]
Nota redatta nel maggio 1972
Ho lasciato il lavoro. I contrasti con i proprietari dell’industria dove svolgevo il mio compito di dirigente amministrativo erano diventati all’ordine del giorno. Mi si accusava di essere “estremista” e “dalla parte degli operai”, “rivoluzionario”, qualifiche non proprio adatte a un dirigente. Non potevo continuare ed ho mollato. Adesso mi devo programmare un altro tipo di vita, più aderente alla realtà dei problemi che mi stanno a cuore, problemi sociali e politici, teorici e pratici insieme.
Guardando allo stato attuale delle mie ricerche non si può non notare una profonda modificazione. Il vecchio concetto di “efficienza” non esiste più, almeno nei termini appesantiti nei quali appariva ne La distruzione necessaria, e questo è molto chiaro nel libro Potere e contropotere, che è della prima metà del 1971. Si tratta di un’analisi sul governo che non lascia dubbi sulla direzione del mio pensiero in senso anarchico.
Resta il problema dell’etichetta e dell’accettazione ufficiale di questa direzione, in questo senso avvertivo una vera e propria ritrosia, anche al momento di far sortire il libro, per altro edito da una editrice anarchica. Ritrosia che oggi, di fronte a impegni reali sempre più urgenti, avverto sempre meno, convincendomi della necessità “pratica” dell’indicazione e del segno.
Ma anarchismo non significa ortodossia. Su questo sono e sarò irremovibile. Ortodossia è morte della libertà, della riflessione indipendente, della riflessione e della forza che ci spinge a modificare noi stesti e a cercare la nostra strada. Ortodossia è negazione di eresia, ed eresia è sinonimo di verità, un parallelo che avevo di già individuato nel 1961 (“Il problema della verità”). In questo senso se devo rifiutare tutte le bandiere non sono disposto ad accettare quella anarchica. Solo a condizione che anarchia significhi veramente al di là degli schemi, delle strettoie, anche di tipo “funzionale”, sono d’accordo con essa.
È in questa prospettiva, oggi più reale e nel 1971 meno, che si deve leggere Potere e contropotere, come pure il saggio su Malatesta e le note a L’anarchia. Prospettiva che è andata maturando nel corso delle esperienze e degli scritti che si possono collocare tra La distruzione necessaria e l’Introduzione a L’Etica di Kropotkin.
PARTE QUARTA (1970-1974)
Sugli intellettuali
Prodotto di una classe di privilegiati, o uscito con grandi sforzi dalla classe proletaria, l’intellettuale si sente, a sua volta, un privilegiato ed è portato istintivamente verso la conservazione di uno stato di cose che garantisca il suo privilegio elevato ad istituzione.
Quando non partecipa apertamente per la reazione e l’imperialismo, sente crescere in sé un senso di colpa che lo porta verso una critica della società che lo ospita, una critica che si ispira a concetti democratici e che propone un giusto piano di riforme progressive.
È giusto quindi il sospetto, frequente nelle classi degli sfruttati, verso l’intellettuale e, in contropartita, il desiderio di quest’ultimo di capire la sua posizione e di “fare qualcosa” che non sia lesiva della propria posizione di privilegio.
Vista da una certa angolazione, in particolare da quella della lotta militante, la figura dell’intellettuale democratico è estremamente pericolosa.
[1969]
La cultura ai porci
In definitiva lo scopo primo dello scrittore dovrebbe essere quello di comunicare, quindi comunicare bene, ma ciò da solo non basta, è necessario che oltre a comunicare – che poi i marinai con le loro bandierine non fanno nulla di meno importante – si sappia che cosa comunicare e si abbia, quando lo si sappia, il coraggio di comunicarlo. Ed è qui che il mio asino cade. Crediamo veramente di comunicare? Non è invece tutta una messa in scena per iniziati, la quale ha finito per coinvolgerci a tal punto da farci credere veramente che stiamo comunicando qualcosa? E poi, che cosa?
Accade di leggere che il tizio, di certo imbecille ripetitore della dittatura ideologica dei porci, abbandoni il cipiglio del censore per indossare un abito trasandato. E allora si rischia di non capircene più nulla. Se davanti si profila un bel muro, massiccio e invalicabile, uno ha almeno la soddisfazione di sbatterci contro la testa, ma trattandosi di una cortina di nebbia nemmeno questa magra soddisfazione diventa possibile. Poi nemmeno a parlare dei contenuti, il gioco monotonamente si ripete privo di senso.
Questa nostra malattia – che lo scrivere oggi può anche considerarsi malato visto che la cultura è stata mistificata forse in modo irreparabile dai porci – minaccia di mascherare la nostra impotenza. Idiotamente ci ripetiamo parole ormai prive di senso illudendoci di sapere quello che vogliamo dire e fondando questa illusione sulla certezza – solida, da cospiratori – che anche gli altri, quelli che ci leggono, a loro volta, si vogliano illudere di sapere che cosa intendiamo comunicare. La tirannide del foglio stampato finisce per sconvolgere le nostre menti e codificare le nostre reazioni: ecco in che modo gli “scrittori”, coloro che da sempre hanno dato tante gatte da pelare ai porci, restano invischiati nel sistema che questi trucidi animali hanno tessuto.
Lo scrittore deve potersi illuminare ancora di uno scopo, se non vuole davvero rappresentare l’oscura parte di una lampadina fulminata, non deve avere regole, strutture, codificazioni, stili, forme. Se lo stile è l’uomo, come ebbe a dire quel naturalista di buona memoria, deve dimenticarsi di essere uomo, deve diventare mille, centomila uomini in una volta, non deve avere tradizioni perché non deve volere traguardi, se guarda qualcosa deve poterla dare alle fiamme, magari per potere poi gridare con tutti gli altri, insieme, “al fuoco!”. Solo in questo modo, libero da tutto ciò che la cultura gli ha creato attorno, può in qualsiasi momento posare la penna e scendere nella strada, superare il pensiero – assai sterile cosa se non alimentato dall’azione – e passare alla guerriglia, al combattimento. L’alternativa non è difficile: dalla morte alla vita.
Se lo scrittore non può togliersi in un attimo i vestiti di dosso, se non può uscire dallo stampo che minaccia di automizzarci tutti, non deve definirsi tale, allo stesso modo che un ripetitore tv non può definirsi una stazione trasmittente di programmi.
Al di là del numero delle pagine, degli ordini dell’editore, del prezzo del volume, al di là di tutto, del contenuto e delle stesse speranze dell’autore, al di là della carriera e del perbenismo, se c’è la comunicazione e se c’è il contenuto, c’è l’azione rivoluzionaria dello scrittore ed allora questa è tutt’uno con l’azione rivoluzionaria nelle strade e nelle piazze, nelle barricate e nei conflitti a fuoco.
[“La cultura ai porci”, pubblicato su “Tempo Sud”, vol. II, 1970]
No, alle armi nucleari
Non è possibile collocare nel tempo l’origine della guerra e, conseguentemente, quella degli eserciti. Ambedue sono tanto vecchie da perdersi nella notte dei tempi. Quello che possiamo fare è, invece, individuare gli sforzi, condotti dagli uomini, per giustificare eticamente l’esistenza di questi due fenomeni.
È connaturato nell’uomo darsi da fare per costruire delle interpretazioni etiche di tutte le sue attività. E quasi sempre avvenuto che queste costruzioni si fondassero sulla validità di un mondo di valori già pronto e sperimentato. È comune, infatti, la giustificazione della guerra nel senso di difesa per il proprio popolo e di protezione per la propria famiglia. Anche gli eserciti hanno avuto in passato una specie di codice etico, identificato qualche volta con il codice dell’antica cavalleria. Ovviamente si tratta di costruzioni assurde in quanto ricavate nell’àmbito del “costruito” e presupponenti all’inverso la “distruzione”.
Abbiamo chiarito in altra sede questo contrasto, ci serve adesso avvertire il lettore su di un unico punto. La validità di una proposta distruttiva si deve ricercare nel mondo di valori che questa proposta avanza, valori di ordine distruttivo e non costruttivo. Infatti in quest’ultimo caso si cadrebbe nell’antinomia del costruito o del costruibile. In ambedue i casi si finirebbe per interpretare la distruzione nel senso di “sconvolgimento di un ordine prestabilito”, o nel senso di “anticamera necessaria di un ordine da stabilirsi”.
Ma le guerre e gli eserciti che le combattono non si pongono questi problemi. Caso mai si tratta di problemi che deve porsi una rivoluzione libertaria diretta a distruggere un sistema di prevaricazione e di soprusi. Difatti, in passato, simili problemi non sono mai sorti. Dal codice etico delle guerre e degli eserciti, che limitava il conflitto solo agli uomini armati e alle cose immediatamente afferenti alla battaglia, si è passati nelle ultime due guerre all’attacco contro i civili. Bombardamenti a tappeto sono stati diretti contro città come Rotterdam, Conventry, Varsavia, contro decine di città italiane, tedesche, ecc. Tutto ciò è culminato con l’eccidio di Hiroshima e di Nagasaki. Ecco in proposito le parole di un grande fisico nucleare, premio Nobel 1954, Max Born: «Le bombe usate allora sfruttavano la fissione nucleare dell’uranio o del plutonio. Da allora si sono inventate le bombe all’idrogeno, che utilizzano la fusione dei nuclei di idrogeno. Le bombe gettate sul Giappone sono un gioco da bambini in confronto ai cosiddetti esplosivi termonucleari. Già le prime che sono state sperimentate corrispondono a mille bombe atomiche, e non c’è praticamente alcun limite alle loro dimensioni e alla loro potenza. Poi viene ancora la tecnica dei missili, che annulla il rischio degli aviatori. Ma la cosa fondamentale è che la difesa del proprio paese, la protezione della propria famiglia è diventata una frase senza senso. In una grande guerra atomica le truppe al servizio delle macchine della morte (che non si possono più chiamare soldati) hanno una migliore probabilità di sopravvivenza dei cittadini dei paesi belligeranti (o anche neutrali)». (Il potere della fisica, tr. it., Torino 1962, pp. 135-136).
Queste poche considerazioni preludiano, a nostro avviso, in modo efficiente il lavoro di Viola, No, alle armi nucleari!, appassionatamente diretto a cogliere l’essenza umana e il momento storico di questi problemi.
L’indagine di Viola condotta con grande larghezza di materiale ha il merito di avere saputo condensare una documentazione che a dir poco risulta immensa. Accanto a questo ostacolo iniziale al compito di Viola si poneva l’altro, non indifferente, della generale superficialità di questa pubblicistica, diretta il più delle volte a sollevare l’indignazione del singolo verso una strutturazione atomica di future guerre, piuttosto che a indirizzare l’indignazione verso la guerra in generale, di qualsiasi sorta essa sia.
Alla descrizione della nocività degli effetti di una guerra atomica e alle assurde politiche di coloro che oggi gestiscono le forze atomiche mondiali è dedicato il capitolo V, tra i più interessanti di tutto il volume.
È naturale che questo nuovo ordine delle cose, questa grande paura che prende tutto il mondo di fronte all’eventualità di una guerra nucleare, cambi il corso dell’interpretazione della realtà politica di ogni nazione. Possiamo dire, con l’autore, che tutti gli Stati vivono in funzione di questa tremenda realtà e con loro tutti gli uomini. Il detto: “se vuoi la pace preparati alla guerra” deve potersi sostituire con una dottrina di preparazione alla pace, anche attraverso il sacrificio di una rivoluzione.
[“No, alle armi nucleari”, pubblicato su “Il Gazzettino del Jonio”, 7 marzo 1970]
Chiarezza
Molte prospettive di lotta coinvolgono oggi il rivoluzionario in una situazione che spesso, all’apparenza, può sembrare confusa e incerta. Su questo gioca la critica reazionaria accusandoci di sprovvedutezza ideologica e di mestierante adesione alla moda corrente. Il tutto corredato dalla sempre vastissima ignoranza di questi soloni della critica sia dei motivi di fondo che determinano l’attuale situazione rivoluzionaria, sia della ineluttabilità della stessa realtà economica.
Comunque, se il discorso ai borghesi reazionari è impossibile, viste le carenze di disponibilità e le chiusure dei pregiudizi, quello ai rivoluzionari dovrebbe essere aperto, ed è per questo che conserviamo un residuo di fede nella possibilità e nell’utilità del linguaggio come mezzo di comunicazione.
La molteplicità delle prospettive non può fare sottovalutare la sostanziale unicità del fondamento materiale della situazione del rivoluzionario, la presa di coscienza, contrapposta alla situazione della base economica e sociale oggettivamente intesa che determina il comportamento delle masse popolari. Questa e quella agiscono congiuntamente reagendo sia alle posizioni di resistenza del conservatorismo reazionario, sia sulle stesse prospettive rivoluzionarie.
Se oggi combattiamo la nostra lotta nella scuola è perché questa situazione si inserisce nella prospettiva rivoluzionaria generale modificandola, mentre nello stesso tempo è un portato della situazione economica di base. Con la nostra azione non vogliamo fare soltanto opera di persuasione o pedagogica, ma reale e concreta attività rivoluzionaria.
Lo stesso possiamo dire per ogni altra forma che via via la nostra lotta viene prendendo, contro l’intellettualismo, contro la cultura ufficiale, contro la repressione della polizia, contro il militarismo, contro i pregiudizi sessuali, contro il fascismo, contro la religione, ecc. Scambiare il discorso specifico su un punto particolare dello schieramento del nostro nemico per discorso a sé stante, privo di raccordi col fondamento rivoluzionario di base, significa fare scadere l’unicità dell’azione nella particolarità della bega personale o della questione culturale specifica, senza fini diversi da quelli della chiarificazione.
Solo questa possibilità di riallacciarsi a un discorso di fondo ci rende in grado di superare l’ostacolo del riformismo e del frammentarismo. Se guardiamo alla scuola noi non la vogliamo riformare ma distruggere, se guardiamo all’esercito la stessa cosa, al parlamento lo stesso e così via. E nella distruzione identifichiamo il capovolgimento violento dei valori, la sostituzione senza mezzi termini di un mondo di sfruttatori e sfruttati con un mondo di eguali nella libertà. Anche nel caso concreto questa prospettiva non deve abbandonarci, servendoci da guida giornalmente, ininterrottamente.
Eccoci quindi di fronte a una necessità che dobbiamo perseguire giorno per giorno: la chiarezza. Chiari con i nostri nemici, chiari con i nostri compagni. Ai primi la nostra azione non deve potere sembrare debole o indecisa, colpendo con fermezza le loro debolezze e le loro istituzioni, ai secondi dobbiamo raccomandare la dirittura personale, al di là di semplici giochetti di parole che camuffano malamente vecchi concetti burocratici e autoritari, al di là dei vari fatti associativi o dei vari programmi. E se ai primi faremo una lotta senza quartiere non indietreggiando dinanzi ad alcun mezzo, ai secondi saremo sempre vicini, con la parola e con l’azione, anche nei casi in cui le crisi di fronte alla violenza necessaria, i dubbi di fronte alle cose che bisogna fare ma che non si ha il coraggio di fare, trasformano questi compagni in revisionisti in germe.
La chiarezza è indispensabile in chi ha scelto una strada che si diparte dalla concretezza, una strada che rifiuta il fumoso abisso in cui si adagiano tanti ideologi della cosiddetta sinistra autoritaria, una strada che accetta solo l’azione e il pensiero mediato dall’azione. Se l’equivoco e l’oscurità possono fare comodo ai controrivoluzionari o agli pseudo-rivoluzionari, ai veri rivoluzionari fanno solo da ostacolo.
Dobbiamo attaccare e distruggere questo sistema che ci opprime, dobbiamo farlo con mezzi violenti, la rivoluzione è violenza, ogni tentennamento, ogni concessione al trasformismo riformista è sostanzialmente un atteggiamento controrivoluzionario, è fascismo. Continuare a discutere quando è tempo di prendere le armi è fascismo. Avere paura dell’estremismo rivoluzionario perché può essere accomunato con l’estremismo reazionario è pusillanimità e idiozia. Il pericolo dei due opposti estremismi è falsa dottrina del comunismo autoritario, la rivoluzione non si fa con le paure e i tentennamenti, come non si fa con il riformismo o il parlamentarismo.
[1970]
Francisco Sabaté
Di un uomo come questo, della dimensione di quelli che passano ai ricordi delle generazioni successive non attraverso le riflessioni muffite dello storico, ma quasi sempre tramite la fantasia della ballata e del cantastorie, ben poco potrebbe fare intendere una biografia alla “solita maniera”.
E questo libro non è per niente un libro “alla solita maniera”. Scarno, affaticato, ricco di notizie e di dettagli minutissimi, tutti controllati con pazienza di ricerca che copre più di un decennio, finisce per costruire – senza alcun intervento retorico, che poi sarebbe stato quasi spontaneo se non legittimo – la figura di Sabaté, il guerrigliero spagnolo che intese continuare, praticamente da solo, la lotta in terra di Spagna, mentre altri, al di là dei Pirenei, milioni di fuoriusciti riflettevano sul da farsi con accanimento bizantino.
E il lettore dovrà adeguarsi all’impegno cui è chiamato, quasi nulla è concesso al folclore, comunque niente che possa anche solo offuscare la verità storica del personaggio.
Tema determinante del libro, nato dall’amicizia – dall’amicizia vera – dell’autore con il suo protagonista, accanto all’impegno narrativo e biografico, è quello più sottile e costantemente polemico in senso costruttivo, di individuare i motivi del contrasto che si venne a determinare – durante tutta la vita di Sabaté – tra la sua azione politica concreta in Spagna e l’azione che, in linea teorica, il Movimento Libertario Spagnolo (M.L.E.) in esilio intendeva condurre.
È ovvio che concetti come quello tipicamente spagnolo, e precisamente della Confederación Nacional del Trabajo (C.N.T.) in esilio, della responsabilità del militante nei confronti dell’organizzazione, per cui veniva ad essere immediatamente posto al bando chiunque non aderisse in pieno con l’indirizzo voluto dal “centro”, o comunque non si limitasse ad esporre le sue critiche in seno ai congressi, non potevano essere accettati da uomini come Sabaté.
Per questi l’organizzazione aveva sempre un’importanza preponderante, e ogni accusa in senso contrario diretta contro Sabaté è senz’altro da considerare tendenziosa, ma non potevano condividere che l’organizzazione diventasse sinonimo di burocratizzazione, di sclerotizzazione e di vigliaccheria. Affermare che questi processi non vennero mai in atto nel movimento ufficiale spagnolo in esilio non è possibile in quanto si hanno prove sufficienti per determinare responsabilità collettive, erronee valutazioni di singoli militanti, e deviazioni coscienti, quando non sia possibile parlare di veri e propri tradimenti.
Al di là dell’organizzazione, quindi, Sabaté vedeva l’efficienza della struttura stessa, in mancanza della quale, nel momento in cui quest’ultima perde la sua funzione, che è sempre quella rivoluzionaria, e si riduce a rimasticare i soliti problemi teorici, diventa senz’altro superata e quindi deve essere posta da canto.
L’alternativa resta allora o quella della scissione – e può a volte essere una dolorosa alternativa sebbene in linea di principio non dia sufficienti garanzie di non trasformarsi a breve scadenza in una ulteriore burocratizzazione – oppure l’azione dei singoli gruppi d’azione, in diretto contatto con le masse potenzialmente rivoluzionarie.
Se questo contatto attivo può determinare l’entrata in funzione del processo rivoluzionario è faccenda che andrebbe approfondita, ma che ovviamente non può avere una esatta considerazione in questa sede, il problema volontarista resterà sempre il punto centrale di ogni discorso rivoluzionario, però possiamo dire che quando si verifica una situazione di generale addormentamento, l’azione di pochi uomini come Sabaté o di pochi gruppi che al sonno – simile alla morte – preferiscono la morte vera, ma in combattimento, è da considerare come l’unica soluzione accettabile.
Per questo abbiamo visto in Sabaté non solo un esempio limpidissimo di dedizione alla causa, un esempio di vita morale in perfetta aderenza all’idea, ma anche un esempio di condotta concreta della lotta contro la tirannia e i padroni.
[1969] [Introduzione a A. Téllez, La guerriglia urbana in Spagna. Francisco Sabaté., tr. it. di A. M. Bonanno e Carmela Di Marca, Ragusa 1971]
Rivoluzione, violenza, antiautoritarismo
La lotta rivoluzionaria
Studiare i metodi di lotta rivoluzionaria senza avere prima chiaro il concetto di che cosa si debba intendere per rivoluzione può essere estremamente pericoloso. Si possono avere risultati sconcertanti.
Purtroppo si è caduti spesso in errori di questo tipo. In particolare i leninisti hanno ripetuto a vuoto concetti applicabili alla guerra in generale, spesso sotto l’influsso della lettura di Karl von Clausewitz (vedere la recente edizione dell’opera Della guerra, tr. it., Milano 1970), o di un Lenin lettore di Napoleone, Clausewitz, Moltke, von der Goltz, Federico il Grande, ecc. Da ciò tutte le conclusioni relative a una dialettica della guerra e della pace (cfr. Mao Tse Tung, Identità e lotta degli aspetti della contraddizione, nel volume Sulla contraddizione, tr. it., Pechino 1968, p. 9) che nella migliore delle ipotesi è tirata per i capelli. Da ciò, cosa ancora più grave, un concetto di rivoluzione eminentemente autoritario, considerato come l’estrinsecazione di una personalità particolarmente dotata, o di una élite di uomini particolarmente preparata, in grado quindi di programmare la rivoluzione con piani strategici tipo guerra tradizionale e portarla alla vittoria. Su questa strada si vengono a porre in linea uomini come Cesare, Napoleone, Trotskij, Mao Tse Tung, fabbricanti di vittorie che sfumano tutti insieme nella notte della necessità del risultato a ogni costo.
La rivoluzione diventa così un problema teorico e la lotta rivoluzionaria un problema teorico di strategia. In un recente libro, Cesare Milanese ha visto negli anni londinesi tra il 1900 e il 1903, che Lenin e Trotskij trascorsero insieme studiando al British Museum, l’origine del “pensiero rivoluzionario del bolscevismo” (Princìpi generali della guerra rivoluzionaria, Milano 1970, p. 25), come pure il germe delle future vittorie.
È evidente, almeno per noi, che con simili prospettive di partenza una metodologia della lotta rivoluzionaria si traduce in un semplice manuale per militari, quando dovrebbe essere un manuale per militanti. La differenza non è lieve. Il militare, nell’accezione tradizionale del termine, è un oggetto che deve obbedire e morire, il militante, nella accezione rivoluzionaria del termine, è un soggetto che deve ragionare e, se del caso, anche morire. E quindi impossibile suggerire, o imporre, al secondo precetti che vanno bene solo per il primo.
Ora, l’errore di partenza è quello della non eccessiva fiducia nella capacità costruttiva delle masse, donde il singolo rivoluzionario, nel chiuso magari del British Museum, si crede in dovere di lavorare, non per loro ma al loro posto, indipendentemente dalla considerazione della loro presenza, non tenendo conto che una rivoluzione non è soltanto un fatto guerresco ma anche e principalmente un fatto umano, sociale. Tutto ciò conduce irrimediabilmente verso nuove e più terrificanti forme di struttura autoritaria.
Che una minoranza agente, una ristretta avanguardia rivoluzionaria possa svolgere un lavoro preventivo di chiarificazione è fatto certo, che possa anche servire da guida insostituibile, perché meglio approfondita nel mestiere della rivoluzione è anche sicuro, ma che per questo debba considerare la sua azione come qualcosa di avulso dal contesto sociale effettivo, dalla situazione effettiva delle masse – tal che si possa parlare di una scienza della guerra rivoluzionaria valida in assoluto – mi sembra del tutto assurdo.
Non è affatto vero che una indagine sui metodi di lotta non possa prescindere da una concezione della lotta rivoluzionaria astrattamente considerata. Teorizzare in questo senso significa smarrire il significato concreto di una metodologia rivoluzionaria. Ecco perché, prima dell’esame dei metodi, bisogna chiarire alcuni punti di partenza: il concetto di rivoluzione, l’alternativa (solo apparente) tra violenza e nonviolenza, l’alternativa (concreta) tra autorità e libertà.
Il concetto di rivoluzione
Mai termine è stato più controverso. Anche i fascisti hanno parlato di rivoluzione. Rivoluzione è da considerarsi quella russa della scalata al potere dei bolscevichi, rivoluzione quella francese dei diritti dell’uomo. Situazioni diverse e contrastanti, epoche diverse, diversi problemi, ma persistenza nell’uso della stessa parola, con tutte le conseguenze fuorvianti del caso.
La rivoluzione è un cambiamento di valori, non una banale modificazione di norme. Con la rivoluzione nascono nuove situazioni, nuovi istituti, si distruggono precedenti particolarità e privilegi, mentre un clima di giustizia e di uguaglianza viene a sostituire il precedente clima di soprusi e di divisione sociale. Ma questo schema teorico trova una scarsa corrispondenza, non tanto nella realtà storica, che questo non potrebbe costituire elemento valido per danneggiare l’istanza teorica, quanto nell’analisi obiettiva degli elementi che oggi concorrono a determinare una situazione di privilegio, da modificarsi a seguito dell’inserimento del momento rivoluzionario.
Ma è logico che in quest’ultimo caso è intervenuta una componente di disturbo, rendendo impossibile l’applicazione lineare del principio rivoluzionario che, per comune accettazione, è di natura libertaria. Lo studio di questa componente coinvolge due difettose situazioni: una tipica della minoranza agente e una tipica delle masse. La prima, determinata dal fatto che la minoranza agente, la quale per prima dovrebbe avere le idee chiare, non le ha per nulla, lasciandosi spesso irretire da prospettive immediate, da soluzioni di comodo, da accordi con elementi solo apparentemente rivoluzionari, ma intimamente controrivoluzionari. La seconda, determinata dal fatto che le masse hanno subìto per troppi anni la costrizione delle ideologie autoritarie, per cui non possono – anche a volerlo – di punto in bianco, accettare senza riflessi condizionati la nuova struttura antiautoritaria. Se a tutto ciò si aggiunge la ineliminabile forza d’urto dei residui reazionari, l’impossibilità di provvedere subito alla costituzione di una vera e propria organizzazione rivoluzionaria improntata a concetti essenzialmente funzionali e non strutturalistici e piramidali, si avrà un quadro sia dei problemi che della situazione.
Ecco quindi il grande lavoro che le minoranze agenti devono compiere, trasformare l’ambiente, prepararlo alla lotta contro le ideologie autoritarie, prepararlo quindi alla rivoluzione. Per fare questo si deve combattere con la violenza un sistema violento, non esiste altra scelta. Il nostro combattere non deve essere il cieco dibattersi di un esasperato, ma il razionale colpire, con occhio freddo e preciso, il nostro nemico, senza esitazioni ma senza un odio che non solo causerebbe più danni che benefici, ma svaluterebbe sul piano morale tutto il processo rivoluzionario.
L’alternativa tra violenza e nonviolenza
Alternativa solo apparente, abbiamo detto, in quanto in concreto essa non si pone, essendo la dottrina della nonviolenza solo una degenerazione dei princìpi della violenza difensiva, oppure un semplice gioco di parole, in quanto in realtà con un banale sofisma si fa sempre ricorso alla violenza. Quando i seguaci indiani del grande teorico della nonviolenza circondavano un reazionario che volevano costringere ad accettare alcune loro richieste, poniamo a seguito di uno sciopero, e lo chiudevano in un cerchio di uomini, lasciandolo a capo scoperto, al sole canicolare, finché non gli prendeva un colpo, attuavano la tecnica della nonviolenza, ma solo coperta da un banale sofisma. Per ovviare a ciò siamo sicuri che la teoria della violenza rivoluzionaria, intesa come violenza difensiva, non ha alternative per chi oggi vuole combattere e distruggere un sistema di obbrobrio e di vergogna.
Noi crediamo che solo la rivoluzione violenta può risolvere il problema sociale, allo stato in cui oggi si trovano i paesi delle varie parti del globo, stato determinato o comunque influenzato dalla fase acuta del capitalismo borghese o di Stato.
Ma non bisogna credere che la violenza rivoluzionaria, solo perché l’abbiamo definita “difensiva”, debba essere impiegata per forza dopo che le forze reazionarie abbiano scatenato la loro offensiva, abbiano attaccato lo schieramento rivoluzionario, oppure, il che è ancora peggio, abbiano posto in atto una controrivoluzione preventiva. Credere in ciò sarebbe vero e proprio suicidio.
La violenza rivoluzionaria è organizzazione preventiva ed attacco preventivo contro le forze borghesi, è lotta contro le istituzioni statali, è specifica ricerca dello scontro, sollecitazione del cedimento della sovrastruttura statale. La violenza rivoluzionaria è iniziativa, preparazione delle organizzazioni di guerriglia, formazione delle forze di resistenza, ideazione dei futuri programmi di attacco. Eppure la violenza rivoluzionaria è sempre violenza difensiva. Infatti l’istituzione, lo Stato, la struttura borghese, l’organizzazione militare repressiva, la polizia e ogni altro accorgimento attuato dall’occhiuta rapina organizzata dai padroni, è in se stesso una provocazione, un attacco, una condanna, un sistematico colpire. Anche quando tutte queste forme repressive assumono l’aspetto allettante del dialogo e della tolleranza (cfr. H. Marcuse, La tolleranza repressiva, in Critica della tolleranza, tr. it., Torino 1968, pp. 79-105), anche quando da parte del poliziotto ci viene messa familiarmente la mano sulla spalla, proprio allora è il momento di colpire più forte, più a fondo.
La potenza generatrice della violenza rivoluzionaria è da considerarsi alla base di ogni tentativo di liberazione degli oppressi, non essendo pensabile che i meccanismi automatici dei fattori economici e politici possano determinare da soli la maturità della situazione rivoluzionaria. Occorre anche la volontà degli uomini, la loro azione predeterminata e cosciente, la loro azione violenta diretta contro le istituzioni.
L’alternativa tra autorità e libertà
Ma la rottura di valori, causata dalla rivoluzione, può indirizzarsi verso due direzioni. La prima è quella autoritaria, favorita dal fatto che il momento rivoluzionario, di per se stesso quanto mai caotico, consente scarse possibilità di riflessioni, un momento in cui le situazioni avvalorate dalla volontà degli uomini si intersecano con le situazioni create dalla forza delle cose e delle strutture economiche e politiche. La presenza delle vecchie strutture ideologiche autoritarie, frutto il più delle volte dei preconcetti organizzativi e produttivistici borghesi, non può facilmente essere eliminata. Se a questa situazione oggettiva si aggiunge la presenza di uomini non sufficientemente preparati da un punto di vista delle soluzioni antiautoritarie, di uomini che non hanno molta fiducia nella possibilità di autodeterminazione delle masse, si capisce perché siano molte le possibilità di una svolta autoritaria della rivoluzione.
Resta l’altra direzione, quella antiautoritaria. Direzione più cosciente, più difficile. Non tanto più difficile perché le situazioni oggettive – cioè quelle determinate in prevalenza dai fattori economici – siano in contrasto con questo tipo di soluzione, quanto perché le minoranze agenti possono non avere quella necessaria fiducia nelle masse che questa soluzione richiede, per cui si ritengono autorizzati, dal fine superiore della rivoluzione, a sostituirsi loro. È qui il grosso equivoco che abbiamo rilevato anche all’inizio di queste pagine. Il fine superiore della rivoluzione – onde è frequente sentire parlare di teoria astratta della rivoluzione, come teoria della guerra rivoluzionaria – non esiste più quando la rivoluzione è tradita dalla direzione antiautoritaria, quando il punto di vista iniziale è trasformato nel compromesso della ripresentazione della struttura governativa sotto le mentite spoglie, mettiamo, di una dittatura del proletariato.
Purtroppo le previsioni di una rivoluzione, allo stato attuale dello sviluppo libertario antiborghese, con la fioritura di dottrine e tendenze rivoluzionarie e pseudo-rivoluzionarie, tutte a sfondo autoritario, non appaiono favorevoli a un’attuazione immediata della soluzione antiautoritaria. In ogni caso la partecipazione cosciente delle forze libertarie, all’interno del movimento di liberazione, la loro azione costante e documentata a favore di un’educazione alla libertà, la loro apertura sempre maggiore verso l’eliminazione del settarismo e della clausura, saranno tutti elementi che renderanno possibile una presenza e un’azione libertaria all’interno delle future soluzioni rivoluzionarie. La lotta di domani, la lotta post-rivoluzionaria, sarà ancora più dura di quella di oggi, ma la cosa non deve spaventarci, il cammino per arrivare alla vera rivoluzione può passare anche attraverso le rivoluzioni autoritarie o pseudo-rivoluzioni.
[1970]
Intorno alla dialettica
Il conflitto tradizionale che ha segnato la storia dei movimenti rivoluzionari è stato quello sorto attorno alla necessità di delimitare il campo d’azione dell’autorità. Che la nuova “autorità” sorga a contrapporsi alla vecchia è faccenda comunemente accettata, come intrinseca componente del corso delle cose su cui è inutile discutere, almeno una volta data per certa la sostanza dialettica della realtà.
E non discutiamone. La lotta è alla base della vita, anche di questo non discutiamo. Tutte questioni di sostanza ma anche di metodo. Se per metodo intendiamo quello dialettico, sostanza e metodo si identificano, onde appare sostanza il metodo stesso. Ma la realtà è al di là, non chiara – altrimenti sarebbe al di qua (dentro di noi = idealismo) o sarebbe inutilmente cristallizzata nel paradosso di Parmenide – tale che la sua azione ci appare a volte come un processo unico, uno sviluppo, talvolta invece come un rifiorire di contraddizioni. Possono queste dare il segno della vita, e va bene, ma non possono essere a loro volta sostanza della realtà. La lotta e il rifiorire della contraddizione persistono e fondano la realtà perché è questo l’unico modo di “conoscere” la realtà, e quindi è l’unica possibilità che la realtà abbia di “essere”.
Il metodo dialettico, anche se “riformato” marxisticamente è soltanto un metodo di conoscenza, un modo di avvicinarsi alla realtà, rinunciando a considerarla nella sua totalità, scendendo nel compromesso della parzialità e quindi collocandosi, mano a mano, nell’arco limitato delle sue espressioni parziali.
Questa sostanza indeterminista del processo conoscitivo, che abbiamo individuato in altra sede, rende possibili alcune conclusioni notevoli in sociologia ed in particolare sul problema dell’alternativa tra autoritarismo e antiautoritarismo.
La dialettica, in qualsiasi modo la si voglia fare camminare, è sempre un meccanismo e deve rispondere a determinate regole. La sua validità metodologica è unica, ma non deve trascendere a un livello diverso. Considerando metodo e sostanza la stessa cosa saremmo costretti a un materialismo meccanicista che farebbe ripresentare – in forma inalterata – le opere dell’illuminismo francese.
Che la realtà costituisca un qualcosa fuori di noi e indipendente dalle nostre capacità intellettive – anch’esse realtà – è un dato empirico, per quanto oscuro e confuso. Ma che questa “sia” una realtà dialettica non ci è dato saperlo. Le parzialità che di volta in volta sperimentiamo hanno significato solo se viste attraverso un movimento dialettico di contraddizione e di negazione della negazione.
In questo modo l’antiautoritarismo è non solo elemento utopista d’una enucleazione della realtà fatta a uso e consumo propri, ma elemento d’una parzialità possibile perché pensabile in modo non dialettico.
La prospettiva del proletariato, come classe emergente, è dialettica. La scomparsa della lotta e la formazione di un mondo nato dalla lotta ma basato sulla solidarietà è realtà dialettica ma non necessariamente, in quanto i metodi di comprensione di quella realtà potrebbero, nel frattempo, essere diversi e al momento impensabili, appunto metodi antiautoritari.
[1970]
La comunicazione rivoluzionaria
Il concetto di comunicazione rivoluzionaria
La lotta rivoluzionaria presuppone la necessità di comunicare tra i membri agenti e tra questi e le masse. Dalla possibilità della comunicazione viene fuori la possibilità della preparazione e dei chiarimenti necessari all’azione concreta. In linea generale possiamo dire che tra teoria rivoluzionaria, comunicazione di questa teoria e azione concretamente rivoluzionaria non esiste soluzione di continuità. In altre parole non si può distinguere tra teorico rivoluzionario e rivoluzionario pratico, ambedue sono rivoluzionari e basta, nel caso che ambedue svolgano bene il loro compito.
L’adeguamento dei modi di comunicazione alle situazioni e alle possibilità di spazio consentite dal sistema repressivo è anche principio che attiene direttamente al concetto di comunicazione rivoluzionaria, in quanto, ad esempio, una comunicazione intrinsecamente rivoluzionaria, ma attuata con un mezzo o in modo sbagliato, finisce per non essere più rivoluzionaria. In altre parole se una comunicazione del genere è trasmessa in un libro del prezzo di diecimila lire non è più rivoluzionaria perché non arriverà mai alle masse, oppure se è trasmessa con un linguaggio eccessivamente complicato o artistico che dir si voglia, non è allo stesso modo rivoluzionaria.
I modi fondamentali della comunicazione rivoluzionaria sono le scritte murali, i manifesti murali, i volantini, i cartelli, gli slogan, le conferenze, i comizi, i fogli periodici, le riviste periodiche, i numeri unici, i libri, le ristampe dei classici rivoluzionari, gli opuscoli, il dialogo con le singole persone. Restano l’azione diretta attraverso i fatti e il comportamento personale del singolo, ma questo è un altro discorso e lo abbiamo più volte affrontato.
Le scritte murali
Antichissimo mezzo di comunicazione, la scritta murale è molto efficace per trasmettere un concetto lapidario, in genere usato da chi ama l’indottrinamento ideologico più che la formulazione chiara dei problemi. È un mezzo di propaganda relativamente efficace potendo facilmente essere manomesso dagli attivisti controrivoluzionari, la qual cosa finisce per trasformare la comunicazione di partenza in un banale gioco di opposte opinioni. In ogni caso è strumento introduttivo di emblemi, simboli, brevi concetti che poi saranno sviluppati in altra sede e con altri mezzi.
I volantini
Ottimo mezzo di comunicazione rivoluzionaria. Può essere usato nei momenti più appropriati e risultare estremamente efficace, raggiungendo direttamente il singolo, senza il ricorso a una distribuzione anonima e per ciò stesso estraniante. Il volantino deve però rispondere a certi requisiti essenziali. Deve essere quanto più breve possibile, evitando l’inserimento di digressioni dispersive o riflessioni personali del compilatore. Deve essere incisivo e frazionato da brevissime frasi, due o tre parole al massimo, che illustrano i punti essenziali del discorso e richiamano – anche graficamente – l’attenzione del lettore. Alla migliore efficienza visiva del volantino a stampa si contrappone la maggiore celerità di produzione e il minore costo del volantino ciclostilato. In genere è preferibile ripiegare sul ciclostilato quando si tratta di argomenti che investono problemi conosciuti quasi esclusivamente dai gruppi militanti o comunque da persone in cui è presupponibile una certa preparazione rivoluzionaria, ad esempio, quando la distribuzione deve avvenire in una fabbrica occupata, o durante un comizio, o durante una dimostrazione politica, ecc., viceversa quando si svolge un’opera divulgativa nei confronti della popolazione di una zona o di una città in generale, allora è preferibile compatibilmente con i costi tipografici il volantino a stampa.
I cartelli e gli slogan
Strumenti tipici della dimostrazione politica, segnano un passo avanti riguardo alle scritte murali avendo la caratteristica della mobilità e della non strumentabilità da parte dei gruppi controrivoluzionari. Anche per i cartelli vale il discorso della limitatezza e della lapidarietà. Per gli slogan l’argomento sarebbe quello approfondito a sufficienza dalla pubblicità capitalista. In effetti lo slogan resta nella mente delle persone, ma poiché dal punto di vista rivoluzionario questo non è sufficiente – in quanto non si tratta di convincere il singolo ad andare a comprare il prodotto – occorre che questa comunicazione venga corroborata da qualcosa di più sostanzioso. Ecco perché in genere è consigliabile l’uso abbinato – nelle dimostrazioni politiche – di questi strumenti e del volantinaggio. E questo perché non si deve mai sottovalutare la possibilità di fare ricorso, a seguito del volantinaggio, anche al dialogo con le singole persone, ulteriore fase di chiarimento che allarga l’iniziale stringatezza della comunicazione rivoluzionaria.
Le conferenze
Limitatissimo valore hanno invece le conferenze, intese nel tradizionale significato dottrinario di discorso di uno alla moltitudine, in un luogo chiuso, di fronte a persone selezionate preventivamente, magari a mezzo inviti. Siamo davanti a comunicazioni quasi del tutto superflue in quanto o i presenti appartengono a minoranze agenti che hanno le idee chiare a sufficienza per proprio conto, oppure appartengono ai cosiddetti intellettuali nei confronti dei quali – quando si tratta della specie parassitaria meno recuperabile ai fini rivoluzionari – il discorso è vuoto di significato. Ovviamente questo è il vero caso limite. In pratica poi si possono avere casi concreti in cui anche la conferenza, specie se stabilita sulla base del dibattito, che è poi la forma più comune di conferenza, può avere una certa validità come comunicazione rivoluzionaria, sempre nei limiti e con le perplessità che il dialogo in generale non manca di suscitare.
I comizi
Qui l’accentuazione critica, in un certo senso la stessa socializzazione della comunicazione tipica della conferenza, è resa più superficiale. La sostanza diventa simile a quella delle scritte murali, dei cartelli e degli slogan, solo più vasta, con un certo tentativo di riflessione tra i vari suggerimenti ideologici. L’inevitabile limite del comizio è tutto qui, che deve fare per forza leva su di una suggestione acritica che se in certi casi può ottenere notevoli risultati pratici, specie quando si tratta di sottolineare avvenimenti recentissimi o addirittura contestuali al comizio stesso, in altri casi può risultare controproducente. Invece arma notevole per gli autoritari rivoluzionari resta il comizio, dando modo a questi ultimi di affermare il loro messaggio in forma quanto mai producente dal punto di vista della suggestione.
Il foglio periodico
L’importanza del foglio periodico è grandissima per svariati motivi, non ultimo quello che consente un discorso continuato, protratto nel tempo, raggiunge sempre le stesse persone, o persone via via in numero maggiore, consentendo pertanto che in queste si chiariscano le idee, sia a seguito dell’azione stessa del foglio, sia a seguito del naturale processo di maturazione che, nelle avanguardie agenti, avviene in senso rivoluzionario. Ma il foglio periodico, per attuare in pieno la sua comunicazione rivoluzionaria, deve corrispondere a determinati requisiti. Gli argomenti affrontati, sia di natura contingentale che di natura teorica, devono essere costantemente messi in relazione con la dirittura rivoluzionaria animatrice del foglio stesso. Si può dire che nemmeno una riga deve essere lontana da questo scopo. Mentre qualsiasi altro foglio (letterario, politico, di varia umanità, sportivo, ecc.) si consente delle digressioni, fatte anche allo scopo di alleviare il lettore, il foglio rivoluzionario deve essere una martellata costante, precisa, sistematica, una freccia che raggiunge direttamente il bersaglio. Il linguaggio stesso deve essere semplice, privo di fronzoli letterari, deve comunicare e basta, non curarsi di sollecitare nel lettore emozioni varie, né curarsi di non dire certe cose quando queste vanno dette. Ecco perché il foglio periodico, quasi sicuramente, incappa, e non può fare a meno di incappare, nelle ire della legge. A questo proposito, stante l’esistenza di un potere costituito che deve combattersi, si può dire in assoluto che un foglio periodico che si proponga la comunicazione rivoluzionaria deve andare incontro a una denuncia per ogni numero pubblicato.
Sono state sollevate delle obiezioni sulla validità dei fogli periodici rivoluzionari, oggi che ci troviamo nell’era della carta stampata. Si è detto che un’iniziativa del genere finisce per ragione di cose per essere sommersa dalla grande pubblicistica periodica. In tutto ciò ci sarebbe molto di vero se, per la distribuzione del foglio in questione, si seguisse la strada normale valida per i fogli generici. Ma qui la faccenda è diversa. Per il foglio di comunicazione rivoluzionaria si deve seguire una distribuzione underground, coi metodi che vedremo più avanti, quando parleremo specificatamene di questo problema.
Le riviste periodiche
Dovrebbero servire di sostegno e di rincalzo al foglio periodico, continuando la sua linea rivoluzionaria, sebbene in chiave più complessa, a un livello teorico più approfondito. In questo senso diventa del tutto superflua una rivista periodica che non abbia alla base un foglio periodico, la sua comunicazione rivoluzionaria risulterà attutita o, nella migliore delle ipotesi, diretta a una cerchia assai ristretta di persone. Non dobbiamo dimenticare che le difficoltà pratiche, per l’uomo non abituato alla lettura, di avvicinare una rivista sono maggiori di quelle di accostarsi a un foglio, in quest’ultimo egli sente un “impegno” minore, una maggiore familiarità. Anche l’impostazione grafica, in questi casi, ha grande importanza, e quella della rivista deve per necessità di cose essere più “severa” dal punto di vista dei caratteri tipografici, giustezza del rigo tipografico, ecc., di quanto non sia consentito al foglio periodico.
I numeri unici
Sia fogli che riviste hanno le stesse caratteristiche e gli stessi problemi delle riviste e dei fogli periodici. In particolare bisogna dire che i numeri unici hanno una maggiore aderenza a problemi specifici, spesso di natura contingentale – almeno per quanto concerne i fogli – di grande interesse, argomenti che debbono essere chiariti al più presto e che magari non possono aspettare l’uscita della rivista o del foglio periodico. L’impostazione generale del numero unico deve essere, però, curata meglio, dal punto di vista della dirittura interpretativa rivoluzionaria, di quanto non avvenga per i periodici, in quanto qui si può contare su lettori assidui – almeno nella maggior parte dei casi – e su di un discorso continuativo, mentre il numero unico rappresenta un piccolo mondo a se stante, che dovrebbe avere una propria compiutezza autonoma.
Il libro
Il libro ha rappresentato sempre un grande mezzo di diffusione delle idee rivoluzionarie. Il libro, in genere, è un oggetto che rimane, viene custodito, conservato, riletto più volte nel tempo, non gettato alla rinfusa in un cassetto in mezzo alle altre carte, come avviene per il foglio e in misura molto minore per la rivista. Il libro può quindi presentare un messaggio più ampio, dettagliato, che va dalla teorizzazione anche a un certo livello di difficoltà, alla concretizzazione diretta dell’applicazione rivoluzionaria della dottrina a fatti specifici. Il libro che si propone una comunicazione rivoluzionaria deve, in ogni caso, avere delle specifiche caratteristiche formali, un formato non molto grande, possibilmente tascabile, una voluminosità ridotta e, principalmente, un carattere tipografico piuttosto grande, comunque non inferiore al 12 su 12. Tutto ciò per favorire la lettura anche a chi non è abituato a questo esercizio, non ostacolando la presa di contatto con il messaggio culturale di quanti non hanno dimestichezza con questo genere di cose.
In particolare in merito al libro si apre quel complicato discorso della possibilità rivoluzionaria delle forme letterarie della comunicazione, romanzo, saggio critico e ogni altra forma di impegno di uno scrittore. In pratica il tema non sarebbe aderente al nostro problema, ma non possiamo non notare, di sfuggita, che in effetti la comunicazione rivoluzionaria può assumere anche le forme letterarie, però in questo caso si hanno due grosse limitazioni, o viene preventivamente, su decisione dello stesso scrittore, diretta a una ristretta élite di intellettuali, per la quale ogni sottointeso, ogni allusione, ogni metafora ha un proprio significato ben preciso, per cui al di là della figura letteraria balza subito evidente il messaggio rivoluzionario, o viene filtrata attraverso un lento processo di decomposizione dell’originale messaggio rivoluzionario. È ovvio che in tempi d’azione, in tempi in cui non è possibile nessun tipo di baloccamento, quello che conta prima di tutto è la chiarezza. Compito del letterato diventa pertanto il superamento della barriera della comunicazione filtrata, anche a scapito del valore artistico letterario del suo messaggio, ciò che lo salva in ogni caso è sempre il contenuto rivoluzionario di fondo.
Con ciò non si vuole negare la validità di messaggi filtrati attraverso l’istanza artistico-letteraria o culturale in genere, si vuole solo parlare dell’urgenza dell’azione, niente di più. Quando la casa sta crollando si cerca di salvare prima la vita delle persone, poi, se c’è tempo, le opere d’arte e gli oggetti di valore.
Le ristampe dei classici rivoluzionari
La loro utilità consiste nel messaggio che rimane integro nel tempo, rivolgendosi non tanto agli uomini in generale, ma a quelli che hanno la buona volontà di intendere questo messaggio nella sua esatta consistenza. Infatti il classico rivoluzionario deve essere sempre rivissuto alla luce della problematica contingente, non perché possa servire da modello per la risoluzione di problemi attuali, la storia non si ripete in tale maniera da consentire queste banali sovrapposizioni, ma allo scopo di fornire chiarimenti per prima cosa di natura teorica, in secondo luogo anche di natura pratica, su come sono stati risolti problemi del passato e sulle conseguenze pratiche che quel tipo di risoluzione ha determinato.
Una ristampa in forma critica, con un’ampia introduzione e note di chiarimento, sarebbe auspicabile in ogni caso. Purtroppo i mezzi della pubblicistica rivoluzionaria non sempre consentono queste iniziative. Da canto suo la pubblicistica borghese, specie in questi ultimi anni, ha scoperto la produttività di questo filone editoriale, e ha ristampato decine di classici. Ciò può anche tornare utile, solo evidentemente nel caso in cui il lavoro sia stato fatto da persona competente e onesta.
Gli opuscoli
A nostro avviso rappresentano un mezzo di propaganda rivoluzionaria di grande efficacia. Riassumono, specie se editi con un certo rispetto per la buona editoria, pure nella generale penuria di mezzi, un felice connubio tra il foglio periodico e il libro, hanno l’essenza di oggetto del libro e la svelta freschezza del foglio. Anche qui il discorso si pone sul contenuto che deve, questa volta, essere più aderente a un immediato chiarimento rivoluzionario, risultando dannoso, o inutile, affrontare con questo mezzo problemi teorici di portata notevole. L’essenziale praticità del mezzo deve quindi corrispondere alle caratteristiche pragmatiche del contenuto, solo così l’opuscolo risponderà veramente ai fini per cui è stato ideato.
Il dialogo con le singole persone
È il mezzo di comunicazione rivoluzionaria orale più frequente. Il rivoluzionario vive la sua vita di tutti i giorni in mezzo alle persone, parla e affronta quasi in continuazione problemi che consentono un’accentuazione di propaganda rivoluzionaria. La sua costante attività in questo senso, anche se non appariscente, anche se non produce risultati clamorosi ed immediati, ha l’utilità di dare risultati col tempo. Non deve essere una persona dotata di grandi possibilità di eloquenza, ma una persona come tutte le altre, come tutti quelli che lavorano e vivono problemi comuni, niente di trascendentale o di eroico, la figura del vecchio rivoluzionario del passato è roba da soffitta, oggi il rivoluzionario è simile agli altri, solo che è in grado di dare una particolare angolazione dei problemi di tutti e di comunicarla agli altri.
Che poi si possano nutrire dubbi, assai fondati, sulla possibilità del dialogo è tutta un’altra faccenda. In effetti il dialogo, come abbiamo più volte dichiarato, è quasi sempre una grossa mistificazione. Le due parti non agiscono, se non apparentemente, su di un piano di parità. Le riserve mentali, la dottrina gesuitica della doppia verità, impediscono di raggiungere risultati concreti. Ma qui il nostro caso è differente. Il rivoluzionario nella comunicazione orale non deve impiantare un dialogo che in senso molto limitato, cioè non deve aspettarsi nulla dalle persone, soltanto suggerire una speciale angolazione di un problema, nient’altro. Nel caso si aspettasse, per errore, un’adesione o una critica costruttiva, un dibattito da cui ricavare risultati positivi, andrebbe incontro a grosse delusioni.
È il vecchio concetto democratico della libertà intesa come strumento utile ad esprimere la propria opinione, finché questa non viene a ledere i diritti degli altri ed in particolare quelli – moltissimi – dell’ordine costituito, che alimenta il concetto moderno di dialogo. Di tanta propaganda attorno a questo strumento democratico ci è rimasta solo l’emblema della farsa partitica recitata in Parlamento o, farsa ancora più umoristica, quella che i politicanti recitano davanti alle telecamere, a uso e consumo del popolo addomesticato e credente. Quindi la ricerca di un dialogo del genere non rientra affatto negli scopi del contatto e della comunicazione rivoluzionaria.
[1971]
Underground
Il problema dell’editoria è oggi più che nel passato un problema di potere, un problema politico che investe sotto aspetti diversi la possibilità di una contestazione al sistema, come pure la condizione di chi a questo contrasto partecipa.
Soluzioni diverse sono state tentate in quell’America che rappresenta il banco di prova di ogni rottura della cerchia burocratizzata delle pseudo-forme di libertà costituzionali. Una di queste ha preso il nome di “underground” or sono parecchi anni ed è oggi, nella maggior parte dei casi, rigettata dagli stessi estremisti americani. Il Black Power viene così alla luce rigettando le inutili forme di un nascondimento che risultava ormai assurdo. La lotta continua sulle strade, sulle piazze, nelle istituzioni stesse del potere tradizionale, nelle università, nelle fabbriche, è una lotta che ha rotto ormai gli argini delle vecchie titubanze e marcia diritta.
L’importazione delle ideologie, al solito, ha avuto un certo ritardo per via del dazio doganale che bisogna pagare e quindi solo da poco tempo in Italia ci si accorge che tutta la faccenda dell’“underground”, nel vecchio senso cospirativo, è roba ormai superata. Oggi quando parliamo di “underground” intendiamo riferirci non più ai gruppi ma al lavoro di diffusione delle idee – in genere e specificatamente al lavoro editoriale – effettuato non più attraverso i soliti canali di diffusione ma col mezzo di nuovi collegamenti che, appunto, per la non immediata evidenza sono “underground”.
Pertanto, quando oggi parliamo di attività sotterranee ci riferiamo solo alle attività editoriali o di diffusione delle idee e non più all’attività politica concreta di rigetto delle forme istituzionali, quest’ultima è ormai uscita alla luce del sole.
Quali sono le possibilità di una editoria del genere? Questo è veramente un grosso problema. Ed è anche un quesito che chi scrive si è posto da molto tempo in forma pratica. In particolare a Catania abbiamo costituito una “libreria underground” che vende solo testi politici della sinistra parlamentare ed extraparlamentare, che tiene testi non distribuiti tramite i normali canali e non editi dai grossi editori, quindi irreperibili nelle altre librerie. Naturalmente accanto a questi testi bisogna pure tenere quelli che coinvolgono tematiche di sinistra – editi dai grossi complessi editoriali per consentire alla libreria di offrire al suo pubblico un quadro più ampio e una maggiore possibilità di scelta.
Altra iniziativa – sempre nella prospettiva “underground” – è stata attuata a Catania in collaborazione con un’altra editrice di Ragusa, sempre sotterranea, “La Fiaccola”, costituita dalla collana “La sinistra libertaria”, che ha già pubblicato quattro titoli, un lavoro sulla Comune di Parigi del 1871, curato dalla Lega Comunista Libertaria di Catania, un lavoro di Jean Maitron della Sorbona di Parigi dal titolo L’anarchismo e i giovani, un lavoro di Bernd Œlgart dal titolo Marcuse, un rendiconto, e un lavoro di Gaston Leval dal titolo Rinascita del movimento libertario. Sono in programma lavori di Joll, di Guerin, di Montseny, di Reich, di De Marchi ed altri.
Questa l’iniziativa. Veniamo adesso alle possibilità e alle difficoltà. Le possibilità sono una distribuzione sotterranea attraverso i gruppi d’iniziativa politica, naturalmente di sinistra, quindi una distribuzione che rompa decisamente con i canali tradizionali della grossa editoria. In questo modo si avrà la presenza dei libri in alcune librerie particolarmente sensibilizzate, non in tutte, ma si avranno i libri nelle mani di coloro che si interessano a questi particolari lavori. Per alcune zone si utilizzeranno distributori locali, anche dotati di una certa organizzazione libraria, ma che diano garanzie di appartenenza ai movimenti di sinistra. Particolari sforzi saranno diretti ad ottenere una penetrazione capillare nelle campagne e nelle fabbriche, tralasciando quell’intellettualismo tradizionale che ormai ha poco da esprimere.
Dopo le possibilità, le difficoltà. Per prima cosa la scarsa efficienza dei servizi postali, ecc., la sistematica e persistente ottusità di coloro che sono preposti ai vari uffici burocratici immediatamente a contatto con iniziative come quella che veniamo descrivendo, che in un attimo acuiscono la loro pur grande burocratizzazione non appena sentono parlare di sinistra, di extraparlamentare, di underground, difficoltà finanziarie in quanto i rientri sono assai ritardati dipendendo esclusivamente dall’onestà personale dei partecipanti ai singoli gruppi e movimenti, dovendosi del tutto escludere i tradizionali sistemi coercitivi di pagamento (fatture, cambiali, tratte e roba del genere).
Questo il quadro. Tutto consiste in definitiva nella possibilità di potere resistere e di lavorare con tenacia e fiducia. I risultati non possono, per ragione di cose, essere immediati ma non si può dire che debbano mancare del tutto.
[Inserito nel volume Un tulipano rosso, a cura di S. Calì, Catania 1971, pp. 26-27]
Revisionismo rivoluzionario
La rivoluzione è fatto permanente, individuale e collettivo, ineliminabile nell’uomo che ha preso coscienza di certe disparità economiche e delle tremende conseguenze che queste ultime causano in continuazione. Riflettere su questo punto non è possibile, se non come premessa all’agire, come condizione chiarificatrice dell’azione. Ogni riflessione che si ponga sterile anticamera di una ulteriore riflessione è sostanziale revisionismo, modificazione aristocratica del primitivo bisogno distruttivo della rivoluzione.
Abbiamo più volte avvicinato il problema della politicizzazione della nostra azione rivoluzionaria, dell’adeguamento a nuove forme di lotta, a nuove coabitazioni con la tolleranza repressiva del sistema. Ma di tutto questo ne abbiamo ricavato soltanto un’impressione di insufficienza.
Può essere valida la tesi di coloro che guardano all’inserimento nel corpo multiforme dello schieramento di sinistra come a condizione di sopravvivenza, e in effetti concordiamo limitatamente a quanto di negativo si può reperire in ogni chiusura chiesastica, ma ciò che non ci convince è il passaggio ulteriore, verso la solidificazione delle strutture rivoluzionarie, verso la formazione persistente di certi quadri, verso la delegazione decisionale a certi organismi, al di là dei nomi e delle sigle.
La lotta è fenomeno collettivo, diventa significativa quando assume proporzioni tali da intaccare visibilmente le “armonie” del sistema. Ma con tutto ciò non riesco a convincermi che essa sia, a priori, una cosa programmata e programmabile in tutti i particolari. L’esplosione popolare non è facilmente prevedibile, anche se non sono pochi coloro che la ritengono individuabile con precisione di date e di numeri, resta sempre affidata a quei piccoli particolari che in fondo hanno fatto gli avvenimenti da sempre. Ma una volta in atto questo fenomeno deve essere conosciuto nel suo significato più profondo, nelle possibilità concrete che apre agli scopi rivoluzionari, nelle condizioni sostanziali che lo hanno determinato. Conoscenza questa che può essere attinta soltanto da chi è a contatto con la problematica rivoluzionaria e non si chiude dietro preconcetti valori di scuola filosofica. In questo modo le immense forze messe in moto possono essere aiutate a raggiungere certi scopi che, se da un lato sono potenzialmente inerenti ad esse, dall’altro possono in qualsiasi momento essere disattesi o travisati.
Fatto questo tipo di premessa si deve però aggiungere subito che queste prospettive e queste cautele, questo volere a priori bloccare ogni eventuale stimolo autoritario, non devono in nessun modo autorizzare a trasformare l’attesa vigile ed attiva del rivoluzionario nell’attesa sorniona e passiva del revisionista disposto ad adattarsi alle condizioni del momento.
E il banco di prova di questa alternativa o, se si vuole, di questa discriminazione, è ancora una volta il problema della violenza. La titubanza e l’eccessiva incertezza nel colpire la controrivoluzione equivale, in pratica, a favorirne la crescita. L’antica formula di Machiavelli anche questa volta non si tradisce, i nemici vanno colpiti profondamente perché delle piccole offese si vendicano, delle grandi non possono. E un esempio di quanto sia vera questa formula l’abbiamo avuto dopo il Maggio francese del ‘68, dopo il quale la borghesia ha posto in atto una repressione ferocissima verso la fonte principale della sua grande paura.
Ecco perché siamo sicuri che l’unica via rivoluzionaria sia ancora e sempre quella del sangue e della lotta, della violenza organizzata e della guerriglia, della distruzione e della morte alla borghesia e alle forze della repressione, via validissima anche quando le condizioni esterne sembrano contrarie, anche quando tutto concorre a far pensare alla inevitabile eliminazione di ogni conato rivoluzionario, anche quando gli stessi movimenti rivoluzionari sono più o meno inseriti in una pantomima recitata attorno al potere e alle sue putride filiazioni.
E il popolo da canto suo è cosciente di questo fatto, non si aspetta nulla dalla struttura e dal sistema, nulla al di là del piccolo favore personale o del posto per il figlio laureato, nulla al di là del piccolo aumento periodico di fronte al costo della vita. Tutto quello che sta oltre, che lo colpisce confusamente – scandali del potere, putredine parlamentare, violenze dei padroni, morti bianche nelle fabbriche, oppio istituzionalizzato attraverso la televisione e gli stadi – tutto ciò gli resta davanti come una immensa muraglia di cui vede solo e confusamente i contorni, ma di cui avverte la tremenda pressione psicologica. Contro tutto questo non si sogna nemmeno che il potere costituito possa fare qualcosa, coltivando dentro il remoto bisogno di una liberazione completa, totale, definitiva.
Quando poi scatta una piccola molla, un meccanismo che nessuno poteva controllare e di cui nessuno conosceva l’esistenza, allora quelle pressioni confuse diventano chiare e insopportabili, la massa si rivolta, reagisce, dapprima inconsultamente, distruggendo tutto quello che gli sta attorno, poi con maggiore determinazione e coscienza, quindi con maggiore pericolosità, man mano che l’azione stessa delle minoranze agenti si apre la strada nel caos dei primi momenti. Da questo punto in poi le possibilità sono praticamente aperte a tutto, la fantasia finisce veramente per prendere il posto dell’ottusità e della programmazione.
Non è questo il luogo per dare conto di una certa problematica delle dimensioni future che potrebbe o non potrebbe assumere una rivoluzione popolare. Abbiamo molte volte avanzato i nostri dubbi su di una sistemazione dichiaratamente anarchica dell’assetto rivoluzionario, mentre ci sembra molto probabile una sistemazione autoritaria con larga componente libertaria, ad esempio come una Repubblica dei Soviet. Ma già siamo nel campo delle previsioni che, come si sa, lasciano il tempo che trovano.
Problema ben più grave ci sembra quello che abbiamo accennato prima, cioè quello di perdere di vista l’azione rivoluzionaria, immergendosi fino al collo nel piccolo gioco politico della sopravvivenza, nei piccoli compromessi e nei camuffamenti ridicoli. Tutto ciò può non solo indebolire le forze rivoluzionarie ma fare perdere di vista, specie nelle nuove leve non ancora adatte a rivestire l’incarico di minoranza agente, i veri scopi del loro lavoro.
[1971]
Parigi 1871
Il lavoro che presentiamo, redatto dall’autore in collaborazione con la Lega Comunista Libertaria di Catania, si prefigge scopi ben precisi riguardo a uno dei problemi più appassionanti della storia delle lotte del proletariato, quello della Comune di Parigi del 1871.
Anche volendo escludere la contingenza della ricorrenza, verso cui tanta pubblicistica superficiale si è diretta in questi ultimi mesi, resta il fatto inoppugnabile che l’argomento è quanto mai interessante, a livello di lotta politica concreta, per la fondamentale chiarificazione che negli avvenimenti della Comune, nei suoi errori, nei suoi provvedimenti, nei suoi sacrifici, si può cogliere. Il colore di questa chiarificazione è decisamente libertario, ed è questo il compito che l’autore si è dichiaratamente prefisso.
Dopo una breve esposizione dei fatti storici che determinarono l’azione rivoluzionaria dei comunardi, l’autore passa a un esame dei più importanti provvedimenti decisi in quei giorni come pure degli inevitabili errori che furono commessi sia per la fretta, sia per un residuo di pregiudizi borghesi, sia per la presenza di elementi non proprio rivoluzionari infiltratisi nei giorni del successo e poi scomparsi al momento della resa dei conti. Ma la parte più importante resta il riesame condotto dei passi di Marx, in particolare della Guerra civile, di Engels e di Lenin, con cui si è voluto ridare vita a una interpretazione del fenomeno storico non propriamente distorto dal successivo ritorno della riflessione teorica necessariamente legata a canoni preesistenti e rigidi.
In effetti, specie in Marx, esiste questa strana disposizione verso gli avvenimenti della Comune che lo coinvolgono, insieme alle sue teorie, in modo diretto, convincendolo di essere davanti al primo esempio storico di rivoluzione proletaria e di dittatura del proletariato. Ecco perché dall’impressione generale di rigidezza autoritaria che si ricava da tutto il sistema delle opere di Marx, collocandosi soltanto negli scritti dedicati alla Comune si passa a una maggiore apertura in senso libertario. In questo non si deve comunque vedere una netta contraddizione, e tanto meno pensare all’eventualità di un’alterazione storica, quanto piuttosto a una chiarificazione concreta e quindi a una riprova delle sue precedenti teorizzazioni (in vero appena accennate).
Lo stesso avvenimento influenza pure Engels che, nella Prefazione alla nuova edizione del Manifesto (1872), scriverà insieme a Marx ammettendo la necessità della sostituzione della macchina statale dopo la conquista del potere da parte del proletariato.
In Lenin l’avvenimento avrà importanza preponderante in quanto suggerirà la creazione dei soviet che come primo organismo di base daranno vita alla dittatura del proletariato post-rivoluzionaria. Che poi questi organismi non ebbero a reggere lo scontro, sia col “partito-guida” leninista, sia con la rinnovellata macchina burocratica staliniana, è tutto un altro discorso.
Siamo quindi in un clima decisamente nuovo, assolutamente lontano dal parlamentarismo paraborghese, dal riformismo socialdemocratico, dai tentennamenti dei revisionisti teorici, dalle paure dei moderni soloni dell’attesa che la pera marcia cada da sé. La violenza, matrice di tutte le nuove istituzioni, assiste alla nascita della Comune, il fallimento detta i termini del suo condizionamento storico. Una situazione veramente ideale, quale nessun governo rivoluzionario si era mai sognato di immaginare prima, un esercito a disposizione di non meno di 60.000 uomini, secondo le valutazioni restrittive di Prosper Lissagaray, e di circa 200.000 uomini secondo le valutazioni del generale Appert nel suo rapporto sulle operazioni condotte contro i comunardi, comunque, in ogni caso, una forza ragguardevole, anche non volendo considerare l’apparato di difesa veramente eccezionale costituito da ben sei forti che gli stessi Prussiani non avevano potuto espugnare. Se a questo si aggiunge l’esistenza di una zona neutra (quella occupata dai Prussiani) attraverso la quale i rifornimenti potevano entrare regolarmente a Parigi senza essere molestati, il possesso dell’immenso tesoro della Banca di Francia valutato a circa tre miliardi, il generale entusiasmo di tutti, in quanto tutti si rendevano conto dell’eccezionalità dell’esperimento e del fatto che per la prima volta non si lavorava e non si moriva per Bonaparte, si potrà avere un quadro esatto della situazione rivoluzionaria della Comune.
Eppure, con tutte queste condizioni favorevoli, il risultato non fu positivo. Su tutto ciò scese l’ombra dell’equivoco alimentato dal veleno borghese che screditava all’estero e nella stessa Francia l’azione dei comunardi e che tutt’ora si ripercuote nella storiografia di parte che di regola preferisce tacere, quando non disinforma sugli avvenimenti di quel fatto eccezionale. Croce dedica poche righe, Salvatorelli appena una pagina, Barbagallo credo taccia del tutto, Pareto ne accenna ma solo per fare notare le storture che i comunardi commisero nella loro azione rivoluzionaria e i campioni di un’umanità dissoluta che scesero in campo dietro le barricate.
Il proletariato conquista il potere, attua in un clima di eccezionale entusiasmo la sua dittatura, combatte eroicamente contro la reazione borghese, tutto qui, questa la Comune. L’elencazione degli errori commessi come pure dei motivi che non consentirono il migliore impiego dei vasti mezzi a disposizione è studio interessantissimo ma che deve farsi in separata sede. Che nel suo Comitato vi si trovassero parecchie persone inclini alle peggiori tradizioni democratiche, come i cosiddetti oratori da club, è un fatto accertato, lo stesso deve dirsi per la presenza di parecchi letterati che se in buona fede lottarono e morirono, in pratica fecero più male che bene, soltanto un nucleo ristretto aveva competenza dei problemi del lavoro e questo gruppo – al di là dell’eroismo di tutti – fece della Comune non solo un simbolo ma anche un riferimento concreto della produttività di un’amministrazione proletaria. Vediamola questa organizzazione, i suoi risultati ci diranno, sia pure in sedicesimo, quali potrebbero essere quelli di una vasta applicazione del principio libertario dell’abolizione del potere centrale.
La Comune aveva abolito per prima cosa gli alti onorari, molti operai si seppero improvvisare impiegati e ricoprirono il nuovo incarico con grande zelo e competenza. Un cesellatore (Albert Theisz) divenne il direttore delle poste, trovò un servizio quasi inesistente, disorganizzato, con i valori rubati. Riunì tutti i dipendenti rimasti, li arringò e li convinse a passare alla Comune, in breve la levata delle lettere e la consegna fu ristabilita in tutta la città, si arrivò anche a far partire la corrispondenza per la provincia a mezzo di agenti abili e coraggiosi. Lo stesso avvenne alla zecca dove un operaio aggiustatore in bronzo (Zéphirin Camelinat) venne incaricato di mandare avanti la baracca, si fecero nuove coniazioni con l’argento dell’argenteria che si requisì. L’assistenza pubblica venne curata da Treilhard che redasse un minuzioso rapporto sui risultati ottenuti e sulle modificazioni dell’assistenza come pure sull’allargamento della stessa. Il delegato alle finanze (François Jourde) riuscì a presentare un bilancio talmente preciso, oltre che attivo, da costituire un vero gioiello d’amministrazione e un’eccezione in materia di bilanci pubblici, nella relazione al bilancio lo stato delle finanze della Comune era giudicato florido, in questo lavoro Jourde era stato assistito da Eugène Varlin, ambedue operai internazionalisti.
Se si pensa che tutto questo, e altro, specie nel campo dell’istruzione, delle biblioteche, della lotta contro la Chiesa, della propaganda a mezzo dei giornali, fu compiuto in appena 72 giorni, ci si rende conto che la produttività raggiunta fu massima e che ognuno fece il proprio dovere. Le eccezioni furono immediatamente circoscritte ed eliminate dall’incarico.
È proprio questo il principio che deve reggere il fondamento della rivoluzione proletaria e della successiva organizzazione, la delega in base alla funzione, non più quindi in base al titolo o al casato, ma soltanto in base alla funzione, naturalmente con la premessa indispensabile della removibilità.
In questo vedrei il più alto insegnamento della Comune, al di là dei teorici di professione, al di là dei letterati e dei giornalisti, l’operaio seppe mettere a disposizione del “suo” apparato rivoluzionario la sua esperienza e la sua produttività. Questo fenomeno, in quella sede, non fu che un lampo appena, in altre sedi successive, come in Ucraina e in Spagna, l’esperimento poté durare più a lungo, non dovrebbe essere lontano il giorno in cui da esperimento si possa passare a fatto definitivo. La volontà nella massa operaia non manca, la sua capacità produttiva è sempre più ampia, la sua rottura con le ristrette cerchie degli sfruttatori capitalisti è sempre più decisa, resta solo da evitare che una nuova marea di oratori, di letterati, di sognatori in buona e mala fede, riesca a montare all’assalto della “realtà” operaia, il resto non tarderà a venire.
[Introduzione a F. Coniglione, Parigi 1871. La comune libertaria, Catania 1971]
Ricerca sui precursori dell’anarchismo. Possibilità e limiti
Perché parlare di precursori? Non è da considerarsi arbitrario un ricorso indietro nel tempo alla ricerca di una tradizione anarchica? Non può questa pretesa nascondere il bisogno di individuare testimonianze autorevoli a favore di una dottrina e di un movimento politico che hanno visto la luce solo in epoca molto recente?
Queste domande e altre molto simili sono state poste da diversi studiosi ma, a nostro avviso, non hanno ricevuto una risposta esauriente.
Vediamo di rispondere con ordine alle domande che ci siamo posti all’inizio.
Perché tanto spazio dedicato ai precursori? Se l’anarchia, come pensiero e azione giunti a maturità, è data dal rifiuto dell’ordine fondato sul principio di autorità, dal rifiuto della violenza che scaturisce automaticamente dalle istituzioni dello Stato, dal rifiuto di ogni forma di autorità che non sia quella della ragione, dall’affermazione che non è concepibile nemmeno l’autorità e quindi la stessa esistenza di Dio, dall’affermazione della capacità dell’uomo di padroneggiare la natura e le stesse leggi biologiche determinando le condizioni della propria liberazione, se l’anarchia è tutto questo e, più ancora, è movimento organizzato di idee e di azioni dirette a fondare una società nuova capace di conciliare armoniosamente la libertà individuale e le necessità sociali, allora non può avere una fede di battesimo con tanto di data e testimoni. Tutte queste condizioni e caratterizzazioni affondano le proprie radici nella storia del passato, nelle vicende tormentose attraverso le quali alcuni uomini hanno saputo vedere oltre la nebbia soffocante delle istituzioni e dei pregiudizi. Vera e propria avanguardia intellettuale, questi uomini hanno coltivato beni di grande valore: lo spirito critico, il coraggio di guardare in faccia la spaventosa divinità, il rifiuto del pregiudizio, il sospetto verso l’autorità, il desiderio di libertà e l’insofferenza della servitù. Niente di più. Nessuna avvisaglia di quella moderna tendenza al movimento di massa che giustamente detta i princìpi moderni dell’anarchismo, ma con tutto ciò presenta i germi di quel lavorio critico dell’epoca matura che determinerà la genesi degli attuali movimenti di massa ispirati all’anarchismo.
Partendo da un punto di vista diverso dal nostro, limitandosi a considerare l’anarchismo come fenomeno essenzialmente moderno, catalogabile in schemi fissi, validi a interpretare la sua azione dalla metà del secolo scorso a oggi, dalla storia dell’idea e dell’azione anarchica si dovrebbe tagliare via, ad esempio, Max Stirner, come pure, per motivi assai simili, Benjamin Tucker e Josiah Warren (cfr. G. Cerrito, “Geografia dell’anarchismo”, in “Anarchismo ‘70” Quaderno II, Pistoia 1971, p. 71). È logico che in questo modo diventa assurdo parlare di precursori addirittura più lontani. Ma, stabilendo i termini esatti del rapporto tra le attuali manifestazioni dell’anarchismo e le idee che queste manifestazioni personificano, non si può negare il fatto che queste idee hanno una caratteristica essenziale che le lega ad altre manifestazioni del passato, anche se queste ultime ebbero ad assumere forme concrete di estrinsecazione assai diverse da quelle attuali.
E la prima grande differenziazione è che, mentre oggi assistiamo a manifestazioni di massa, di cui l’ultima grande esplosione è da considerarsi il movimento contestatario messo in moto dal Maggio francese del 1968, in passato si avevano esclusivamente manifestazioni di élite, ristrette minoranze di intellettuali capaci di cogliere l’essenza negativa di quelle istituzioni che la maggior parte delle persone da una propaganda faziosa era portata a considerare assolutamente positiva.
Solo in questo modo quindi possiamo stabilire una continuità storica, un rapporto ininterrotto e, allo stesso modo, giustificare la nascita stessa di quelle manifestazioni moderne che, altrimenti, resterebbero stranamente sospese a mezz’aria oppure, cosa assai peggiore, legate a una banale degenerazione antiautoritaria degli stessi princìpi autoritari.
La seconda domanda che ci siamo posti ha visto in parte la sua risposta in quanto precede. È da considerarsi arbitrario un ricorso indietro nel tempo alla ricerca di una tradizione anarchica? In effetti il pericolo dell’arbitrarietà esiste ed è legato alla concezione della storia intesa come un tutto progressivo che si evolve secondo schemi prefissati in cui l’azione dell’uomo, con tutto il suo liberum arbitrium, recita solo una parte marginale. Certo in questo modo vedendo le cose si può correre un rischio grosso. Ad esempio, scambiare gli stimoli riformisti per ribellione all’autorità, gli sforzi diretti a rendere più efficace il potere per abbattimento e distruzione dello stesso.
Prendiamo il caso direi fondamentale di Jean-Jacques Rousseau. Leggendo alcuni passi delle sue opere si è portati a sottoscriverle in pieno da un punto di vista anarchico, ma poi leggendone altri, leggendo alcune opere nel loro insieme, vedendo le conclusioni generali del suo pensiero, ci si ricrede subito. Facciamo degli esempi. Egli scrive: «Il primo uomo che, avendo recinto un terreno, ebbe l’idea di proclamare questo è mio, e trovò altri così ingenui da credergli, costui è stato il vero fondatore della società civile. Quanti delitti, quante guerre, quanti assassinii, quante miserie, quanti errori avrebbe risparmiato al genere umano colui che, strappando i pali o colmando il fosso, avesse gridato ai suoi simili, “guardatevi dall’ascoltare questo impostore, se dimenticherete che i frutti sono di tutti e che la terra non è di nessuno, sarete perduti”». (Discours sur l’origine de l’inégalité, II). E altrove: «L’uomo è nato libero e dappertutto è in catene. Persino chi si crede il padrone degli altri non è meno schiavo di costoro. Come si è prodotto questo mutamento? Lo ignoro». (Contrat social, I, 1). E si potrebbe continuare a lungo con passi simili a questi. Ma l’opera complessiva di questo pensatore fa riflettere. Ha scritto recentemente Sergio Cotta: «Il cantore della natura e della sorgiva, esaltante spontaneità dell’io… D’accordo, ma come ricondurre ad esso il minuzioso, talora soffocante o arido pedagogista o l’oppressivo legislatore affascinato dai meno poetici popoli esistiti, gli Spartani per l’antichità, gli Svizzeri per i tempi moderni? Non si sottrae agli antitetici richiami del poetico e del teoretico, o del didascalico, nemmeno la Nouvelle Héloise, il romanzo esemplare dell’amore romantico, della felicità ideale, condotto sul filo del sogno e della trasfigurazione. Troppo spesso, infatti, l’impeto dei sentimenti si raggela in una fredda precettistica dei doveri e la partecipe descrizione della natura scade a un’ambigua esaltazione politica della vita agreste, parsimoniosa, modello anacronista di una società spiritualmente ed economicamente autarchica, chiusa al progresso... Il pedagogista, il maestro di Emilio o di Sofia, che vuol bandita ogni autorità e ogni costrizione dalla loro educazione... Ma questa autorità è veramente bandita o soltanto abilmente nascosta? Invero, a che cosa tende la nuova pedagogia delineata da Rousseau? Senza dubbio, essa mira ad impedire, in ogni caso, che si formi ancora l’homme de l’homme, l’uomo cioè legato all’opinione altrui, condizionato da essa nel suo desiderio di “apparire”, e quindi sempre estroverso ed alienato. Ma al suo posto, in definitiva, quale uomo dovrà sorgere? L’homme de la nature, della spontaneità innocente e liberatrice, dell’umanitarismo, oppure il citoyen, che è costretto ad assoggettare la sua ragione alla volontà generale, che riconosce di aver valore solo “dans son rapport avec l’entier qui est le corps social”, il patriota, che è “dur aux étrangers”». (Introduzione a Jean-Jacques Rousseau, Grande Antologia Filosofica, vol. XV, Milano 1968, pp. 850-851).
Come conclude più avanti lo stesso studioso, Rousseau è in favore di questa seconda soluzione, ed è proprio per questo che sfugge irrimediabilmente a un inserimento legittimo tra i precursori dell’idea anarchica, anche se non sono mancati studiosi che hanno stabilito paralleli assai fruttiferi tra lui e alcuni pensatori libertari. (Cfr. S. Rota Ghibaudi, Proudhon e Rousseau, Milano 1965, I. M. Markovitch, J.-J. Rousseau et Tolstoj, Parigi 1924).
Abbiamo quindi precisato un punto a nostro avviso assai importante. Per precursore nel nostro significato intendiamo coloro che hanno attaccato l’autorità dello Stato, o di Dio, che hanno inteso fare qualcosa, anche limitatamente alle loro poche forze, per la liberazione dell’uomo. Questi ribelli sono però tutti caratterizzati dalla loro posizione scomoda e insostenibile in seno alla società in cui si trovarono a vivere, in nessun modo il loro pensiero e la loro azione si diressero qualche volta al sostegno e al perfezionamento delle istituzioni di questa società. Anche quando la loro azione disgregatrice avvenne quasi involontariamente, oppure assunse l’aspetto esteriore della banale esercitazione retorica, resta denominatore comune dell’astensione di ogni contributo diretto al mantenimento dell’autorità costituita.
Una preoccupazione di questo genere era sorta nel curatore della edizione italiana del condensato della Storia dell’anarchismo di Max Nettlau, Giuseppe Rose, che scriveva: «Quanto al lavoro di Nettlau che viene ora pubblicato (e l’appunto potrebbe estendersi alla grande Storia dell’Anarchismo), deve dirsi che il richiamo a certe antiche fonti, quali espressioni di anarchismo, ci appare esagerato, anche se giustificato, per come si è già rilevato, dal modo di intendere la storiografia da parte del Nettlau. L’anarchismo, quale cosciente lotta contro una ben determinata autorità (quella dello Stato) – da parte del singolo, del gruppo, o di un intero movimento non ha importanza – nasce molto tempo dopo, in epoca molto vicina a noi, sicché quelle prime ed antiche manifestazioni d’intolleranza verso l’autoritarismo, in senso generico, sono da considerarsi come gli albori nebbiosi del nascere di un pensiero libertario, allo stato fetale e successivamente bambino. Una storia dell’anarchismo, a nostro modo di vedere, non può abbracciare tutte le manifestazioni di umana rivolta contro l’oppressione toutcourt, giacché significherebbe scrivere la storia dell’umanità e lasciare entro contorni vaghi l’ideologia e l’azione dell’anarchismo, il quale appunto perché possiede una sua ben precisa fisionomia, ha anche il suo ... atto di nascita». (Breve storia dell’anarchismo, tr. it., Cesena 1964, p. XIX).
Preoccupazione infondata, a quanto ci risulta, per due motivi che l’amico Rose non ha tenuto presenti. Primo, non è affatto vero che la ricerca condotta da Nettlau sulle origini dell’anarchismo, ricerca prolungata fino ad epoche remotissime, sia giustificata solo dal suo modo di concepire la storiografia. In pratica questa affermazione sarebbe valida solo nel caso in cui Nettlau avesse voluto veramente tratteggiare la storia della ribellione umana all’autorità, storia che, come giustamente nota Rose, finirebbe per confondersi e forse coincidere con la stessa storia dell’umanità. Invece Nettlau ha cercato di individuare singoli spunti di pensiero, singoli pensatori, singoli pezzi di ben precisi lavori, che presentano le caratteristiche della rivolta verso l’autorità, il tutto al di là del contesto generale che assume, al più, l’aspetto dello sviluppo progressivo, interrotto di volta in volta da continui ritorni della reazione. La concezione storiografica di Nettlau è quindi fuori causa, i suoi scopi erano molto più limitati. Infatti se da un lato afferma: «Una storia dell’idea anarchica è inseparabile dalla storia di tutte le evoluzioni progressive e dalle aspirazioni verso la libertà...». (Ib., p. 1), dall’altro ammette: «pochi uomini sono giunti a formarsi una vera e propria coscienza anarchica, ed anche coloro che si sono battuti per delle libertà limitate ne hanno raramente ed insufficientemente compreso l’essenza ed hanno, invece, spesso tentato di conciliare le nuove libertà col mantenimento delle antiche autorità». (Ib., pp. 1-2). E più avanti: «Queste ricerche storiche ci insegnano ad essere moderati nelle nostre aspettative, giacché, mentre non sarebbe difficile trovare i più sperticati elogi della libertà, dell’eroismo dei tirannicidi e di altri ribelli, nonché delle rivolte sociali, ecc., è invece assai rara la coscienza del male immanente nell’autoritarismo e la completa fiducia nella libertà, per modo che, le manifestazioni di pensiero più sopra menzionate sono da considerarsi come i primi tentativi intellettuali e morali per progredire senza numi tutelari e senza catene coercitive». (Ib., p. 9).
Quindi Nettlau ebbe la chiara idea dei limiti di una ricerca condotta tanto indietro e non si illuse mai di pervenire a una indiretta unificazione della storia della rivolta con la storia dell’umanità, quindi con una ipotetica storia dell’anarchismo come storia dell’umanità. E qui risiede il secondo punto non tenuto presente da Rose. L’atto di nascita dell’anarchismo moderno in effetti non è mai esistito, è esistita invece l’attuazione di manifestazioni di pensiero e di azione dirette a scopi diversi, capaci di rivolgersi a ceti più ampi e capaci, soprattutto, di uscire dalla prigione dorata del pensiero da élite. Questo è il segno dell’anarchismo come l’intendiamo noi oggi.
Vale la pena di spendere qualche parola per le affermazioni di George Woodcock contenute nel suo L’anarchia, storia delle idee e dei movimenti libertari (tr. it., Milano 1966), se non altro per dimostrare ulteriormente la malafede e lo scarso senso storico di questo autore, doti che si manifestano ampiamente anche sul problema dei precursori, come per altro trovano maniera di apparire a chiare lettere nel corso di tutti i suoi lavori dedicati all’anarchismo, ai suoi uomini e alle sue idee. Scrive il nostro autore: «Ma le radici di questo frondosissimo albero genealogico sono di gran lunga troppo deboli per la corona di rami che dovrebbero reggere. Anche un esame frettoloso degli scrittori chiamati in causa dimostra che quella che è stata tante volte presentata come la preistoria dell’anarchia è piuttosto una mitologia creata per conferire autorevolezza a un movimento e alle sue teorie, più o meno nello stesso modo in cui un clan o una tribù primitiva creano miti totemici per conferire autorevolezza alla tradizione o a un dato tabù. Nel rivendicare più o meno remote ascendenze, i teorici e gli storici dell’anarchia non si rendono conto che, sebbene la ribellione e il desiderio di libertà siano entrambi elementi antichissimi nella società umana, essi cambiano forma con il mutare delle situazioni storiche. Prendiamo per esempio il caso di grandi e famosi ribelli dell’antichità classica come Bruto o Spartaco, certo entrambi si batterono in buona fede per una loro idea della libertà, e tuttavia né Bruto, che in nome degli interessi di un’oligarchia patrizia combatté contro la minaccia della dittatura, né Spartaco, che cercò di liberare gli schiavi affinché potessero tornare ai loro paesi e alla loro esistenza d’un tempo, avrebbero condiviso e neppure capito le idee di uguaglianza economica, libertà, abolizione delle classi che gli anarchici del diciannovesimo secolo svilupparono in reazione allo stato capitalista sempre più centralizzato e meccanizzato». (Ib., pp. 32-33).
Anche escludendo il sottile atteggiamento di sufficienza che si ricava dalla lettura della prima parte del pezzo riportato e volendosi soffermare, con serietà, sulla seconda parte, non si possono concedere attenuanti allo studioso. L’errore è molto simile a quello che anche altri studiosi commettono nel considerare il rinvio alle origini, nel problema storico dell’anarchismo, cercare di considerare l’anarchismo moderno nella molteplicità delle sue formulazioni dottrinali o, sia pure in una qualsiasi di esse, nel calare queste formulazioni nell’attività pratica di esso come movimento politico e nel cercare, indietro nei secoli, esempi di questa realtà tipicamente moderna. È logico che simile procedimento non solo è assurdo storiograficamente, ma anche è privo di qualsiasi utilità concreta.
A questo si aggiunge la malafede tipica di Woodcock nell’impostare la ricerca. Ad esempio, restando nei termini del suo stesso esempio, se Bruto resta ben delineato il discorso di Spartaco non è del tutto vero. La rivolta che prese l’inizio dalla scuola dei gladiatori di Capua si trasformò in breve in una specie di movimento di liberazione degli schiavi, capace di mettere in campo un esercito equipaggiato e armato di quarantamila uomini. (Cfr. G. Giannelli, S. Mazzarino, Trattato di storia romana, vol. I a cura di G. Giannelli, IV ed., Roma 1970, p. 377). Come conseguenza si ebbe che l’iniziale disegno di assicurare il rimpatrio degli schiavi, per cui Spartaco stesso diresse le operazioni per il passaggio al Nord dei rivoltosi, che si radunarono nei pressi di Modena, si trasformò nella pretesa di attaccare e distruggere Roma. Le operazioni che l’esercito dei rivoltosi condusse nel litorale adriatico e in Lucania non furono altro che l’attesa del compito finale dell’attacco alla capitale. Proprio perché a Roma si era sicuri di questo si approntarono forze tali che non si erano mai viste per una lotta contro le rivolte di schiavi (in precedenza ce ne erano state altre due). Non è vero quindi quello che dice Woodcock, o almeno non è vero del tutto. I rivoltosi avevano la possibilità di applicare il piano iniziale – tornarsene nelle terre di origine – ma non lo vollero attuare. La storiografia borghese che ha sempre sbrigato con poche righe il problema ha visto in questo, come dice Mazzarino, “l’ebbrezza di trionfo e di rapine”, la letteratura anarchica ha invece cercato di idealizzare al massimo questa vicenda (cfr. G. Bifolchi, Spartaco. La rivolta che dura, Cesena 1971), per contro, a nostro avviso, ci sembra che la figura e l’azione di Spartaco e di coloro che lo seguirono in quella lotta sia da rivalutare alla luce di una considerazione non “moderna” del problema ma storicamente esatta. Al di là del ritorno alla vita precedente gli schiavi posero la vendetta contro la classe dominante che li aveva sfruttati e ridotti al rango di oggetti. Una rivolta che nebulosamente contiene degli stimoli libertari, nient’altro che questo.
L’altro punto della tesi di Woodcock, cioè che l’albero genealogico sia stato costruito apposta per dare autorità a un’idea e a un avvenimento, trova immediata contraddizione nel fatto che il ricorso ai precursori è valido solo per figure “scomode”, quasi mai per i grandi uomini, cosiddetti dalla tradizione e dalla storiografia borghese. In pratica, ad esempio, è possibile trovare in Fichte o in Kant notevoli spunti libertari, ma l’insieme della loro opera, per quello che abbiamo detto prima, non ammette la possibilità di essere considerata libertaria. Abbiamo invece pensatori come François Rabelais, Jean Meslier, Thomas Paine, Gerrard Winstanley, Denis Diderot, Gotthold Lessing, Étienne de La Boétie e altri che possono essere considerati precursori. Tutti uomini che la storiografia borghese ha considerato in una ben precisa dimensione, ponendoli all’estremo delle opinioni correnti. È logico che ogni tentativo di ricorso a queste “autorità” non sarebbe argomento convincente per uno storiografo borghese e tanto meno per un lettore borghese. Ma questa faccenda della ricerca dell’autorità nella ricerca dei precursori è negata dalla stessa essenza delle idee anarchiche, per cui è un vero e proprio torto, come in effetti è quello che viene a fare Woodcock, affermare l’esistenza di questa tendenza.
Vediamo adesso di esaminare un altro metodo, originalissimo, di indagare le origini dell’anarchismo, quello di Kropotkin. Egli scrive: «Come il socialismo in generale e come ogni altro movimento sociale, l’Anarchia è nata in seno al popolo e non conserverà la sua vitalità e la sua forza creatrice che restando popolare. In ogni tempo, due correnti si sono trovate in lotta nelle società umane. Da una parte, le masse, il popolo, elaboravano sotto forma di costumi un gran numero di situazioni necessarie per rendere possibile la vita in società... Dall’altra parte, vi furono in tutti i tempi degli stregoni, dei maghi, dei facitori d’oracoli e di miracoli, dei preti... È evidente che l’Anarchia rappresenta la prima di queste due correnti, ossia la forza creatrice, costruttrice delle masse, che elaboravano le istituzioni di diritto comune, per meglio difendersi contro la minoranza dagli istinti dominatori». (La scienza moderna e l’anarchia, tr. it., Ginevra 1913, p. 13).
È logico che questo punto di vista, se affascinante, non risolve la totalità del problema delle origini. Giustamente più avanti lo stesso Kropotkin parla della ribellione dei singoli individui che riescono a emanciparsi e si ribellano contro l’istituzione. Ma dobbiamo distinguere tra questi individui coloro che combattono l’istituzione perché fonte dell’autorità artificiale e individui che la combattono per modificarla e costruirne una più efficiente e capace di meglio consentire il dominio sulla maggioranza. Ora, escludendo questa distinzione, resta il fatto che anche in Kropotkin, che pure avanza l’idea di una origine popolare dell’idea anarchica, è presente la necessità di individuare l’opera e la presenza di singoli che seppero rompere le catene della servitù.
In altri termini, a prescindere della solita critica fuor di luogo di Woodcock (L’anarchia, op. cit., p. 31), con Kropotkin siamo davanti a una visione molto aderente alla tesi moderna riguardante le origini dell’anarchismo. Singoli pensatori si ribellano e cercano la possibilità, per noi che osserviamo quelle lontane vicende con gli strumenti limitati dello storico, di stabilire una presenza rivoluzionaria, sia pure da élite. Accanto alla loro isolata ribellione, la massa lentamente elabora una prospettiva diversa da quella ufficiale imposta dal potere coordinato. Questa elaborazione se non è documentabile in una presenza letteraria è rintracciabile in alcune vicende storiche, in manifestazioni embrionali di massa che, comunque, escono fuori dal presente lavoro e dalla prospettiva che intendiamo attuare con la raccolta che presentiamo. [Originariamente questo scritto era stato pensato come introduzione a un’antologia dei precursori dell’anarchismo]. Resta la realtà finale, l’epoca matura dell’anarchismo in cui lotta di popolo e pensiero teorico si identificano interagendo vicendevolmente. Rivoluzione francese e Illuminismo, 1848 e Socialismo utopista, Comune di Parigi e Anarchismo, ecc. per la Rivoluzione Russa e per la Guerra Civile spagnola fino al Maggio francese del 1968.
Certo in questa prospettiva kropotkiniana manca una base per capire il rapporto tra rivolta del singolo e rivolta della massa. Un travaso, come abbiamo detto, per quanto continuamente interrotto e contrastato dal potere, esiste ed è rintracciabile, ma un rapporto preciso sfugge all’indagine sia oggi sia ai tempi di Kropotkin. In un certo senso tutta la storia occidentale è attraversata da continui movimenti di rivolta. Società con grandi diseguaglianze economiche fanno scaturire movimenti di rivolta (Roma, India, ecc.) tali che non è possibile con i mezzi del potere costituito farli cessare del tutto. Società in cui esiste una uguaglianza teorica alimentano lo stesso sentimenti di rivolta nei singoli e, in certi casi di maturità, anche rivolte di massa. La semplice contrapposizione di due realtà non è sufficiente per giustificare il rapporto tra rivolta del singolo e rivolta della massa, il concetto di lotta di classe ne illumina soltanto una parte.
Ma, a ben considerare il programmatico contrapporsi di riforma e rivoluzione, ci si accorge che quest’ultima, mettendo in discussione i valori di una data epoca, non può non nascere da un’idea. L’estendersi di questa idea non è faccenda metafisica ma di propaganda e di azione rivoluzionaria, il coglierla, via via nel tempo, anche in momenti storici legati al più oscuro dei dispotismi, è faccenda che può essere sintetizzata dal coraggio o, se si vuole, dalla capacità storica di un singolo.
La guida è solo quella che ci viene fornita dalla comprensione della vera rivolta, della ribellione per la conquista dell’uomo nuovo, del rifiuto dell’autorità, non per la costituzione di un’autorità più raffinata e persistente ma per la sua definitiva distruzione. Tante sono le rivolte storiche e tanti i pensatori che in epoche diverse si rivolsero alla teorizzazione della rivolta, ma non tutte queste rivolte e non tutti questi pensatori entrano di diritto nella preistoria dell’anarchismo. Chiare le famose parole di Camus: «La rivolta, con questo, prova di essere il moto stesso della vita, e non la si può negare senza rinunciare a vivere. Il suo grido più puro, ogni volta, suscita un essere. È dunque amore e fecondità, o non è niente. La rivoluzione senza onore, la rivoluzione del calcolo che, preferendo un uomo astratto all’uomo di carne, nega l’essere tante volte quante occorrono, mette appunto il risentimento al posto dell’amore. Non appena la rivolta, dimentica delle sue generose origini, si lascia contaminare dal risentimento, nega la vita, corre alla distruzione e fa alzare la coorte ghignante di quei piccoli ribelli, seme di schiavi, che finiscono per offrirsi, oggi, su tutti i mercati d’Europa, a qualsiasi servitù. Non è più rivolta né rivoluzione, ma rancore e tirannia. Allora, quando la rivoluzione, in nome della potenza e della storia, si converte in meccanismo omicida e smisurato, diviene sacra una nuova rivolta, in nome della misura e della vita. Siamo a questo estremo. In fondo alle tenebre avvertiamo già l’inevitabile luce e non ci resta che lottare perché sia. Al di là del nichilismo noi, tutti, tra le rovine, prepariamo una rinascita. Ma pochi lo sanno». (L’uomo in rivolta, tr. it., Milano 1962, pp. 333-334).
Queste frasi di Camus si legano alle vicissitudini dolorose degli ultimi decenni ma, in se stesse, hanno una verità eterna, comunque valida a sufficienza nell’indagine che storicamente possiamo portare sulle varie rivolte del passato e sulla tesi dei diversi pensatori che hanno assunto una posizione estremista. Quando la rivoluzione è parziale, quando la teorizzazione rivoluzionaria è parziale, cioè quando ci si limita all’odio e al risentimento, il raccordo con la realtà delle lotte sociali, che dovrebbe restare legato solo alla necessità di costruzione dell’uomo nuovo, è assai debole e ben presto finisce per degenerare. In questo modo possiamo capire quando un pensiero, anche se all’estremo, ha tutti gli aspetti dell’estremismo rivoluzionario, almeno per i tempi che lo videro venire alla luce, non è altro, in sostanza, che un modo, efficace oltre misura perché camuffato, di ristabilire su nuove basi la forza del potere dell’autorità.
Adesso si capisce la preoccupazione di Malatesta: «L’anarchismo nella sua genesi, nelle sue aspirazioni, nei suoi metodi di lotta non ha nessun legame necessario con un qualsiasi sistema filosofico. L’anarchismo è nato dalla rivolta morale contro le ingiustizie sociali. Quando si sono trovati degli uomini che si sono sentiti come soffocati dall’ambiente sociale in cui erano costretti a vivere e la cui sensibilità è stata offesa dal dolore altrui, come dal dolore proprio, e questi uomini si sono convinti che buona parte del dolore umano non è la conseguenza fatale di inesorabili leggi naturali o soprannaturali, ma deriva invece da fatti sociali dipendenti dalla volontà umana ed eliminabili per opera umana allora fu aperta la via che doveva condurre all’anarchismo». (“Pensiero e Volontà”, 16 maggio 1925).
Legame necessario, intende Malatesta, nel senso di impedire ogni comprensione dell’azione dell’anarchismo se non alla luce di una ben determinata prospettiva filosofica. La conoscenza precisa di un sistema filosofico non è necessaria alla comprensione dell’anarchismo. Di più, come scriveva altrove lo stesso Malatesta: «Si può essere anarchici qualunque sia il sistema filosofico che si preferisce. Vi sono anarchici materialisti come ve ne sono di quelli, come me, che senza nulla pregiudicare sui possibili sviluppi futuri dell’intelletto umano, preferiscono dichiararsi semplicemente ignoranti». (“Pensiero e Volontà”, 1 luglio 1925). Anche non giustificando del tutto questa conclusione che al più andrebbe vista, a nostro avviso, soltanto nell’angolazione dell’azione direttamente rivoluzionaria e non nell’angolazione complessiva di tutti gli interessi dell’anarchismo, resta il fatto, chiarissimo, che il pensiero filosofico borghese e reazionario nelle sue grandi linee può essere utilizzato per la costruzione del mondo nuovo in ben modesta misura. Nato dalla rivolta, l’anarchismo è conscio di questa dura realtà e si rivolge al passato con quelle cautele e, anche, con quei sospetti – quello di Malatesta è un esempio tra i tanti – che la tradizione di soprusi e di sangue rende giustificatissimi.
Ma pur al di dentro di questa barriera di sospetto, l’indagine s’impone quasi inevitabilmente. Se, ad esempio, teniamo presente il mito di Prometeo che, come ha notato Paolo Rossi «ha accompagnato costantemente lo sviluppo della coscienza culturale dell’Occidente da Esiodo a André Gide» (I filosofi e le macchine (1400-1770), Milano 1962, p. 177), si colgono i termini di un’angolazione storiografica utile ma decisamente condannabile dal punto di vista della genuinità della ricerca storica e, quindi in ultima analisi, del suo stesso potersi utilizzare. Usando le stesse perplessità di Rossi diciamo: «Esiste un tipo di storiografia che crede di poter determinare il “significato” dei movimenti di cultura o dei pensatori del passato servendosi di una serie di formule riduttrici, teorizzate indipendentemente dalla ricerca, che eliminano come accidentali e irrilevanti tutti gli aspetti storicamente concreti delle varie dottrine che non si prestano a tale riduzione. La ricerca storica si riduce in tal modo a un affrettato rilievo delle varie “modernità” e a un lavoro di collocamento dei filosofi del passato al posto che ad essi necessariamente compete in un quadro “logico” tracciato a priori». (Ib., p. 175). Giusta preoccupazione di uno storico che non resta legato a schemi indissolubili e che ci indica, nel problema di individuare il filone della rivolta nel pensiero dell’uomo, la cautela e la più ampia larghezza di vedute. Lo stesso mito di Prometeo, ad esempio, ha una interpretazione in Eschilo e un’altra in Esiodo, una in Agostino e una nei filosofi del Rinascimento, poniamo in Pietro Pomponazzi o in Charles de Bouelles. Mentre per Esiodo Prometeo è un mito di creazione, per Eschilo è un mito di ribellione verso il potere tirannico degli dèi, mentre per Agostino Prometeo è un mito “riformista” in quanto è considerato come l’inventore delle arti e degli strumenti dei vivere civile, per Bouelles, Pomponazzi e altri filosofi del Rinascimento, Prometeo è il “filosofo” dell’espressione dell’individuo che si erge contro il potere supremo e determina la nascita di qualcosa di nuovo, è in altri termini il mito della centralità e della dignità dell’uomo.
Crediamo di avere fissato le condizioni alle quali il nostro intero discorso sui precursori dell’anarchismo può avere possibilità di risultare coerente, nessuna pretesa di autorità nelle ricerche “preistoriche”, nessuna individuazione dell’uomo chiave che possa dall’alto della sua antica dottrina autorevole illuminare la realtà attuale dell’anarchismo, soltanto una modesta indagine alla ricerca delle ribellioni contro ogni forma di autorità, ribellioni che attestano ancora oggi la presenza della volontà dell’uomo di abbattere il potere anche in tempi tanto oscuri che da per se stesso questo solo pensiero diventava una grande conquista.
Certo bisogna avere chiare alcune cose nell’intraprendere una ricerca del genere. Per cominciare, le diverse caratterizzazioni che la storia assume da un punto di vista ideologico. Non allo stesso modo può essere esaminato il mondo dei Greci e quello del Medioevo. Epoche diverse corrispondono quindi a diversi modelli di rivolta.
[1972]
Contro gli intellettuali
L’attacco di un intellettuale contro gli intellettuali può essere valido e giustificato solo in un caso, quando chi lo conduce si sia reso conto non solo della pericolosità del ruolo storico degli intellettuali ma anche della loro latente tendenza al dominio e allo sfruttamento.
Infatti, solo nel caso che gli intellettuali si riconoscano come una ristretta cerchia di privilegiati, slegati e contrapposti alle masse, hanno una loro ben definitiva fisionomia che li giustifica come entità sociologica, in caso contrario scompaiono come intellettuali e si ripresentano, all’interno delle masse, come punta avanzata delle lotte rivoluzionarie di quest’ultime, come avanguardia cosciente.
Ma, non possiamo nasconderlo, questa non è la realtà che osserviamo tutti i giorni, specialmente in Italia. In una società travagliata da un parto difficilissimo, in una struttura economica che non riesce a superare le antinomie di un capitalismo avanzato, basato su di un consumo sempre maggiore dei beni prodotti, in una tradizione politica di sinistra che finalmente si accorge del tradimento dei partiti revisionisti, l’intellettuale intende conservare ancora il suo piccolo, miserabile, privilegio.
Non mi riferisco soltanto a quei quattro stronzi della pseudo-cultura borghese e retriva, non mi interessano le teste di cazzo che oggi si trovano nelle varie cattedre universitarie e blaterano le solite annose imbecillità spacciandole per verità sacrosante, non mi interessano nemmeno gli intellettuali cosiddetti liberi che si affaticano a cavare fuori dalla merda solida del proprio cervello qualche cognizione su che cosa passa davanti ai loro occhi accecati dalla febbre del denaro e della scalata sociale. Il mio discorso si incentra verso gli intellettuali di sinistra, quelli che purtroppo frequentemente soltanto a parole parlano di lotta di classe, ma dall’interno delle loro calde poltrone, con la pancia ben piena, con un più o meno grande conto in banca, con la macchina di media cilindrata davanti la porta. Sono queste facce di culo che vorrei portare davanti al tribunale delle proprie responsabilità, è contro di essi che più di tutti gli altri è giusto spingere la critica.
L’intellettuale di sinistra ha una grossa responsabilità, continuando a restare all’interno della sua dimensione privilegiata, pur parlando in termini di contrapposizione di classe finisce per fare capire agli altri, a quelli che ancora lo stanno ad ascoltare invece di mandarlo a fare in culo, che tutto il problema rivoluzionario è proprio lì, nel discutere e analizzare, mentre il resto, la lotta concreta nelle piazze e nelle fabbriche, nei quartieri e nelle scuole, nelle campagne e nelle strutture burocratiche dell’esercito e della polizia, sono faccende estranee, lontane, che avverranno per maturazione spontanea, senza che ci si debba preoccupare di studiarne la realizzazione insieme alle masse e dal di dentro dei problemi degli sfruttati.
Costoro non solo sono da condannare, ma individuando in essi, nella loro preparazione e nella loro possibilità di capire alcuni meccanismi dello sfruttamento, un elemento notevole di lotta contro gli sfruttatori, non ci resta altro che considerarli potenzialmente come dei controrivoluzionari.
Non è possibile continuare il discorso rivoluzionario nascondendosi dietro il paravento della rispettabilità borghese, non possiamo più tollerare che gente come Leonardo Sciascia o Ignazio Buttitta ci parlino a nome di una sinistra che loro stessi hanno tradito. Se li lasciassimo impunemente parlare si finirebbe per fare capire alle masse che veramente il compito rivoluzionario che li aspetta è quello di continuare sulla strada delle riforme, fino alla conquista del potere da parte del partito comunista. Se lasciassimo i letterati continuare sulla strada della concessione e della reciproca convivenza, la reazione borghese e fascista finirebbe ancora una volta per avere il sopravvento.
Dobbiamo capire che gli intellettuali non hanno nessuna autorizzazione dall’alto che li possa far considerare una “casta superiore”. Tutto il loro lavoro deve essere fatto non per le masse, ma all’interno delle masse. Non è vero che ci deve essere un rapporto tra intellettuali e masse, ma all’inverso gli intellettuali devono essere nelle masse, all’interno di queste, confondersi con queste. Ogni altro contatto è di tipo autoritario e porta soltanto alla formazione di un dominio intellettuale sulle masse dei lavoratori. Questa è una verità che gli studenti – il serbatoio tradizionale da cui provengono gli intellettuali – hanno ormai capito. A chiarire loro le idee è stata la presa di coscienza del fatto di essere sfruttati come e forse di più di quanto siano sfruttate le masse dei lavoratori. Questa unità di classe è la base delle lotte future e non deve essere rotta in alcun modo dal barocco atteggiarsi di qualche bastardo intellettuale che intende portarsi dietro i suoi problemi isterico-sentimentali, inserendoli in una dimensione che solo in apparenza sembra quella della sinistra di classe.
Tutto ciò ci spiana di molto il cammino. Scadono gli impegni precedenti dell’intellettuale, anche di sinistra. L’estetica borghese va a farsi fottere, sorge un bisogno più pressante: trasmettere qualche cosa alle masse in lotta, essere nella rivoluzione dal di dentro, non vedersela passare sotto le proprie finestre restando nell’illusione di poterla indirizzare verso questo o quell’obiettivo.
È quindi compito del poeta, dello scrittore, ecc., quello di costruire la parola d’ordine della rivoluzione, quello di abbattere i falsi miti che la borghesia agonizzante costruisce sul tracciato della rivoluzione, quello di porsi come parte della massa impegnata nella lotta di liberazione.
In questa dimensione il problema del “che dire?” diventa centrale. Non si vuole qui fare una critica alla tematica di alcuni e indicare in quella di altri l’unica verità possibile, al contrario si vuole precisare che non esistono tematiche fisse. La parola d’ordine della rivoluzione può trovarsi, e storicamente si è pure trovata, anche in una poesia d’amore, ma all’inverso non tutte le poesie d’amore sono parole d’ordine della rivoluzione.
Quindi chiarezza del messaggio. Canone realista che si trova in molti manuali estetici borghesi. E allora, in che cosa consiste la novità della posizione del rivoluzionario? Proprio in questo: quella chiarezza non è un fatto oggettivo, ma un fatto che emerge dalla persona che la pone in essere, dalla chiarezza che ognuno ha finito per ritrovare in se stesso.
Non è possibile che parole chiare ci pervengano da un letterato, per quanto di sinistra, che resta legato alla dimensione borghese della vita, ai valori tradizionali che condizionano e costituiscono questa dimensione, ai tabù che storicamente l’hanno resa possibile. Quand’anche questo messaggio contenesse parole “estrinsecamente rivoluzionarie” esse sarebbero vuotaggine letteraria, mera esercitazione retorica priva di senso logico e, quel che è peggio, di senso morale. Quelle parole sarebbero la denuncia peggiore di una mistificazione e di un tentativo di passare al di sopra delle masse, giocando con le parole sulla loro pelle e sul loro sangue.
Più volte abbiamo sentito parlare di letterati “impegnati”, di intellettuali che alla generica posizione di sinistra, ormai impastata nella vecchia paccottiglia democratica, hanno aggiunto gli orpelli di una “contestazione globale” al sistema. Più volte abbiamo letto le loro smancerie, le loro pochezze letterarie, i loro ridicoli sforzi di impostare un discorso distruttivo al di dentro delle vecchie categorie del pensiero borghese.
Una realtà come questa è veramente alla luce del giorno in Sicilia. Qui gli sforzi di molti scrittori per legarsi a un concetto spurio di lotta di classe, dando nuova linfa al loro rinsecchito o mai esistito contenuto, sono esemplari.
Ma la verità è che tutta questa brava gente non vuole sul serio combattere contro i porci, perché in definitiva anche per loro l’infame brodaglia che alletta i setolosi antagonisti costituisce punto di riferimento e agognata meta. In pratica essi hanno scelto una strada diversa per arrivare agli stessi risultati. Hanno scelto la strada dell’impegno e della contestazione per fortificare le basi del sistema, quel sistema che domani, dopo la restaurazione, garantirà il loro dominio e la loro fortuna.
Non è possibile operare una netta divisione tra realtà e fantasia, tra compromessi quotidiani e costruzione letteraria. Non è possibile contemporaneamente scrivere contro il sistema e lavorare costantemente per arricchire o rendere più comoda la propria posizione sociale. Non è possibile nemmeno utilizzare le vecchie scuse della retorica passata, la sospensione del giudizio, l’astrazione teorica, il rapimento poetico, scuse per non pescare fino in fondo nel fango della propria realtà, nella pochezza dei propri orizzonti.
Ora, gli intellettuali sono per definizione i più adatti a ricorrere a questi espedienti astratti per giustificare la propria schifosa situazione di opportunisti. Se consideriamo la storia del pensiero rivoluzionario, vediamo come sistematicamente le tesi principali siano state voltate e rivoltate a cura di gruppi di intellettuali, al solo scopo di garantire una migliore e più inattaccabile posizione di dominio e di sfruttamento.
Specie in Sicilia, come dicevamo, l’impegno dei leccaculi è veramente notevole. Qui, come in ogni zona sottosviluppata che si rispetti, l’intellettuale ha una sola via per farsi strada, attaccarsi a qualche santo protettore del Nord, qualche scrittore o qualche funzionario di grossa casa editrice, iniziare una lunga attività di adulazioni e preghiere, andare a fargli visita, inviargli periodicamente bigliettini di auguri e cassette con arance o fichidindia, e poi aspettare pazientemente.
In Sicilia, infatti, non esistono casa editrici, non esistono grossi giornali di sinistra o riviste specializzate, tutto si trova al Nord, quindi è giusto che tutti gli sforzi vengano fatti rivolgendosi al Nord. Da ciò la duplice attività di merda di tutta questa gente, da un lato il compromesso quotidiano, per assicurarsi una posizione sempre più sicura e redditizia, dall’altro il compromesso saltuario ma altrettanto impegnativo sul piano morale, per assicurarsi una posizione più forte nel campo delle lettere. Il contenuto di ciò che si scrive, i motivi che determinano i contrasti presenti nei propri lavori, le forze rivoluzionarie che uno scrittore riesce a mettere in moto, le prospettive che pone in atto per il futuro dell’uomo, tutta roba che assume una importanza decisamente secondaria.
È questa la realtà. È proprio per questo che scrittori come Sciascia continuano a dettare legge in campo nazionale, all’interno del loro piccolo dominio, sebbene dal punto di vista del contenuto ormai siano quasi per non dire più niente. È per questo che Ercole patti continua a balbettare, che Ignazio Buttitta insiste su temi reazionari spacciandosi per comunista e per generico e inconcludente antifascista.
[1972]
Disponibilità
La lotta organizzata contro il potere repressivo può assumere forme molto diverse, dalla manifestazione non violenta all’attentato terrorista. La scelta dei mezzi è, di volta in volta, dettata da motivi contingentali di produttività dell’atto rivoluzionario, ma predeterminata in anticipo da chiusure nei confronti di certi specifici mezzi che si trovano a portata dei compagni impegnati nella lotta.
Questo è un principio fondamentale. L’atto terrorista stesso, l’attentato nel migliore stile ottocentesco della tradizione anarchica, non è mai condannabile a priori, ma solo a posteriori, studiando la situazione e le conseguenze, può essere considerato più o meno produttivo.
Ma, quanto si è detto, pure rivestendo le caratteristiche dell’evidenza, incontra un ostacolo gravissimo nella stessa chiusura psicologica di molti compagni che, disponibili per qualsiasi atto rivoluzionario in generale, non lo sono per uno specifico, per cui si finisce per trovare ostacoli di natura idealistica dove meno uno se l’aspetterebbe.
Si può avere il caso di colui che, prontissimo a qualsiasi cosa, non si trova a suo agio con un’arma in mano, o si lascia prendere dal panico. Si può anche verificare che chi è disponibile per uno scontro cruento, non lo sia più quando l’attività rivoluzionaria si sposta nel campo dell’espropriazione, ovvero della rapina alle organizzazioni capitalistiche, alla estorsione, al rapimento.
In particolare una tradizionale ritrosia si è sempre avuta nelle organizzazioni di sinistra riguardo al cosiddetto banditismo sociale. Spesso la condanna non è solo venuta dalle forze istituzionali ma anche dagli stessi movimenti rivoluzionari, poco propensi a estendere la loro tutela a dei “ladri”. Il fatto che questi ladri si siano battuti per la causa della rivoluzione, morendo, nella maggior parte dei casi con pochi soldi in tasca, falciati dalle pallottole della polizia, lasciando le famiglie nella più nera miseria, non ha avuto assolutamente importanza, non è facile distinguere ladro da ladro, il potere non ci riesce e i sedicenti movimenti rivoluzionari, a causa della loro forma burocratica, finiscono per non riuscirci neanche loro.
Eppure il bandito sociale è il rivoluzionario più conseguente, il più vicino alla realtà del problema, quello che si fa meno illusioni. Crede, come tanti altri, alla possibilità di un processo rivoluzionario nascente da certe condizioni obiettive, ma lavora perché queste condizioni vengano alla luce, rendendosi conto con chiarezza che perché ciò avvenga occorre usare gli stessi mezzi del sistema, obbedire alle stesse leggi del mondo capitalista, impadronirsi di parte, della maggiore parte possibile, di quello che è lo strumento più efficiente del nemico, il denaro, e usarlo per sollecitare la costituzione di quelle condizioni obiettive.
[1972]
Dimensione estetica e dimensione politica
I tradizionali termini della contrapposizione politica si sono modificati profondamente in questi ultimi anni. Come sappiamo, alla invecchiata forma della repressione dichiarata e feroce, al regno dei leoni, è succeduta una repressione più affinata e sottile (eccedente a volte in improvvise esplosioni di follia repressiva violenta), indirizzata in genere ad assorbire ogni tipo di contrapposizione, il regno delle volpi.
Accorgersi di questa evoluzione istituzionale non è faccenda difficile, specie per coloro che si definiscono scrittori e che dell’attività intellettuale hanno fatto, o cercano disperatamente di fare, una professione. Eppure ci accorgiamo sempre di più che siamo in errore. Lo abbiamo notato anni or sono quando ci occupammo dettagliatamente del problema della violenza (cfr. la nostra vivace polemica con Jacometti a seguito della critica apparsa sull’“Avanti!” diretta a snaturare l’interpretazione rivoluzionaria condotta nel nostro libro La distruzione necessaria). Comunque anche oggi non sono stati fatti molti passi nella strada di una chiarificazione.
Il perché di questa persistente ottusità – malattia quasi sempre cronica dell’intellettuale che non riesce a svincolarsi della cappa di piombo della propria struttura mentale – è da individuarsi nella mancanza di uno scopo veramente rivoluzionario che si ponga a base dello sconsiderato dibattersi di tanta parte della contestazione intellettuale.
Abbiamo esempi fondati sulla diretta esperienza personale di uomini e cose visti ed ascoltati a bocca aperta per lo stupore, abbiamo assistito a distorsioni operate coscientemente da intellettuali che ritenevamo impegnati fino in fondo in una lotta non certamente “riformista”, abbiamo avuto insieme a tutto ciò una certa quale disillusione sulla stessa possibilità dell’intellettuale di arrivare a riconoscersi come semplice mezzo di attacco e non come stato maggiore di un esercito esistente solo sulla carta. È sempre il riaffiorare di una certa mentalità autoritaria, che la polvere delle biblioteche alimenta costantemente, a causare questo stato di cose.
Immaginarsi poi quando questi intellettuali, nella sottospecie non ben identificata di “scrittori” (consideransi scrittori quegli animali non ben identificati morfologicamente che in una simbiosi trascendentale accomunano tendenze e concretizzazioni poetico-narrativo-artistico-musicali), si danno da fare per riconoscersi una coscienza di classe. Gli sforzi di questo riconoscimento, specie se inquadrati nel clima istituzionale di una repressione “morbida”, assumono il contorno di una farsa veramente gustosa. Questa gente non ha nemmeno l’idea della demarcazione necessaria tra “riforma” e “rivoluzione”, non si rende conto che è assurdo e contraddittorio andare a sostenere che bisogna chiedere agli organi istituzionali la riduzione ferroviaria o la casa o qualche altra amenità del genere, non ultima anche la pensione. Questa gente non si rende conto che l’acquisizione di una coscienza di classe avviene solo sul piano rivoluzionario, nel vivo di una lotta che non può ammettere mezzi termini, che non può essere dimensionata in senso riformista, ma che deve essere impostata fin dall’inizio nel segno del “vogliamo tutto, ecco perché non chiediamo nulla”.
Non chiedendo nulla si ha la prospettiva del tutto. La trascendentalità si colloca nella giusta dimensione del reale, diventa visione materialista della posizione storica di lotta della classe intellettuale, diventa l’anticamera di ogni vittoria e la possibilità di cogliere in ogni sconfitta la parte migliore che serva da insegnamento nelle future battaglie.
La conquista della libertà può essere attuata solo dopo la presa di coscienza di una certa posizione di classe, altrimenti la lotta avverrà in forma slegata e disarmonica, una lotta per le piccole cose che nelle piccole cose naufraga e scompare, una lotta senza scopo e senza mordente, capace solo di attirare gli spiriti meschini che nelle piccole cose si fondono e si riconoscono. Al di là di tutto questo la lotta decisiva, che gli scrittori devono cercare di porre in atto una volta riconosciutisi come classe, la lotta contro lo Stato e le sue ramificazioni imputridite.
Ancora una volta il discorso che vorrei fare allo scrittore, proprio io che sono del tutto fuori delle tradizionali forme di espressione e che mi occupo quasi esclusivamente di sociologia e politica, è quello dell’impegno, che non è poi tanto quello dell’espressione e – se vogliamo usare una parola più grossa – dell’arte, quanto quello della espressione e dell’arte (che è poi, nella somma dei due termini non antitetici, semplice comunicazione) nell’impegno politico, l’unica dimensione possibile per l’uomo che si riconosca veramente come tale e che voglia uscire dall’abbrutimento ideologico e dalla strumentalizzazione del potere istituzionale.
Ogni ricerca eccessivamente specifica, ogni indugio eccessivo sull’accuratezza della forma, ogni bamboleggiamento romantico, diventano subito stucchevole decadentismo nel momento in cui lo scrittore abdica l’impegno politico ripiegando sul frammentarismo provinciale.
Abbiamo in questo modo la possibilità di una nuova dimensione operativa. La necessità di una determinata comunicazione, di un allargamento del discorso a sempre più larghi strati di lettori, l’involontario ma importante assorbimento di una persistente corrente critica nei confronti delle istituzioni, contribuiscono a creare questa dimensione che è essa stessa una dimensione estetica, nel momento in cui viene in vita come dimensione politica e quindi di prassi.
Una riprova di questo fatto ci è data quando ingenuamente il lettore si ritrova a non gustare più un certo prodotto letterario, la causa è che quel prodotto, per certi motivi che possono andare dall’ottusità del produttore al fatto di essere collocato in una dimensione temporale del tutto tramontata, non mantiene più una correlazione con la dimensione politica che determinò la sua nascita o, se si vuole, condizionò a causa della sua assenza o della sua difettosa interpretazione la riuscita in senso stretto del prodotto letterario.
In ultima analisi, nessuna manifestazione letteraria, nessuna manifestazione dell’uomo, è scindibile in assoluto dalla dimensione politica.
Ecco perché non facciamo distinzione tra scrittore e uomo d’azione, non distinguiamo tra chi scende sulle barricate al momento della rivoluzione. Lo scrittore deve trovarsi al posto che la sua essenza di uomo gli suggerisce e gli impone, non essendo affatto vero che il posto dello scrittore sia sempre quello dietro la scrivania. Come ebbi a dire, e non mi piace ripetere le cose dette ma qui mi sembra proprio necessario, lo scrittore non deve restare sempre con la penna in mano, può arrivare il momento che questa penna deve essere sostituita con il fucile, in questo caso non accorgersi di questa necessità e restare abbarbicati al proprio tavolo di lavoro significa non avere nessuna sensibilità politica e quindi, come si è detto, nessuna sensibilità estetica, in altri termini significa essere dei pessimi scrittori o non esserlo affatto.
[“Dimensione estetica e dimensione politica”, pubblicato su “Volontà”, n. 6, 1971, pp. 467-469]
Rinascita del movimento libertario
Gaston Leval non ha bisogno di molti sforzi introduttivi. Militante anarchico da prima della guerra spagnola, è uno degli esponenti più accreditati del libertarismo mondiale, sempre in prima linea nei momenti decisivi che precedettero la caduta della dittatura de Rivera, costretto all’esilio, ritorna in Spagna per la preparazione della rivoluzione che trova i suoi giorni migliori nel 1936. In quegli anni di lotta Leval apporta il suo contributo di teorico e di propagandista oltre che di militante.
Questo l’uomo Leval, oltre, dopo le malinconiche chiusure della repressione franchista, quando altri prendevano o si mantenevano sulla strada della contrapposizione armata (cfr. A. Tellez, Sabaté. La guerriglia urbana in Spagna, tr. it., Ragusa 1971, p. 328), Leval pure non condannando apertamente queste prese di posizione andava chiarificando una sua particolare configurazione dell’anarchico, destinata a fare maturare non poche polemiche, oltre a una tematica che, per molti aspetti, ci risulta assai difficile condividere.
Qui di seguito, in questa Nota introduttiva, cercheremo in breve di chiarire i punti di contrasto tra le tesi di Leval e la disposizione di ricerca che ha reso possibile tutto il nostro lavoro di “Sinistra libertaria” e che informerà sempre di più le pubblicazioni che via via faremo nel corso della collana stessa.
Leval inizia il suo intervento al Convegno Seminario di studi sull’anarchismo indetto dalla Fondazione Luigi Einaudi nel 1969 con un’approfondita analisi della situazione attuale del movimento anarchico. Le conclusioni sono disastrose, non solo dal punto di vista numerico, ma anche da quello intellettuale e contenutista. La validità di queste indagini statistiche – per altro condotte a livello di notizie personali non controllate o controllabili e su di un settore in cui per forza di cose non si possono attingere dati certi – ci sembra assai dubbia. Da parte nostra, ed evidentemente da un punto di vista completamente opposto, in altra sede (cfr. A. M. Bonanno, Introduzione a L’anarchia di E. Malatesta, Ragusa 1969, pp. 5 e sgg.), avevamo concluso per una decisiva posizione di vantaggio dell’anarchismo, posizione che se non è stata conquistata per una virtù intrinseca dei singoli militanti – che spesse volte, e concordiamo in questo con Leval, sono rimasti legati a una predilezione per la vuota declamazione – come pure se non è stata conquistata per avvenimenti storici favorevoli all’anarchismo come costruzione concreta e determinata territorialmente, la si è venuta identificando lentamente nel tempo a seguito di una maturazione critica di tutti, tanto da consentirci di parlare di una vera e propria vittoria dell’anarchismo e della necessità di dare inizio al periodo della revisione critica.
Ora, se le cose stessero come dice Leval, se davvero tanto grama fosse la composizione dell’anarchismo mondiale, ci si dovrebbe accontentare della produzione apologetica e non invocare, come invece fa il nostro scrittore, l’avvento della revisione critica, che potrebbe scoprire tante pecche e fare diminuire i proseliti invece di aumentarli, la critica è da ricercarsi nel momento della stabilizzazione della base che finisce automaticamente per produrla, invece quando questa base non esiste la critica o non si produce o se si produce è negativa.
Comunque, non è questo il tema principale del discorso di Leval, quanto invece l’identificazione di alcune cause che hanno determinato il fallimento dei movimenti anarchici del passato. Tra questi motivi viene indicato per primo l’uso quanto meno improprio del termine anarchia, la qual cosa oltre che a fuorviare la gente, esistendo l’altro significato corrente di disordine, contribuisce solo a dare alla tematica libertaria un senso negativo, non costruttivo. È ovvio che qui, se da un lato dobbiamo concordare con Leval sulle possibilità di confusione che nelle persone non politicizzate ingenera di primo acchito il termine anarchia, dobbiamo negare la possibilità che l’uso di questo termine trasformi in senso soltanto negativo tutta la tematica anarchica e faccia della sociologia libertaria il regno dei morti. Francamente tutto ciò ci sembra un volere rivestire di sostanza quello che invece non è altro che una questione di forma con delle semplici implicazioni di natura comportamentista.
A questo assunto di partenza – che la questione terminologica finisca per diventare centrale – Leval passa all’identificazione di una vera e propria “ossessione rivoluzionaria”, incredibile negazione non solo della possibilità della riuscita di una rivoluzione popolare violenta, ma anche della stessa legittimità in sede libertaria. La posizione violenta rivoluzionaria viene quindi interpretata come la vana attesa del “Grand Soir” che, guarda caso, sono le stesse parole che il socialdemocratico Alberto Jacometti usava sulle pagine dell’”Avanti!” (“I limiti di certi tipi di contestazione, La distruzione necessaria”, in “Avanti!”, 10 dicembre 1969) per criticare la rivalutazione della rivoluzione violenta attuata nel mio libro (La distruzione necessaria, Catania 1968, pp. 40 e sgg.).
La validità della rivoluzione violenta, anzi la sua insostituibilità come mezzo a disposizione delle classi sfruttate per interrompere lo sfruttamento e dare inizio a una società nuova, non può essere posta in dubbio da una qualsiasi posizione determinista che poggi la propria base su di una concezione meccanicista della storia, ormai obsoleta anche in seno alle stesse formulazioni borghesi più retrive. Infatti è questo il motivo di fondo di Leval, motivo che utilizza soltanto una parte di Kropotkin e che tace dell’altra parte, quella rivoluzionaria e, guarda caso, violenta. Utilizzando solo il Kropotkin del Mutuo appoggio o dell’Etica bisogna comprendere che dietro sta tutto l’altro Kropotkin, quello delle Parole di un ribelle e quello de Lo Stato, quello de La conquista del pane e quello delle Memorie di un rivoluzionario, altrimenti si finisce per tradire il pensiero di un autore.
Tutto ciò, e quanto altro sorgerà davanti al lettore nel corso della lettura del lavoro di Leval che proponiamo nella collana “La sinistra libertaria”, deve essere tenuto presente, ed è proprio qui che individuiamo, a nostro avviso, la parte significativa delle riflessioni di Leval, l’azione di impatto, di rottura, che senz’altro determinerà nel lettore attento il ricorso a una serie di considerazioni che non potranno che tornare utili sotto ogni aspetto.
È naturale che il nostro lavoro di presentatori di una serie di opere che abbracceranno molteplici aspetti dell’attività di pensiero libertario, non potrà prescindere, come è accaduto di fatto per Leval, da una puntualizzazione chiara dei nostri intendimenti di ricerca, tanto più utile quanto più il campo delle opinioni e delle soluzioni prospettate si allargherà, e quest’ultimo aspetto sarà quanto cercheremo di attuare con tutti i nostri sforzi, proprio per evitare di fare “chiesa chiusa” e per dare al lettore un quadro completo delle forze agenti oggi in campo sotto il larghissimo prospetto di “sinistra libertaria”.
[Introduzione a G. Leval, Rinascita del movimento libertario, tr. it., Catania 1971]
L’anarchismo e i giovani
Il lavoro di Jean Maitron, presentato al Convegno Seminario di studi sull’anarchismo del dicembre 1969, indetto dalla Fondazione Luigi Einaudi, si articola su tre punti essenziali: a) un esame del pensiero anarchico tradizionale, b) la rivolta dei giovani, c) un tentativo di prendere in considerazione il rapporto tra i due punti precedenti.
Oggetto specifico della ricerca: il Maggio parigino del 1968 e la rivolta giovanile o più specificatamente studentesca che in quel momento vide la sua massima concretizzazione.
Il lettore si renderà subito conto, fin dalle prime battute, che la testimonianza di Maitron va al di là di un qualsiasi studio sull’argomento, essendo stato, egli, professore alla Sorbona, presente costantemente all’occupazione di quell’Università e a contatto con tutti i gruppi che vi parteciparono. In questo modo Maitron ha potuto prendere visione delle varie tendenze, discuterne i fondamenti con molti giovani, documentarsi sulla vasta congerie di opuscoli, comunicati, ciclostilati, scritte murali e altro che in quei giorni videro la luce. Tutto ciò va tenuto presente nel dare un’esatta collocazione sia allo sforzo del nostro autore di giungere a una chiarificazione del problema di fondo, sia alle inevitabili imprecisioni o, comunque, errate valutazioni che un argomento del genere necessariamente si porta dietro.
La conclusione proposta è un’ispirazione di fondo dell’anarchismo più che una presenza dichiarata e condensata in specifici testi della tradizione anarchica o dei suoi autori più rappresentativi. Conclusione che va analizzata in quanto potrebbe indurre il lettore a due tipi di errori, il primo di considerare sostanzialmente antiautoritarie espressioni del Maggio francese che invece restano legate alla tradizione autoritaria anche se esteriormente parvero disporsi in senso libertario. Ciò consentirà di effettuare una più o meno esatta discriminazione tra la componente veramente libertaria del Maggio francese e la componente di riporto o d’occasione. Il secondo errore sarebbe quello di considerare quest’ispirazione di fondo un’idea astratta, d’impronta eminentemente negativa (e quindi negativa anche dell’autorità), mancante in senso assoluto di una costruttibilità rivoluzionaria, quindi interpretabile con i canoni borghesi determinati dalla tradizione filosofica, canoni quasi sempre sufficienti a valutare movimenti non più rivoluzionari come ad esempio il comunismo parlamentare o revisionista.
Incominciamo col dire che la presenza dell’ispirazione di fondo, dichiarata da Maitron, trova altre testimonianze, diverse da quelle indicate dall’autore. Oltre l’affermazione di Louis Althusser, che individua nel movimento di maggio una “ideologia anarchica o anarchicheggiante”, la qual cosa, almeno nella sostanza, è molto diversa di una vera e propria ispirazione di fondo come quella considerata prima, in quanto investirebbe una razionalizzazione a livello teorico riconosciuto che, invece, non c’è stata. Comunque le altre testimonianze ci vengono da giovani e da studiosi che seguirono o furono dentro gli avvenimenti di Maggio. Ecco una dichiarazione di Daniel Cohn-Bendit rilasciata a “Magazine littéraire” del luglio 1968, «La domanda che pongo è come si possa non essere anarchici precisamente oggi. Tutto quello che è accaduto, questo movimento che ha sconvolto la Francia e che dicono si appresti a passare negli altri paesi è la conferma di tutti i grandi temi dell’anarchismo. a) La spontaneità delle masse. Bisogna essere ciechi per non averla vista. Durante le giornate di Maggio chiunque poteva prendere una bandiera rossa o una bandiera nera sul boulevard Saint-Michel e ritrovarsi seguito da qualche decina, poi da centinaia, poi da migliaia di giovani. b) Il ruolo delle minoranze. È stato esemplare in questo movimento. Non si è trattato, secondo la tradizione giacobina o leninista, di una minoranza organizzata come un esercito e destinata a prendere il potere. A questa tradizione si è opposta quella dell’anarchismo, una minoranza che suscita l’avvenimento e che lascia alle masse la cura di proteggerla. Non si è trattato di imporre la sua autorità alla società ma di darle l’occasione di svilupparsi. c) Lo sciopero generale illimitato. Da decine di anni ci veniva ripetuto che si trattava di un’utopia, e bruscamente malgrado l’inquadramento sindacale, è diventato una realtà. Contro i sindacati. d) L’autogestione. Oggi tutti ne parlano come di qualcosa di normale. Prima mi dicevano che era un’utopia. e) Le elezioni. È provato che sono soltanto un modo per mantenere l’ordine». Qui i termini dell’anarchismo ci stanno tutti, in particolare di un anarchismo che si rivolge ai giovani, che interessa i giovani, di un anarchismo che non si ferma al culto di Ravachol o Bonnot, come pure non si ferma alle teorizzazioni di Kropotkin o di Bakunin, ma di un anarchismo conseguente e diverso, capace di alimentare una rivolta come quella di Maggio, tanto complessa e frastagliata nelle sue componenti. Della stessa nostra opinione sembra Edgar Morin, sociologo, attento studioso della rivolta di Maggio, che nello stesso numero sopra citato di “Magazine littéraire” dichiara: «Mi sembra che si possa parlare nello stesso tempo di una risurrezione e di una rinascita dell’anarchia fra la gioventù intellettuale… Questo fenomeno di risurrezione dell’anarchismo fra gli studenti è dovuto al fatto che in tutti i paesi, ivi compresa la Francia, una parte dei giovani vuole cambiare la propria vita insieme a cambiare la società».
Veniamo alla prima possibilità di errore. Molte componenti del Maggio francese non possono considerarsi che con molta buona volontà “libertarie”. Quegli stessi studenti che contestarono Louis Aragon, il cantore della Ghepeù e dello stalinismo, non possono dirsi libertari in senso vero e proprio, ma semplicemente estremisti rivoluzionari di sinistra che se rifiutano da un lato il paternalismo del partito tradizionale (paternalismo che per altro finirà poi per tradursi in vera e propria calunnia con l’entrata in azione della ventata controrivoluzionaria di cui fu investita l’“Humanité”) dall’altro si rendono conto dell’utilità di un tentativo di dialogo con i militanti di base del partito comunista. Ma il segno più profondo di questo libertarismo si ha veramente negli slogan inventati dalla gioventù, in quei giorni. Primo tra tutti “È vietato vietare”, apparso per la prima volta alla Sorbona. Tra i più interessanti in senso libertario ricordiamo: “L’immaginazione prende il potere”. “L’azione non deve essere una reazione ma una creazione”. “Inutile restaurare. La struttura è marcia”. “Lavoratore, tu hai 25 anni ma il tuo sindacato è nato il secolo scorso. Per cambiare, vieni a trovarci”. “Non esiste un pensiero rivoluzionario. Esistono degli atti rivoluzionari”. “Siate realisti, domandate l’impossibile”. E tanti altri che potremmo citare. In queste scritte sui muri, che tante lacrime fecero versare ai borghesi preoccupati delle operazioni di restauro, più chiaramente che nei numerosi libri usciti sull’argomento a posteriori, si legge appunto la morte della vecchia Università, che è un poco la morte del vecchio mondo, non proprio la nascita di un mondo nuovo.
Qui dobbiamo cogliere il punto più interessante della tesi di Maitron: il tema centrale della rivolta di Maggio non fu tanto l’anarchismo tradizionale quanto il libertarismo. Abbiamo quindi un trionfo dell’idea anarchica nei termini in cui questa coglie l’essenza profonda del libertarismo e non si chiude a nessun genere di riesame delle posizioni veramente rivoluzionarie.
Concordi nell’accettazione della componente libertaria, stabiliti i limiti della partecipazione di alcuni gruppi a questa componente, non resta da dire, a questo proposito, che si sono ingannati di grosso tutti coloro che hanno decretato la morte dell’anarchismo come idea. Tra questi va considerato lo stesso Henry Arvon che nel suo studio sull’Anarchismo della collezione “Que sais je?”, scriveva: “Il tempo ha fatto il suo lavoro relegando l’anarchismo nel numero dei movimenti di idee che è possibile studiare oggettivamente”. Se con ciò l’autorevole studioso vuole intendere che l’anarchismo si è abbastanza mummificato da essere possibile un esame obiettivo sui suoi resti, crediamo si sbagli di grosso, la parte mummificata dell’anarchismo è quella che non è mai stata presa in grande considerazione dagli anarchici, la parte relativa al corpus della dottrina. I grandi nomi del passato, siano essi Kropotkin o Malatesta, Stirner o Bakunin, sono stati considerati sempre dei rappresentanti dell’idea anarchica, mai dei fondatori o dei numi tutelari ai quali rifarsi continuamente per controllare l’esattezza del proprio pensiero. In questo senso, pertanto, siamo d’accordo con Maitron che parla di un antagonismo tra anarchismo e tradizione.
Veniamo per ultimo alla seconda possibilità di errore. L’idea libertaria, di cui abbiamo prima riscontrato la presenza negli accadimenti del Maggio francese, non può considerarsi un’astrazione operata a posteriori esaminando avvenimenti e materiali di un certo fatto storico, come se fosse possibile concretizzare un andamento statistico in mezzo a una presenza nettamente divisa in diverse tendenze. Nulla di tutto questo, dopo il Maggio 1968 l’anarchismo sembra essere diventato un’idea nuova in Europa, questa è stata la conclusione di uno studio di Jean Hurtin, apparso su “Magazine littéraire” subito dopo i fatti in questione. Infatti l’essenza di una nuova dimensione si coglie nell’analisi più approfondita e aperta che si pone in seno ai rapporti tra anarchismo e marxismo. A tale proposito citiamo un’altra parte dell’intervista concessa da Danil Cohn-Bendit a “Magazine littéraire”, «La vecchia generazione anarchica condannava in blocco tutti gli ideologi del comunismo. Essi mescolavano tutto. Per loro Marx era da rigettare insieme a Stalin. I marxisti per gli anarchici sono tutti piccoli borghesi, lo stesso per i vecchi “anars” i marxisti sono tutti stalinisti. I giovani anarchici accettano la critica marxista della produzione. Ma rigettano nello stesso tempo molto di Marx. Rigettano per prima cosa il ruolo che è accordato allo Stato nel periodo transitorio tra il capitalismo e il socialismo perché è con questa giustificazione teorica che si è arrivati allo stalinismo. Lasciano da parte anche tutto quello che appare come evidentemente falso nel marxismo, per esempio l’analisi delle crisi economiche, rigettando per prima cosa il ruolo che si accorda allo Stato nel periodo di una situazione rivoluzionaria nata non necessariamente da uno squilibrio economico. Il capitalismo per altro trova dei procedimenti per rispondere a queste crisi che lo minacciano. Per quel che mi riguarda, nego anche il ruolo che il marxismo attribuisce alla classe operaia considerata come la sola classe rivoluzionaria. Quando la massa degli operai sarà ridotta al 15% della popolazione attiva, capisco con difficoltà cosa potrà fare tutta sola». In questo modo il libertarismo rivelatosi come fondamento dei giorni di Maggio diventa costituito in forma positiva cancellando quell’ombra di negatività che l’interpretazione gratuita dei borghesi aveva inteso avvalorare. Il rifiuto della tesi marxista delle crisi è argomento di analisi economica che oggi non viene quasi più esposto a livello di fatto scientifico indiscutibile, come pure l’essenza della funzione dello stesso nella dottrina marxista ortodossa viene, in sede sociologica, vista attraverso la duplice considerazione (anarchismo = distruzione, marxismo = estinzione) comunque sempre nell’ammissione di fondo della necessità di “spezzare la macchina statale”.
Speriamo di essere stati utili al lettore con questa Nota introduttiva mentre rimandiamo al testo, nell’ottima traduzione del compagno Giuseppe Rose, per una presa di contatto conclusiva con l’interessante argomento del nuovo anarchismo giovanile. Lo sforzo interpretativo di Maitron deve considerarsi tanto più importante quanto più difficile è stato avvicinarsi ai documenti – farraginosi, confusi e numerosi – valutandoli nella loro essenza al di là dell’esteriore appartenenza.
[Introduzione a J. Maitron, L’anarchismo e i giovani, tr. it., Catania 1971]
Comunismo e individualismo anarchici
Quello che avevamo da tempo temuto è ormai cosa fatta. Gli avvertimenti di pericolo, i modesti tentativi di difesa, le lettere agli amici, le telefonate, a nulla sono valsi, la dilagante ondata della cultura universtaria si è riversata sulle sparute schiere della dottrina libertaria, travolgendole e sottomettendole in un batter d’occhio. Il sacrificio è consumato. Non ci resta che fare l’inventario di quello che è rimasto, ben poco. Il resto è ormai in pasto al nemico. Topi di biblioteca, selettori ufficiali di bibliografie, imbecilli ripetitori di parole altrui, canuti impotenti del pensiero, inefficaci ragionatori arrampicatisi con ardimento da vertigine fino alle più alte vette della carriera universitaria, si sono messi al lavoro. Tutto viene sezionato, tagliuzzato, disossato, catalogato, graduato, giudicato. Si stabilisce, con tronfia sicumera, che Malatesta ha avuto almeno due periodi di pensiero, che Kropotkin era un pacifista ma che in certi determinati casi era anche un violento, si elencano le differenze tra i settantadue modi d’intendere il termine “anarchia”, si compilano elenchi di attentatori, di banditi sociali, di teorici libertari. Tutto in un clima di generale euforia. Ognuno di questi imbecilli, per non passare per quello che in effetti è, corre subito ai ripari dandosi una preparazione affrettata su di un argomento che fino ad ieri non solo conosceva per sentito dire, ma al quale non assegnava valore dottrinario alcuno.
E di tutto questo dovremmo per giunta essere contenti. Dovremmo considerare concluso il nostro compito e passare la mano a codesti roditori perché possano portare a compimento il loro misfatto, dovremmo in altri termini ridurre il processo libertario a un banalissimo fossile che si studia all’università?
Sono certo di no. Anche se alcuni soloni, come i vari compagni Gino Cerrito, Carlo Doglio, Virgilio Galassi, Antonio Scalorbi, non rilevano il pericolo, questo esiste, ed è quello della mitizzazione, dell’inglobamento di una presenza culturale e di un’azione che non ha mai avuto nulla a che fare con la cultura borghese, che con essa non vuole avere a che fare, che ha sempre sputato in faccia alle strutture universitarie, ai preziosismi, alle ricerche erudite, ma ha costantemente cercato la riprova di se stessa nelle piazze, nell’azione rivoluzionaria diretta, lontano dai tetri ambienti delle biblioteche da cui, guarda caso, “escono i massacratori”.
Scusateci la tirata iniziale, che per altro riprenderemo in sede più acconcia, ma in un certo senso il lavoro di Joll – uno dei più rappresentativi esponenti del mondo universitario inglese di oggi – si inquadra perfettamente nel pericolo prima denunciato, ed è questo uno dei motivi che ci hanno indotto a pubblicare il suo lavoro, allo scopo di sollecitare nel lettore quella riflessione su questi problemi che non è mai sufficientemente diretta in forma critica verso quanti amano avvolgersi nel manto caritatevole dell’erudizione e della cultura ufficiali.
La conclusione di Joll è di riconoscenza verso il fenomeno anarchico, specie nelle forme che ha preso in questi ultimi anni, perché ha consentito di costituire un vero e proprio “laboratorio per lo studio delle idee politiche in azione”. Capirete! Roba da restare a bocca aperta. Ma è proprio la mentalità del professore universitario che lo porta a conclusioni di questo genere. In effetti, per lui, l’indecisione dell’anarchismo tradizionale a superare il dilemma tra individualismo e comunismo – naturalmente nel senso del comunismo e non in quello dell’individualismo – ha causato l’inefficienza di tutte le sue espressioni, l’inutilità sostanziale (dal punto di vista rivoluzionario) dei suoi sforzi, sebbene – grande merito – abbia sollevato le sorti della riflessione politico-filosofica.
I giovani, in alcuni casi ben determinati e, principalmente, fissati localmente in avvenimenti marginali, hanno superato questo dilemma ma soltanto a prezzo della rinuncia all’incidenza vera e propria sul piano di una lotta efficace contro le istituzioni costituite. Ad esempio, le esperienze delle lotte studentesche di questi ultimi anni hanno avuto certi risultati tradottisi in comuni veramente libere, ma di breve durata, isolate nello spazio e di nessuna incidenza sul piano della lotta.
Per questo il dilemma, continua Joll, nei giovani rivoluzionari di oggi, è andato via via sfumando d’importanza, trasferendosi nell’altro tra violenza e nonviolenza, tra autoritarismo e spontaneismo. Anche qui, con la presenza del nume tutelare George Sorel, la problematica sulla violenza non è affrontata nel suo giusto verso, diretto alla pratica risoluzione dei conflitti sociali, ma rilanciata (la complicità di Sorel non è casuale) verso un orizzonte mitico, la violenza inevitabile, liberatrice, come esperienza preziosa, ecc.
Capirete! hanno scoperto che Francisco Ferrer, il pacifista pedagogo, era implicato in un attentato per uccidere il re di Spagna. La cosa li getta nella prostrazione. Come mai? Un uomo come lui! Che sia una malattia questa degli anarchici di volere la violenza a tutti i costi? Questo spiegherebbe la diffusione dei testi di Sorel nei giovani rivoluzionari di oggi. Tutte fandonie. Non sono questi i problemi, qui ci stiamo allontanando, e Joll lo sa meglio di noi, dal nesso centrale del rapporto tra anarchismo e struttura sociale, rapporto che può essere inteso solo in senso di lotta, di lotta di classe, di combattimento e non di discussioni teoriche senza fine, di congressi e convegni, di ricerche erudite e smaniose di agghindarsi con i resti puzzolenti di una cultura che non ci ha mai detto nulla.
Joll lo sa, ma la sua disposizione mentale non gli consente altra via. Da un lato le lodi all’efficacia dissacratrice dell’anarchismo, dall’altro il tentativo – non riuscito – di rintracciare residui di liberalismo nelle concessioni esemplificative di un Kropotkin incantato davanti agli organismi cooperativi non governativi. Ma se tutti sappiamo ormai che la struttura economica di oggi è ben differente, se tutti sappiamo che da ciò derivano profonde modificazioni in seno ai problemi relativi al comportamento dei gruppi rivoluzionari, che senso ha riproporre quelle riflessioni, oppure un senso ce l’ha, ed è quello di tirare una stoccata alla dottrina dello spontaneismo, che prima o poi – secondo Joll – potrebbe andare a finire in una difficoltà di mantenere intatta la sottile demarcazione tra liberalismo e libertarismo.
La lezione che si ricava dalla lettura del lavoro che presentiamo è che, nell’arco dell’azione in atto di svolgimento da parte del mondo della cultura ufficiale, ci troviamo davanti a un tentativo, forse non del tutto consapevole ma alimentato dalla stessa essenza intima di quella cultura, di spostare lo spontaneismo verso l’autoritarismo o, comunque, verso un tipo particolare di cogestione che finirebbe per rendere impossibile la dottrina anarchica anche sul piano teorico, donde poi sarebbe naturale il passo definitivo, verso l’esaltazione delle figure eroiche del passato, verso la mitizzazione, verso il totale annullamento di ogni incidenza sulla realtà presente.
È per questo che non consideriamo superflua la riflessione sul lavoro di Joll, anche se dobbiamo prescindere da quanto costituisce oggetto di deformazione resta il fatto, indiscutibile, di sollevare il problema dandoci modo di contestare i limiti di una posizione. Se il nostro lavoro diventa in questo modo più arduo, se il lettore è così chiamato a una maggiore penetrazione critica, a una più solerte documentazione sull’azione pratica dell’attività rivoluzionaria di oggi, tutto ciò trova contropartita nella necessità di prendere coscienza di questi tentativi della cultura ufficiale, di approfondirli onde poterli minimizzare al momento opportuno.
Al di là di tutto ciò resta pur sempre la rivoluzione.
[Introduzione a J. Joll, L’anarchismo tra comunismo e individualismo, tr. it., Catania 1971]
Marcuse. Un rendiconto
Siamo ormai fuori del periodo caldo della ricerca degli scritti di Marcuse, ed è tempo della riflessione, tempo del rendiconto.
Fino a che punto l’opera del pensatore tedesco contemporaneo ha significato qualcosa per la rivoluzione oggi nel mondo, fino a che punto il movimento studentesco, dal 1968 ad oggi, è stato da essa influenzato, fino a che punto lo stesso pensiero critico delle istituzioni sociali ha subito una svolta sotto l’azione di quest’opera? Tutte domande alle quali cerca di rispondere il lavoro di Bernd Œlgart che presentiamo nella collana “La sinistra libertaria”, nel segno di quell’allargamento verso schieramenti di pensiero che pur appartenendo alla sinistra libertaria non si possono ortodossamente definire anarchici.
Tirate le somme, fatti i debiti calcoli, quello che resta non è molto. Restano alcune riaffermazioni di principio, quella della libertà, della negatività distruttiva, della potenzialità utilizzabile della tecnica, specialmente quella della tolleranza repressiva. Di alcune diagnosi, come quella economica basata sulla duplicità della realtà sovra-infrastrutturale, non ci resta molto, considerato che di più si ricava addirittura dallo stesso marxismo ortodosso. Per molte analisi permane l’ostacolo di partenza, fatto di una valutazione semplicemente “descrittiva” di non pochi punti – come ad esempio il caso dell’economia di guerra e del suo rapporto con il capitalismo maturo – per poterle definire decisive. Questa la parte negativa, su cui si sofferma molto volentieri Œlgart, preoccupato di chiarire i contraccolpi che involontariamente (e questo è grave) Marcuse con la sua persistente ambivalenza finisce per dare alla struttura di pensiero rigidamente marxista.
C’è poi la parte positiva. Non quella dell’influenza di questo pensatore sul movimento studentesco dopo il 1968 (di prima è ovvio che non se ne deve parlare in assoluto). Basta verificare quanto dice a questo proposito J. Maitron nel lavoro L’anarchismo e giovani (n. 2 di questa stessa collana) e James Joll nel lavoro L’anarchismo tra comunismo e individualismo (n. 6 di questa stessa collana), per rendersi conto che questa influenza non c’è stata, piuttosto si è trattato di un tipico fenomeno consumista che ha orchestrato nei modi consueti invece di un qualsiasi prodotto commestibile o di consumo durevole (elettrodomestici, televisori, ecc.) l’opera di un filosofo, e per giunta tra quelli meno facili. Non si tratta ovviamente della parte positiva, infatti fra l’altro non crediamo alla positività di certo interessamento della cultura ufficiale nei confronti dell’anarchismo e dei movimenti rivoluzionari in genere, il più delle volte ci si trova davanti a un interessamento diretto a trasformare il movimento rivoluzionario in mito onde renderlo più debole e inglobarlo facilmente. In questo la cultura universitaria è specialista da sempre.
La parte positiva, per cui la lettura di Marcuse, naturalmente fatta con certe cautele di premessa, non è del tutto tempo perso, è costituita dal suo “critical spirit”, dal suo spirito critico. Comunque da Eros e civiltà ai saggi più recenti un certo progresso, sulla strada di una maggiore incidenza critica nei confronti delle istituzioni, c’è stato e notevole. Dalle molteplici riserve di natura ideologica che la lettura di Eros e civiltà aveva sollevato, adesso si è arrivati alla trasformazione in mito e in oggetto di consumo, ma anche prescindendo da tutto ciò abbiamo la possibilità di identificare un Marcuse diverso e più vicino alla realtà rivoluzionaria (ad esempio, come appare nella Fine dell’utopia, frutto delle discussioni alla Freie Universität).
Di grande valore, infine, a nostro giudizio, la critica della tolleranza repressiva, con la quale si è riusciti a vedere con chiarezza i termini del nuovo tipo di conflitto tra le forze istituzionali e le forze di liberalizzazione. Su questa strada, che in un certo senso consente di rivedere la necessità della rivoluzione dell’astio, si può ancora fare un ottimo lavoro. La “morbidezza” delle istituzioni, il loro camuffamento sotto forme di democrazia, l’impossibilità di resistere agli stimoli di inglobazione, avevano determinato uno stato di cose che, se non in linea di classe ma in linea di singolo individuo, aveva finito per rendere praticamente inefficiente la classe operaia, questa può essere richiamata al suo compito rivoluzionario attraverso un processo di chiarificazione del ruolo repressivo oggi giocato dalla tolleranza statale.
Certo il valore scientifico dell’opera di Marcuse sarà assai limitato, come disadatto sarà il suo metodo descrittivo a rispondere alle pretese di concretezza che oggi si richiedono a una analisi socioeconomica, comunque anche questa descrizione può avere la sua importanza come mezzo di riflessione se vista attraverso lo scopo della lotta immediata al posto del dilettantismo filosofico. In bilico tra ottimismo e pessimismo, Marcuse resta legato alla contingenza del caso, agli avvenimenti che determinano il flusso politico di questi ultimi anni, avvenimenti caotici che presentano uno schieramento di partizioni della sinistra militante da fare girare la testa, in ciò è uno dei limiti ma anche uno dei tentativi più onesti di questo pensatore, una delle sue speranze essendo proprio sulla capacità operativa dei singoli gruppi nelle precise e determinate condizioni d’ambiente.
Da un punto di vista specificatamente dottrinario esistono in Marcuse non pochi elementi di estrazione feuerbachiana o baueriana, ad esempio quando parla della ineluttabilità del cambiamento o della critica dell’esistente, senza dare a tutto ciò un fondamento diverso da una superficiale trascendenza idealista o, se vogliamo usare un termine meno crudo, ideologica. Anche la stessa presenza di Marx è alquanto deformata da imprecisi riferimenti al senso più che alla lettera del discorso marxista. Tutto ciò ovviamente non ha un gran valore sul piano concreto, ma data la scarsa incidenza pratica del pensiero del nostro filosofo, almeno fino ad oggi, finisce per assumere importante prevalenza almeno sul piano teorico.
Comunque il lavoro di Œlgart resta di grande validità perché si presenta come uno dei primi tentativi di vederci chiaro al di là della cortina fumogena del consumismo editoriale, come pure si presenta come un serio tentativo di approfondire le tesi di uno studioso che potrebbe oggi, fuori del clima del 1968, ripiombare in un oblio forse non del tutto meritato.
[Introduzione a B. Œlgart, Marcuse: un rendiconto, tr. it., Catania 1971]
Anarchia e famismo
A più riprese Gino Raya si è occupato di alcuni nostri lavori relativi alla problematica anarchica, a cominciare dall’edizione de L’anarchia di Malatesta, corredata da note critiche, apparsa nel 1969 per i tipi de “La Fiaccola” di Ragusa, alle recenti edizioni della Libreria Underground di Catania dei lavori di J. Maitron (L’anarchismo e i giovani) e di G. Leval (Rinascita del movimento libertario).
Ma il fatto che se ne sia occupato non significa che ne abbia capito molto, come pure il fatto che si sia occupato di Stirner non significa che ne abbia capito il messaggio. Tutto un grosso equivoco, tutta una colossale incapacità di afferrare certi nessi o certe conseguenze che, ovviamente, non dipendono da difficoltà insormontabili dei problemi in se stessi, ma soltanto da errati punti di partenza nella riflessione e da vere e proprie deformazioni professionali.
Infatti non dobbiamo dimenticare due cose, prima Gino Raya è un professore universitario e, per quanto a suo modo controcorrente, ragiona sempre come un professore universitario, seconda, Raya è il teorico del famismo e, per quanto questa accozzaglia di ingenuità pescate in una obsoleta biologia mischiate con un dottrinario positivismo fuori moda non possa essere proprio del tutto considerata una teoria, ragiona sempre come un teorico autoritario.
È per questo che ci siamo visti necessitati a puntualizzare alcune cose, non tanto per una difesa della dottrina anarchica – che ovviamente può essere contestata su molti piani e con molti argomenti, ma non sul piano della più assoluta ignoranza dei suoi princìpi, e con l’argomento ridicolo del famismo – quanto, invece, perché simili grossolane mistificazioni ci sembra rientrino in una certa prospettiva della cultura ufficiale di interessarsi delle dottrine rivoluzionarie in genere e dell’anarchismo in particolare. È naturale poi che questo interessamento si traduce in una completa deformazione di una sostanza che non può assolutamente risultare adeguata alle modeste possibilità di comprensione dei professori universitari, dediti da secoli a studiare fossili, o a illudersi di studiare esseri viventi – come è il caso appunto del famismo – quando non si trovano davanti che incartapecoriti residui di una grossolana metafisica passata.
Vediamo, come prima cosa, di esaminare i punti dell’interpretazione data da Raya del lavoro di Malatesta, con particolare riferimento a L’Anarchia, vista l’ignoranza del nostro recensore degli altri scritti del rivoluzionario italiano.
Raya propone una ripartizione in due filoni della cultura di Malatesta: «a) la reazione, tutta biologica (ma trasposta da millenni nelle ideologie della libertà, della giustizia, ecc.), b) la recente ideologia del socialismo nella particolare accezione della proprietà come furto». (“Biologia culturale”, anno IV n. 4, p. 168). La qual cosa sarebbe da considerarsi almeno superficiale, visto che egli non ha letto nulla degli scritti malatestiani precedenti a L’anarchia – con la loro particolare componente empirica e ancora meno degli scritti seguenti, con la loro apertura verso una struttura organizzativa anarchica che, ripetiamo, può essere criticata – e l’abbiamo fatto noi stessi – ma non può essere ignorata da chi, per giunta, intende tranciare giudizi come se fossero biscotti al miele.
Ogni diseredato ha reazioni, come ogni borghese, dall’alto della sua sicurezza economica, ha le sue. Può anche essere che alcune di queste reazioni – le primordiali e più efficaci dal punto di vista operativo-emozionale – siano reazioni biologiche, aventi immediata attinenza con il meccanismo fagico. Possiamo anche indulgere nel gioco metafisico di considerare inseribili nell’arco di questo meccanismo fagico altre reazioni primordiali dell’uomo, come l’istinto sessuale, l’impulso a prevalere sugli altri, ecc. Possiamo allungare lo sforzo includendo in questa specie di carrozzone anche le manifestazioni attinenti alle attività intellettuali dell’uomo e possiamo anche – giocando questa volta d’astuzia – includervi pure lo stesso istinto di solidarietà, che evoluzionisti non del tutto imbecilli, come Kropotkin, hanno definitivamente accertato nella specie. Ma non dobbiamo avere la sfacciataggine di spacciare tutto questo per qualche cosa di sostanziale, per qualche cosa che elude il semplice giochetto metafisico, anzi per qualche cosa che da sola rappresenta il massimo sforzo antimetafisico oggi raggiunto dall’uomo. Ed è purtroppo quello che fa Raya. Rimprovera a Kant di credere di essersi svegliato dal sogno metafisico mentre era più che mai immerso nelle sue fantasie, ed invece è lui stesso a trovarsi ancora nel mondo dei fantasmi. Il peggiore interprete del più deteriore darwinismo sociale, oggi, riderebbe del famismo, definendolo, nella migliore ipotesi, banalissima esercitazione scolastica di un letterato ignorante di biologia.
Abbiamo quindi il punto di partenza che ci consente di indagare sotto tutta questa montatura. Raya, metafisico eccellentissimo, ha preteso rinchiudere tutta la realtà dentro il principio primo del meccanismo fagico, credendo – in buona fede o in mala fede non lo sappiamo, vista la sua persistente inadeguatezza a uscire fuori delle vuotaggini verbali e a fornire una esatta documentazione scientifica a sostegno delle semplici petizioni di principio – in questo modo di mettersi il mondo in tasca, e con il mondo, capirete bene!, anche la dottrina anarchica. Ma, l’improntitudine dimostrata nel trattare, senza un minimo di documentazione, quest’ultima, ci dà la misura della macroscopica mistificazione che regge dalle fondamenta tutto il famismo.
Ma continuiamo con la nostra analisi. Il secondo punto ci fa capire come l’allegra lettura dei classici socialisti e anarchici dell’Ottocento, condotta da Raya, sia più un’incrostazione che una sostanza. La componente ideologica socialista, presente in Malatesta, non può in modo alcuno richiamarsi a una frase – semplicemente a una frase che per altro non riassume per niente il federalismo e il mutualismo – di Proudhon. Se così fosse, tutte le dottrine politiche e sociali, anche quelle serie, sarebbero buffonate tipo famismo. Per altro, e qui casca veramente l’asino, la dottrina proudhoniana non è affatto una delle componenti ideologiche di Malatesta. Un uomo come lui, alieno da ogni forma di principio assoluto, restò sempre legato, come scrisse Luigi Fabbri, «a tutte le probabilità che si presentassero di un’azione rivoluzionaria su vaste basi». (Malatesta. L’uomo e il pensiero, Napoli 1951, p. 41). Il processo di orientamento fu sempre quello che dall’inizio del collettivismo bakuniano si indirizzava verso il comunismo anarchico, questione se si vuole discutibile a lungo in sede teorica ma che non potrà essere confusa, se non da persona del tutto lontana da questi problemi, con il mutualismo proudhoniano. Infatti se la proprietà è un furto lo è per motivi ben precisi, e differenti, per Marx, per Proudhon, per Bakunin, per Cafiero, per Malatesta e così via, una serie di sfumature, sempre all’interno della matrice socialista, che possono sfuggire solo a un incompetente.
Non è trascurabile che il principio di solidarietà – che come tale non può considerarsi però assoluto o trascendentale, come appare invece l’opposto principio del famismo o della “struggle for life” che dire si voglia – mal si colleghi con il mutualismo, quanto invece possa considerarsi fondamento del comunismo. Infatti la formulazione comunista dell’Internazionale, che suona: “Tutto è di tutti, tutto è sfruttato a vantaggio di tutti, ciascuno deve fare per la società tutto ciò che le sue forze gli permettono di fare, ed ha il diritto di esigere dalla società il soddisfacimento di tutti i suoi bisogni, nella misura concessa dallo stato della produzione e delle forze sociali”, è il vero fondamento del comunismo. Che poi quest’ultimo possa prima passare attraverso la fase collettivista – ad esempio nella accezione bakuninista – è faccenda di aderenza dei singoli gruppi e delle singole zone a un maggiore o minore sviluppo morale. Così scriveva appunto Malatesta: «Il comunismo per essere attuabile ha bisogno di un grande sviluppo morale nei membri della società, di un alto e profondo sentimento di solidarietà, che lo slancio rivoluzionario forse non basterà a produrre, tanto più che mancheranno in sulle prime le condizioni materiali che servono a facilitarne lo sviluppo, cioè una tale abbondanza di produzione che ciascuno possa soddisfare ampiamente ai suoi bisogni senza nuocere agli altri, e un’organizzazione del lavoro tale che questo non riesca penoso. Si potrà rimediare a queste contraddizioni attuando immediatamente il comunismo solo in quei luoghi e in quei limiti che le circostanze permettono, ed accettando per il resto, ma transitoriamente, il collettivismo». (Internazionale collettivista e comunismo anarchico, in “Pensiero e volontà”, 25 agosto 1926).
Quindi, se di componente ideologica si deve parlare, non è assolutamente quella che si può riassumere nella formula “la proprietà è un furto”, ma tutto quello che sta dopo e, per giunta, nella specifica accezione del comunismo anarchico. Non si tratta di un errore quanto di un piano conoscitivo differente, del tutto inadeguato a consentire un’esatta focalizzazione del problema dell’anarchismo.
Malatesta è un figlio della sua epoca, questo non si discute, ed è quindi sotto l’influenza di un certo meccanismo positivista. Ma lo spontaneismo che riesce a ricavare da queste premesse, anche se turbato da una presenza organizzativa diretta a limitare sostanzialmente le possibilità del singolo nell’interesse della collettività (comunismo anarchico contrapposto all’individualismo anarchico), è senz’altro un prodotto rivoluzionario attuale e significativo. Altro che metafisica. Frasi come le seguenti : «La lotta contro il governo si rivolge, in ultima analisi, in lotta fisica, materiale». (Cfr. Il nostro programma, New York-Paterson 1905). «Lo sciopero generale di protesta, o per appoggiare delle rivendicazioni economiche o politiche, compatibili col regime, se fatto in momento propizio, quando governo e padroni trovano opportuno cedere subito per paura di peggio, può giovare. Ma bisogna non dimenticare che bisogna mangiare tutti i giorni e che, se la resistenza si prolunga solo per parecchi giorni, bisogna o piegarsi ignominiosamente al giogo padronale, o insorgere... anche se il governo o le fasce irregolari della borghesia non prendono l’iniziativa della violenza». (Cfr. “Gli anarchici nel movimento operaio” in “Umanità Nova”,
Roma, 26-27-28 ottobre 1921). «Io non parlerò del modo come può essere combattuta ed abbattuta la tirannia che oggi opprime il popolo italiano. Qui noi ci proponiamo di fare semplicemente opera di chiarificazione delle idee e di preparazione morale in vista di un avvenire, prossimo o lontano, perché non ci è possibile far altro. E del resto, quando credessimo giunto il momento di una più fattiva azione... ne parleremo anche meno». (Cfr. “Il terrore rivoluzionario”, in “Pensiero e volontà”, 1 ottobre 1924). Queste frasi non possono essere considerate metafisiche. Il meccanismo è servito, nel pensiero di Malatesta, a liberarlo dallo spauracchio idealista, e qui ha ragione finalmente Raya quando accenna ai cori “stonati” e affini insieme di Croce e Gentile, D’Annunzio e Mussolini, che soli avevano diritto di cittadinanza a quell’epoca. Qui siamo davvero al cospetto della metafisica fatta persona e, nello stesso tempo, della sostanza di questa metafisica, che non sempre è sogno di inerme professorucolo, ma spesso diventa disegno preordinato e freddo di genocida folle.
Ed eccoci al discorso sulla metafisica, tante volte in altra sede affrontato da Raya con la baldanza di chi sa per certo di trovarsi dalla parte giusta e osa guardare gli altri dall’alto in basso, col cipiglio severo del cerbero coduto.
L’antimetafisicismo contemporaneo è venuto dalla scienza, in particolare dalla fisica moderna e dalle scoperte che quest’ultima ha concretizzato. Da Max Planck in poi e dalla sua “costante” si è aperto un mondo empirico nuovo, retto da leggi nuove che, riflesse nel mondo dei nostri problemi quotidiani, sociali, economici, morali, ecc., hanno determinato una vera e propria rivoluzione copernicana, di cui ancora oggi non comprendiamo appieno gli effetti.
La fonte più concreta dell’antimetafisicismo è però la filosofia del linguaggio, cioè quella particolare branca dell’epistemologia che ricerca il fondamento, le possibilità di significanze e di comunicazione del linguaggio. Ciò ha dato vita alla corrente filosofica del neopositivismo, che ha anch’essa la sua metafisica, ma che in molte formulazioni dei suoi migliori interpreti ci appare tra i contributi più liberi di questa malattia, questo è, ad esempio, il caso di Rudolf Carnap.
Ma non vogliamo condurre il lettore su di una strada che non porta direttamente al nostro assunto di partenza. In pratica anche Carnap ha dovuto rivedere molte formulazioni della sua “prima maniera”, assai radicalizzante nei riguardi della possibilità del linguaggio di trasmettere significati reali, in una ammissione della pluralità del linguaggio (ovviamente in senso semantico e non letterale), in una ammissione dell’ineluttabilità del compromesso. E se Moritz Schilick venne assassinato dai fascisti sui gradini dell’Università di Vienna non fu un fatto casuale, ma un preciso riconoscimento del pericolo che una filosofia antimetafisica presenta per qualsiasi irrazionalismo e in particolare per l’irrazionalismo fascista.
Ma la posizione antimetafisica non è una posizione assolutista, come invece si pone l’antimetafisicismo apparente del famismo – in quanto se così fosse sarebbe immediatamente elevata al grado di metafisica con tutti gli onori. Ecco perché il radicalismo antimetafisico di Carnap della prima maniera, con la sua ristretta valutazione delle possibilità del linguaggio, diventa una forma particolarmente sottile di metafisica, ed ecco perché il principio del famismo è, questa volta in forma grossolana, una specie di metafisica altrettanto pericolosa, e sul problema della pericolosità torneremo più avanti.
Il metafisico, in pratica, non è un uomo diverso dagli altri. Solo che arriva ai problemi attraverso una struttura precostituita – come ci arrivano tutti gli altri – ma crede di arrivarci direttamente, spontaneamente, senza nessuna barriera che lo divida dalla realtà. Per questo motivo il paradosso centrale della storia della filosofia, della sostanziale uguaglianza tra realismo e idealismo, non è poi un paradosso, in quanto tutte e due queste correnti filosofiche danno per scontata l’esistenza del mondo esterno, oltre che la sua conoscibilità nei modi da stabilire.
La metafisica consisterebbe pertanto non nel modo di interpretare la realtà, e difatti in questo caso non sarebbe più una deformazione gnoseologica ma una differenziazione ontologica, quanto piuttosto nell’illudersi che la sua sia una posizione privilegiata nei confronti della possibilità di risoluzione dei problemi della vita, in quanto portatrice di un principio di chiarificazione e di salvezza, un principio che deve stare alla base di tutto e che non deve dipendere da nulla, un principio motore e assoluto. Che poi si chiami Dio o famismo non ha importanza, quello che conta è il meccanismo di salvazione.
Nella gelosa necessità di difendere il suo principio Raya non si accorge di dire delle gravi inesattezze (per altro dipendenti dalla sua costante ignoranza dell’argomento). Egli scrive: «Malatesta, forse per sua fortuna, non è stato a un qualsiasi posto di potere, bensì in prigione per una decina d’anni, o con gli arnesi di meccanico in mano per sbarcare il lunario, ciò gli risparmia ogni risentimento che il potere comporta, e gli conferisce una sorta di aureola laica, corrispondente a quella, se non dei santi, almeno dei venerabili delle varie Chiese». (“Biologia culturale”, op. cit., p. 170). In effetti, come scrive Cerrito, «Errico Malatesta veniva acclamato ovunque da folle immense di lavoratori. A Genova, a Milano, a Bologna, nelle Marche, nelle Romagne, a Roma, le manifestazioni di plauso per il rivoluzionario assumevano un aspetto plebiscitario tale di entusiasmo, che Malatesta scriveva agli amici “Grazie, ma basta!”, ricordando che l’esaltazione di un uomo “è cosa politicamente pericolosa e moralmente malsana per gli esaltati e per gli esaltatori”. Alle acclamazioni, agli applausi, agli “evviva il Lenin d’Italia”, egli rispondeva che non era tornato per candidature politiche o per cariche presidenziali. E sosteneva un fronte unico e rivoluzionario del proletariato, una rivoluzione che, distruggendo lo Stato, producesse libertà». (Cfr. E. Malatesta, Scritti scelti a cura di Gino Cerrito, Roma 1970, p. 53). Malatesta fu il personaggio più rappresentativo dell’anarchismo italiano tra la fine del secolo scorso e i primi decenni del secolo presente, ebbe una larghissima influenza sul movimento di quasi tutti i paesi civili dell’epoca, ancora oggi è uno dei punti di riferimento di tutta la problematica anarco-comunista. Se Malatesta non giunse a un posto di potere non fu per un semplice caso, ma fu per una precisa decisione e non certo, scusatemi, perché credeva di potere mangiare più facilmente e di più in questo modo. Se nel 1919, quando ebbe a scrivere che si trattava dell’ultima occasione, perduta la quale si sarebbe pagata a caro prezzo la paura fatta ai borghesi, avesse strumentalizzato l’entusiasmo che animava gli anarchici durante le settimane di occupazione delle fabbriche, entusiasmo che si può rilevare con facilità come ha provato Cerrito dalle colonne di “Umanità Nova” e dalle decine di comizi tenuti da Malatesta a Milano e a Bologna, forse avrebbe potuto dare il via a una rivoluzione tipo quella bolscevica, sfociante nell’autoritarismo della dittatura del proletario, ma sarebbe stato in contrasto con la dottrina anarchica e non l’ha voluta. Se questo – e altri esempi a decine se ne potrebbero ricavare dalla guerra civile spagnola – è un’espressione di famismo allora o il famismo è un principio assoluto che tutto spiega e quindi finisce per non spiegare nulla perché banale illusione metafisica, oppure è una stupida montatura valida solo per le platee orchestrate e per gli antri polverosi delle università.
Oggi è finito il tempo della validità imperitura dei classici dell’anarchismo. I giovani guardano al passato, ai vari Bakunin, Kropotkin, Proudhon, Malatesta, ecc. con l’occhio critico che viene loro da un contatto con la realtà che quegli altri potevano solo immaginare ma non vagliare. Oggi ci troviamo davanti a fenomeni di capitalismo maturo che solo se valutati empiricamente, lavorando sulla struttura di base dell’economia delle singole espressioni sociali, si possono capire e, quindi, combattere. Tutto il resto diventa vana retorica se non aiuta questa comprensione, quando non diventa dolosa mistificazione.
Veniamo adesso ai pericoli dell’analogia biologica applicata alle scienze dell’uomo. Su questo argomento ci sia permesso rinviare alla nostra estesa ricerca pubblicata su “Quaderni di cultura contemporanea” (vol. II, 1968, pp. 47-61).
Una collaborazione tra scienza e filosofia è sempre auspicabile, solo che quando prende le vesti grossolane dell’analogia, specie se diretta, allora diventa pericolosa per le conclusioni della filosofia, quando poi l’analogia è posta con la scienza biologica, questo pericolo diventa massimo.
Uno degli esempi più evidenti dei pericoli di degenerazione logica cui può condurre un impiego sconsiderato dell’analogia biologica è dato dagli sviluppi della teoria della razza, come è stata formulata da Joseph Arthur Gobineau fino agli ideologi nazisti.
Con Gobineau si teorizza (non per la prima volta perché si potrebbe risalire addirittura all’apologo di Menenio Agrippa e a Edmund Burke, tanto per fare dei nomi) la fondamentale ineguaglianza degli uomini e la fatale decadenza della civiltà a causa della mescolanza delle razze. Ma una forma pseudo-scientifica questa dottrina la prende solo con Houston Stewart Chamberlain, Hitler, Alfred Rosenberg, ecc. La forma ispirata del lavoro di Gobineau, ai suoi tempi, non poteva avere una grande influenza sullo spirito europeo, permeato di positività scientifica, per cui il Saggio sulla ineguaglianza delle razze, uscito all’incirca nel 1855, venne passato sotto silenzio in Francia, mentre suscitava un notevole interesse negli Stati Uniti del Sud dove incontrava terreno molto nella mentalità dei grandi piantatori schiavisti.
La definitiva veste pseudo-scientifica, la teoria della razza la ricevette dall’incontro col darwinismo. In effetti alla base di questa fusione è da porsi il distacco intervenuto tra economia e sociologia.
Il darwinismo, dal canto suo, subiva una profonda revisione, ponendosi l’accento sullo sviluppo dato da Charles Darwin alla dottrina evoluzionista nell’opera La discendenza dell’uomo anziché nell’opera L’origine della specie. In questo senso lavorò moltissimo Kropotkin e la maggior parte del gruppo legato alla “Nineteenth Century”. Siamo già davanti a un evoluzionismo sociale che afferma la legge della solidarietà in sostituzione della legge della lotta per la vita, o comunque in concomitanza di quella legge, in questo modo diventa possibile trasferire altrove, in deformazioni successive dovute alle contingenze naturali e sociali, gli accanimenti dell’uomo sull’uomo e tutto quello che l’ortodossia darwinista aveva in precedenza scambiato per legge universale.
In questo clima sorge e si afferma l’opera di Friedrich Nietzsche, sebbene non possa ricondursi direttamente ai princìpi ideologici visti sopra. In certi punti dei suoi scritti si notano delle analogie biologiche, pur non in grado di sollevarsi al di sopra dell’atmosfera del mito, comunque sufficienti a dare sostegno alla contingenza che stava alla base delle pretese intellettuali della nuova classe dirigente.
A questo punto si possono cogliere due motivi principali della teoria della razza, così come venne applicata nella Germania nazista. Da un canto l’autorità di Nietzsche, non afferente in alcun modo in linea diretta al razzismo, ma lo stesso interpretabile in questa chiave per la sua, a volte, eccessiva mitizzazione della realtà, dall’altro l’obiettivo interesse di gruppi di potere specifici al genocidio organizzato, ad esempio, degli Ebrei. L’ineguaglianza, l’oppressione, lo sfruttamento, diventano fatti “naturali”, ineliminabili. Da ciò le gravi mancanze del sistema capitalista diventano del tutto “normali”.
Quest’ultima fase della dottrina nazista delle razze si può riassumere così: primo, ogni progresso sociale si attua attraverso una “lotta per la vita” in cui i più capaci emergono mentre i deboli vengono eliminati, questa lotta avviene all’interno di una razza dando vita ad una élite naturale. Secondo, la commistione di più razze causa una degenere ibridazione, donde si deve correre al riparo con una sistematica eliminazione degli ibridi. Terzo, tutte le maggiori civiltà e le più alte manifestazioni della cultura, pure potendo appartenere a razze diverse, sono l’espressione di una sola razza superiore. Da questo punto di vista le razze si dividono in razze creatrici di cultura come la razza ariana, razze portatrici di cultura che la possono trasmettere ma non creare, razze distruttrici di cultura come la razza ebraica.
Possiamo quindi dedurre che per molti aspetti la teoria della razza, degenere manifestazione dell’intelletto umano, purtroppo ancora oggi viva sia pure allo stato di camuffamento, deve il suo rigoglioso sviluppo, alimentato dal clima nazionalista, alla prospettiva teleologica fornita dall’analogia organica.
Ecco il pericolo cui facevamo cenno. Il biologismo dei letterati, e l’esempio di Raya calza proprio a pennello, è tra i più pericolosi prodotti culturali, perché facilmente utilizzabile da ideologie irrazionaliste. Per gli stessi motivi esposti prima, l’estremo realismo non si discosta per nulla dall’estremo idealismo, anticamera dello spiritualismo e dell’irrazionalismo.
Gli avvertimenti di pericolo, in questo senso, non saranno mai troppi, come pure non saranno mai sufficienti le stroncature di coloro che in buona o mala fede, nell’illusione di un oggettivo realismo, alimentano il fuoco sempre caldo dell’irrazionalismo nazionalista. Tanto per fare un esempio, ma l’argomento meriterebbe ben altra trattazione, una tesi come quella del famismo si presta molto bene a giustificare ogni sorta di autoritarismo, da quello religioso a quello politico e militare. Infatti se la religione è negata in teoria dal famismo, sul piano concreto della vita politica di un gruppo di persone questa teoria si vede costretta, per intrinseca consequenzialità logica, ad accettarne la messa in scena, utile per calmare o limitare a forme meno cruente la fame comune e i reciproci istinti fagici. Allo stesso modo diventa utile lo Stato, con i suoi sistemi repressivi, allo stesso modo sarebbe utilissimo un ritorno alla Santa Inquisizione, alle forme di tortura medievali. Allo stesso modo la guerra non solo diventa ineluttabile – infatti questo verrebbe ad essere implicito nella petizione di principio – ma armarsi nel migliore dei modi diventa indispensabile. E così via, all’infinito, giù, giù, sempre più giù, sempre più giù, fino a Hitler, fino ai campi di sterminio.
Ma il “buon Malatesta parla di solidarietà, per giunta a tutte lettere nella sua grande ingenuità”. Raya non può fare a meno di notare questa ingenuità e di sorriderne, invitando il lettore a un complice sorrisetto di commiserazione. Credere in simili cose, ma via!, siamo sinceri, è roba da idealisti, roba muffita del secolo scorso. Oggi dobbiamo invece credere nel verbo razzista che la nuova biologia ci ha insegnato, l’uomo si sbrana continuamente con l’uomo, di tutte le cose la fame è misura.
Per sostenere questa tesi dell’ingenuità della dottrina scientifica del mutuo appoggio, il cui autore Kropotkin, evoluzionista e darwinista anche lui, guarda caso e uno dei massimi teorici dell’anarchismo, Raya ci dice due cose: primo, che la solidarietà è l’altra faccia “dell’unica realtà fagica la quale rende l’uomo ora lupo ora compagno dell’uomo”. Secondo, che Bakunin, malgrado le sue tirate sulla solidarietà, si accapigliava con Marx e Mazzini. Scusate se è molto. Come contrapposizione a una tesi su cui da secoli si discute e su cui anche oggi ogni rivoluzionario pone la sua riflessione, una tesi che deve fare riflettere non tanto sulla natura umana – che poi non è quello il compito del teorico politico o dell’agitatore di professione – ma sulla natura delle situazioni specifiche, che rendono o meno possibile l’attuarsi della rivoluzione.
Raya se ne esce da par suo, cioè da letterato, dilettante di materie filosofiche, orecchiante al massimo di problemi del socialismo e dell’anarchismo. Se ne esce affermando che non può essere vera la tesi della solidarietà visto che Bakunin si accapigliava con Marx e Mazzini, il che sarebbe come dire che non è possibile che i gatti abbiano la coda visto che quello della mia vicina di casa non l’ha (perché gliel’hanno tagliata).
Basta pensare al grosso dibattito intorno al dilemma tra individualismo e comunismo, tra violenza e nonviolenza, tra spontaneismo e autoritarismo, per rendersi conto della portata del problema e dell’abisso di ignoranza da dove il Raya cerca di alzare la sua timida voce.
La teoria della solidarietà è una teoria, e sul piano della teoria, da un punto di vista che potremmo definire “di professore universitario”, si contrappone con pari diritto alla teoria della “lotta per la vita” e al “famismo”. Fin qui una dottrina in contrasto con il principio di solidarietà non avrebbe alcun fondamento per dichiarare quest’ultimo non valido o scaduto d’importanza.
Ma oltre la teoria c’è la realtà, la lotta continua che ogni giorno dobbiamo affrontare sulle piazze, contrapponendoci a un governo che occhiutamente cerca di mantenere in piedi gli ultimi sussulti di rapina, rafforzando la struttura delle istituzioni, ordinando alla polizia di sparare, mettendo le bombe, uccidendo sistematicamente gli operai nelle fabbriche, imbestialendo sempre di più, nel clima di tolleranza repressiva ormai generalizzato, l’imborghesimento dei ceti che da sempre erano restati disponibili per la rivoluzione. Eccola la parola, l’abbiamo detta. La parola che ci può servire da guida e che dirime subito tutte le ambivalenze, tutte le dicotomie, tutti i dilemmi teorici. La parola che rende anguste le biblioteche, irrespirabili le aule universitarie, soffocanti gli uffici, la parola che fa cercare la piazza, la lotta dura, il combattimento corpo a corpo. La parola che fa trasformare la filosofia in bottiglie molotov, la scienza in opuscoletti di propaganda sovversiva, i sofismi in micce e detonatori. La parola che ci fa vedere gli uomini, tutti gli uomini oppressi, per quello che sono, degli sfruttati, non degli oggetti sottomettibili al nostro istinto fagico.
Nella prospettiva rivoluzionaria e nella distruzione cadono tutte le vecchie prospettive borghesi, cade il famismo, perché eminentemente dottrina controrivoluzionaria e reazionaria, cadono i dilemmi tra individualismo e comunismo, l’azione rivoluzionaria richiede solo l’azione diretta con lo scopo determinato di difendersi con la violenza dal sopruso in atto, sopruso perpetrato giorno per giorno, per il semplice fatto della sola esistenza, dall’ordine costituito.
Se ci si fermasse a metà nel corso dell’azione, smettendo per un solo momento di tenere d’occhio la prospettiva rivoluzionaria, se si pensasse al costruito cui inevitabilmente tutti siamo legati, se si almanaccasse sul costruibile, come è costume di molti di noi che amano programmarsi il futuro, tutto ritornerebbe come prima, le discussioni, le teorie, le imbecillità, si accavallerebbero come i marosi di un mare in tempesta, lasciando la nostra spiaggia piena di detriti, detriti di naufragio, il nostro.
Di recente (“Biologia Culturale”, VI, 3, pp. 136-137) Raya è tornato sui nostri lavori, cogliendo l’occasione per dire altre amenità sull’anarchismo. Purtroppo i temi presi in esame, in particolare il lavoro di Gaston Leval sulla Rinascita del movimento libertario, malgrado la nostra introduzione chiarificatrice – evidentemente saltata a pie’ pari – non gli sono stati di giovamento.
Le idiozie sono state di meno, ma non per maturità dell’autore, solo per casuale minore dimensione dello scritto. Dal che si potrebbe dedurre che tanta gente farebbe bene a scrivere telegrammi. Alcuni esempi basteranno anche per il lettore meno provveduto.
«L’anarchia, come la cultura, vive solo a patto di restare continuamente scontenta (di tutto, e specialmente di se stessa): compito troppo difficile per gli individui ma operante attraverso le generazioni».
«Il paradosso del decadimento e della diffusione insieme. Quello deriva in parte dalla grettezza o dall’ingenuità degli stessi anarchici, i quali rimangono irretiti negli schemi religioso-idealistici dell’eden e della libertà sino al punto (come s’è visto nel Leval) di respingere la stessa, insostituibile, insegna anarchica, e in misura ancora più decisiva dal fatto che ciò che guadagna in estensione deve pur perdere in profondità».
«La diffusione [dell’anarchismo] è appunto una conseguenza della formulazione della sostanza biologica dell’anarchismo, la quale una volta intravista dallo Stirner e poi esplicitata dal famismo, non può non dilagare nel costume, sia pure comunista (e per ciò stesso deformata e adattata) a molte altre tecniche fagico-culturali che somigliano, o simulano, o adottano per mimetico, l’elasticissimo metodo della contestazione».
Non vogliamo continuare perché come campionario di bestialità ci sarebbe da fare un giardino zoologico vero e proprio. Quasi quasi non vale la pena di controbatterle punto per punto, visto che per la maggior parte si contraddicono da loro stesse, ma dato il gravoso compito che ci siamo assunti, tanto vale portarlo fino in fondo.
L’anarchia non vive solo a patto di restare sempre scontenta, prima di tutto perché non è un essere vivente che possa provare il sentimento della scontentezza o della felicità, ma una dottrina di pensiero e una dimensione di vita. Forse il nostro illustre professore voleva dire che l’anarchismo esiste solo a patto che faccia permanere negli uomini uno stato di scontentezza, ma se è così questo lo abbiamo capito noi, che dopo tutto siamo del mestiere, non crediamo però che lo possano capire tutti i lettori di Raya. Comunque, sorvolando sull’infelicità dell’espressione (veramente indegna di un letterato che in definitiva non ha altro da dire, mancandogli la dottrina di fondo), dobbiamo però fare notare che oggi, come ormai si riconosce dappertutto, una rivoluzione del risentimento non solo non è più possibile, ma non è nemmeno auspicabile, bastando una rivoluzione cosciente, diretta a colpire il centro del sistema capitalista avanzato, approfittando delle sue gravi contraddizioni, senza distruggere il nesso produttivo e benefico che ormai è stato concretizzato. In altre parole – non dimentichiamo che la nostra messa a punto si rivolge a un letterato, quindi dobbiamo essere quanto più semplici è possibile nell’espressione – una rivoluzione oggi non dovrebbe distruggere le autostrade, infatti anche se queste oggi sono l’espressione di una sanguinosa antinomia del capitalismo, potrebbero tornare utilissime domani, in una situazione diversa che, se non per forza sarà anarchica nel senso integro del termine, potrebbe essere collettivista nel senso migliore o comunista con una larga componente libertaria.
In questo caso, cioè nell’eventualità dell’affermarsi, all’indomani della rivoluzione, di una prospettiva autoritaria – poniamo di una dittatura del proletariato, gli anarchici sarebbero ancora una volta all’opposizione, combatterebbero la loro battaglia, come l’hanno combattuto in Ucraina e in Spagna, per contribuire a modificare la dittatura in libertà, per eliminare definitivamente il dominio dell’uomo sull’uomo o, se è questo il senso del discorso di Raya, per eliminare il fenomeno fagico dal mondo sociale, in quanto qui esso non è affatto ineliminabile trattandosi di fenomeno tipico del mondo biologico ed essendo ineliminabile solo in quella sede. La trasposizione infatti è banale fantasia di un letterato in vena di pubblicità.
Che poi la diffusione dell’anarchismo sia conseguenza della sua sostanza biologica è enormità di tale portata che si contraddice da sola. Infatti, essendo la biologia, a detta dello stesso Raya, sostanza di tutte le cose e di tutte le manifestazioni umane, tutte dovrebbero avere pari diffusione, il che è palesemente assurdo. Qui, come abbiamo detto, la speciale problematica di Leval gioca un brutto tiro a Raya che, sprovveduto intorno alla particolare posizione dell’anarchismo spagnolo in seno al movimento internazionale, scambia fischi per fiaschi e crede che sia connaturata all’anarchismo, nelle sue linee generali, la preoccupazione di Leval e la sua specifica impostazione dottrinaria. Cose che càpitano.
Un’ultima perla è quella relativa a Stirner, la cui allegra lettura, denunciata in “Biologia Culturale” (V. 3, pp. 97-106), non è priva di insegnamenti, ma che in ogni caso allargherebbe troppo il nostro discorso, rendendolo fieramente inadeguato all’assunto. Il filosofo tedesco avrebbe intravisto nientemeno la componente fagica dell’anarchismo, per cui lo si potrebbe considerare un precursore del famismo, per altro non rilevato dal preistorico del famismo, Domenico Cicciò – deceduto recentemente ancora giovanissimo – che all’argomento ha dedicato addirittura un volume. Naturalmente la presenza di simili idee in Stirner è del tutto fantastica, dovuta appunto a una di quelle allegre letture che Raya ci elargisce in tema di classici del socialismo e dell’anarchismo. Infatti solo da una premessa del genere si può arrivare a siffatte conclusioni. Da Stirner si possono ricavare cose impensate e impensabili, solo che si trascuri di leggerlo tutto, e attentamente, e ci si affidi al semplice spulciare l’indice. Questa nostra supposizione non è del tutto campata in aria e a tal proposito citiamo letteralmente: «Una recente edizione de L’unico (Max Stirner, L’unico e la sua proprietà, trad. di Pino Turco Liveri, Introduzione di Roberto Di Marco, Roma 1970, Ennesse editrice, vol. II, p. 469) non agevola certo la lettura mediante qualche sottotitolo esplicativo o un indice analitico». (Cfr. “Biologia Culturale”, V. 3, p. 97). Il che sarebbe come dire che mancando l’indice analitico e non essendogli bastato il coraggio – e la preparazione filosofica – di immergersi nelle non facili pagine di Stirner, il tutto si è ridotto a una lettura “allegra” di qualche passo “a saltare”.
E va bene, niente di male. Non sarebbe poi il primo a dire di avere letto un libro che poi in effetti ha visto solo dal di fuori. Questo sport, anzi, è assai praticato dai professori universitari che, di regola, lo pongono in pratica con le tesi di laurea degli studenti, le quali vengono religiosamente tenute nel segreto claustrale delle proprie pagine fino al giorno degli esami di laurea, quando, appena pochi attimi prima della discussione, il professore si limita a dare una breve scorsa all’indice (da mettersi obbligatoriamente questa volta, non dipendendo dalla accortezza grafica di un editore, ma da precise disposizioni impartite dal professore stesso che conosce bene il suo mestiere). Si può dire, in aggiunta, che i professori universitari siano i più bravi lettori di indici che io conosca. Dall’indice di un libro riconoscono tutto il contenuto, la sua validità, i punti critici, le tesi interessanti. Tutta questa gente pretende, per dare a un libro il crisma della serietà scientifica, che abbia un indice generale, un indice analitico per materia, e un indice dei nomi, dopo di che la lettura del libro diventa superflua e ognuno resta nella propria ignoranza patentata di preparazione e di erudizione.
Ma poi il gioco a volte si scopre, come pure si scoprono altri giochetti più gravi e divertenti, se non fossero meschini e necessitanti di una coltre di pudico silenzio. Si scopre, leggendo tra le righe di un articolo, sperduto in un giornale di provincia o in una rivista a non larga diffusione – che volete farci se il sottoscritto ha la brutta abitudine di leggere molto e le cose più impensate, oltre che, naturalmente, nei posti più impensati – si scopre ad esempio che un certo Giulio Cogni, grande sostenitore del famismo, autore di una Introduzione al libro del defunto Cicciò: Preistoria del famismo (Roma 1964), ha avuto una cortese polemica con Julius Evola (salvo ognuno) a proposito di una recensione di Cogni al volume Metafisica del sesso del predetto figuro e a proposito della risposta di quest’ultimo apparsa su “I problemi della pedagogia”, Roma, marzo-aprile 1970. Ma la recensione di partenza era smaccatamente ammirativa, anzi “apologetica”, per riportare il termine stesso usato da Domenico Cicciò nel valutarla. Come parentela spirituale non c’è che dire, e poi si afferma che queste teorie sulla fame o sulla merda che siano non conducono tutte a Roma. Parole, semplici parole, ma che al momento buono possono trasformarsi in dardi affilati. E chi lo sa se questa gente non attende proprio il momento buono per attuare tale metamorfosi?
Io, per principio, diffido delle persone che amano costituire una scuola. Diffido intellettualmente di tutti costoro, anche se sono anarchici o amici di anarchici, anche se si professano libertari o comunisti. La mia diffidenza è qualcosa di ancestrale, atavica, viscerale, l’avverto subito e metto in pochi secondi in moto il cervello. Le catene delle deduzioni non mi portano lontano, ma bastano per vedere chiare alcune cose. Primo, un uomo che ama farsi una scuola è un debole. Secondo, un uomo che lavora ad alimentare la sua scuola con qualcosa di più che siano il semplice esempio e la semplice attività personale, è un debole che ha preso coscienza della sua debolezza. Terzo, un uomo che cerca qualsiasi mezzo, anche quello di scrivere articoli su di se stesso e poi farli firmare agli amici non curando nemmeno di modificare il proprio stile, è un debole che essendosi scoperto debole comincia ad avere paura.
Questo è il caso di Raya, certi giochetti, come quello accennato sopra, danno solo il senso esatto di un uomo e di una dottrina.
[“Anarchia e famismo”, pubblicato su “Volontà”, n. 1, 1972, pp. 41-54]
Il concetto di espropriazione rivoluzionaria
Le masse derubate hanno il diritto di rientrare in possesso di tutto quello che è stato loro tolto. L’atto con cui questa ripresa di possesso viene portata a compimento si può chiamare espropriazione, perché toglie la proprietà a coloro che la detengono, rivoluzionaria, perché non prevede alcuna forma di indennizzo.
Ma i problemi che sorgono, dopo una definizione del genere, sono infiniti. Vediamo di chiarire i più urgenti.
Innanzi tutto espropriazione non significa furto, nel senso comune che viene dato a questo termine, infatti chi ruba, tranne il caso limite di chi si appropria del sostentamento per sé e per chi gli sta vicino essendogli impossibile provvedere altrimenti, non fa altro che trasferire la proprietà di qualcosa, non compie nessuno atto direttamente rivoluzionario. Abbiamo detto direttamente in quanto il ladro, anche se non ancora portato a coscienza rivoluzionaria, compie un gesto contro il sistema che lo opprime e lo determina un duplice risultato: la sottrazione di ciò che era stato rubato alla collettività e l’eliminazione di una sovrastruttura giuridica – il diritto di proprietà – con la quale quella sottrazione era stata resa “legale”.
È logico che non possiamo aspettare che sia tutto il popolo, in armi, a determinare l’espropriazione di tutti i mezzi di produzione, lavorando nel frattempo soltanto ad alimentare questa prospettiva e a educare le masse al momento rivoluzionario finale. Nell’attesa dobbiamo agire in senso rivoluzionario determinando anche delle espropriazioni fatte da minoranze rivoluzionarie per quanto riguarda la realizzazione del fatto espropriatorio, ma sempre a favore di una collettività per quanto riguarda la destinazione del bene espropriato.
In questo modo potremmo avere un’espropriazione di terra, di capitali, di beni strumentali o di consumo.
L’espropriazione rivoluzionaria può essere quindi un fatto isolato, e in questo caso avrà valore dimostrativo e di preparazione, oppure un fatto collettivo, generale, per cui la realtà reazionaria e capitalista viene modificata di colpo nella sua consistenza economica.
L’espropriazione isolata è quella che desta il maggiore interesse in questa sede, con una grande prospettiva di lavoro oscuro davanti alle minoranze rivoluzionarie e alle masse, mentre l’espropriazione generale si può ipotizzare come il punto finale di una lotta rivoluzionaria, il punto da cui partire per la costruzione della società nuova.
Il primo ostacolo da superare è la latente ritrosia, anche delle minoranze rivoluzionarie militanti, a comprendere il concetto che l’espropriazione rivoluzionaria non è un furto. Spesso molti militanti restano bloccati davanti all’idea di impadronirsi di qualcosa che non appartiene a loro, una chiusura etica che è un residuo della speciale educazione borghese ricevuta da tutti noi attraverso i canali tradizionali: famiglia, scuola, Chiesa. Ora, è logico che i borghesi, titolari dei beni di produzione, hanno tutto l’interesse a diffondere un’ideologia che nasconda i loro furti antichi e recenti, denunciando alla pubblica recriminazione il ladro, senza stare a sottilizzare se si tratta di ladro comune, oppure di un espropriatore che trasferisce a una comunità il bene prelevato. Ma non è questo il compito dei borghesi, loro fanno ciò che torna utile ai loro interessi, noi dobbiamo invece combatterli e organizzare le nuove strutture che renderanno possibile la società del futuro.
L’espropriazione isolata potrà essere di terre, di capitali, di beni strumentali o di consumo. I casi più importanti sono l’espropriazione delle terre e quella di capitali. Le altre espropriazioni sono facilmente riconducibili alle prime due, i beni strumentali possono considerarsi come la terra (macchine, utensili e altro possono infatti essere usati in comune da una collettività), i beni di consumo come il capitale (infatti i beni commestibili, ad esempio grano, scatolame ed altro, possono essere ripartiti e consumati dalla collettività).
L’espropriazione rivoluzionaria della terra quando è fenomeno isolato deve essere realizzata, nei limiti del possibile, fino in fondo. Infatti, ipotizzando il fenomeno isolato, siamo davanti all’eventualità di una durata dell’espropriazione molto limitata nel tempo. La repressione giungerà quasi certamente a ricostituire lo stato precedente del dominio padronale. Ma, per quanto durerà la nuova condizione rivoluzionaria, devono essere poste in atto tutte quelle condizioni che renderanno riconoscibili, nel futuro, la gestione comunitaria, l’eliminazione della proprietà e dello sfruttamento, con tutti i risultati raggiunti, per quanto modesti o di breve durata essi siano stati.
L’espropriazione rivoluzionaria di capitali, nella forma di industrie produttive o di denaro, deve avere gli stessi scopi ed essere organizzata allo stesso modo. L’industria verrà immediatamente attaccata dalle forze repressive, ma per quanto potrà funzionare in gestione comunitaria si dovrà dare la massima evidenza a questi risultati, prospettando l’uso del sistema espropriativo su larga scala a coloro che li prenderanno in considerazione. Nel caso dell’espropriazione di denaro l’attacco padronale avverrà contro le realizzazioni rivoluzionarie e comunitarie che con quel denaro verranno portate a compimento, quindi avremo più o meno il caso dell’espropriazione delle terre e delle industrie.
Resta da dire che l’espropriazione isolata, realizzata dalla minoranza rivoluzionaria, deve essere sempre diretta in vista dei problemi delle masse sfruttate e non in vista di un eventuale rafforzamento di questa minoranza stessa, anche se il più delle volte – specie nell’espropriazione di denaro liquido – si può correre questo rischio, appunto trattandosi di un bene che può essere destinato agli usi più disparati. Ciò non toglie che una certa parte venga utilizzata per alimentare le necessità e le possibilità operative della minoranza rivoluzionaria, ma si deve trattare di una materia su cui esercitare un controllo da parte della collettività agente (la minoranza rivoluzionaria è sempre una collettività).
Quindi è il problema che le masse hanno che determina l’indirizzo dell’espropriazione, il conflitto con le forze padronali in corso, l’occupazione della fabbrica o della terra, lo sciopero spontaneo o con una presenza dei sindacati tradizionali solo come espressione marginale, sono tutte queste cose che fanno scegliere alla minoranza rivoluzionaria il tipo di espropriazione.
Non solo, ma l’espropriazione potrà essere realizzata solo con la collaborazione e con la determinazione della collettività in lotta che deve poi rilevare il bene espropriato. Infatti, dovendosi occupare una terra, la realizzazione potrà avvenire solo tramite i contadini che la riceveranno per lavorarla, che conoscono i problemi di quella terra, le possibilità di lavoro e di produzione, che hanno gravissimi problemi di sopravvivenza e di insopportabilità dello sfruttamento. La minoranza rivoluzionaria agirà da detonatore, svolgendo il lavoro più improbo e più pericoloso, sostenendo i primi scontri con i servi del padrone fin quando i contadini stessi non si saranno organizzati per la difesa del bene della comunità o il padrone non avrà vinto riprendendosi la terra. Anche nel caso limite dell’espropriazione di denaro il discorso non cambia. Infatti, finché il danaro uscito dalle casse dei capitalisti si trova presso la minoranza rivoluzionaria non è avvenuta l’espropriazione vera e propria, questa si realizzerà quando si concretizzeranno dei fatti con quel denaro. Ora, questi fatti riguarderanno sempre masse di lavoratori e di sfruttati, dovranno essere gestiti da queste masse e, in ultima analisi, l’espropriazione di denaro sarà pienamente realizzata con il loro concorso e la loro determinazione.
Quella parte dei beni espropriati (quasi sempre danaro, salvo che non si ipotizzi l’espropriazione di materiale bellico) che viene consumata direttamente dalla minoranza rivoluzionaria può essere considerata come un vero e proprio costo di produzione del fatto rivoluzionario ed espropriatorio. Ovvio che dato l’attuale stato di deformazione della natura umana, deformazione dovuta come sappiamo alla pressione della società in cui viviamo, non si può escludere il caso di degenerazione rivoluzionaria. In altri termini si potrà verificare il caso che uno o più membri della minoranza rivoluzionaria si appropriano di tutto o di parte del bene espropriato (ancora una volta, data la varietà degli usi, si tratterà quasi esclusivamente di denaro). In questo caso sarà la minoranza stessa a decidere i provvedimenti da prendere a carico di questi traditori della causa rivoluzionaria, comunque, questa eventualità, da sola, non potrà certo farci pronunciare in senso sfavorevole all’espropriazione rivoluzionaria come strumento di lotta contro i padroni.
Prima di lasciare l’argomento dell’espropriazione nelle sue linee generali, dobbiamo porlo in relazione con la condizione necessaria di questo atto di giustizia distributiva, la violenza. Non temiamo in questo di essere tacciati di scarsa consequenzialità affrontando un argomento etico dopo e in relazione a un argomento di tecnica rivoluzionaria e di economia. La separazione scientifica dell’economia dalla politica e dall’etica è stata fatta dai borghesi allo scopo, troppo manifesto, di impedire che alcune inopportune considerazioni etiche rendessero meno facili i loro maneggi diretti all’arricchimento a danno dei lavoratori.
Il padrone applica la più spietata delle violenze contro l’uomo, lo trasforma in una cosa, lo oggettivizza nel momento in cui lo pone come semplice componente della produzione al pari della terra, delle materie prime e delle macchine. Non contento di ciò lo compra, lo vende, lo sfrutta, gli ruba il frutto della sua fatica, e non sono pochi i casi in cui lo uccide sul posto di lavoro (omicidi bianchi). Anche non volendo citare i casi estremi (ma non tanto in questi ultimi tempi) della repressione a mezzo della polizia e dei fascisti dei tentativi di autogestione degli scioperi (picchetti, occupazioni, difesa degli scioperanti, ecc.), resta evidente che il padrone ruba con l’uso della violenza. Se rivolgiamo indietro lo sguardo, considerando lo svolgimento di questo fenomeno, come vedremo meglio più avanti, la violenza padronale diventa veramente terribile. Milioni di uomini sono morti a causa delle rapine dei padroni, del fatto che è stata tolta loro la terra con mille sotterfugi, a causa delle carestie e delle guerre. E come se tutto ciò non bastasse adesso il padrone ha inventato l’ultima violenza (espediente in vero intelligentissimo che ha consentito al capitalismo di sopravvivere), quella psicologica, tramite la pubblicità e i mezzi di informazione di massa, costringendo il proletariato ad entrare nell’aria del consumo signorile e defraudandolo di quella parte di salario che non riusciva a rosicchiare in modo diverso.
Dovendo riprendere il maltolto non si può non ricorrere alla violenza. Primo, perché il padrone difenderà il bene che gli viene sottratto, secondo, perché esiste tutta una struttura, vecchia di secoli, che ha provveduto a cristallizzare per tempo alcuni processi automatici che attaccano violentemente coloro che cercano di impadronirsi della proprietà altrui. È lo Stato, nella forma complessiva, che diventa quindi il tutore massimo, e con la massima violenza possibile, dei diritti del ladro capitalista. Pensare pertanto a una espropriazione senza violenza è completamente assurdo.
[1972]
Analisi del concetto di proprietà
Da punto di vista meramente logico-formale la proprietà si caratterizza come una ripartizione tra un “mio” e il “non mio” degli altri. Da ciò emerge un fatto: per aversi il concetto stesso di proprietà occorre una contrapposizione, una concorrenza, da un lato una cosa che io dico “mia” e dall’altro il fatto che per gli altri quella cosa non possa dirsi, nello stesso tempo, “mia” anche per loro. In questo modo la proprietà diventa il punto di partenza di una rottura, di una esclusione di qualcuno da qualche cosa. Questa esclusione può essere pacifica o violenta. È pacifica nel caso di sovrabbondanza della cosa oggetto di proprietà, violenta nel caso di scarsità.
Ora è caratteristico il fatto che, per aversi il concetto di proprietà nella pienezza della sua espressione, occorre che l’oggetto che sta a fondamento della pretesa esclusivista sia limitato. Infatti, anche se da un punto di vista logico si può parlare di proprietà di oggetti a disponibilità illimitata, la proprietà vera e propria si ha solo quando sussiste una minaccia, la presenza di qualcuno escluso dalla cosa e che vuole in un certo qual modo appropriarsene.
Ma una simile conclusione non è affatto soddisfacente. Purtroppo è una conclusione assai comune ed è servita da sostegno alle tesi reazionarie dei padroni e agli economisti loro servitori. Innanzi tutto, c’è da dire che le cose sono immediatamente assunte come cose strumentali, senza nessuna distinzione, o caratterizzazione, inoltre gli altri assumono la forma immediata di “massa” avente solo lo scopo di creare una confusa contropartita al mio desiderio di esclusività sulla cosa-strumento. Siamo più o meno nel regno della fantasia.
Un ostacolo ancora più grosso e che rende inutilizzabile questa prima approssimazione logico-formale è che viene data per scontata una specie di tendenza congenita per il “mio”, un vero e proprio sentimento della proprietà, senza scendere a una specificazione poniamo tra il bambino che afferra il dito che gli si porge e l’adulto che costruisce la sua fabbrica sul sudore dei suoi dipendenti e se la tiene stretta.
Una ulteriore penetrazione nell’analisi del concetto della proprietà possiamo raggiungerla studiando l’aspetto storico del problema. Le ricerche condotte da Herbert Spencer e dalla sua scuola hanno provato grosso modo questa linea di sviluppo. La proprietà privata era riconosciuta nei popoli primitivi indubitabilmente per gli oggetti mobiliari fabbricati dal possessore e parzialmente per quanto riguarda il prodotto della caccia. Col passaggio dallo stato nomade a quello sedentario, la comunità fissa in un certo qual modo la proprietà collettiva del suolo. Cominciano le prime forme di proprietà individuale a carattere temporaneo, si tratta di forme quasi di affitto del suolo in quanto questo restava sempre della comunità, ma questo affitto aveva anche la possibilità di essere lasciato in eredità. Comincia così la storia della proprietà individuale. La forma più duratura e diffusa fu però la proprietà collettiva della terra e la proprietà individuale dei frutti in funzione del lavoro esplicato nella coltivazione della stessa. Con il diffondersi della guerra e il sorgere del frazionamento in classi e ceti della popolazione, sorge la proprietà privata individuale per il terreno, ad opera di un conquistatore. Sorge pure tutta una gerarchia di vassalli e di servitori.
Secondo Spencer “l’individualizzazione completa della proprietà è un fatto concomitante del progresso industriale”. Le transazioni commerciali la favoriscono, sorgono le unità di misura e di scambio, la terra viene venduta, comprata, in una parola si identifica come un oggetto personale, come le cose prodotte dall’uomo.
Da ciò emerge un concetto di forza e di violenza. I più forti si sono impossessati della terra e l’hanno ridotta ad oggetto di proprietà individuale sottraendola al possesso comune. Spencer ci dice che però non è dell’opinione che questa sia la forma definitiva, come non lo fu la proprietà delle persone fisiche, cioè la schiavitù, per quanto ai suoi tempi sembrasse la cosa più logica e definitiva.
Per noi non è tanto importante l’attesa di una modificazione di carattere evolutivo, che potrebbe venire e potrebbe non venire, quanto la decisa eliminazione con la violenza rivoluzionaria di uno stato di cose che con l’inganno viene spacciato per definitivo e immutabile perché pertinente alla natura umana.
Se la violenza e l’inganno hanno fatto sorgere la classe povera costretta a vendere il proprio lavoro per non morire di fame, dobbiamo nella storia dell’uomo trovare le tracce di questi misfatti. Infatti, puntualmente troviamo spaventevoli espropriazioni, le cosiddette chiusure, che distruggono l’agricoltura decentrata, la grande pastorizia, la proprietà minuta e fanno nascere il latifondo. Milioni di uomini morirono di fame, il resto emigrò, i più forti andarono nelle città e costituirono i primi gruppi di offerta del lavoro gettando le basi della proprietà capitalista.
Ma la terra, da sola, non poteva costituire quell’accumulazione di capitali che sarà la base di sviluppo dell’economia moderna. Se la classe dei diseredati, spogliati, come abbiamo visto, con la forza e con l’inganno delle terre che possedevano, costituisce l’offerta di lavoro, che cosa determina la nascita della classe dei capitalisti?
Gli elementi sono diversi. Werner Sombart ebbe a indicare l’accumulazione della rendita fondiaria urbana. Ma da sola essa non basta, tra l’altro sarebbe anche illogico considerarla il punto di partenza, in quanto la rendita stessa è dovuta a investimenti precedenti di capitali. Infatti, nel Medioevo, era comune la vendita della rendita urbana contro il pagamento di una somma in denaro. Lo stesso discorso vale per la rendita agricola. Invece il commercio e l’usura furono i due sistemi principali dell’accumulazione di capitali. Ingenti somme erano già state messe da parte quando incominciarono le chiusure e si ebbe a disposizione quella grande massa di nullatenenti, così ebbe inizio il processo industriale moderno. Ma il richiamo della terra esisteva sempre e chi riusciva a mettere qualcosa da parte si cercava una terra disponibile, visto che di terre libere ormai non ce n’erano più. Da qui sorse la necessità, per i capitalisti, di portare i salari al minimo di sussistenza per potersi assicurare una domanda di lavoro costante. Ma questo è un altro problema.
È la storia, quindi, che ci ha detto chiaramente come la violenza militare e l’inganno dei servi dei conquistatori abbiano ridotto alla miseria milioni di persone, gettando le basi del moderno proletariato. Accanto a questa realtà storica si consolidava il concetto tipicamente moderno di proprietà individuale nel suo complesso.
Esaminiamo adesso il problema dal punto di vista giuridico e della storia delle istituzioni giuridiche. In questo modo la proprietà diventa un potere di godimento relativo a una cosa. Fino dagli inizi si è cercato di dare un assetto a questo tipo di potere che garantisse da un lato il consolidamento dei diritti di coloro che erano riusciti ad appropriarsi di qualcosa, dall’altro la separazione netta di coloro che non erano riusciti in questo intento.
La legislazione adulta parla di una limitazione in relazione agli obblighi che il proprietario trova indicati nella legge. In questo modo il dominio assoluto del proprietario trova un ostacolo negli interessi della collettività. Tutte belle parole che al momento dei fatti significano ben altra cosa. Questa collettività non è altro che l’insieme degli altri proprietari, essendo scontato che solo chi detiene il potere può imporre le leggi, nelle quali si trova appunto l’ostacolo al dominio assoluto del proprietario, chi detiene il potere è solo chi detiene la ricchezza, cioè l’insieme dei proprietari.
Quando si parla del divieto degli “atti emulativi”, cioè il divieto di compiere atti che senza arrecare vantaggio portano danno ai vicini, è logico che ci si riferisce al vicini proprietari. Quando si dice che la proprietà non deve essere d’impedimento alla realizzazione d’interessi pubblici, poniamo alla costruzione di un’autostrada o di un aeroporto o, sia pure, di un complesso di case popolari, non occorre molto a capire di quali interessi si parla. Sono infatti i padroni a essere interessati all’autostrada, all’aeroporto, strumenti del loro processo di arricchimento, e anche alle case popolari, strumenti di emarginazione e di tamponamento, a volte abominevoli, degli istinti di ribellione della classe proletaria. Non mette conto dimostrare la vera assenza degli altri limiti, ad esempio gli ammassi, o il dovere del proprietario di non abbandonare la conservazione, la coltivazione, l’esercizio di beni che interessano la produzione nazionale, o l’eventualità della formazione di consorzi coattivi, tutti strumenti diretti all’arricchimento dei padroni e al mantenimento, nelle classi più povere, di quell’equilibrio della sussistenza che è lo scopo principale di ogni arte economica.
Neanche questa approssimazione ci è però sufficiente. In questo modo non comprendiamo come si possa sostenere il concetto di proprietà individuale, salvo ad ammettere che si sostiene ad esclusivo beneficio di una classe ben determinata, la classe che paga questi farabutti di letterati e giuristi, avendone in cambio una ben congegnata costruzione metafisica, tanto utile per imbrogliare la povera gente.
Passiamo ora al problema della proprietà dal punto di vista economico-sociale, punto di vista che ci porterà al centro di tutte le discussioni e ci farà comprendere come siamo davanti a un falso problema. Seguiamo Ferdinand Tönnies in una esposizione molto importante che ci farà capire la vera differenza tra possesso e proprietà. Questo autore comincia col fare una distinzione tra volontà essenziale e volontà arbitraria. La prima è data dal complesso delle forze appartenenti in sé e per sé a un uomo o a un insieme di uomini, la seconda invece è tutto ciò che un uomo è o ha in relazione a certi mutamenti che arriva a percepire, conoscere ed immaginare.
Ora la proprietà, nel senso di possesso, appartiene alla sfera della volontà essenziale, nel senso di patrimonio appartiene alla sfera della volontà arbitraria.
In questo modo il possesso diventa una specie di proprietà organica e interna, mentre il patrimonio viene considerato come una proprietà meccanica ed esterna. Da un punto di vista psicologico il possesso costituisce un allargamento del proprio essere reale, ed è quindi esso stesso una realtà umana, il patrimonio costituisce invece un ampliamento delle possibilità di certi mutamenti e di certe relazioni del pensiero dell’oggetto. È proprio per questo che il possesso finisce per essere un’unità naturale e indivisibile, inseparabile dal soggetto se non contro la sua volontà, con la forza e principalmente con dolore. Il patrimonio si configura come un insieme di cose che non solo possono essere alienate con godimento per il soggetto, ma che sono proprio destinate all’alienazione.
Lasciamo adesso lo studioso tedesco per utilizzare dei dati concreti che ci confermano la tesi teorica suddetta. Spencer ci ha riportato le documentazioni relative agli usi di vita di alcune tribù selvagge dell’America del Nord, così come furono constatate da viaggiatori diversi in epoche diverse. Egli dice: “Nei primi tempi è difficile, per non dire impossibile, stabilire e distinguere i diritti degli individui sulle parti del territorio che la tribù percorre in cerca di nutrimento, ma non è difficile definire i diritti sugli oggetti mobiliari e sulle abitazioni, quindi troviamo normalmente questi diritti riconosciuti. La stessa cosa è documentata per alcune tribù del Brasile e per gli Esquimesi”.
È sempre nel concetto di possesso che inizialmente la terra venne propriamente posseduta dalle comunità. Queste si svilupparono e si articolarono in tribù e popoli ma la terra, pure assumendo come importanza e come realizzazione economica una dimensione anch’essa via via diversa, rimase sempre un bene comune.
Qui sorge una prima luce sul nostro problema. Abbiamo detto che il possesso è connaturato all’uomo, fa parte della sua sfera personale e reale. La capacità lavorativa, il suo lavoro, è un possesso dell’uomo in quanto egli si realizza in esso. Cedere questo lavoro, alienarlo per una contropartita in denaro è una cosa dolorosa, infatti si tratta di fare passare questo bene dalla sfera del possesso a quello della proprietà o del patrimonio, dalla sfera delle cose inalienabili a quella delle cose alienabili, passaggio che avviene, come abbiamo visto, con la violenza. Lo stesso deve dirsi per la terra. È la violenza che priva l’uomo della terra da lui posseduta in comune a tutti gli altri membri della comunità, come è la violenza che lo priva del suo lavoro e lo costringe a cederlo contro un salario. In questi due grandi avvenimenti della storia dell’uomo dobbiamo vedere un’analogia, analogia che ci consentirà di comprendere la profonda natura del possesso comunitario della terra e del lavoro, la base di quella che potrà essere in futuro la comunità di domani, contrapposta alla società di oggi fondata sulla sfera dell’alienabile e del commerciabile, cioè sulla sfera del patrimonio e della proprietà.
Vengono così a cadere le premesse logico-formali del concetto di proprietà. Non è possibile parlare in astratto di un “mio”, ponendosi al di qua di una ripartizione tra possesso e proprietà, ripartizione che anche l’aspetto giuridico cerca di afferrare ma che considera parzialmente solo riguardo alla maggiore o minore intensità del diritto reale. La vera e propria consistenza del “mio” è quindi quella della sfera patrimoniale in cui ogni oggetto è considerato esterno alla personalità umana, alienabile perché base dello scambio.
Si rivelano senza consistenza le supposizioni che da Thomas Hobbes in poi si trovano in tutta la letteratura autoritaria. Il potere statale è stato necessario per fare cessare una situazione disastrosa di continua guerra in cui il più forte aveva facilmente ragione del più debole, in cui non era possibile parlare di tuo e di mio. Assicurare la proprietà individuale è stato in questo modo lo scopo che assicurava nello stesso tempo la pace. Al contrario, il potere statale è stato necessario per consentire senza possibilità di difesa la rapina e il genocidio, per fare più forte il forte e più debole il debole.
[1972]
La proprietà fondiaria
Sappiamo oggi come la proprietà della terra fu agli inizi un possesso in comune. Dagli studi di Emile de Lavaleye ad oggi si è allargato di molto il campo delle nostre conoscenze. Dobbiamo però chiarire un punto, che di solito gli economisti difensori della proprietà individuale avanzano come elemento negatorio della tesi della proprietà comune. Gli uomini primitivi, come appare dal comportamento dei primati oggi, dovevano vivere isolati, quindi non è possibile la tesi della proprietà comune. In pratica l’obiezione è priva di fondamento, in quanto il concetto di proprietà di quegli esseri primitivi non poteva essere uguale al “mio” che oggi leggiamo negli occhi avidi del capitalista. La terra era per il primitivo un oggetto come gli altri, un possesso simile ai rudimentali strumenti che gli servivano per la caccia o per accendere il fuoco. Ed è questo stesso concetto di possesso, con la sua positività esistenziale, che viene mantenuto all’interno della comunità e quindi del possesso comunitario. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che quando parliamo di proprietà comunitaria intendiamo proprietà nel senso di possesso e non nel senso corrente oggi.
Se la tesi contraria alla nostra fosse vera, non si comprenderebbe come liberamente – in quanto la violenza non sarebbe logico aspettarsela dalla comunità nei confronti di un membro della stessa comunità – si sia verificato il passaggio dalla proprietà individuale a quella comunitaria. Infatti è possibile immaginarsi un passaggio violento dalla proprietà comunitaria a quella individuale, a seguito della forza di un conquistatore che fa proprio il diritto di tutti e lo esclusivizza, un passaggio inverso non è pensabile.
Ma il conquistatore non fa proprie le terre solo perché in esse identifica la ricchezza. Anzi le ricerche più recenti, fatte ad esempio da Georges Duby, hanno dimostrato che queste conquiste non avevano uno scopo diretto di arricchimento, almeno agli inizi. Il signore, infatti, non si considerava ricco in funzione delle terre che possedeva e tanto meno del danaro, ma si considerava ricco (e quindi potente) in funzione degli amici (vassalli, ecc.) su cui poteva contare. La terra serviva quindi sia per una diretta amministrazione sia per darla a questi amici legandoli al carro del conquistatore e costringendoli con un giuramento all’aiuto in caso di guerra.
L’evolversi dei commerci, delle necessità delle corti feudali, le scoperte dei nuovi paesi, la nascita del ceto proletario, il costituirsi delle prime industrie manifatturiere, il sorgere dei comuni e tanti altri fenomeni, determinarono una sostituzione del valore precedente (l’amicizia) con un nuovo valore (la produzione e quindi la ricchezza).
[1972]
Nota a Lo spirito di ribellione di Kropotkin
Educare e sviluppare lo spirito di ribellione, questo il compito del breve scritto di Kropotkin. Cogliere tutti i mezzi e tutte le occasioni perché si alimenti la rivolta e l’insofferenza popolare allo sfruttamento dei padroni e dei loro servi, lettura interessante, oggi, che buona parte dei compagni anarchici insistono sui tentennamenti e sulle riflessioni, facendo quasi l’inventario dei pro e dei contro, prima di spendere una parola a favore della rivolta e della ribellione.
L’insegnamento di Kropotkin resta ancora oggi chiarissimo su questo fatto. Non esistono momenti di riflusso di riferimento. Non esistono situazioni che fanno pensare più opportuno il camuffamento riformista o l’attesa revisionista, il compito degli anarchici è sempre uno, attaccare il potere sotto qualsiasi veste si nasconda, incitare gli animi alla rivolta, trovarsi pronti dove questa si sviluppa, indicando la strada per la liberazione dell’uomo e la distruzione del potere.
In questo breve scritto, l’analisi di alcuni fatti della rivoluzione francese s’intreccia continuamente con la spinta e l’incitamento all’azione diretta e all’insurrezione. Sono le masse, dice Kropotkin, che fanno la rivoluzione, l’azione diretta e continua delle masse, spinte ed incoraggiate da minoranze dotate di spirito di sacrificio e di abnegazione.
[1973]
Nota a La fine dell’anarchismo? di Galleani
Chiare parole, queste di Galleani, sul problema di quell’azione rivoluzionaria diretta – espropriazione e attacco – che costituiscono anche oggi argomento di grande importanza per tutto il movimento anarchico.
Non mancavano, all’epoca in cui Galleani redasse lo scritto che presentiamo [anche questo testo originariamente fu pensato come introduzione a una nuova edizione di La fine dell’anarchismo?, libro che poi uscì, diversi anni dopo, solo in ristampa], compagni che avversavano l’azione di Bresci o le espropriazioni di Ravachol, la loro opinione, cosiddetta legalista, si basava sul fatto che l’anarchismo era dottrina di fratellanza e di amore e che quindi non poteva partire dalle uccisioni e dai furti, dalla violenza e dall’attentato, per raggiungere la nuova società. Galleani con grande abilità controbatte questa tesi illustrando non solo la legittimità degli atti di espropriazione e degli attentati, ma la loro logica consequenzialità di fronte all’attacco permanente dei padroni contro i lavoratori, di fronte alla violenza degli sfruttatori e dei loro servitori in divisa o in livrea di burocrate.
Verificare oggi l’ipotesi di Galleani, la sua tesi costante di lotta e attacco alle istituzioni senza un attimo di riposo o di ripensamento, è cosa di grande importanza. Gettando uno sguardo alle lotte nazionali e internazionali ci accorgiamo che spesso, in molte situazioni, il movimento anarchico è stato superato dagli eventi, è rimasto impigliato nelle trappole involontarie tese da quei compagni che credono ancora in buona fede che bisogna aspettare, che non è il momento di attaccare, che non è il momento di incitare alla ribellione e alla rivolta armata.
Di riflesso, quelle realtà nazionali (Palestina, Irlanda, Grecia, Vietnam, ecc.) dove sono condotte lotte a sfondo nazionalista, ma senz’altro con una larga matrice di massa e dove i nostri compagni sono impegnati a fianco degli altri schieramenti, per la conquista minima del territorio o dell’indipendenza, dopo le quali diventano possibili tutte le componenti del discorso specificatamente libertario, quelle realtà nazionali – dicevamo – spesso vengono capite male o, peggio ancora, denunciate come lotte puramente nazionaliste, quando addirittura non vengono bollate come lotte fasciste o reazionarie in genere.
In questo modo corriamo il rischio di non capire la realtà mondiale che ci circonda e, a nostra volta, spostiamo il ragionamento sulla realtà italiana, determinando conseguentemente il fallimento di ogni tentativo di riscossa delle masse sfruttate, oppure accettando supinamente i tentativi – non sempre chiari – di strumentalizzazione che le componenti autoritarie del marxismo e del socialismo nostrani cercano di portare avanti.
La grande chiarezza di idee di Galleani, sia pure attraverso la sua prosa ormai superata dal tempo, è a nostro avviso un notevole contributo a questo problema.
[1973]
Vietnam e fatti italiani
“Ci troviamo oggi alle soglie di una nuova era di pace nel mondo”. Con queste parole Nixon ha incominciato il discorso di apertura della sua seconda presidenza, il 20 gennaio [1972] scorso. Ma il mondo intero non ha mancato di avvertire, dietro questo schema fisso, la vera sostanza dei rapporti di forza che si nascondo sotto il nome di “pace”.
La stampa borghese ha alzato inni di contentezza e di gioia, tutti guardano però con sospetto a questa nuova linea di politica internazionale. I servitori di casa nostra hanno anche trovato il coraggio di dire che presto ci sarà una proposta per dare a Nixon il Nobel della pace (non si tratta di una battuta umoristica ma di una precisa notizia trasmessa dalla TV italiana il giorno prima della firma definitiva dell’accordo).
Comunque, nel Vietnam le due parti in causa continuano a combattere per impadronirsi di alcuni punti chiave – dicono i corrispondenti della stampa padronale – in effetti perché le forze dell’esercito imperialista del Sud sono in rotta senza l’aiuto massiccio dei bombardamenti americani.
Abbiamo quindi un quadro della situazione che grosso modo si presenta così:
a) In America la fine della guerra anziché frenare la contestazione giovanile e dei gruppi di sinistra in genere sta determinando un accentuarsi di questo processo in tutti i sensi. William Shire, l’autore della Storia del Terzo Reich, (tr. it., Torino 1959-1960), ha affermato: “Il fatto che Nixon ha concluso la pace non cancella i crimini commessi negli ultimi quattro anni”. Paragonandolo infine a Hitler, Phil Hart, capo della sinistra democratica americana, ha detto, “Le forze che si sono battute contro la guerra avranno nel prossimo quadriennio una funzione ancora più importante, evitare alla società americana una involuzione autoritaria”.
b) In Vietnam la parola d’ordine vietcong “concordia e riconciliazione” sembrerebbe avallare la tesi riformista e quindi la definitiva cessazione della lotta a tutti i livelli. Da parte del Sud Vietnam imperialista, l’accordo assume le caratteristiche di una “carta delle variazioni”, un documento che sarà sistematicamente violato decine di volte.
Ma, in effetti, le prospettive del popolo vietnamita, al di là degli interessi internazionali di Nixon o di Breznev, sono solo quelle di partire dall’accordo di Parigi come da una piattaforma riformista per rilanciare la lotta rivoluzionaria. Perduta la guerra e anche la faccia, Nixon pretende adesso di rivincere tutto in un colpo dimostrando, con la conclusione delle trattative di pace, che in effetti la strada della lotta rivoluzionaria e insurrezionale è sbagliata, pretendendo di convincere un popolo, che lotta ininterrottamente da trent’anni, a posare il fucile e accordarsi per sottomettersi allo sfruttamento organizzato e sancito dall’urna elettorale. In pratica l’America non può rinunciare ai suoi servitori (Italia in testa) o ai suoi soci (Russia in testa), come questi ultimi, in blocco, non possono rinunciare ai capitalisti americani e ai loro investimenti finanziari. Certo la sinistra americana potrà dire la sua, ma sul piano politico vero e proprio, di un movimento di massa che causi una frattura d’opinione, non ha molte prospettive. I movimenti estremisti americani, come quello dei neri, forse possono indicare con più esattezza lo sdegno del popolo americano, ma non potranno fermare Nixon sia sulla via di una nuova guerra su altri lidi, sia sulla via di un rafforzamento imperialista.
Ecco perché non possiamo battere le mani anche noi. Ecco perché i giornali borghesi scrivono a lettere cubitali la parola “pace”. Ecco perché “L’Unità” si limita solo a dire “continui la mobilitazione e la vigilanza” ma non indica chiaramente agli Italiani in che cosa dovrà consistere questa continuazione della lotta.
La pace di oggi è un passo avanti, ma solo un passo, la guerra continua, anche senza gli “ufficiali” bombardamenti americani, ed anche se una votazione plebiscitaria desse al Vietnam un governo proletario la guerra continuerebbe lo stesso. Sono proprio i borghesi a tirare il più grande respiro di sollievo nell’apprendere che il Nord Vietnam non combatterà più. In questo modo potranno pensare con comodo al sistema di cancellare una sporca guerra che ha prodotto milioni di morti, i campi sterilizzati, le case e le città distrutte, tutto ciò sarà stato inutile e tutto si ricostruirà nelle stesse dimensioni di prima, attraverso la scheda elettorale, solo col grande schieramento di bandiere di diverso colore, con una appropriata modificazione di vocaboli e di invettive, con un cambio della guardia al potere più o meno appariscente e cruento.
Ma è appunto questo che dovrebbe essere evitato a tutti i costi. Il popolo del Vietnam dovrebbe poter ricostruire da sè, senza la presenza di ideologie autoritarie o di “consiglieri” stranieri portatori di “verità”, il proprio paese, la propria storia, la propria vita.
Un discorso del genere non può essere fatto in Italia dalla stampa ufficiale, comunista o borghese che sia. Come abbiamo detto “L’Unità”, organo ufficiale dei riformisti, richiama alla vigilanza, ma non ci spiega come mai la grande lotta Russia-America, vista attraverso il filtro del Vietnam, sia interpretabile alla luce del comune imperialismo di questi colossi. Lo stesso dicasi per la Cina che ormai, con la gestione Ciu En-Lai, si avvia verso un dichiarato social-imperialismo. (Il tavolo da ping-pong, in questo caso, non è da considerarsi soltanto un attrezzo sportivo).
Il “Corriere della Sera”, dopo gli annunci strepitosi dei giorni della pace, dichiara che si continua a combattere ma che “qualcosa si muove”, come a dire che le speranze dell’internazionalismo capitalista non sono del tutto morte. Si restituiranno i prigionieri e tutto finirà in una bolla di sapone. Sui vari campi di sterminio si metterà una bella lapide – del genere di Hiroshima o Nagasaki – e non ci si penserà più, e l’America di Nixon tornerà a essere la terra della libertà e della democrazia. La stessa preoccupazione si legge sulla “Stampa”, nel foglio del lunedì. “Un’altra guerra”. È sempre il motivo centrale dei massimi organi del capitalismo italiano, riflettenti in sostanza le preoccupazioni del capitalismo di tutti i paesi che, in un modo o nell’altro, dipendono finanziariamente dagli Stati Uniti.
“L’Epoca”, da canto suo, preferisce pubblicare una bella fotografia in prima pagina di Mussolini, ponendosi il drammatico problema, è stato fucilato una volta o due volte? Non è la prima occasione che questo settimanale, decisamente di destra, coglie per stornare l’attenzione della classe intellettuale italiana che lo legge, dal problema reale del momento. All’epoca dei fatti di Milano non pubblicò una copertina tricolore? All’epoca dei fatti di maggio alla Sorbona non pubblicò la grande vittoria di De Gaulle con tanto di bandiera sventolata da un balcone sul Boulevard pieno di gente? Questa volta, la problematica del Vietnam è relegata all’interno con un’accentuazione sugli aspetti religiosi.
Su posizioni più aperte il settimanale “Tempo”, organo di una certa sinistra italiana, che punta di più la sua attenzione sulle prospettive del popolo vietnamita, ma non ci dice niente né su quello che a giudizio dei suoi redattori dovrebbero fare i combattenti di quel paese nel corso di una probabile futura lotta di liberazione né quello che tutti gli uomini sono tenuti a fare a favore di questo popolo che lotta e che muore da trent’anni, e che certo non vedrà sul serio migliorata la propria situazione da una riunione di pezzi grossi in una bella capitale europea.
Più aderente a una prospettiva di lotta l’estrema sinistra italiana, ad esempio “Potere Operaio”, ma sempre al di dentro di uno schema autoritario e di settoriale conquista politica ed economica, al di dentro di quella prospettiva che i rivoluzionari comunisti vedono chiaramente ma che dagli anarchici è sottoposta a precisa critica, in quanto non è possibile ammettere la necessità di affidarsi alle urne, cosa che significherebbe non solo un tradimento della lotta vietnamita di liberazione, ma un tradimento dei princìpi rivoluzionari.
Non è stato colto, invece, nella giusta misura, dagli organi di sinistra, il fatto che il Vietnam non è solo quel posto dove gli americani hanno perfezionato il genocidio hitleriano, ma che nel mondo esistono molti Vietnam dove, palese o nascosta, esiste l’azione di sfruttamento dell’imperialismo capitalista e dove esiste quella forma particolarmente raffinata di oppressione che è il social-imperialismo comunista. Questo discorso – ovviamente non colto in nessun senso dalla stampa borghese – andava fatto, se non altro per indicare la vera realtà di un mondo diviso in zone di ingerenza dai tempi di Kennedy e soci, di un mondo che però accetta sempre meno questa ripartizione e che si ribella organizzandosi, anche se in forme sbagliate e con prospettive di scarso significato liberatorio, ma comunque dirette verso quella lotta allo sfruttamento che è la base del discorso rivoluzionario.
Non per niente, dal loro punto di vista, un fondo del “Corriere della Sera” dei giorni immediatamente successivi all’accordo, si intitolava “Il mondo muta anche per l’Italia”. In effetti la pace nel Vietnam creerà nei prossimi mesi la necessità di chiarificazioni nelle politiche internazionali di molti paesi, allo stesso modo in cui saranno chiamati a rendere conto delle loro scelte non pochi partiti riformisti che sul fatto “Vietnam” avevano trovato di che campare.
I recenti fatti di Milano e di Torino ci impongono una riflessione. Gli scontri di Milano – nel corso dei quali, davanti alla Bocconi, è stato colpito a morte lo studente comunista Franceschi – e quelli di Torino, davanti alla sede del MSI, nel corso dei quali sono stati feriti alcuni militanti di estrema sinistra, in ambedue i casi per colpi sparati (pare) dalla polizia, stabiliscono un punto fermo sull’inizio di una nuova procedura spicciola: sparare sui dimostranti.
Mentre in passato Avola o Battipaglia, Porto Marghera o Modena, costituivano fatti isolati, ben circoscrivibili nella logica di tentativi radicalizzati di reazione, questa volta siamo davanti a normali sussulti di rivolta, normali dimostrazioni, normali tentativi di impedire ai fascisti di organizzarsi e di diventare più forti di quanto non siano. Eppure la repressione è arrivata puntualmente con colpi di pistola, morti e feriti.
Certo da Pinelli a Franceschi, tre anni di lotte costellati di morti dovrebbero fare riflettere meglio sulle banali conclusioni cui è giunta la stampa borghese e riformista. Dovrebbero fare capire che quando uno Stato democratico, che per definizione sfrutta e tiranneggia con la dolcezza in bocca e con le tecniche scientifiche dell’inglobamento, deve ricorrere ai mezzi forti, alle repressioni sanguinose nella piazza, cioè ai mezzi cui di solito ricorrono le dittature totalitarie, allora si vede che qualche cosa nell’apparentemente perfetto meccanismo democratico si è inceppato.
D’altro canto, pure non essendo questo il luogo per aprire un discorso sulle frange estremiste di sinistra che oggi agiscono in Italia, alcune delle quali effettivamente sono prive di una strategia e di una prospettiva rivoluzionaria, ma semplicemente vanno avanti alla giornata, basando la propria crescita non tanto su problemi di scelta ma solo su accadimenti di piazza, resta il fatto che la sinistra riformista, con costanza degna di migliore causa, continua ad insistere che tutti questi gruppi non sono altro che provocatori che impediscono l’effettiva emancipazione dei lavoratori, l’effettiva strada verso il socialismo.
Ma quale sia questa strada italiana verso il socialismo i partiti riformisti italiani non dicono. Sarebbe interessante vedere adesso, dopo che in un certo senso verrà a cadere la facile polemica antiamericana (americani che bombardano, americani che uccidono bambini e vecchi, americani che devono andare via dal Vietnam), che cosa resterà a costoro da dare in pasto ai loro militanti. Certo non potranno riaprire il discorso “punto di riferimento” su Mosca, specie dopo l’inevitabile, sia pure piccolo, dissenso dei fatti di Praga. Non è un caso infatti che i carri armati russi siano ancora a Praga. Non potranno sottovalutare l’altro fatto, anch’esso macroscopico e che colpisce come un pugno in un occhio l’internazionalismo proletario, che Mosca considera un nemico più pericoloso i Cinesi di quanto non consideri gli Americani. E allora? Se buttiamo l’acqua con tutto il bambino non ci resta che sperare che papà Breznev si ricordi di essere anticapitalista, quand’anche la sua dimensione di marxista ortodosso e quindi di socialista autoritario gli consenta di fare una vera e propria distinzione tra capitalismo privato e capitalismo di Stato.
Eppure le lotte esistono, i sindacati riescono via via più difficilmente a tenere a freno gli operai. Caoticamente e per via sbagliate la critica di sinistra al tradizionale partito operaio ha dato per frutto una certa tendenza spontanea nell’organizzazione delle lotte. È qui che gli anarchici collocano la propria attività e il proprio impegno, inserendosi nelle lotte ma senza dimenticare il programma integrale, lavorando accanto agli altri senza però lasciarsi portare fuori strada, impegnandosi per la rivoluzione senza perdere di vista la definitiva costruzione dell’uomo nuovo. Malatesta scriveva: “Per noi l’importanza maggiore non sta in quello che si consegue, ché tanto conseguire tutto quello che noi vogliamo, cioè l’anarchia accettata e praticata da tutti, non è cosa di un giorno né di un semplice atto insurrezionale. L’importante è il metodo con cui il poco o il molto si consegue. Se per ottenere un miglioramento nella situazione si rinunzia al proprio programma integrale e si cessa di propagarlo e di combattere per esso, se si inducono le masse a sperare nelle leggi e nella buona volontà dei governanti, anziché nella loro azione diretta, se si soffoca lo spirito rivoluzionario, se si cessa di provocare il malcontento e l’insofferenza allora qualunque vantaggio risulta ingannevole ed effimero, ed in tutti i casi preclude le vie dell’avvenire”.
[“Vietnam e fatti italiani”, pubblicato su “Volontà”, n. 1, 1973, pp. 5-10 (pseud. Diable)]
La teoria del sabotaggio di Emile Pouget
Redatto nella prima decade del secolo, Sabotage rappresenta il manuale più spedito e completo di teoria e pratica del sabotaggio inteso come strumento di lotta dei lavoratori contro lo sfruttamento padronale. Di lettura agevole, ricco di esempi significativi, provvisto di un naturale supporto giustificativo dei motivi che condussero il movimento operaio all’uso di quest’arma di lotta, Sabotage ha oggi la stessa freschezza e la stessa utilità dell’epoca in cui fu scritto e, ancora oggi, si pone di fronte alle stesse titubanze e alle stesse indecisioni del movimento operaio, quando non si pone davanti alla stessa delittuosa azione frenante, posta in atto dai riformisti.
Emile Pouget fu giornalista francese e militante del movimento rivoluzionario internazionale. Figlio di un notaio di Pont-de-Salars, sull’Aveyron, fin da ragazzo svolse attività di pubblicista, giungendo a redigere “Le Père Peinard”, il famoso giornale anarchico che in breve divenne un simbolo di lotta e di fede nell’idea.
L’attività rivoluzionaria di Pouget si svolse quasi esclusivamente nel campo sindacale. Nel 1883 vene accusato di propaganda antimilitarista e arrestato. Nel corso di una perquisizione al giornale furono trovati opuscoli diretti all’esercito e opuscoli che parlavano della “propaganda con i fatti”. La manifestazione, che culminò con l’arresto di Pouget, vide per la prima volta nelle piazze la famosa bandiera nera. In testa al corteo erano, appunto, Pouget, Louise Michel e Mareuil.
La tesi di Pouget, in materia sindacale, è quella fondata sui princìpi fondamentali di natura rivoluzionaria. I lavoratori hanno il diritto e il dovere di attaccare i padroni, per strappare loro quella parte che questi ultimi rubano con l’ingordigia capitalista e con i processi di accumulazione, ma questa lotta deve essere basata sulla logica rivoluzionaria e sull’iniziativa della massa lavoratrice, non affidata, delegata, a rappresentanti che poi costituiscono strutture burocratiche, che possono magari prendere il nome di sindacati, ma che in definitiva non fanno altro che servire il padrone, vendendosi al migliore offerente, o restando legati al loro dialogo col potere.
Creatore, in Francia, delle Camere sindacali, insistette molto sulla capacità organizzativa delle masse lavoratrici, studiando tutte le possibili forme di una struttura sindacale nazionale o multinazionale, ma sempre cercando di garantire l’autonomia dei gruppi e delle camere locali, prevedendo al limite – in certe occasioni particolari – l’azione rivoluzionaria di gruppi capaci di attaccare il padrone e di danneggiarlo nei propri interessi, restando nell’anonimato, ma lavorando sempre all’interno di una logica sindacale di richiesta di miglioramenti.
L’esperienza inglese delle Trade Union lo fece lungamente riflettere sulle possibilità di un simile disegno. Nel suo pensiero è in un certo senso presente costantemente questa ambivalenza tra la necessità di un’organizzazione sindacale che minaccia sempre di sclerotizzarsi e l’imprescindibile apertura all’iniziativa spontanea delle masse lavoratrici. Verso la fine del secolo, sul giornale “Le Père Peinard”, scrive una serie di articoli in cui finisce per identificare lo sciopero generale con la rivoluzione, partendo sempre però da quella spinta della base che costituisce, in un certo senso, la caratteristica essenziale del suo sindacalismo.
Dopo “Le Père Peinard” passerà a dirigere il settimanale della CGT “La voix du peuple”, intorno al 1900. Pouget morirà nel 1931.
Il punto di partenza di Pouget era scaturito dalla constatazione che nell’ultimo ventennio del secolo, in Francia, l’attività dei gruppi anarchici era andata ad arenarsi praticamente in una miriade di attività frammentarie. A tal proposito Max Nettlau scrive: «In Francia, a partire dal 1880, il gruppo – con la sua assoluta autonomia, con le sue attività volontarie, con l’assenza di forze contrastanti, di ostacoli e di avversari, a meno che non cercasse la lotta – fu indubbiamente per gli anarchici una forma ideale di raggruppamento, ma quando il gruppo non aveva un obiettivo molto diretto da raggiungere, esso rappresentò anche un modo per isolarsi e per paralizzare le energie. Il gruppo fu anche un organismo facilmente annientabile giacché non era difeso da alcuna vasta collettività». (Breve storia dell’anarchismo, tr. it., Cesena 1964, p. 275).
Fin dal 1879 Pouget lotta per convincere gli anarchici della necessità di superare questo isolamento ed entrare nei sindacati, visto che non esistevano praticamente altri strumenti d’azione in seno al movimento operaio. Dopo la parentesi del suo arresto – dal 1883 al 1886 – Pouget prende contatto con Fernand Pelloutier. Il meccanismo delle Bourses du Travail, creato sotto il beneplacito del governo per fare concorrenza agli uffici di collocamento padronali, nella speranza che la cosa servisse da freno alle pretese degli operai, divenne in breve il mezzo più idoneo per l’entrata degli anarchici nelle strutture sindacali. Nel 1894 Pelloutier era vicesegretario della federazione, mentre l’anno successivo era segretario generale e vicesegretario era un altro anarchico, Paul Delesalle.
Che cosa apportarono gli anarchici all’interno del movimento sindacale francese ed europeo? Per prima cosa l’odio contro le strutture statali e contro il militarismo. Pouget venne arrestato, tra l’altro, perché in possesso di un opuscolo diretto all’esercito dove i soldati venivano spinti ad imbracciare le armi, uccidere gli ufficiali, marciare insieme al popolo contro il governo e lo Stato.
Sempre all’interno della struttura sindacale vi furono anarchici che si interessarono più specificamente del sindacalismo vero e proprio, anche senza arrivare all’estremo di Pierre Monatte (famosa la polemica Malatesta-Monatte al Congresso di Amsterdam del 1907), come Georges Yvetot e Delesalle, ed altri – la gran maggioranza – che si interessarono dell’introduzione di metodi di lotta operaia diretta, come appunto Pouget. Un esempio di questi metodi è lo scritto che presentiamo.
Questa, in poche righe, la situazione in cui viene pubblicato l’opuscolo di Pouget. In una lettera diretta a James Guillaume Kropotkin scriveva: «I sindacati sono stati durante venti anni la preda dei Dupire e dei Basly (militanti politici e non veri sindacalisti), sino a quando gli anarchici, dopo essersi creato un diritto alla vita per mezzo della dinamite, non si rivolsero ai sindacati allo scopo di trovare in essi un terreno per le nostre idee». (Lettera del 6 agosto 1907. Cfr. M. Nettlau, op. cit., p. 289)
Si prospetta il primo decennio del ventesimo secolo. La Francia vedrà durissime lotte sindacali, dove l’arma dell’azione diretta verrà impiegata su larga scala dagli operai. Man mano l’attenzione si sposterà, nelle organizzazioni sindacali rivoluzionarie, ad affinare una piattaforma teorica che giustifichi e renda applicabile questa azione diretta su scala sempre più ampia. Lo scontro produttore-capitalista, particolarmente acuto nel settore industriale, porta con sé strutture di lotta che in altri settori non avrebbero mai visto la luce, mentre queste strutture, anche se immediatamente non danno risultati tangibili ai fini migliorativi per i lavoratori, consentono l’apertura verso quella fase finale di lotta che, preceduta dal sabotaggio, dal boicottaggio e dallo sciopero, giunge allo sciopero generale, considerato come anticamera e come sinonimo di rivoluzione. Con questa fase finale non solo si risolve il conflitto produttore-capitalista ma si rovescia tutta la struttura del capitale arrivando alla fondazione della nuova società, della società libertaria.
La grandissima fioritura di iniziative, di lotte e di risultati pratici, si ebbe fino alla vigilia della prima guerra mondiale, dopo, il declino, accelerato anche dal successo della rivoluzione russa e dalla incapacità di molti militanti di adeguarsi alle nuove esigenze di lotta del riassettato mondo borghese postbellico. L’esperienza spagnola darà il colpo finale. Per una rinascita del movimento libertario bisognerà aspettare anni molto vicini a noi.
Ma torniamo al nostro discorso, ed esaminiamo meglio questa componente sostenitrice dell’azione diretta all’interno del movimento sindacale francese. Non bisogna dimenticarsi che lo spazio nel movimento operaio, gli anarchici, come scriveva Kropotkin, se l’erano acquistato con la dinamite e col sacrificio di migliaia di militanti, con la presenza costante su tutte le barricate rivoluzionarie e in tutti i moti di piazza, quindi uno spazio che aveva un significato ben preciso, ancora più preciso, possiamo dire, dello stesso antimilitarismo, quello del rifiuto della lotta politica nei termini di disputa parlamentare e governativa. È per questo che ogni tentativo di inglobamento da parte della struttura sindacale, ogni tentativo di cristallizzazione, veniva immediatamente rigettato, attraverso un ricorso sistematico all’azione diretta della base, all’organizzazione autonoma delle lotte.
L’ipoteca politica restava quindi ineliminabile riguardo i sindacati revisionisti e riformisti, legati al dialogo col potere e manovrati da uomini di potere. Al contrario, gli anarchici animano il movimento sindacale dal basso, identificando – spesso confusamente e a torto, ma sempre con grande dedizione alla causa – il sindacato rivoluzionario con la società futura, o almeno, con un embrione della società futura che tutti vogliono costruire. L’azione diretta, attraverso queste esperienze, si libera dalla prerogativa “necessaria” di azione violenta, che fino a qualche decennio prima aveva caratterizzato gli anarchici a tutti i livelli, per diventare azione esercitata dagli operai stessi contro i padroni senza l’intermediazione parlamentare o governativa. Come ha giustamente notato Jean Maitron (Histoire du Mouvement Anarchiste en France (1880-1914), Paris 1955, pp. 284-285), essa non deve intendersi come una forma particolare di lotta, ma come un metodo, lo spirito del quale conduce inevitabilmente alla lotta. Questo spirito può dare vita a forme d’azione differentissime, tra le quali sono al primo posto come efficacia il boicottaggio e il sabotaggio. Nel 1896 comincia Pouget (nella rivista “La Sociale”, n. 41 del 16-23 febbraio), nel 1897 Delesalle ne parla al IX Congresso della Confederazione generale del Lavoro (tenutosi a Tolosa dal 20 al 25 settembre).
Non tutti gli anarchici furono d’accordo con questa tattica. Jean Grave, tra gli altri, si schierò contro scrivendo che essa «affievolisce i caratteri e degrada l’operaio». (“Les Temps Nouveaux”, n. 42, 9-15 febbraio 1901). Altra corrente contraria a questa tattica, e che rappresentò una curiosa contraddizione all’interno stesso del movimento, fu quella che nello stesso Congresso di Tolosa fece votare una mozione di “rappacificazione sociale” costituendo un comitato permanente di conciliazione e di arbitraggio. Il rendiconto del Congresso di Tolosa del 1897 è stato stampato nella stessa città dalla stamperia Berthoumieu lo stesso anno. La mozione si trova a p. 139. Il panorama si complica se si tiene presente che quest’ultima corrente non risultava costituita solo dai “sindacalisti puri”, ma anche da coloro che credevano di più nell’azione diretta, però soltanto attraverso la struttura dello sciopero generale, per cui preferivano – per lotte particolari – fare ricorso a un meccanismo di pacificazione, in attesa del decisivo sciopero generale.
Ma in quale rapporto si può porre il sindacalismo rivoluzionario con l’anarchismo? Abbiamo visto che tutti gli elementi promotori dei successi del sindacalismo rivoluzionario in Francia, fino allo scoppio della prima guerra mondiale, furono anarchici, ma il più delle volte – come è indiscussamente il caso di Pouget – il loro passaggio dall’anarchismo “vecchia maniera” al sindacalismo vero e proprio avvenne quasi inavvertitamente.
Alcuni hanno affermato che sindacalismo rivoluzionario e anarchismo sono due cose ben diverse. (A. Rosmer, Le Mouvement ouvrier pendant la guerre, Paris 1936, p. 34). Altri hanno sostenuto che non si ha una vera e propria differenza, anzi che il sindacalismo rivoluzionario non è affatto una cosa diversa e nemmeno una corrente nuova dell’anarchismo, è soltanto una tattica nuova svolta all’interno dello stesso movimento anarchico. (R. Garmy, Histoire du mouvement syndacal en France, vol. I, Paris 1933, p. 276).
Altri militanti anarchici che, sulle prime, pure militando come sindacalisti, avanzarono delle riserve, accettarono poi una totale identificazione. Amédée Dunois in “Le Temps Nouveaux”, n. 31, 1 dicembre 1906, afferma che il sindacalismo se è sufficiente a se stesso non è sufficiente a tutto. Dopo meno di un anno, però, identifica sindacalismo rivoluzionario e anarchismo (“Le Réveil Socialiste Anarchiste”, 2 novembre 1907, Ginevra). È in questo momento che sorgono, però, le prime degenerazioni interpretative e che, storicamente, si può cogliere la nascita di quel prodotto ibrido che risponde al nome di marxismo libertario. (Cfr. A. Dunois, “L’Action Directe”, n. 9, 11 marzo 1908).
In questo modo si arriva al congresso di Amsterdam del 1907, indetto in contrapposizione al precedente congresso di Amiens che aveva segnato la nascita di un sindacalismo apolitico e quindi, almeno ufficialmente, anche privo di etichetta anarchica. Anzi nella “Carta di Amiens” non figura nessuno riferimento al movimento anarchico, sebbene i militanti anarchici costituissero, come abbiamo visto, l’ossatura principale del sindacalismo rivoluzionario francese del momento.
Qui il dibattito Malatesta-Monatte indica, chiaramente, come quella corrente avesse finito per assumere via via, specie in alcuni esponenti come appunto Monatte, una certa caratterizzazione di autonomia, generata in un certo senso dalla stessa convinzione che sindacalismo rivoluzionario e anarchismo si identificavano. Per la verità, se per Dunois questa identificazione è da considerarsi indiscutibile, per Monatte diventa il fondo di un discorso dal quale si diparte tutto un programma diverso, in cui socialismo e anarchismo trovano il loro migliore completamento. (Cfr. J. Maitron, op. cit., p. 306).
La risposta di Malatesta fu efficacemente inquadrata nello schema: “Il sindacalismo può essere accettato come mezzo, non può mai diventare un fine. Lo stesso sciopero generale, che per i sindacalisti è sinonimo di rivoluzione, non potrà essere considerato che come mezzo”.
Altrove, più avanti negli anni e nelle esperienze di lotta, Malatesta doveva confermare questi giudizi, anzi ribadirli più chiaramente. Nel 1927 scriveva: «Gli anarchici devono riconoscere l’utilità e l’importanza del movimento sindacale, devono favorirne lo sviluppo e farne una delle leve della loro azione, facendo tutto quello che possono perché esso, in cooperazione colle altre forze di progresso esistenti, sbocchi in una rivoluzione sociale che porti alla soppressione delle classi, alla libertà totale, all’uguaglianza, alla pace ed alla solidarietà fra tutti gli esseri umani. Ma sarebbe una grande e letale illusione il credere, come fanno molti, che il movimento operaio possa e debba da se stesso, in conseguenza della sua stessa natura, menare a una tale rivoluzione. Di qui la necessità impellente di organizzazioni prettamente anarchiche che, dentro, come fuori dei sindacati, lottino per la realizzazione integrale dell’anarchismo e cerchino di sterilizzare tutti i germi di degenerazione e di reazione». (“Il Risveglio”, 1-15 ottobre 1927).
Nel 1925 aveva scritto: «Il sindacalismo (intendo quello pratico e non quello teorico che ciascuno si foggia e suo modo) è di sua natura riformista. Tutto quello che da esso si può sperare è che le riforme che esso pretende e consegue siano tali ed ottenute in modo che servano all’educazione ed alla preparazione rivoluzionaria e lascino la via aperta a sempre maggiori pretese». (“Pensiero e Volontà”, 16 aprile 1925).
Meglio ancora nel 1922: «Per noi non ha grande importanza che i lavoratori vogliano di più o meno, l’importante è che quel che vogliono, cerchino di conquistarlo da loro, colle loro forze, con la loro azione diretta contro i capitalisti ed il governo. Un piccolo miglioramento strappato colla forza propria, vale più per i suoi effetti morali e, alla lunga, anche per i suoi effetti materiali, che una grande riforma concessa dal governo o dai capitalisti per fini subdoli o sia anche per pura e semplice benevolenza». (“Umanità Nova”, 6 aprile 1922).
Se il congresso di Amsterdam del 1907 segna la separazione dell’anarchismo come movimento dal sindacalismo come movimento, sebbene militanti anarchici restarono all’interno delle strutture sindacali, la tesi di Malatesta indica la possibilità di individuare ciò che oggi, come allora, significa qualcosa nell’azione sindacalista, e ciò che invece non significa altro che una inutile concessione al carro riformista. E il lavoro di Pouget, dal cui esame abbiamo preso le mosse per tutta questa discussione, si pone nell’àmbito di quella ricerca dei mezzi di azione diretta che, per l’appunto, Malatesta indicava congeniali a una interpretazione anarchica del sindacato come strumento e non come fine.
Torniamo, dunque, al discorso su Sabotage. Discorso di azione diretta, come si è detto, ma discorso che resta legato a schemi concreti e a schemi teorici. Vediamo di esaminarli separatamente.
Gli schemi teorici sono diretti a giustificare l’uso del sabotaggio. L’analisi condotta in questo scritto da Pouget è chiarissima, la classe dominante sfrutta e uccide con grande disinvoltura, nelle fabbriche e al fronte, i lavoratori sono trattati come strumenti di produzione e come carne da cannone e, ancora di più, anche nella stessa organizzazione della produzione la classe dominante non ha scrupoli, la mistificazione, spesse volte dannosa per la salute, è alla base di buona parte dello stesso processo di accumulazione capitalista. Eppure, contro questi crimini nessuno alza la voce indignato. Viceversa tutti i borghesi, all’unanimità e, purtroppo, anche qualche pseudo-rivoluzionario, s’indignano subito quando si parla di sabotaggio, come se non fosse più che legittimo l’uso di questo mezzo di lotta di fronte all’azione delittuosa costantemente svolta dalla classe dominante.
Gli schemi concreti sono diretti a esemplificare l’uso del sabotaggio. Oggi, con la situazione attuale di sviluppo della produzione, alcuni di questi schemi vanno aggiornati e perfezionati sebbene, da un punto di vista strettamente tecnico, non vadano sostituiti del tutto.
Per prima cosa il paragone tra sabotaggio e guerra di guerriglia è quanto mai valido ed attuale. Oggi abbiamo l’esperienza dello scacco subito dalla più grande nazione guerrafondaia del momento ad opera di un piccolo popolo, quello del Vietnam, dedicato alla guerra di guerriglia fino a costringere il colosso americano a scendere a patti. Qui non facciamo un discorso di merito sui risultati raggiunti, in questo momento, dal popolo vietnamita con la pace ottenuta, ma facciamo solo un discorso tecnico, la guerra di guerriglia mette in grave imbarazzo un esercito regolare, anche il più forte e il più perfezionato del momento. Allo stesso modo applicando il sabotaggio su vasta scala, come azione diretta della classe dei lavoratori nella lotta contro i padroni, si mettono in grave imbarazzo questi ultimi, costringendoli a scendere su di un terreno a loro ignoto, costringendoli a combattere contro avversari che sfuggono alla presa e che non possono essere individuati, isolati e colpiti.
Il fenomeno che oggi i capitalisti denunciano sotto il nome di “assenteismo” rientra, a nostro avviso, nell’applicazione inconscia dei metodi di sabotaggio, studiati da Pouget. Usando le nuove norme contrattuali che aboliscono la visita fiscale e delegano a questo l’Istituto di assistenza contro le malattie (INAM), i lavoratori possono godere di un periodo di due o tre giorni, nei quali non vanno a lavorare e non ricevono la visita fiscale, questa si presenta di regola il terzo giorno, dato che l’Istituto incaricato non può disporre di un numero sufficiente di medici fiscali. Ogni tentativo di superare questo ostacolo (con telegrammi o altro) da parte dei datori di lavoro si è arenato di fronte alla burocrazia dell’Istituto di controllo. Questo stato di cose ha dato vita a una intensificazione del fenomeno dell’assenteismo. Possiamo dirci certi che quando anche gli operai delle categorie che attualmente (come accade per i chimici) non godono del pagamento dei primi tre giorni di malattia, saranno pagati per intero, l’indice di questo fenomeno salirà ancora di molto. Il motivo è presto detto, a poca paga poco lavoro, inconsciamente il lavoratore ricorre a mezzi di lotta autonoma che rientrano nel discorso “totale” del sabotaggio.
Il fenomeno del “rallentamento del lavoro” ha subito una forte limitazione a seguito dell’estensione delle linee meccanizzate di produzione. Oggi tutto il settore metalmeccanico è organizzato in questo modo – solo una parte non significativa resta sganciata dalle linee meccanizzate. Il settore chimico, l’altro grande settore industriale, è legato allo stesso fenomeno per quanto riguarda la mano d’opera di base (confezionamento). Altri settori, come l’edilizia e i trasporti, restano più aperti a questa forma di lotta. La questione del “ritmo” nella fabbrica è una questione di violenza, violenza a senso unico, che produce incidenti mortali e ferimenti in quantità incredibile. Ogni ora lavorativa muore un uomo, ogni 6 secondi se ne ferisce un altro. Lo stesso direttore dell’INAIL ha dichiarato che si tratta di un fenomeno che assume sempre più le dimensioni di una guerra (“Un morto all’ora, un ferito ogni 6 secondi”, “Il Giorno”, 19 aprile 1968). Per i ritmi è qualcosa di allucinante. Le interruzioni raramente sono previste più di due al giorno con pausa di circa cinque minuti, una la mattina e una la sera. In alcune fabbriche si arriva anche a lavorare dodici ore al giorno a causa degli straordinari. Il discorso diventa più grave quando si parla dei cottimi. Spesso il lavoratore non può allontanarsi dalla catena perché manca la quarta squadra (la squadra che sostituisce i lavoratori che si debbono allontanare per un qualsiasi bisogno). Non è infrequente il caso che sono regolati anche gli orari per andare al cesso. In questa dimensione, come si vede, il rallentamento non è possibile, resta però valida l’arma del sabotaggio. Infatti, rendendo inefficiente tutta la catena, si procura non solo un danno considerevole fermando la produzione ma anche si interrompe il ritmo del lavoro. Gli operai metalmeccanici sanno benissimo come si può fermare una catena ma occorre però che la cosa venga fatta “a regola d’arte”, con mezzi idonei e con procedimenti che non consentano di individuare la responsabilità dei lavoratori.
Meglio collocati riguardo l’utilizzo della forma di lotta costituita dal “rallentamento del lavoro” sono gli operai metalmeccanici non legati alla catena di montaggio (gruisti, trasportatori, tecnici di grado più specializzato, manovali semplici, ecc.), gli operai dell’industria chimica addetti alle operazioni di controllo, i lavoratori dell’edilizia e quelli dei trasporti.
L’applicazione, in questi settori, delle tecniche di rallentamento può dare risultati positivi solo quando si costituiscano, all’interno di ogni organismo produttivo, delle unità operative, dotate di elevato spirito sindacale e di lotta, ma non legate a discorsi di potere del tipo tradizionale.
Il discorso sulla “qualità” del prodotto, fatto da Pouget, ovviamente adesso va aggiornato. Ad esempio, parlare oggi degli aiuti farmacisti non ha senso. I preparatori dipendenti di una farmacia sono veramente rarissimi, dato che adesso la farmacia vende solo prodotti specialistici confezionati direttamente dalla casa farmaceutica. All’epoca in cui venne redatto lo scritto di cui ci occupiamo, i medicinali erano preparati in farmacia, oggi invece i vecchi “preparatori farmaceutici” sono stati sostituiti dal settore dei lavoratori alle dipendenze delle grosse e medie industrie farmaceutiche. Qui, in una proporzione di circa l’80% dei casi, è stata adottata – in tutti i paesi a capitalismo avanzato – la catena di confezionamento. Sorgono quindi gli stessi problemi dell’industria metalmeccanica. L’inquinamento del contenuto, che sarebbe facilissimo, è invece un mezzo molto pericoloso in pratica in quanto i controlli delle partite prodotte non sempre vengono effettuati – come d’obbligo – prima dell’entrata sul mercato dei prodotti, ma spesso, di fronte alla pressione delle richieste, le partite vengono controllate quando già i prodotti sono sul mercato e quindi possono, anche se in parte, essere già stati consumati. In questo modo, inquinando una partita, non si sarebbe sicuri che la stessa verrebbe bloccata dai laboratori di controllo, ma potrebbe verificarsi il caso di danneggiare seriamente i consumatori.
Viceversa, sempre restando nell’àmbito del sabotaggio nel settore chimico-farmaceutico, branca produzione di medicinali, si possono differenziare e, al limite, ridurre a zero, i riempimenti dei contenitori. In questo modo, se il sabotaggio, che è comunque tecnicamente attribuibile a un difetto o a una non perfetta messa a punto della dosatrice, è abbinato all’azione degli addetti ai controlli del contenuto (non degli addetti ai controlli di qualità), il risultato sarà quello di immettere sul mercato confezioni prive di contenuto o di contenuto ridotto. Il consumatore non verrebbe danneggiato in quanto il farmacista venditore ha l’obbligo di cambiare il prodotto che risulti vuoto prima di essere stato aperto. Naturalmente la cosa finisce per danneggiare notevolmente l’industria di partenza che in breve si accorgerebbe del sabotaggio.
Riguardo lo strumento di lotta “a bocca aperta”, la sua efficacia è grandissima nei settori dei servizi in genere, in particolare quei settori dove il segreto e la fiducia sono alla base della “produzione” capitalista. Un settore importante e decisivo, perché darebbe subito il segno della estrema gravità di questo mezzo, una volta bene impiegato, è quello dei servizi bancari. In pochi giorni la filiale di una grande banca sarebbe costretta a chiudere gli sportelli se i suoi dipendenti decidessero di attuare questo sabotaggio, detto “a bocca aperta”. Come tutti sanno, infatti, il lavoro bancario si basa principalmente sulla segretezza, i depositari in particolare non vogliono fare conoscere l’entità dei capitali versati, gli speculatori di borsa non vogliono fare conoscere il giro d’affari dei titoli venduti e comprati in un certo periodo di tempo, i commercianti non vogliono fare conoscere le somme versate perché da queste il fisco capirebbe il loro giro d’incassi effettivo, gli industriali non vogliono fare conoscere l’ammontare dei pagamenti effettuati da terzi a loro favore, l’ammontare delle fatture emesse (che si potrebbe ricavare dalle tratte spiccate e presentate in banca per l’incasso), l’ammontare degli stipendi pagati al loro dipendenti, ecc. Tutti hanno qualcosa, di piccolo o di grosso, da nascondere. Basterebbe un piccolo foglietto distribuito in giro, davanti alla porta di una banca, contenente qualche nome e qualche cifra, per far danni di tale portata a quella banca da indurla subito a modificare il suo atteggiamento verso i dipendenti.
Volendo approfondire questo discorso, si vedrebbe come un simile atto di sabotaggio avrebbe due tipi di ripercussioni, ambedue deleteri per i padroni. Un primo tipo, spingerebbe gli altri lavoratori del settore, visti i risultati veramente macroscopici ottenuti, a usare la stessa tattica, sia nella stessa banca che in altre banche, sia nello stesso settore che in altri settori (ad esempio il settore assicurativo, sebbene in ferma più limitata, ha anche un grande fondamento di segretezza). Un secondo tipo, causerebbe ripercussioni negative in tutta l’economia nazionale, con spostamenti repentini nei depositi, scelta di canali di risparmio diversi (ad esempio i buoni postali o i depositi postali – ma anche qui il discorso potrebbe essere applicato dai dipendenti delle Poste e Telecomunicazioni), conseguenze gravi in borsa e nella stessa gestione governativa degli investimenti. Senza volere andare oltre con la fantasia, si avrebbe un mezzo di lotta di portata vastissima e di risultati certi.
A questo punto vorremmo illustrare un mezzo di lotta che rientra nel sabotaggio “a bocca aperta” che, a quanto ci risulta, non è stato impiegato come mezzo corrente in gestione normale d’impresa, ma che è stato usato una volta, nel corso dell’occupazione di una fabbrica, dopo che il padrone aveva deciso di chiuderla perché, secondo i suoi calcoli, improduttiva.
La fabbrica, che chiameremo “X”, occupava 250 dipendenti circa ed operava nel settore filati. La situazione aziendale, dal punto di vista finanziario, secondo un documento messo in circolazione dallo stesso padrone e diretto alle organizzazioni sindacali e agli organi responsabili governativi, oltre che agli stessi dipendenti, era disastrosa. I bilanci degli ultimi anni presentavano passivi crescenti, succedutisi ad attivi irrisori. Conclusione, chiusura e licenziamento dei dipendenti. Alternativa, finanziamento dello Stato per diversi miliardi e apertura di una nuova fabbrica, con macchinari più aggiornati e quindi più competitivi.
L’azione dei sindacati riformisti non era arrivata al di là di una manifestazione, accompagnata da opportune parole grosse, diretta a denunciare l’azione del padrone che, chiaramente, voleva farsi fare la fabbrica nuova a spese dello Stato senza pagare una lira di tasca propria.
In effetti, i bilanci presentavano una crescente diminuzione dei margini di profitto, specie nelle esportazioni, in conseguenza della diminuzione all’estero dei prezzi di vendita del prodotto, essendosi quei mercati orientati verso scelte più idonee a una tecnologia più avanzata. Da qui la richiesta della nuova fabbrica, dei nuovi impianti, ecc. Il compagno che ebbe modo di esaminare i bilanci, con l’aiuto di altri compagni che lavoravano nell’amministrazione della fabbrica, si accorse che nel discorso padronale c’era qualche cosa di vero come in tutte le bugie di questo mondo – ma non era del tutto vero. Cioè, il falso del bilancio era che esso risultava maggiorato in certe valutazioni passive, mentre alcune voci dell’attivo – come il monte merci – erano state decurtate a seguito di eccessivamente “cautelativi” criteri di valutazione. In questo modo di fronte a una perdita poniamo di circa 10 milioni si poteva ricostruire un utile di circa 15-18 milioni, utile reale che comunque non copriva l’interesse sugli investimenti immobili dell’imprenditore. Per questo ultimo motivo egli aveva – dal suo punto di vista – ragione a dolersi della situazione produttiva, a sofisticare il bilancio, denunciando una perdita e a costruire tutta l’impalcatura di menzogne che avrebbe portato sul lastrico decine di lavoratori e le loro famiglie.
In linea teorica, partendo da una logica economica capitalista, la fabbrica andava buttata a mare perché improduttiva. Infatti quell’utile reale, riportato alla luce dall’esaminatore del bilancio, non raggiungeva l’importo che l’imprenditore avrebbe incassato se, venduto tutto (terreno, fabbricato e macchinari), avesse depositato il ricavato in banca. Quindi, per lui, la soluzione andava sbloccata, o nuova fabbrica, a spese dello Stato, o vendita e investimento del ricavato in altro settore più produttivo. Per i lavoratori, l’autogestione della fabbrica sarebbe stata invece oltremodo produttiva, in quanto la parte del loro cosiddetto guadagno – i salari – è già compresa nel costo di produzione, quindi non andava ad intaccare quell’utile reale riscontrato, anzi si poteva pure prospettare una più lunga lotta contro la non concorrenzialità dei prezzi all’estero e un’attesa più fiduciosa di una sistemazione diversa.
Proprio perché il discorso aveva una seria probabilità di attecchire venne immediatamente bloccato dai sindacati che però non riuscirono ad evitare l’occupazione dell’industria.
A questo punto il colpo di scena. Alcuni compagni dipendenti dell’industria “X” si impadronirono dei dati contabili relativi agli ultimi bilanci presentati al fisco, per la precisione i tre anni precedenti a quello in corso, cioè dei dati relativi ai bilanci che erano stati esaminati prima. Questi dati fecero emergere un fatto nuovo, il padrone aveva operato una precisa doppia fatturazione dei suoi prodotti alla vendita, una ufficiale con applicazione dell’IGE e denuncia al fisco per l’Imposta di Ricchezza Mobile, e una non ufficiale, con fatture in carta velina, senza applicazione dell’IGE e senza denuncia al fisco. Per fare questo egli aveva dovuto occultare, proporzionalmente, parte delle fatture all’entrata, relative agli acquisti di materie prime. Si era di fronte alla classica doppia contabilità, situazione normale di quasi tutte le aziende.
A questo punto si decise di costringere il padrone a riaprire la fabbrica, a potenziarla con l’acquisto di nuovi macchinari, a rivedere i suoi piani di fabbricazione, ad aumentare i salari portandoli al limite fissato dai contratti di categoria, insomma in una parola a fare tutto quello che non aveva fatto e che affermava di non potere fare. L’arma che lo costrinse ad agire fu un banalissimo foglietto di carta in cui erano segnate, per i tre anni precedenti, due colonne di cifre, nella prima le cifre “ufficiali” denunciate al fisco, nella seconda le cifre “non ufficiali” occultate al fisco.
Le richieste vennero accolte immediatamente con grande sorpresa dei sindacati, in primo luogo, e degli stessi dipendenti i quali, naturalmente, non tutti sapevano dell’operazione che era stata condotta a termine nel corso del primo giorno di occupazione.
Questo strumento di lotta può essere adottato, a nostro avviso, anche nel corso della gestione aziendale e in regime di normalità di produzione, cioè anche quando il padrone non minaccia chiusure o altro. Naturalmente occorre la collaborazione dei lavoratori addetti agli uffici. Infatti anche una semplice segretaria può venire in possesso di certi documenti che possono essere fotocopiati e conservati per il momento opportuno, per predisporre quest’arma di lotta non occorre avere dalla propria parte il direttore generale.
Resta il fatto che il padrone, di fronte alle richieste e allo strumento impiegato per queste richieste, si rivolgerà immediatamente contro i dipendenti amministrativi. Per questo si può ricorrere all’opera di un compagno di un’altra unità lavorativa, oppure a un biglietto presentato da uno sconosciuto. Di fronte all’alternativa il padrone non ha che una unica soluzione, accettare quanto gli viene richiesto.
C’è da dire un’ultima cosa, quelle notizie, usate una volta, possono essere usate nel corso degli anni futuri anche altre volte, fino a quando gli anni a cui si riferiscono i dati in possesso dei lavoratori non siano stati concordati con il fisco, cosa che in genere non avviene prima di quattro o cinque anni.
Questo strumento di lotta, di risultato sicuro, rientra a nostro avviso tra gli strumenti dell’azione diretta, e può essere gestito solo da lavoratori estremamente sensibili alla lotta, non solo sindacale ma rivoluzionaria. In mano a persone senza scrupoli morali, oppure a singoli staccati dalla lotta comune, si traduce in un ricatto, cioè uno strumento di arricchimento personale che non può essere assolutamente tollerato.
Resta da esaminare, prima di concludere, l’ultimo mezzo a disposizione della lotta contro i padroni, sempre restando all’interno della logica del sabotaggio, la rappresaglia.
Se il padrone ricorre ai mezzi forti, licenziamenti e denunce, fascisti davanti alla fabbrica o alle porte del feudo e poliziotti dietro a proteggerli, l’azione diretta dei lavoratori può ripiegare sulla rappresaglia nei confronti dei beni di proprietà del datore di lavoro, dei mezzi di produzione e di tutto quanto concorre a determinare la capacità di resistenza della controparte.
Pouget ha fatto l’esempio, dettagliato e ricco di dati, del sabotaggio delle linee telegrafiche. Oggi, di fronte alla struttura monolitica delle grandi industrie dei settori metalmeccanico e chimico, questa tecnica di sabotaggio diventa di grande importanza. Come abbiamo visto il lavoratore non può applicare, ad esempio, la tecnica del “rallentamento del lavoro” se è legato alla catena di produzione, non può applicare la tecnica a “bocca aperta”, in quanto quest’ultima è valida soltanto in alcuni casi, ma può applicare la rappresaglia. Gli impianti possono essere danneggiati nel corso delle ore lavorative, con grande perizia e da lavoratori che sono talmente preparati – sotto l’aspetto tecnico e l’aspetto politico – da sentirsi di farlo.
Lo stesso discorso è valido per i grandi impianti chimici che, di regola, sono legati alla continuità operativa ma che possono essere attaccati da un commando di lavoratori, in forma clandestina, ottenendo risultati veramente notevoli.
C’è da dire, in ultimo, che trattandosi di specialisti e non di terroristi estranei all’ambiente e desiderosi solo di distruggere, l’azione dei sabotatori potrà essere fatta rientrare nei limiti di salvaguardia e quindi non presentare alcuna pericolosità per le persone, pure realizzando la massima dannosità per gli impianti e i beni del datore di lavoro.
Questo, in parole e con prospettive più aggiornate, il discorso di Pouget, un discorso sindacale ma impostato sull’azione diretta, un discorso al bivio tra la mera rivendicazione parziale e l’educazione alla lotta rivoluzionaria. Un discorso nel quale crediamo e che consideriamo un valido strumento nelle mani dei lavoratori, nel corso delle future lotte, fino alla vittoria finale.
[Introduzione a E. Pouget, Sabotaggio, tr. it., Ragusa 1973]
Analisi antigruppo ed estetica libertaria
L’impressione generale che si ricava dall’Analisi antigruppo, almeno da parte mia che non sono uno specialista, è che si voglia dire qualcosa tra i denti, con violenza, magari, ma trattenuta, come se si prendessero le misure da una posizione troppo arrischiata. Nat Scammacca scrive: “Voglio essere ottimista, credo negli uomini e negli scrittori critici dell’establishment come Leonardo Sciascia e Carlo Bo, in fondo penso che siano buoni ma si trovano sopraffatti dalla condizione di stare al vertice di un triangolo”. Ma, caro Nat, credere negli uomini non significa essere ottimisti, significa solo essere realisti, in quanto l’uomo ha veramente quella carica di amore e di reciproco aiuto che può fare pensare possibile la costruzione della società futura, carica che è continuamente coartata dalla presenza del potere. Ma un ottimismo (o realismo) come questo diventa immediatamente sciovinismo pericoloso e controrivoluzionario, quando dalla fede nell’uomo si passa alla debolezza di credere possibile la resipiscenza in coloro che si sono fatti servi del potere, e servi tanto più subdoli e pericolosi quanto il loro servilismo si ammanta delle vesti socialdemocratiche e critiche, delle vesti moderne ed efficaci del potere inglobante che ha superato la fase idiota della pura brutalità. Gente come questa non è affatto sopraffatta dalla situazione di potere, ma la costruisce giorno per giorno, sacrificando tutto sull’altare della notorietà e dei benefici concreti che da questa provengono. Credere sul serio (salvo che mi sia sfuggita una sottintesa ironia nel tuo discorso) che questa gente svolga una funzione critica è un’illusione che domani potrebbe tornare assai pericolosa.
Un altro punto che non ho capito bene è il ricorso alla definizione “poetica populista”. In effetti oggi in un ambiente di filistei e di mafiosi questa parola potrebbe dare l’apertura a tutta una serie di distorsioni e di incomprensioni. Mi sarebbe sembrato tanto più logico l’impiego del termine “poetica libertaria”, visto che, se ho ben capito, fino dall’inizio del discorso dell’Antigruppo, il tema centrale è stato proprio questo, dissacrazione dell’arte aristocratica con tutta la sua futilità e indicazione di un’arte che tenga presente non solo il popolo – che come mezzo brutale di espressione potrebbe risultare estraneo e ottuso – ma l’uomo, che costituisce il popolo, il singolo che presa coscienza della sua situazione di sfruttamento non si apparta in un angolo a guardarsi l’ombelico, ma si inserisce nel popolo e col popolo combatte la sua battaglia rivoluzionaria, da artista, se artista egli si considera, pronto comunque, come è accaduto in passato ad artisti veramente tali, a scendere nelle strade se il momento lo richiede.
Vediamo allora in questa prospettiva, e per ragione di cose in succinto, quali potrebbero essere, secondo me, le essenziali caratteristiche di un’estetica libertaria.
1) Il pluralismo libertario determina la necessità di una presenza feconda di correnti estetiche. Se la corrente individualista esalta la persona singola, in compenso le aperture pericolose che questa corrente può presentare (ad esempio, Wagner) vengono corrette e integrate dalle correnti collettiviste e comuniste che mettono l’accento sulla capacità artistica della collettività e della comunità.
2) Un’arte nuova, capace di uscire dalla distruzione dei musei e delle pinacoteche, come pure delle biblioteche. Distruzione, quest’ultima, che deve intendersi non tanto in senso reale (se l’atto rivoluzionario popolare lo richiedesse non saremmo certo noi a piangere sul latte versato o a commuoverci per una Gioconda in più o in meno), quanto in senso di eliminazione di valore propedeutico, come di qualche cosa che vada considerata presente, senza la quale non è possibile la creazione artistica.
3) L’arte come esperienza, creazione che si oppone e cerca di eliminare anche con la violenza l’arte che ci fanno subire, quella delle caste padronali e aristocratiche del passato e del presente. In questo modo ogni individuo diventa un artista capace di creare. Il contadino che ara il suo campo, una volta liberato dalla schiavitù dello sfruttamento, può manifestare l’essenza artistica e creatrice del suo lavoro, alla pari dell’operaio che rotta la catena dell’officina emerge al livello creatore dell’artigiano rinascimentale, ma in chiave moderna e con un’accorta coscienza rivoluzionaria. Non è possibile, in questo senso, fornire indicazioni, perché le capacità creative dell’uomo sono costantemente terrorizzate dalla presenza del potere, ma è certo che quando riescono ad emergere (e allora imprudentemente noi parliamo dell’artista) esse esistono e s’impongono. Si tratta quindi di trasformare l’arte da fatto individuale (e quindi per necessità di cose aristocratico) in fatto generale, modificando il mondo e creando la società nuova. In questo senso, intendiamo quindi che l’artista non si differenzia dal rivoluzionario, in quanto se vuole essere veramente tale deve fare lo stesso lavoro del rivoluzionario, cioè lavorare alla creazione della società del futuro.
4) L’arte come situazione diventa quindi la necessaria conseguenza dell’arte come esperienza. L’antiautoritarismo libertario distrugge il “capolavoro”, il “grande artista”, il “genio”, e ridicolizza il loro ruolo storico, indicando come tutte le volte questi fenomeni sono stati messi a profitto dal potere, quando non sono stati finanziati e voluti dallo stesso. Con Proudhon potremmo allora parlare di un’arte spontanea, funzione della situazione, cioè del momento e del posto. L’accento passa dal lavoro nella sua oggettività – prodotto meramente marginale – all’arte come creazione diretta, come impegno di vita. Quindi distruzione di ogni barriera che separa l’arte dalla vita e che rende spesso incomprensibile e falsa la prima una volta portata davanti alla prova della seconda.
5) Un’arte fatta dal popolo, quindi, non solo un’arte per il popolo. La seconda soluzione, che potrebbe essere ravvisata nella tua proposta di “arte populista”, diventa sempre qualcosa che parte dal presupposto dottrinario ed esplicativo, un’arte didascalica come che sia. Ma l’arte, in sostanza, ha una missione ben precisa, portare il popolo a prendere coscienza di se stesso. Quindi, anche nel momento in cui i mezzi limitati e la situazione di alienazione determinata dal potere politico ed economico ci consentono soltanto un’arte per il popolo, il nostro lavoro deve essere fatto in modo che emerga la chiarificazione che anche il popolo può e deve diventare artista e non soltanto passivo fruitore di una produzione aristocratica e circoscritta.
[1973]
Tra contadini. Dialogo sull’anarchia
Lavoro chiarissimo e utile. Nato per la propaganda e strutturato in forma dialogica, tale da risultare immediatamente accessibile a coloro che non hanno dimestichezza con lo scritto, il libretto di Malatesta a quasi cento anni di distanza mantiene intatto il suo valore di fondo, ed è per questo che l’editore ne ha curato una nuova edizione.
Il lavoro di Malatesta è troppo noto per dilungarci sulla sua esposizione, in esso sono trattati quasi tutti i temi fondamentali dell’anarchismo, con chiarezza e sintesi. Quello che conta, in questa sede, è indicare l’utilità che se ne può cavare dalla sua lettura oggi, di fronte agli impegni sempre più pressanti che la situazione ci propone.
Siamo dell’opinione che la lettura dell’opuscolo torna utile perché innanzi tutto esso è chiaro su alcuni punti assai controversi, proprio quei punti sui quali spesse volte ci disarma con tanta facilità l’ingenua domanda del nostro ascoltatore. Che cosa avverrà dopo la rivoluzione? In che modo si potrà procedere alla costruzione della società nuova? Non correrà un rischio troppo grande la rivoluzione lasciata in balia di se stessa? Non sarebbe forse più accettabile la tesi marxista del periodo transitorio della dittatura del proletariato? Tutte domande che chi fa propaganda anarchica si è sentito ripetere centinaia, migliaia di volte, e alle quali sa come rispondere, ma forse non con la chiarezza delle risposte che Malatesta fornisce in questo piccolo libretto.
Se, d’altro canto, si pensa all’epoca in cui esso fu scritto, allo stato di sviluppo della scienza sociale e delle scienze in generale, ci si accorge come veramente l’agitatore e pensatore anarchico vedesse le cose con lungimiranza e chiarezza uniche. Oggi sappiamo come molti problemi gravi, per l’epoca di Malatesta, sono facilmente risolvibili con lo stato di sviluppo attuale delle ricerche scientifiche, solo che la gestione padronale del potere lo volesse.
E a fianco di questa ammirevole parte, l’altra, altrettanto chiara e incisiva, la problematica della disciplina rivoluzionaria, intransigente, senza mezzi termini e senza dispotismi inutili e controproducenti. Quante volte oggi di fronte a tanti compagni che disperdono le loro forze in mille cose di cui solo alcune utili alla causa della rivoluzione, di fronte a compagni che prendono impegni con la stessa facilità con cui non li mantengono, ci vengono in mente le parole di Malatesta.
E così su tanti altri problemi, il comunismo subito, il rifiuto della dittatura del proletariato che non può non essere dittatura sul proletariato, la distruzione della macchina statale che non può estinguersi per inedia ma che tende sempre a rafforzarsi sostituendo la vecchia classe dirigente con la nuova, il problema della democrazia diretta, della partecipazione alle decisioni collettive, il problema della vita stessa della base che determina l’andamento della comunità.
Questo l’opuscolo, Tra contadini, apparentemente una piccola cosa nella grande e varia produzione di Malatesta, ma una piccola cosa che rischiara tanti problemi tutti estremamente difficili.
[1973]
Un’analisi nuova per la strategia di sempre
Lavoro abbastanza serio fatto in collaborazione da cinque compagni che hanno rifuso insieme la loro esperienza di militanti e di studiosi del movimento anarchico. In rapporto all’estrema povertà di quanto viene a trovarsi oggi in circolazione a livello analitico si può dire che si tratta di uno sforzo notevole. Considerando, invece, il lavoro in relazione ai problemi che pretende di affrontare e ai risultati ai quali giunge, come pure in relazione ai debiti che contrae con una scontata pubblicistica borghese, non possiamo che restare su di una valutazione negativa.
Poiché le incensate non sono il nostro forte (e di questo genere di valutazioni tra poco vedremo qualche esempio sulle solite riviste nostrane), non ci resta che tentare un’analisi approfondita del lavoro, naturalmente nei limiti dei nostri mezzi.
Grosso modo il libro si divide in cinque parti, le prime tre comprendono una trattazione dei fini, una analisi e una trattazione dei mezzi, le ultime due sono dedicate al problema dell’organizzazione e al problema della definizione storica dell’anarchismo. I compagni che hanno sviluppato il lavoro sono Roberto Ambrosoli, Nico Berti, Amedeo Bertolo, Paolo Finzi, Luciano Lanza.
Fino dalla premessa, che costituisce una breve esposizione delle condizioni in cui si è venuto a trovare il movimento anarchico italiano dal ‘50 ad oggi, si nota la tendenza a sottovalutare alcune cose e a tacerne altre. Non siamo d’accordo con l’affermazione che “il movimento anarchico ha dovuto interrompere (o, quanto meno, rallentare) il processo di ammodernamento, a causa del pesante attacco poliziesco iniziato nei primi mesi del 1969”.
Al contrario pensiamo che non esiste mai un momento adatto alla riflessione teorica, intesa come fatto isolato dalla lotta. Se l’attacco contro il movimento, che incominciò agli inizi del ‘69, avesse trovato in sostanza una risposta concreta delle masse (cosa possibile solo a condizione che il movimento stesso significasse qualcosa per le masse e non che si limitasse a identificarsi con un’astratta ideologia), allora non ci sarebbe stato certo bisogno di difendersi ma si sarebbe senz’altro passati all’attacco. In queste ipotetiche condizioni non ci sarebbe nemmeno stato bisogno della sbadigliata intellettuale di qualche teorico isolato per “ammodernare” le strutture del movimento. In questo modo evidentemente il nostro discorso risale più a monte ancora, a scelte sbagliate o isolazioniste che si collocano nel tempo ancora più indietro, a scomuniche o a ostracismi che ancora oggi persistono e che non debbono essere in alcun modo sottovalutati. Se da un lato la forte crescita libertaria posteriore al ‘68 determinò certe condizioni favorevoli a una parallela crescita del movimento, questo, come sua propria struttura portante, non era affatto in grado di agevolare e recepire quella crescita. Le lotte che pose in atto, assolutamente slegate da ogni contesto reale di carattere sia pure rivendicativo, furono soltanto “tentativi”, “imitazioni”, “adattamenti” di sforzi che altri facevano in senso autoritario, con la debita componente libertaria sottolineata e messa in evidenza. Se, al contrario, si fosse continuata l’azione sporadica di qualche gruppo che intendeva accentuare la sempre presente lotta al potere basata sull’azione diretta e sull’attacco dei centri vitali del dominio e dello sfruttamento, invece di gridare allo scandalo, all’indignazione, la situazione del ‘69 poteva essere affrontata con strutture ben più adeguate alla bisogna, strutture che avevano di già collaudato la persecuzione costante del potere, strutture che rifiutavano il dominio sterile e dannoso degli intellettuali, delle teorie, delle analisi fini a se stesse e di altre coglionerie del genere.
Naturalmente guardando a posteriori diventa facile dire, come dicono gli autori dello scritto che stiamo esaminando, che l’attacco poliziesco del ‘69 finì per bloccare il movimento. In pratica il movimento era di già bloccato su posizioni attendiste e permissive che nessuna analisi, per quanto acuta, poteva cambiare, mentre al contrario, come è sempre storicamente avvenuto, un movimento forte non viene mai bloccato dalle persecuzioni poliziesche, convertendosi spesso queste ultime in uno stimolo alla radicalizzazione delle lotte.
Ci siamo voluti fermare a lungo su questo primo passo, contenuto come abbiamo detto nella Premessa, perché a nostro avviso è indicativo delle mentalità con cui sono stati redatti gli interventi. Da quanto abbiamo letto risulta chiaro che gli autori non nascondono la pretesa di avere fatto un lavoro capace di modificare l’attuale situazione del movimento anarchico italiano, fornendo un’analisi che costituisca una falsariga per l’azione anarchica oggi in Italia. Francamente non comprendiamo come possa essere possibile un mistero del genere.
Ma tralasciamo questa valutazione che in definitiva potrebbe anche essere secondaria. Resta l’altra, innegabile. Nessuna analisi, per quanto perfetta sia, può sostituire l’azione, riguardo alle possibilità di trasformazione che un movimento ha da una fase di attesa e di passività a una fase di attacco. Gli anarchici non sono mai stati contro le analisi, che hanno guardato con rispetto (spesse volte con troppo rispetto), ma hanno anche avuto il buon senso di considerare l’azione rivoluzionaria, la cura di questa azione, il suo sviluppo, il rapporto che può avere con le masse, la spinta di queste ultime verso traguardi sia pure progressivi ma collocati strategicamente in vista della rivoluzione, come l’unica strada, non tanto verso la crescita del movimento (che è cosa secondaria e affatto strumentale), quanto verso la rivoluzione stessa che resta sempre (se non andiamo errati) l’obiettivo principale dell’anarchismo.
Veniamo adesso a un altro grande problema, quello della concezione della lotta di classe (problema che apre la serie delle considerazioni sui fini). I nostri autori si affaticano a costruire un’ipotesi di lotta di classe tripartita, che dovrebbe loro consentire di uscire dal ginepraio dialettico dello schema bipartito. A parte le letture di Pareto, ragguardevole scrittore e critico del socialismo, ma troppo inquinato di parzialità viscerale per risultare utilizzabile a lungo, e a parte alcune reminiscenze di Kropotkin e Archinov, ci sembra che il discorso sia sufficientemente nuovo. Solo che non giunge al risultato sperato. Schema è quello bipartito e schema resta quello tripartito. Figlio della dialettica hegeliana il primo, cugino della stessa dialettica il secondo. Non esiste invero un passaggio netto nello schema delle contraddizioni tra due contradditori chiaramente individuati, ma può esserci spazio per infiniti contraddittori, fermo restando il meccanismo schematicamente fisso della dialettica. Un esempio abbastanza chiaro può essere dato in questo senso dai tentativi di Mao.
Per converso, abbandonando ogni tipo di schematizzazione – e la strada dello schema tripartito potrebbe costituire la chiave di volta di questo abbandono – ci si può trovare davanti a una controrivoluzionaria notte oscura che fa diventare tutte le vacche dello stesso colore. Prospettiva intrinsecamente sciovinista, storicamente verificatasi nelle soluzioni revisioniste delle teorie rivoluzionarie.
Purtroppo siamo qui davanti a un problema filosofico che – come spesso accade – giunge a estrinsecare pericolosità che non sono per nulla filosofiche. Il concetto di lotta di classe non è pericoloso perché bipartito, ma è pericoloso perché legato alla dialettica che a sua volta resta legata a un meccanismo determinista voluto ed esaltato dalla scienza del passato. D’altro canto, se la dialettica può essere ripensata in molti modi, fino al limite di snaturarsi come tale e costituire l’essenza stessa dell’oggetto e non più il nostro metodo di comprenderlo, come ci hanno mostrato i marxisti, al contrario può diventare un modesto strumento di interpretazione della realtà, qualcosa di estrinseco alla realtà stessa, un modo di avvicinarsi e di costruire modelli d’azione. Ridotta in questi termini la dialettica scade di pericolosità, ma può riprendere tutta la carica negativa che ha perduto con la presenza del presupposto dettato dal determinismo. In questo modo il fantasma cacciato dalla porta rientra dalla finestra.
Qui il discorso minaccia di farsi troppo lungo e complicato. Secondo noi non è tanto importante fissare un nuovo schema, tripartito o più, quanto è importante sviluppare una scheletrica analisi delle forze in gioco in una certa realtà sociopolitica, anche utilizzando il meccanismo dialettico tradizionale, però a condizione che si snaturi questo meccanismo dalla pretesa marxista di costituire la realtà e basta, e a condizione (ancora più importante) che gli si tolga il presupposto determinista. Infatti la lotta di classe non ha in sé niente che possa fare pensare alla “necessità” di una emancipazione finale e completa dell’uomo, e non ce l’ha nemmeno nella forma tripartita o in qualsiasi altra forma che la fantasia umana potrà darle. Solo l’azione rivoluzionaria voluta dall’uomo può costruire il progetto della società futura e la sua realizzazione successiva, nessuna legge gravita sovrana sul mondo, come la scienza moderna ci ha dimostrato in modo irrefutabile, solo l’ottusità chiesastica dei marxisti può ancora oggi continuare imperturbata a parlare della legge immutabile dello sviluppo dialettico, usando Hegel e il suo interprete Marx in chiave ottocentesca.
Un altro problema di grande importanza, brevemente sottolineato dai nostri autori e, per giunta, assistito da una citazione di Malatesta che stentiamo a interpretare favorevole alla tesi cui invece dovrebbe servire da sostegno, è il problema delle “condizioni soggettive” necessarie a una rivoluzione sociale libertaria. Se da un lato lo scritto che esaminiamo riconosce limiti ristretti alla militanza rivoluzionaria in periodo non rivoluzionario, dall’altro niente viene indicato come possibile azione anarchica diretta a smuovere questi limiti, che assumono tutta l’apparenza di un’attesa messianica. Se qualche pagina avanti si aveva qualche accenno al volontarismo con il quale si può aprire la porta apparentemente ben serrata del determinismo, qui il determinismo viene implicitamente accettato. Infatti che cosa ci dice che l’attività propagandista della militanza anarchica, il processo di sviluppo del metodo libertario e l’accettazione della stessa ideologia anarchica, siano fenomeni che in una situazione non rivoluzionaria vanno avanti automaticamente, che cosa ci può indurre ad ammettere ciò se non la credenza in un andamento determinista della realtà, assai vicina alla tesi sostenuta dai marxisti?
In effetti ben diversi sono i risultati. Data una certa situazione non rivoluzionaria, poniamo una situazione che oggi è molto diffusa nel mondo, la situazione della gestione socialdemocratica del potere, si verifica che tutti gli sforzi di penetrazione dell’attività anarchica sono spesso assorbiti con somma facilità dal potere, in uno con tutti gli sforzi che il proletariato compie in sede rivendicativa. La capacità inglobante di questa gestione del potere è tale che spesso non ci si accorge nemmeno di esserci dentro fino al collo. Tante analisi, come abbiamo detto più volte in altra sede, sono deteriorate nella prospettiva dalla stessa personale situazione di inglobazione dei militanti che le compiono.
È quindi in questo senso che, secondo noi, andrebbe letto Malatesta, quello stesso Malatesta citato dai nostri autori, quando dice: «È cosa provata che date certe condizioni economiche, dato un certo ambiente sociale, le condizioni intellettuali e morali della massa restano sostanzialmente le stesse e, fino a quando un fatto esterno, un fatto idealmente e materialmente violento non viene a modificare quell’ambiente, la propaganda, l’educazione, l’istruzione, restano impotenti e non riescono ad agire che sopra quel numero di individui che, in forza dei privilegi morali e sociali, possono vincere l’ambiente in cui sono costretti a vivere» (p. 25).
Ma questo “fatto violento” non cade dal cielo, non è un avvenimento che il pensatore anarchico riteneva necessariamente conseguente all’attività propagandista ed educazionista e alla stessa attività sull’ambiente, al contrario Malatesta affermava che tutto questo lavoro resterebbe inoperoso senza quel fatto e che giungerebbe a maturità, diventando estremamente utile ed attivo, solo al verificarsi di quel fatto. Quindi, dobbiamo legittimamente dedurre che oltre all’attività di cui fanno credito all’anarchismo i nostri autori, si debba parlare di un’altra attività, quella di provocare, sollecitare, fomentare, suscitare quel fatto violento, con l’azione diretta continuata, col sacrificio dei militanti che a questo lavoro si dedicano, con la speranza che tutti gli sforzi congiunti e diretti in questo senso potranno determinare il fatto rivoluzionario, al di là e come conseguenza di diversi e reiterati tentativi che potranno avere un limitato carattere insurrezionale. Solo in questa prospettiva tutto il lavoro dei vari imbrattacarte e degli innumerevoli professori cacasenno potrà avere anche la sua parte di utilità.
Ed eccoci alla parte che i nostri autori definiscono “analisi”. Parte eccessivamente sviluppata in relazione alle altre di più grande interesse. Infatti non è chi non veda il grosso debito che questo lavoro analitico contrae con studi e condensati vari che sono stati pubblicati in Italia negli ultimi anni, tutta roba arcinota e spesso di seconda mano. Ma non è questo il difetto più grave. Sviluppare un’analisi come questa, abnorme in relazione all’economia del lavoro nel suo complesso, presupporrebbe una chiara visione dell’impiego delle conclusioni cui intendere giungere l’analisi come tale, chiara visione che i nostri autori non dimostrano certamente. Essi partono da un’indagine sullo stato di sviluppo oggi delle società per azioni, e ci fanno sapere molte cose sulla loro tendenza a trasformarsi e sulla loro trasformazione in atto in società multinazionali, veri mostri superstatali che finiscono per agire indipendentemente dallo Stato che occasionalmente ospita i loro centri motori. Accanto a questo fenomeno, assai chiaro oggi, che ha visto i suoi più recenti effetti nella repressione cilena, i nostri autori si preoccupano di farci una pressoché erudita lezione sulla programmazione economica, sulla funzione delle imposte, sullo Stato come finanziatore e come imprenditore, sui modelli di programmazione sovietica, sulla formazione della nuova classe dirigente sovietica, sulla natura socioeconomica del sistema sovietico e, infine, sulla situazione del “terzo mondo”. Un primo embrione di conclusione appare quando si affronta l’argomento di un “tramonto” del capitalismo come conseguenza dello Stato imprenditore e dell’estendersi di tutte le manovre del vecchio capitalismo (cartelli, trust, ecc.) per sopravvivere. In definitiva simpatiche rimasticazioni dei vari John Kenneth Galbraith, Paul Baran, Paul M. Sweezy e compagni. Ed eccoci infine alla parte che dovrebbe interessarci di più, l’analisi dell’evoluzione dell’economia italiana negli ultimi cinquant’anni, parte dalla quale ci saremmo attesi quella benedetta risposta al nostro “che fare?”. Anche qui, rimasticazioni di dati e criteri analitici, tra cui oltremodo significativo il ricorso alle considerazioni e ai dati forniti da Paolo Sylos Labini. Infine, notevole sforzo, i nostri autori, facendosi luce a fatica tra la marea montante dei numeri da loro stessi ricostruiti, pensiamo, tra un’altra marea di libri e di cartacce varie, riescono a identificare e a prevedere – somma abilità – lo spostamento “a destra” del PCI. La parte si conclude con un’anodina visione degli extraparlamentari.
Francamente non siamo stati in grado di ricavare il minimo profitto dalla lettura delle pagine dedicate all’analisi. Può essere che qualcuno più bravo di noi, con una preparazione economica migliore della nostra, ci riesca, e possa in questo modo dirsi contento di avere allargato le proprie cognizioni su tanti argomenti teorici così interessanti. Saremmo curiosi di sapere, però, se qualcuno riuscirà a mettere a partito lo sforzo dei nostri autori al fine pratico dell’azione rivoluzionaria, in quest’ultimo caso saremmo lieti di esserci sbagliati.
Ma occorre anche parlare della terza parte, dedicata ai mezzi, parte troppo breve in relazione ai gravi problemi che affronta, come la precedente era troppo lunga e troppo gravata di materiale di seconda mano che avrebbe potuto essere descritto in breve. La terza parte si apre con una giusta considerazione, “non tutti i mezzi sono buoni”, una cattiva scelta dei mezzi finisce per condizionare negativamente il fine, in quanto, continuano i nostri autori (non trovandoci questa volta d’accordo), “sono buoni solo quelli che di fatto, realizzano o fanno progredire la rivoluzione”.
Questo problema della scelta dei mezzi è, in pratica, uno pseudo-problema, tipico prodotto dell’attività distorta e malsana dell’intellettuale che si mette, nella quiete della sua casa, magari dopo essersi visto con i compagni del gruppo dove opera (leggasi dove discute le tesi politiche che gli stanno a cuore), a riflettere sul problema di come individuare la via migliore per “fare” la rivoluzione.
Molti anni fa, prima del 1968, in un clima ben diverso da quello presente, scrivemmo che non è possibile parlare di distruzione seduti nella propria poltrona, la sera tardi, dopo aver ben mangiato, in queste condizioni tutte le considerazioni vengono distorte dalla presenza del benessere personale che finisce (spesso involontariamente) per coinvolgere le stesse capacità analitiche di chi riflette. Il problema della scelta dei mezzi non è mai esistito a livello di problema. I compagni che si sono trovati nella situazione adatta ad agire hanno scelto i mezzi adatti ad agire, spesso o quasi sempre non tenendo conto delle eventuali precedenti sbadigliate di qualche intellettuale. Non che sia in tutto la situazione a dettare la scelta del mezzo, in questo interviene la volontà dell’individuo, la sua capacità d’azione, la sua fusione all’interno di un gruppo di compagni che operano in un certo senso, la fusione che quel gruppo o quell’insieme di gruppi hanno con le masse che devono diventare l’elemento attivo della rivoluzione. Certo, a posteriori, o a priori, un intellettuale che non ha mai tenuto una pistola in mano in vita sua può essere portato a mettersi la toga del giudice e a dire, spaccando il millesimo, che quella tale azione, l’impiego di quei tali mezzi, ha fatto progredire la rivoluzione o, all’inverso, l’ha fatta regredire, ma si tratta di un mero giudizio storico o di una banale previsione teorica.
Fuori dell’astratto, esiste la lotta concreta. In questa dimensione l’azione anarchica può essere condannata solo a condizione che preveda la creazione e la gestione di una qualsiasi forma di potere, di una qualsiasi forma di sfruttamento. Ma quando l’azione avviene in armonia con le caratteristiche che abbiamo detto, quando viene – se il caso – pagata in prima persona dai compagni che la compiono, quando l’obiettivo individuato, se di tale argomento si tratta, è spregevole e colpevole verso il popolo, ogni considerazione di diversa natura non solo è inutile, ma spesso può tornare palesemente controrivoluzionaria.
Quante volte abbiamo letto, negli ultimi tempi, parole dense di acrimonia e di superba intenzione giudicatrice, dirette a dare una valutazione negativa dell’operato poniamo dei Palestinesi a Monaco o in altre loro azioni (mettiamoci anche quella dell’aeroporto israeliano), come pure della banda Baader o di alcune azioni condotte in diversi altri posti da compagni che operano nella clandestinità e delle quali non mette conto parlare. Si tratta di critiche assai facili ma difficili a giustificarsi in una logica rivoluzionaria, sono critiche borghesi (non per nulla combaciano con quelle dei giornali del potere) che non tengono conto dell’effettiva situazione in cui questi compagni operano, o della estrema realtà di sfruttamento e di annientamento progressivo in cui si trovano, poniamo, i Palestinesi. È sempre il caldo della poltrona su cui resta seduto che finisce per tradire l’intellettuale e che lo porta a conclusioni come queste, ed è per ciò che riteniamo utile restare in guardia contro simili teorie.
E poi non è nemmeno vero che sia possibile identificare mezzi che fanno progredire in modo certo la rivoluzione. Ad esempio nella polemica tra i compagni de “La Protesta” e Di Giovanni in Argentina, i teorici che lavorano sui cadaveri si sono affaticati a dimostrare che Di Giovanni aveva torto e che non è giusto agire nel modo in cui lui ha agito perché quello, aggiungerebbero i nostri autori, è il modo più certo per fare retrocedere la rivoluzione (magari perché fa sviluppare la reazione poliziesca). Ma in realtà dopo la morte di Di Giovanni, quando questo pericolo pubblico (anche per la stessa anarchia, se i nostri teorici vogliono essere logici con se stessi) venne fucilato, la possibilità per il metodo sostenuto dai compagni de “La Protesta” di svilupparsi e di fare “progredire” la rivoluzione divenne praticamente immensa, visto che non c’era più l’uomo in nero a disturbare i piani rivoluzionari di crescita progressiva. Come si spiega allora che dopo non più di cinque anni il movimento anarchico in Argentina non esisteva praticamente più? Si spiega, a nostro avviso, col fatto che anche metodi e mezzi che apparentemente sembrano sicuri perché utilizzano il lungo termine e la persuasione, evitando per quanto possibile la violenza e la guerra aperta al potere, possono risultare, in una certa situazione storica, controrivoluzionari obiettivamente e fare “retrocedere” la rivoluzione.
Poco interesse hanno le pagine che trattano, troppo in breve, del movimento anarchico, delle organizzazioni libertarie, dell’anarcosindacalismo, della propaganda. Forse il capitolo sul sindacalismo è la cosa più interessante e chiara, ma è troppo poco per salvare un lavoro.
E in ultimo un patetico capitolo sulla violenza. Vi si arriva finanche a parlare della violenza “giustiziera”, quella cioè che coinvolge direttamente le persone. Ma dopo averla ammessa come mezzo di lotta, i nostri autori trovano l’umoristica sortita di indicarla come “pericolosa” e da “utilizzarsi con cautela”, cosa per altro ovvia in se stessa e che sottolineiamo soltanto perché indicatrice della forma mentis che molti compagni assumono nel trattare alcuni argomenti che, dentro di loro, nella calma e nella riflessione, ammettono solo come un’ipotesi limite da rinviarsi continuamente.
Essi ci esortano infatti: “la violenza non è mai, da sola, uno strumento di attività rivoluzionaria e quindi il suo ruolo e la sua portata non vanno mitizzati”. Ma nessuno vuole mitizzare la violenza, in quanto anche la sua mitizzazione sarebbe inutile e dannosa allo stesso modo in cui sono inutili e dannose le elucubrazioni teoriche di chi pretende a priori di indicare una scelta precisa dei mezzi rivoluzionari.
Questo, esaminato nei punti più essenziali, il lavoro che i nostri cinque compagni hanno intitolato: Un’analisi nuova per la strategia di sempre. Esso, come abbiamo detto, comprende due altre parti delle quali non mette conto parlare essendo più scontate sul piano dell’elaborazione. Non intendiamo dare qui un giudizio che non avrebbe grande importanza, possiamo solo dare un’impressione personale, troppa carne sul fuoco per un banchetto per poche persone.
[Recensione inedita a Aa.Vv., Un’analisi nuova per la strategia di sempre, Cesena 1973]
Severino Di Giovanni. L’idealista della violenza
Libro di grande interesse questo di Osvaldo Bayer, diretto a tracciare una biografia dell’anarchico italiano Severino Di Giovanni, con tutte le conseguenze che un lavoro di questo genere comporta.
La figura di Severino Di Giovanni, infatti, come è noto, ha sempre scatenato all’interno del movimento una forte polemica che, partendo dai giorni stessi delle sue azioni, arriva fino ad oggi, una polemica che raccoglie grosso modo da un lato i compagni favorevoli all’azione diretta, alla lotta armata e alla espropriazione, dall’altro i compagni contrari a questi metodi di lotta e favorevoli soltanto alla propaganda e all’educazionismo libertario. Se all’epoca di Di Giovanni quest’ultima posizione venne assunta dagli anarchici che si radunavano attorno al quotidiano “La Protesta”, siamo certi che anche oggi non mancheranno quei compagni che storceranno la bocca a sentire parlare di Di Giovanni, criticando magari la stessa opportunità, per l’editore italiano, di pubblicare la traduzione dell’opera di Bayer.
In effetti il libro, così com’è impostato, presenta alcune carenze di un certo rilievo. L’autore stesso non ha voluto interpretare (o non ha saputo) nella giusta angolazione la misura e il valore dell’opera dell’anarchico italiano, sebbene è indiscusso che abbia fatto un notevole sforzo per mettere insieme un lavoro onesto e obiettivo, lontano dai luoghi comuni dedicati all’anarchico bombardiere o, peggio ancora, al bandito e all’assassino. Vedremo, nel corso di questa recensione, quali sono queste carenze. Per il momento dobbiamo aggiungere che non ci è piaciuta l’Introduzione di Dando Dandi per quanto in essa si cerchi di cogliere il giusto modo di considerare Di Giovanni, cioè in relazione al terrorismo statale. Un lavoro introduttivo non si doveva limitare a questo giudizio, in poche linee, e a un resoconto del libro, cosa quest’ultima che il lettore fa benissimo da sé, leggendo il testo. E poi, anche le stesse righe conclusive dell’Introduzione lasciano intravedere la possibilità di un giudizio, sia pure oggettivamente, negativo di tutta l’opera di Di Giovanni, la quale si salverebbe solo perché «la sua vita e le sue azioni furono tutte improntate per la bellezza del suo ideale, che nulla fece per se stesso, che rimase incorrotto, fiero e integerrimo fino alla morte» (p. 15). Evidentemente ciò non basta, bisogna pronunciarsi chiaramente in merito a questo modello d’azione, modello proposto violentemente e coraggiosamente attuato fino in fondo.
Ancora meno soddisfa la Prefazione di Josè Luis Moreno. Affermazioni come: «Di Giovanni pretendeva dalla violenza quello che la borghesia pretendeva dalle leggi, utilizzare uno strumento essenziale per ottenere lo scopo finale che, naturalmente, in ciascun caso era differente e antagonista. Di Giovanni credeva di poter battere la borghesia con le sue proprie armi» (p. 29). E più avanti: «... utilizzò il suo arsenale da guerra come strumento fondamentale, relegando i problemi ideologici in secondo piano. Per lui, come per molti anarchici, l’azione diretta era questo» (p. 30). E ancora: «In realtà era un romantico. Per paradossale che sia, e parafrasando Bayer, diremmo anche che era un romantico della violenza. Amore e violenza sono dei fini reali, e per lui non c’era altro» (p. 31).
Impossibile essere d’accordo con queste interpretazioni. Non è vero che Di Giovanni pretendeva battere la borghesia con le sue stesse armi, perché non è vero che la violenza, comunque la si usi, sia un prodotto borghese, esiste la violenza giustiziera, la violenza difensiva che gli sfruttati mettono in atto. Anche se all’apparenza sembra difficile distinguerla dalla violenza oppressiva e terrorista dello Stato, questa distinzione può e deve essere fatta. Di Giovanni attaccando a mano armata le istituzioni non utilizzava le stesse armi della borghesia, ma armi ben diverse, armi di liberazione e di rivendicazione popolare, quanto invece quelle delle borghesia sono di terrore e di sfruttamento. E poi, dove mai ha letto l’autore della Prefazione che Di Giovanni relegò i problemi ideologici in secondo piano. Forse lui avrebbe fatto di meglio, seguito come un animale selvaggio dalla polizia, oppure non avrebbe avuto nemmeno il tempo e la forza d’animo di lavorare alle pubblicazioni che invece uscirono dalle mani di Di Giovanni, per esempio l’edizione di Reclus? E in ultima istanza, perché definirlo un romantico? quando sappiamo benissimo che una certa storiografia borghese ha legato questo termine all’aspetto degenerante della poetica romantica, cioè al suo aspetto di negazione della realtà, aspetto sotto cui venne utilizzata appieno dalla giovane rivoluzione industriale borghese? Fare questo oggi può essere solo strumento per confondere le idee del lettore. Ben altro, a nostro avviso, esisteva per Di Giovanni, oltre l’amore e la violenza, esisteva la lotta per una società nuova, la lotta contro il fascismo, la lotta sindacale, la lotta per l’anarchia, tutto ciò con piena coscienza della necessità di usare mezzi pericolosi, mezzi che solo la guerra aperta dichiarata dal potere può giustificare.
Ma veniamo al libro. Abbiamo detto che la ricostruzione biografica è molto obiettiva, specie al confronto delle costruzioni scandalistiche dei giornali dell’epoca. L’evoluzione del lavoro di Di Giovanni è seguita con attenzione, con un’accurata indagine sui documenti e sulle testimonianze. Dagli scontri al teatro Colon, alla tragica conclusione davanti al plotone d’esecuzione, Di Giovanni è guardato con quella giusta miscela di distacco e di simpatia che in genere consentono una ricostruzione storiografica abbastanza efficace. Da parte nostra, non avendo modo di avvicinare personalmente le fonti, dobbiamo accettare le conclusioni cui è giunto lo storico, ed è per questo che diciamo positivo il suo lavoro. Ma ben altre cose ci preoccupano, in particolare le frequenti interpretazioni, le frequenti divagazioni in chiave filosofica, i frequenti giudizi, tutti legati a una visione “romantica e idealista” dell’azione rivoluzionaria di Di Giovanni.
Non vogliamo, in questa sede, levare al lettore il privilegio e il piacere di leggere il libro per il suo contenuto sostanziale in notizie e fatti, ed è per questo che non facciamo un sia pure breve riassunto delle vicende e dell’attività di Di Giovanni, vogliamo però costruire una piccola guida interpretativa diretta a dimostrare l’infondatezza delle conclusioni teoriche di Bayer.
Egli scrive: «Di Giovanni, da buon autodidatta, non si mette sull’attenti di fronte alla teoria. Egli crede, nella sua tragica ingenuità, che la teoria è fatta per essere applicata. Bakunin e Kropotkin dicono che tutti i mezzi sono leciti per giungere alla rivoluzione e per conquistare la libertà. Di Giovanni agisce conseguentemente» (pp. 50-51). È in passi come questo che si avverte profondamente la deficienza editoriale di non avere predisposto per la pubblicazione del libro delle opportune note. Bayer sarà magari un indagatore coscienzioso, ma non ha letto o, se ha letto, non ha capito nulla del pensiero anarchico. Ma dove ha trovato l’affermazione “Bakunin e Kropotkin dicono che tutti i mezzi sono leciti”? dove ha letto che il disporsi criticamente verso la teoria sia tipico degli autodidatti? dove ha appreso che la teoria fatta dagli anarchici è una teoria fatta solo per restare sulla carta? Di Giovanni fu un uomo conseguente, non è vero che per lui tutti i mezzi erano buoni, egli scelse i mezzi in relazione alla violenza terrorista esercitata dal potere e su questa strada si mantenne fino all’ultimo. Chiedersi, come fa il nostro autore, il significato psicologico del suo rapporto verso la teoria anarchica non ha senso: Faccia a faccia col nemico, il titolo del famoso volume di Galleani, che dà il titolo anche a una sezione del periodico “Culmine” redatto da Di Giovanni, indica con chiarezza la vera sostanza del rapporto teoria-prassi. Ogni sofisma resta vana considerazione letteraria, Di Giovanni sapeva benissimo che l’attacco all’oppressione andava fatto con certi mezzi, ma sapeva anche che gli altri mezzi, la propaganda e le pubblicazioni anarchiche, avevano un grande valore perché servivano a preparare il terreno all’intervento attivo rivoluzionario. Solo che per avvenire questo scambio teoria-prassi, la prima doveva essere fatta e sviluppata in una certa direzione, non realizzarsi in un sostanziale ostacolo all’azione diretta come per l’appunto nel caso dei redattori de “La Protesta”.
Un altro lato assai interessante dell’interpretazione fornita da Bayer è quello diretto a identificare in Di Giovanni la presenza dell’individualismo niciano. Questo è un problema assai interessante che ci consentirà l’apertura al successivo, il problema del terrorismo e l’azione particolare di Di Giovanni. Bayer dice a più riprese di questa presenza del filosofo tedesco nella preparazione dell’anarchico. In effetti queste letture non si possono negare. Bayer ci fa sapere: «nel perquisire la sua biblioteca a Burzaco verranno trovati dei cartelli esposti alle pareti, con frasi dell’autore di Zarathustra» (p. 134). In una lettera del 22 ottobre 1928 Di Giovanni scriveva: «Oh, quanti problemi si affacciano sulla scarpata della mia giovane esistenza, travolto da mille turbini del male! Eppure l’angelo della mia mente mi ha detto tante volte che solo nel male vi è la vita. Ed io vivo tutta la mia vita. Il regno della mia esistenza si è perduto in essa, nel male? Il male mi fa amare il più puro degli angeli. Faccio io male? Ma se essa mi guida? Nel male vi è l’affermazione più alta della vita. E stando in essa, sono equivocato? Oh, problema dell’ignoto, perché non ti risolvi?» (p. 134). Da queste presenze è Bayer a concludere: «La tenerezza con la quale Di Giovanni scrive è notevole. Tenerezza che, presto, quando gli toccherà di agire, si convertirà in crudeltà. Era evidentemente un uomo spontaneo, completo nei suoi sentimenti, che agiva come ubriacato da tutta la gamma di colori, di lotte, di contraddizioni, di bellezze, di generosità, di tradimenti che la vita ci presenta. Vale a dire un autentico niciano» (p. 73).
Certo la lettura di Nietzsche può risultare indigesta a molti e, sicuramente, lo sarà stata anche per Di Giovanni, ma da questa lettura alla definizione della persona dell’anarchico e della sua azione come “niciano”, il passo ci sembra eccessivo. Anche la presenza di alcune frasi di Nietzsche sottolineate e trascritte in cartelli nella biblioteca del nostro compagno ci sembra una testimonianza troppa modesta per fare di lui un seguace assoluto delle dottrine del filosofo tedesco. Il problema è molto grave e investe, in blocco, tutta l’azione dell’anarchismo che insiste sull’azione diretta e che pur non negando valore all’opera propagandista ed educatrice, accentua la primaria importanza dell’attacco diretto contro il potere.
Non è vero che Di Giovanni “agiva come ubriacato da tutta la gamma di colori, di lotte, di contraddizioni...”, la pienezza della sua concezione di vita non ha nulla dell’improvvisata violenza che si confonde con la forza vitale nella dimensione filosofica di Nietzsche. Non dobbiamo dimenticare come il filosofo tedesco vedeva l’essenza del mondo, l’essenza della storia, la stessa sua ammirazione per l’ideale del “superuomo”. In Nietzsche l’elemento determinista dell’eterno ritorno si fonde con l’elemento volontarista e mistico insieme della volontà di potenza. Due tendenze opposte che fanno dire al filosofo delle cose assai interessanti intorno al nazionalismo, alla religione, alla guerra, ma che lo portano a delle affermazioni assurde e pericolose che, in bocca ai seguaci del nazionalsocialismo, hanno fatto di lui, a torto, un filosofo di “destra”. Come per Stirner, e più ancora, la lettura di Nietzsche è assai difficile e, quasi sempre, è stata fatta male e con notevole parzialità. Ma tra la lettura di Nietzsche, fatta da Di Giovanni, e la sua attività di rivoluzionario e di anarchico, esiste una ripartizione ben netta. La sua attività e l’accento volontarista che egli seppe imprimere a essa non hanno mai lo scopo di creare un mito o di tratteggiare l’essenza di modello che esiste nella concezione del “superuomo”, sempre egli tiene presente una situazione di lotta precisa, oggettiva. Una situazione di lotta che emerge dallo sfruttamento di classe e dall’oppressione fascista, una situazione di lotta che tutte le volte viene verificata a livello teorico sul suo giornale. Non bisogna farsi ingannare dalla sua prosa, fiorita e traboccante di una certa retorica assai comune agli scrittori libertari del tempo (basta pensare a Galleani). Quando egli dice “solo nel male è la vita”, la sua reminiscenza letteraria viene fuori da una contraddizione assai evidente in un uomo che ha scelto la strada dell’“outsider”. Se la dimensione borghese della vita è quella che tutti definiscono “bene”, allora solo nel “male” è la vita, solo nella rottura di quel cerchio di ipocrisia e di falso amore del bene è possibile trovare un “bene” diverso, più essenziale, l’unico capace di fondare la società del domani attraverso il travaglio e la sofferenza di oggi. Anche nel suo rapporto con la giovanissima compagna egli avverte che, dal punto di vista borghese, la sua azione potrebbe essere condannata, considerata come male, ma se è proprio questo male che gli dà tanta forza? se è proprio questo male che lo fa sentire nel giusto e nel lato positivo della vita? Allora non resta altro che mettere da parte le parole, dimenticare gli equivoci e le contraddizioni, guardare in faccia la realtà e agire.
Come si vede la luminosa concretezza dell’isterismo poetico di Nietzsche non è altro che un bagaglio letterario. Quando ritorna viva e possente è solo nell’aspetto della volontà di potenza, aspetto circoscritto alla creazione dell’uomo nuovo, del singolo abitante di un mondo diverso, che non ha paura di guardare in faccia i soldati che lo fucileranno, che grida forte prima di morire: “Viva l’anarchia!”.
Ed eccoci all’ultimo problema sollevato dalla lettura del libro, quello del terrorismo. Ancora una volta il lavoro di Bayer, al momento di dare delle interpretazioni valutative, si perde in assurdità e infondatezze. Nell’ultima pagina del libro si arriva addirittura ad affermare: «Di Giovanni fu un eroe sfortunato, un giovane uomo che prese sul serio ciò che i libri della sua ideologia dicevano. Ideologia questa che, secondo come la si interpreta, può passare dalla bontà e rispetto per la condizione umana in tutti i suoi aspetti, alla più disperata e violenta azione soggiogatrice, giustificata con l’ideale di volere instaurare la libertà assoluta per tutto il mondo» (p. 262). È quindi indispensabile che il lettore tenga conto di questa assoluta incapacità di Bayer di comprendere che cosa sia l’anarchismo e che cosa, in effetti, significhi l’azione di Di Giovanni.
Ma il nostro problema è un poco diverso. Di Giovanni portò a compimento, insieme ai suoi compagni, azioni che normalmente vengono definite “terroristiche”. A questo proposito egli stesso scrive: «In eterna lotta contro lo Stato e i suoi puntelli, l’anarchico che sente su se stesso tutto il peso della sua funzione e dei suoi scopi emanati dall’ideale che professa e della concezione che ha dell’azione, non può molte volte prevedere che quella valanga che fra poco andrà a fare rotolare per la china dovrà necessariamente urtare il gomito del vicino in astrattiva contemplazione delle stelle o calpestare il callo di un altro che s’impunta in non smuoversi avvenga quello che avvenga intorno a lui. È l’inevitabile della lotta che lui non cerca a bella posta, ma che per un cumulo di causalità attraversa il suo cammino e fa succedere la nota violenta. Non valgono a riparare l’inevitabile le solite recriminazioni, i “distinguo”, le serenate al pianto, le alambiccazioni di azzeccagarbugli, le solite maledizioni e i ripudi, se sul cammino dobbiamo correre, non possiamo farlo sorretti e intralciati da un falso sentimentalismo improduttivo senza ostacolare ciò che si vuole condurre a termine dell’energica rivolta» (p. 81).
Innanzi tutto occorre dire con chiarezza che cosa è il terrorismo. La propaganda statale, fatta attraverso i soliti servitori a pagamento della stampa borghese, ha sempre considerato come terrorismo l’azione attuata da persone o gruppi di persone in modo violento contro altre persone o cose, contro le istituzioni dello Stato, contro l’ordine costituito. L’altro terrorismo, quello vero e proprio, quello compiuto dallo Stato in prima persona nelle guerre, e dai padroni sul posto di lavoro, non è mai stato considerato terrorismo. Tanto per dare un’idea si può ricordare che in Italia muore un operaio all’ora per incidenti di lavoro e si ha un ferito ogni otto minuti (dati pubblicati dall’INAIL), medie assai simili si hanno negli altri paesi. E poi basta pensare al terrorismo attuato per esempio dagli Stati Uniti nella guerra contro il Vietnam con l’impiego di armi speciali dirette a terrorizzare la popolazione (caratteristiche le caramelle micidiali per uccidere i bambini, i gas allucinogeni, i gas per distruggere la fertilità del terreno, e ogni tipo di arma batteriologica). Volendo restare all’epoca e all’ambiente in cui agiva Di Giovanni basta ricordare che lo sport preferito dalla borghesia argentina era quello di fare “partite di caccia” nella Terra del Fuoco, nel corso delle quali venivano uccisi a fucilate gli indigeni delle foreste di quella regione. Sono proprio le stesse persone che sparavano a sangue freddo contro un “selvaggio” per il piacere di andare a caccia che trovarono ogni tipo di recriminazione per gli attentati e le morti che l’azione di Di Giovanni causò. Evidentemente quando il terrorismo si esporta è sempre un’arma piacevole ad impiegarsi, o comunque qualcosa che non tocca la sensibilità del delicato palato dei borghesi, ma quando la minaccia viene a trovarsi all’interno della propria casa le valutazioni cambiano.
È giusto quindi che parlando di violenza repressiva si parli di terrorismo, mentre parlando di violenza degli sfruttati contro gli sfruttatori l’impiego di questo termine diventa causa di equivoci e di lunghe e inutili discussioni.
E l’azione di Di Giovanni non fu mai un’azione genericamente violenta, un’azione indiscriminatamente diretta a colpire qualsiasi cosa per determinare quella tensione che può essere soltanto favorevole al potere e alla sua politica di consolidamento. L’azione di Di Giovanni fu sempre guidata da un ragionamento rivoluzionario preciso, colpire i centri del potere con azioni punitive e d’attacco, con azioni che trovano la loro giustificazione in un atto repressivo del potere e con azioni che prendono l’iniziativa allo scopo di spingere le masse verso l’obiettivo rivoluzionario. E in queste azioni Di Giovanni tenne sempre presente la situazione generale delle masse, anche se spesso lo si accusò di non avere tenuto conto di ciò e di avere contribuito all’attacco contro il movimento anarchico argentino attuato dallo Stato. In effetti non è possibile ragionare in questi termini, la repressione poliziesca uccide un movimento rivoluzionario solo a condizione che quest’ultimo sia di già morto nella sua componente essenziale, che è quella dell’attacco al potere, in altre parole, se un movimento rivoluzionario, in una situazione poniamo socialdemocratica, si illude di esistere solo perché vegeta all’ombra della tolleranza governativa, è logico che in queste condizioni un’ondata repressiva finisce sempre per distruggerlo. Ma in effetti questa repressione uccide soltanto un corpo morto, senza vita, un corpo che si illudeva di vivere solo perché come un vegetale metteva qualche germoglio o proliferava qualche gruppo d’opinione. Al contrario, un movimento rivoluzionario vero e proprio viene irrobustito dalla repressione e ucciso solo dalla facilità della prospettiva tollerante e permissiva. In questa direzione bisogna quindi interpretare il rapporto tra l’attività di Di Giovanni e il movimento anarchico argentino.
Per ultimo occorre dire qualcosa in merito ai possibili “incidenti” che ogni rivoluzionario deve cercare, per quanto possibile, di evitare nel corso della sua azione di attacco contro il potere. Questi incidenti sono sempre assai deplorevoli perché si traducono in una reazione negativa sulle masse e perché, obiettivamente, mettono in gioco la vita di persone che singolarmente prese non sono responsabili di qualcosa di particolare (ad esempio, un bambino). Ma quando l’atto violento, voluto da un militante o da un gruppo di militanti, viene attuato con opportune analisi e opportune garanzie, cioè quando viene considerata l’opportunità politica dell’atto, viene sviluppata al massimo la possibilità di gestire l’atto stesso, quando esso viene posto in relazione alla sensibilità delle masse e alla loro risposta, in definitiva quando veramente il militante o il gruppo di militanti costituiscono quello che può definirsi la minoranza armata degli sfruttati, allora se l’azione violenta determina degli incidenti, qualcuno muore nel corso di essa, se “la valanga”, per usare la parola di Di Giovanni, travolge qualcuno estraneo nella sua corsa, non possiamo criticare l’azione e i compagni che l’hanno attuata.
Ma in ogni caso, anche quando le premesse analitiche di cui abbiamo detto ci sfuggono, anche quando ci sembra assai chiara la possibilità di una critica distruttiva, dobbiamo sempre tenere presente che la nostra critica non potrà mai arrivare al di là del fatto in se stesso o al di là delle notizie concrete che sul fatto e sui suoi autori possediamo. Ogni deduzione, per quanto logica, è sempre gratuita e, come tale, pericolosa dal punto di vista rivoluzionario.
Su Di Giovanni molte polemiche assai gravi non avrebbero senso alcuno se i compagni che le hanno alimentate, in passato e anche oggi, non fossero partiti da concezioni errate intorno alla funzione e agli scopi dell’azione rivoluzionaria. Il libro del Bayer può fornire una chiave alla comprensione di questo problema, limitatamente alle vicende che racconta e ai documenti che porta, ma deve essere accuratamente letto.
[1973]
Alcune considerazioni sul problema dell’organizzazione anarchica
Problema acuto e sentito, questo dell’organizzazione presenta, nelle diverse trattazioni, differenze di rilievo e talora contrasti non indifferenti. Una trattazione completa richiederebbe un grosso lavoro che forse avrebbe la sua utilità ma che, per la più gran parte, si ridurrebbe al resoconto storico di forme analitiche ormai superate e fuori del tempo. Ma l’essenza stessa del problema, il modo di disporsi nei confronti di una realtà che occorre modificare e abbattere, è costantemente un punto di riferimento per gli anarchici, come pure per tutti i rivoluzionari.
Il socialismo autoritario ha risolto questo problema in modo assai semplice, non avendo come elemento fondamentale la concezione che la scelta dei mezzi finisce per influenzare gli scopi, esso ha copiato i mezzi dalla stessa struttura autoritaria che intende combattere, organizzandosi in partiti a struttura rigida e centralizzata. Ora, se è chiaro che dal punto di vista dei risultati immediati (fase distruttiva dello svolgimento rivoluzionario) questa forma presenta i suoi vantaggi, è altrettanto indiscutibile il fatto che non dà alcuna garanzia per una rivoluzione che sia veramente tale e non si trasformi in breve volgere di tempo in un cambiamento di potere con la formazione di una nuova classe dirigente munita di denti ancora più lunghi.
Da ciò le complicazioni e la necessità di approfondimento del problema organizzativo per gli anarchici. Da ciò, tra l’altro, l’origine della “Piattaforma di Archinov”, che in questi ultimi mesi in Italia è stata pubblicata diverse volte e diverse volte portata all’attenzione dei compagni nei tanti gruppi anarchici.
Anche qualche intellettuale in vena di argomenti interessanti ha ripreso la problematica pubblicando la Piattaforma e i dibattiti a essa successivi (G. Cerrito, Il ruolo dell’organizzazione anarchica, Catania 1973, pp. 259-362).
In effetti noi pensiamo che l’acutezza del problema organizzativo presenta due aspetti: uno concreto e uno soltanto immaginario. Il primo, di grande importanza, è in relazione diretta con lo sviluppo della lotta rivoluzionaria, man mano che questa procede a livelli via via maggiori sorgono necessità organizzative sempre più precise e sempre meno cavillose dei nostri amici rivoluzionari in pantofole e veste da camera, il secondo è in relazione inversa con lo sviluppo della lotta rivoluzionaria e aumenta di intensità e di dettagli via via che si acuisce il senso del distacco dalle masse e dai loro problemi concreti di rivolta.
Ciò non significa che l’organizzazione creata in rapporto alla lotta concretamente rivoluzionaria non debba essere assistita da un’adeguata analisi teorica o non debba tenere conto dei risultati conseguiti dalle analisi prodotte a livelli di lotta precedenti. Significa soltanto che la realtà è diversa dalle fantasie masturbatorie degli intellettuali.
Come formulazione generale possiamo dire che il problema dell’organizzazione diventa problema centrale solo a condizione che lo sviluppo rivoluzionario della lotta abbia fatto sì che la coscienza delle masse si impadronisca di questo problema, e solo allora i teorici avranno ragione assoluta di analizzare le necessità e le forme di attuazione. Prima di questo momento, tutte le analisi del problema dell’organizzazione avranno una loro validità, ma limitata e circoscritta, e ben difficilmente riusciranno veramente a influire sulla struttura organizzativa delle masse e delle minoranze anarchiche agenti all’interno delle masse. Più i loro dettagli si estenderanno, più i dibattiti e i cavilli teorici divideranno il movimento, più si allontanerà quella focalizzazione delle energie dei militanti che sola può produrre risultati positivi all’interno delle masse.
È ridicolo, e solo chi l’ha sperimentato personalmente può averne un’idea, che da parte di molti compagni si disputi accanitamente attorno all’organizzazione di un efficiente movimento, quando questo, specie in Italia, in pratica non esiste. Si discute se è utile o non è utile entrare nei sindacati, ma noi nei sindacati non ci stiamo, quei pochi che ci stanno si trovano con un piede davanti alla porta, tutti i tentativi in questo senso trovano ostacoli di portata immensa da un punto di vista organizzativo, considerando la struttura monolitica dei sindacati moderni, ostacoli che certo non si abbattono con anni di discussione intorno alla utilità di entrare o non entrare nei sindacati.
È ridicolo, e anche questo abbiamo sperimentato personalmente, parlare di responsabilità collettiva o no, quando la realtà di tutti i giorni riguardo all’attività militante ci chiama a compiti che richiedono impegni tanto minimi da risultare a volte quasi inesistenti. Eppure esistono compagni, ed è la maggioranza, che non svolgono questi impegni per quanto piccoli essi possano essere, compagni che prima assumono un incarico all’interno di un gruppo e poi fanno passare intere settimane senza farsi vedere. Certo questo comportamento è indice di scarsa responsabilizzazione e da un punto di vista teorico va censurato, potendosi anche prendere in considerazione l’eventualità di suggerire al compagno di andarsene perché nessuna affinità egli può avere con gli altri compagni, ma nessuno si chiede se l’abulia del compagno è dipesa dalla coscienza della vacuità e della superficialità della sua azione. Nessuno si chiede se a un livello di lotta differente lo stesso compagno avrebbe mantenuto lo stesso comportamento. Certo può essere facile rispondere che chi non s’impegna nelle piccole cose non si impegnerà nemmeno nelle più grandi, ma questa è una considerazione borghese della selezione. Il bambino che non è bravo alle elementari non sarà mai capace di andare avanti nella vita, e con questa scusa si stabilisce una selezione precisa, in genere determinata da elementi esterni che nulla hanno a che vedere con le effettive capacità del bambino, riuscendo spesso a distruggerle nel vero senso della parola.
Non vale, a nostro avviso, in queste condizioni, stabilire precetti e codificare norme, firmare patti e sancire accordi federali, tutto si perde nella nebbia della futilità e del pressappochismo. Quanti compagni dotati e attivi sono fuggiti letteralmente dalle nostre organizzazioni per andare in quelle autoritarie, specie tra i giovani che erano venuti a noi dopo il 1968? Sicuramente un grande numero. E non vale affermare che se l’hanno fatto vuol dire che non erano elementi degni di essere anarchici ed è meglio così, che si siano rivelati prima per quello che erano, denunciando chissà quali segni premonitori nella loro più o meno lunga azione all’interno dei gruppi anarchici. Tutti questi fenomeni sono carenze di lotta, carenze di impegno rivoluzionario, ancora prima di essere carenze organizzative. Guai se fosse all’inverso, tutta la nostra teoria dell’organizzazione sarebbe sbagliata e, con essa, tutta la nostra visione rivoluzionaria.
Posto in questi termini il problema organizzativo diventa un problema di prassi e un problema teorico, ma quest’ultimo aspetto ha un senso solo a condizione di servire per una lievitazione del livello di coscienza delle masse e delle stesse minoranze anarchiche, considerate come elemento interno alle masse, mai come problema al di sopra della prassi di lotta, mai problema staccato da obiettivi precisi raggiungibili e non soltanto sognati o fantasticati da speranzosi intellettuali.
Nella lotta è il rivoluzionario anarchico stesso che vede la struttura organizzativa e media il precedente contrasto tra formulazioni arretrate della visione organizzativa del problema rivoluzionario e livelli di lotta sempre più avanzati. In questa mediazione interviene la sua sensibilità, la sua presenza fisica nella lotta stessa, la sua vita nella totale interezza della dedizione alla causa dell’anarchismo. Egli può commettere degli errori, può avere una visione errata, ma il suo lavoro, accanto a quello degli altri compagni, e tutti insieme all’interno della situazione di lotta delle masse, finirà per smussare queste angolazioni errate e questi errori.
La pluralità delle considerazioni del problema organizzativo è solo apparentemente giustificata dal pluralismo teorico dell’anarchismo. Non è vero che accanto alle diverse teorie esistono forme diverse di organizzazione possibile per l’anarchico. Se le diverse teorie prevedono forme e strutture diverse della società futura, esse non prevedono forme e strutture diverse del rapporto col potere, in quest’ultimo caso se una teoria anarchica parlasse di un compromesso col potere, di una partecipazione al potere, finirebbe per trovarsi automaticamente fuori dell’anarchismo e non costituirebbe quindi una vera e propria teoria anarchica. Lo stesso dicasi nei riguardi dell’organizzazione. L’unica cosa possibile, in sede libertaria, è parlare di un’organizzazione non centralizzata e non autoritaria, di un’organizzazione che resti legata alla lotta rivoluzionaria concreta e non pretenda dirigerla verso scopi visti e voluti da una minoranza autonominatasi onniveggente.
Prima di concludere queste brevi note, ci pare importante chiarire perché consideriamo il livello di lotta rivoluzionaria come l’elemento esclusivo per determinare l’organizzazione e le sue forme concrete, cioè l’elemento per superare il contrasto sempre presente tra astratta teorizzazione a priori e prassi rivoluzionaria.
La crescita del movimento anarchico non è fatto separato dalla crescita della coscienza rivoluzionaria delle masse. Se anche a livelli di coscienza assai ristretti esiste sempre una minoranza militante, ciò è dovuto al fatto che certi individui hanno avuto particolari privilegi (economici e morali, oggettivi e soggettivi) e che usano questi privilegi per porsi contro uno stato di cose accettato dalla maggioranza delle persone. Ma quando l’azione rivoluzionaria generale avvia il processo rivoluzionario verso la sua naturale crescita, cioè verso il progressivo aumento dei livelli di lotta, allora lo sviluppo della presa di coscienza delle masse è fatto essenziale alla stessa continuazione del processo rivoluzionario. In queste condizioni le chiarificazioni organizzative sono pressoché automatiche. I tiepidi, gli indecisi, coloro che non sanno mantenere le proprie responsabilità, gli intellettuali dilettanti della rivoluzione, restano a casa di fronte alla paura della repressione, una naturale selezione facilita l’orizzonte organizzativo. Uomini e cose si chiariscono.
Ma, qualcuno potrebbe obiettare, la presa di coscienza delle masse non è fenomeno che procede necessariamente in misura parallela alla situazione economica e sociale nella sua totalità, cosa quest’ultima che influenza grandemente il livello di lotta. Certo, tra i due fatti esiste sempre una differenza che può influire sulle forme concrete che il movimento anarchico può scegliere di volta in volta per inserirsi nel vivo delle contraddizioni che questo sviluppo finisce per determinare, ma in ogni caso non vi potranno mai essere scompensi tali da consentire e rendere valida o accettabile una astratta teorizzazione organizzativa, basata sulla considerazione esclusiva delle condizioni economiche e sociali di un dato momento.
Se le crisi che il capitalismo affronta e via via risolve sono fatti legati alle condizioni della sua struttura economica e sociale, l’azione delle masse sfruttate può rendere via via più difficile questa prospettiva di risoluzione, fino a determinare sbocchi rivoluzionari sempre più maturi e sempre più completi, dalle prime fasi della rivoluzione economica alle ultime fasi della rivoluzione sociale. Ora, l’azione consapevole degli anarchici può spingere questo processo verso la rivoluzione sociale solo a condizione che la loro struttura come strumento attivo e non solo come mera componente ideologica sia in grado di mantenere costantemente il rapporto con il continuo evolversi dei livelli di lotta delle masse. Ogni disarmonia in questo contatto ha come risultato immediato l’isolamento degli anarchici, la facile vittoria degli schieramenti autoritari, la sconfitta sostanziale della rivoluzione.
[1973]
Il movimento anarchico italiano e le differenti strade di un suo possibile sviluppo
Tutti i paesi economicamente sviluppati si sono orientati, o si vanno orientando sempre più velocemente, verso una gestione del potere che possiamo definire socialdemocratica. La burocratizzazione dei sindacati rende possibile questa operazione con il minimo sforzo, ponendo davanti alla classe dei lavoratori obiettivi sempre più lontani e sempre più sradicati da una concreta possibilità di miglioramento. Tutte le altre forze del potere (stampa in primo luogo) sono impiegate nel tentativo di costruire una nuova dimensione del rapporto di classe, in vista della definitiva vittoria della nuova fase capitalista. Con poche varianti, sul piano della scelta dei consumi, i paesi dell’Est si avviano verso soluzioni molto simili. Quello che viene chiamato “Stato permissivo” dovrebbe costituire la regola costante di domani, quando le dittature dominate dagli ottusi gorilla fascisti non saranno che un ricordo di certe concessioni fatte dal potere capitalista ad alcune cosche retrive e stupidamente legate alla visione locale dello sfruttamento.
In questo quadro di sviluppo e di trasformazione della gestione padronale, come sappiamo, un posto di rilievo dovrebbe svolgere il capitale sopranazionale, determinando le possibilità di uno sfruttamento non più legato a situazioni di classe locali, situazioni che spesso restano ancorate a fattori contingenti e scarsamente prevedibili nel breve periodo, determinando quella geografia della distribuzione del potere che consente, nell’ultima parte del secolo, di vedere accanto a gestioni socialdemocratiche gestioni naziste come quella sudafricana o portoghese.
È quindi il potere che determina le condizioni di lotta, almeno limitatamente alle forze repressive dirette o indirette che riesce a mettere in moto, e lo stesso linguaggio dell’azione rivoluzionaria. I movimenti veramente rivoluzionari, le organizzazioni di base dei lavoratori, tutti i fermenti spontanei di lotta e di organizzazione della lotta, vengono indirettamente condizionati da questa gestione del potere, potendosi immaginare un condizionamento sempre più massiccio, fino al limite della loro sostanziale riduzione all’impotenza. Ma, se per il lavoratore esiste un ostacolo fondamentale alla sua riduzione all’impotenza, ed è il suo costante sfruttamento, legge inesorabile di ogni gestione capitalista, per il rivoluzionario, chiamato a svolgere un lavoro preciso all’interno delle masse e a sensibilizzarsi sulla giusta lunghezza d’onda dello sfruttamento, svolgendo analisi e portando a compimento azioni che corrispondono all’effettiva situazione del rapporto di classe, esiste il pericolo gravissimo di lasciarsi avvolgere dalle spire del potere permissivo fino a restarne soffocato.
Un pericolo come questo esiste, ovviamente, anche per il movimento anarchico. In Italia, dopo gli scompensi di gestione padronale degli anni 1968-1969, questo pericolo si prospetta abbastanza grave specie in relazione alla intrinseca debolezza del movimento e alla sua relativa dissociazione da un vero e proprio contributo alla lotta di classe. Dopo il 1968 e le esperienze legate al Maggio francese, il movimento ha avuto nel nostro paese un ricambio di portata mai vista con un relativo profondo cambiamento di esperienze e di letture. La rapidità di questo cambiamento ha spesso determinato una frattura tra i vecchi militanti (ovviamente non tutti, ma la maggior parte legati a esperienze e analisi ormai fuori del tempo) e i giovani, formatisi su esperienze e analisi che oggi sono ancora sul tappeto, oggetto di lotte e di riflessioni. Da ciò una serie di fratture e un complessivo disgregamento, almeno a livello geografico dell’indirizzo dei singoli gruppi o delle diverse federazioni.
In un certo senso questo fenomeno non trova la sua sola spiegazione nell’entrata dei giovani all’interno del movimento, ma anche nella lunga persistenza di un rapporto di mutua tolleranza tra l’anarchismo italiano e il potere costituito. Quanto più, per il passato, l’azione di disturbo dell’anarchismo è stata debole, tanto più è aumentata la possibilità di tolleranza dello Stato nei suoi confronti, non ultimo l’interesse ad avere sempre sottomano un buon spauracchio da agitare davanti alle masse (vedere bombe di Milano). Quando, in passato, alcuni gruppi hanno compiuto azioni di un certo rilievo contro le istituzioni borghesi e contro il potere statale, allora la repressione si è fatta sentire insieme alla critica acerba e sconsiderata dei centri di gestione del cosiddetto “potere anarchico”, pauroso di perdere la propria possibilità di esistenza.
L’alibi della necessità di rafforzarsi nell’astensione della lotta al potere, limitando l’attività alla diffusione delle idee e alla ristampa dei classici fatta quasi sempre in modo acritico, è anche oggi alla base di una grossa parte del movimento che, comunque, viene di volta in volta posta in crisi dall’evidenza di certe situazioni: lotte contro i fascisti, ottusità di alcune branche del potere, incapacità nello stesso svolgimento del lavoro propagandistico, scarsa presenza fra i lavoratori.
Indiscussamente, qualora questa strada di sviluppo fosse intesa per quello che essa è, un piano organico e massiccio di incidenza a lungo termine sulle masse, e qualora la controparte avesse una gestione di potere di tipo arretrato (dittatoriale o centrista), si potrebbe seriamente sperare in un progressivo rafforzamento del movimento. Ma la realtà è ben diversa. Se lasciati a se stessi, questi stimoli verso le masse hanno breve fioritura e morte repentina. Lo sviluppo dell’anarchismo italiano, se passa – e non potrebbe essere diversamente – anche attraverso la strada dell’educazionismo e della propaganda a lungo termine, deve battere anche altre strade: quella dell’azione diretta e della lotta armata contro il potere, se non vuole lavorare a vuoto perdendo sempre di più il credito che oggi gli resta.
Una chiara indicazione di questo stato confusionale e di disgregamento in cui si trova oggi il movimento in Italia è data dalla polemica che si è scatenata al suo interno a proposito del caso Bertoli. Come sappiamo quest’uomo, che insiste anche oggi nel definirsi anarchico, è l’autore della strage di via Fatebenefratelli a Milano, davanti alla sede della questura, nel corso di una manifestazione in memoria del commissario Calabresi.
Dopo il comunicato iniziale delle organizzazioni anarchiche, pubblicato da molti quotidiani borghesi, nel quale si affermava la totale estraneità di Bertoli al movimento anarchico organizzato, la condanna degli anarchici di fronte a un attentato che ha provocato vittime innocenti e la necessità di inquadrare l’attentato stesso nel clima di violenza instaurato dai fascisti e dallo Stato, il problema è stato ripreso a un livello più approfondito, all’interno del movimento, la qual cosa ha dato il segno dell’attuale disgregazione e della confusione che imperano in molti gruppi italiani.
Alcuni gruppi hanno redatto una circolare “interna e strettamente riservata” nella quale si rigettava l’ipotesi data per certa di un Bertoli “provocatore agente della CIA”, “agente dei fascisti”, ecc., come ipotesi sostenuta in blocco dalla stampa borghese e da quella extraparlamentare, oltre che da molti gruppi anarchici, ma senza alcun fondamento di certezza o alcuna prova concreta. Anche se non si hanno notizie precise sulla vita di Bertoli, continuava la circolare, “noi abbiamo ritenuto nostro dovere non accodarci al coro generale della sinistra parlamentare ed extraparlamentare contro la solita provocazione fascista, la solita pista nera, inventandosi chissà quale oscura manovra del solito governo Andreotti”. Al contrario, “le poche informazioni che si hanno sul suo conto (e soprattutto sul suo comportamento), sembrerebbero semmai avvalorare l’ipotesi che ci si trovi di fronte a un individuo isolato, deciso a compiere un atto di protesta individuale contro lo Stato e pronto ad assumersene piena responsabilità individuale. Fino a prova contraria, Bertoli ha pieno diritto di proclamarsi anarchico individualista, negargli questo diritto definendolo un provocatore prezzolato è un comportamento non degno degli anarchici”.
Violenta la risposta di alcuni gruppi che affermano recisamente l’impossibilità di definire anarchico chi compie atti come quelli di Milano, la certezza che Bertoli ebbe ad avere contatti con i fascisti, l’obiettiva provocazione costituita dalla circolare suddetta. Ma la critica di questi gruppi non si pone solo a un livello ideologico e interpretativo dei fatti, pretende estendersi anche al riesame dei rapporti con i gruppi firmatari della circolare giungendo fino a “invitare tutti i gruppi, federazioni ed individualità che si riconoscono nell’anarchismo militante a troncare ogni relazione con i gruppi sopra indicati e con il loro portavoce”, augurando “per sé e per il movimento tutto dei lavoratori che la provocazione venga effettivamente isolata così come ogni altro tentativo, da anni vergognosamente perseguito, di screditare l’anarchismo e di assimilarlo agli occhi degli sfruttati come una setta di dementi, di pazzi sanguinari o, nella migliore ipotesi, di sognatori idealisti predestinati ad essere concime della storia”.
A parte la reminiscenza trotskista quest’ultima tirata, con la precedente, è indicativa di un certo clima interno al movimento italiano, un clima sicuramente non utile al lavoro produttivo per l’eliminazione dello sfruttamento e la rivoluzione sociale. Accanto a queste due posizioni contrastanti sono sorte posizioni intermedie o altrettanto radicalmente in contrasto. Gli stessi gruppi firmatari della prima circolare sono tornati sull’argomento, con altre circolari, nel tentativo di chiarire le cose, ma col risultato di renderle solo più torbide e incomprensibili.
Problema importante, a nostro avviso, questo del rapporto tra individualismo anarchico e anarchismo organizzato (nelle sue varie forme storicamente concrete), ma che infelicemente trova l’attenzione dei compagni in un’occasione concreta (l’attentato di Bertoli a Milano) che non può essere di certo la base migliore per una riflessione teorica e pratica priva di pregiudizi e reazioni di piazza. È quantomeno strano, a nostro avviso, che gruppi come quelli firmatari della circolare oggetto della polemica si siano posti il problema suddetto, e quel che è peggio abbiano tentato di darne un’analisi nel modo in cui hanno redatto il loro documento, in un momento di tensione e di estrema gravità per il movimento tutto, quale era appunto quello successivo al giorno del lancio della bomba di via Fatebenefratelli. È quantomeno strano che in altre occasioni certe proposte di dibattito e di approfondimento, su argomenti non proprio simili ma vicini, come ad esempio l’argomento della lotta armata e della violenza proletaria, siano rimasti senza risposta, sebbene le proposte venissero da compagni e da organizzazioni ben chiaramente definibili all’interno del movimento stesso. Ed è ancora più strana l’ambiguità stessa della circolare, il suo volere dire e non dire certe cose, il suo tacere sul significato preciso dell’individualismo anarchico, il suo tacere sul significato vero e proprio del termine terrorismo (da dove trova origine l’esatta precisazione di un gruppo anarchico uscito recentemente dalla FAI). Se i redattori del documento avevano qualcosa di preciso da dire sul caso Bertoli dovevano dirla chiaramente e per esteso, ricorrendo a mezzi normali di diffusione e non a una circolare riservata, che poi finisce sempre sul tavolo della squadra politica. Se viceversa la loro era soltanto una preoccupazione teorica, il momento scelto è veramente tra i peggiori possibili e il loro atto può assumere l’aspetto di una provocazione oggettiva.
Una situazione come quella che abbiamo descritto si può spiegare solo con la mancanza di chiarezza che oggi è veramente la nota costante del movimento anarchico italiano. La conseguente disgregazione trova, come abbiamo detto, diversi atteggiamenti di risposta, oltre quelli di un tradizionale attendismo e quelli assai interessanti della ricerca di una nuova strada per la costruzione di uno strumento efficiente nella lotta contro l’oppressione, che è poi la strada nella quale crede l’estensore di queste note. Abbiamo una strada verso la ricerca di un efficientismo a qualsiasi costo, modellato sulle strutture marxiste che da sempre, sia pure in forma indiretta, hanno avuto il loro fascino sui militanti anarchici. Il fenomeno, assai chiaro oggi in Francia e in Inghilterra, dove agiscono da tempo l’ORA francese e quella inglese, è in via di chiarimento in Italia. Compagni inglesi ci hanno fatto sapere che tra qualche tempo a Milano sarà indetto un meeting per la fondazione dell’ORA italiana. L’ideologia di fondo di queste organizzazioni libertarie è quella di una revisione dei tradizionali princìpi dell’anarchismo modellata sui concetti marxisti e neomarxisti. Abbiamo avuto modo di esaminare un interessante lavoro dell’ORA francese (Front Libertarie) dal titolo Autour de l’autogestion, dove si parla chiaramente di un vero e proprio “terrore proletario” che dovrà gestire il periodo post-rivoluzionario, dove sono esposti strani concetti, come quello di una “dittatura antistatale del proletariato”. Anche organizzazioni nostrane, specie quelle a impostazione anarcosindacalista, hanno manifestato idee assai simili. Comunque è chiaro che la sostanziale situazione di disgregamento del movimento ha dato vita a questi tentativi in Italia, come pure l’altrettanto chiara situazione di inefficienza e di frammentazione dei movimenti inglese e francese ha determinato la formazione e lo sviluppo dell’ORA in quelle nazioni.
È in un certo senso la stessa situazione che si verificò in Francia all’interno del superstite movimento anarchico russo dopo la rivoluzione di ottobre. I risultati negativi dell’azione condotta dagli anarchici russi a fianco dei bolscevichi prima e contro di essi poi, la sconfitta del movimento in Ucraina, il tragico fallimento dei gruppi anarchici che persistettero nella collaborazione con gli autoritari, un bagaglio di esperienze che finì per stornare molti compagni dalla prospettiva anarchica (come Archinov) e li spinse a dare vita alla “Piattaforma” che prese appunto il nome di Archinov ma che vide la luce principalmente per la collaborazione di Machno. In questa piattaforma è chiara una certa preoccupazione organizzativa diretta a salvare dallo sfacelo il movimento anarchico, con tutte le accentuazioni autoritarie che questa accezione comporta. Non è qui il caso di ricordare le polemiche che la piattaforma determinò al momento della sua pubblicazione, vogliamo solo dire che non è un fatto occasionale che oggi essa vede l’attenzione di tanti compagni, che essa è tradotta e diffusa dall’ORA inglese e francese, che essa è al centro dell’attenzione di molti gruppi e compagni del movimento anarchico italiano. Con questo strumento, come una volta i compagni russi, si cerca di sanare le deficienze dei movimenti attuali, cadendo nell’eccesso di una impostazione centralizzata e autoritaria, assai chiara nelle elaborazioni teoriche dei francesi dell’ORA, che in questo campo, partendo dalla piattaforma, hanno fatto veramente molta strada.
Il recente Convegno Nazionale Lavoratori Anarchici, tenutosi a Bologna il 15 agosto 1973, ha denunciato chiaramente questa tendenza autoritaria infiltratasi oggi all’interno del movimento anarchico, che utilizza l’ingenua adesione di quei gruppi che non avendo chiare le idee, o non avendo alcuna consistenza di lotta e di presenza nella realtà concreta degli sfruttati, trovano comodo “fare qualcosa” allineandosi alla posizione autoritaria che sembra loro garantire almeno una prospettiva di lavoro produttivo. Questa è l’impressione che si ricava leggendo gli atti del convegno. La risoluzione finale è stata presa a maggioranza, niente ci è stato detto in merito alla posizione dei gruppi contrari (che hanno redatto un documento a parte). In questa risoluzione si parla di inserirsi all’interno dei sindacati riformisti per “fare esplodere le contraddizioni tra la base e il vertice”, si parla di due organizzazioni: una specifica (comunista anarchica) e una di massa (proletaria) tenute in rapporto dialettico (sic!) tra di loro, e altre cose del genere. Quando sarà pubblicato il bollettino interno anarco-sindacalista, previsto dalla risoluzione del convegno, vedremo come alcuni gruppi hanno presentato i loro interventi. Per il momento abbiamo solo un breve saggio, pubblicato dai gruppi che si sono ritirati, quello relativo all’intervento dell’ORA-OAL, dove si parla di dittatura antistatale del proletariato negli stessi termini che abbiamo indicato per l’opuscolo dell’ORA francese. Si accenna anche a una parola d’ordine che gli anarchici dovrebbero difendere: “Dittatura del proletariato alla base”.
È chiaro che siamo di fronte a un più o meno ingenuo tentativo di costruzione di una forma autoritaria di gestione libertaria delle lotte. Il bisticcio stesso di questa frase dà l’esatta indicazione della contraddizione insanabile che si profila davanti a queste elaborazioni teoriche. Di fronte alla realtà concreta, di fronte al contatto con le lotte reali degli sfruttati, queste tecniche a mezza strada sono sempre destinate a cadere dalla parte sbagliata, cioè sono destinate a rafforzare sempre più il loro autoritarismo, se si vuole latente agli inizi. Porsi sulla strada del riformismo sindacale, perché è tale il vero significato del termine “lavorare all’interno del sindacato”, significa cadere in pieno nelle contraddizioni della sinistra tradizionale, con l’aggravante di non avere nemmeno la vasta base di appoggio su cui fondarsi per andare avanti. Un codismo non solo ingenuo ma patetico.
Da sempre gli anarchici hanno lottato contro ogni forma di divisione tra lotta economica e lotta politica, tra sindacato e partito, considerando queste divisioni come l’anticamera stessa del futuro potere post-rivoluzionario. Solo chi ragiona ed agisce all’interno di una logica autoritaria può porre in termini precisi il problema della situazione post-rivoluzionaria partendo da una situazione pre-rivoluzionaria, ed avere la pretesa di risolverlo in dettaglio. Noi non diciamo che gli studi e le ricerche, le documentazioni e le analisi delle esperienze fatte nella storia, non debbano essere elaborate e migliorate, diciamo solo che non possiamo accettare una posizione teorica che intenda spacciare – con un semplice gioco di parole – il marxismo per qualcosa di libertario, che intenda parlare di “dittatura antistatale del proletariato”, o di “dittatura del proletariato alla base”.
Abbiamo pertanto visto due delle diverse strade che potrebbero determinare uno sviluppo dell’anarchismo italiano. La prima sarebbe quella predicata dall’anarchismo cosiddetto educazionista, strada a lungo termine che, se valida in contemporanea attuazione ad altri schemi di lotta, diventa sterile e facilmente neutralizzabile dal potere, specie se quest’ultimo gestisce se stesso in situazione socialdemocratica. La seconda strada sarebbe quella dell’accentuazione autoritaria degli strumenti di intervento libertario sulla realtà, strada che, come abbiamo detto, è destinata a richiedere sempre un maggiore efficientismo e quindi sempre una maggiore accentuazione dell’aspetto autoritario. Resta lo sviluppo e l’appoggio alle altre forme di lotta, tradizionalmente anarchiche, legate alla base del proletariato e all’azione diretta, all’elaborazione di possibilità sempre più avanzate di contrasto alle decisioni di sfruttamento del potere, alla realizzazione di fatti contro il nemico di classe aventi precise caratteristiche e non slegati dalla indispensabile relazionabilità alla situazione di sfruttamento in corso, fatti insurrezionali, il tutto in vista di quella dimensione generale della rivoluzione che come accadimento complesso non potrà certo essere “fatta” dagli anarchici ma dovrà vedere gli anarchici all’interno di essa, come fatto di massa, in grado di indirizzarla verso quegli obiettivi libertari e di crescita anarchica che non potranno venire dalla gestione autoritaria dei marxisti.
Non vogliamo dilungarci nel parlare di questa direzione di lavoro, sulla quale da diversi anni insistiamo, essendo altro il nostro compito. Vogliamo solo riconfermare la nostra irriducibile avversione a qualsiasi forma di insalata preparata con l’aiuto degli ideologi francesi o inglesi, quando essa prende la forma di una pretesa possibilità di collaborazione tra l’ideologia autoritaria e l’ideologia libertaria. Abbiamo sempre detto che bisogna cercare la collaborazione rivoluzionaria con la base marxista, che bisogna esaminare la possibilità di un lavoro in comune con le strutture marxiste che si professano aperte a una realizzazione rivoluzionaria, ma sempre dentro certi limiti e con certe cautele e, comunque, sempre con la massima chiarezza nelle nostre tesi libertarie. Guai se domani ci dovessimo trovare a fianco dei marxisti, nel movimento rivoluzionario, con proposte teoriche confuse e facilmente riconducibili alle loro formulazioni di fondo, noi saremo presto perduti nella massa autoritaria, la base non potrebbe più riconoscerci come una vera e propria alternativa agli obiettivi dai marxisti e questi ultimi avrebbero buon gioco nel distruggere il nostro movimento.
Quindi se, come diceva Malatesta, la rivoluzione non possiamo farla da soli ma la devono fare gli sfruttati insieme a noi e insieme agli altri schieramenti che si dicono rivoluzionari, noi abbiamo l’obbligo di chiarire al massimo grado la nostra posizione ideologica e, anche se pochi, costituire un punto di riferimento per gli sfruttati, evitando di perderci nel mare delle congetture e del possibilismo, attirati dalla sirena dell’efficienza a qualsiasi costo.
[1974]
Questo sito, oltre a informare i compagni sulle pubblicazioni delle Edizioni Anarchismo, archivia in formato elettronico, quando possibile, i testi delle varie collane.
L’accesso ai testi è totalmente libero e gratuito, le donazioni sono ben accette e servono a finanziare le attività della casa editrice.
