Prima edizione: agosto 1984
Seconda edizione: dicembre 2013
Del fare e dell’agire
Prima edizione: gennaio 2001
Seconda edizione: dicembre 2013
Alfredo M. Bonanno
La rivoluzione illogica
Seconda edizione riveduta e corretta con l’aggiunta di Del fare e dell’agire
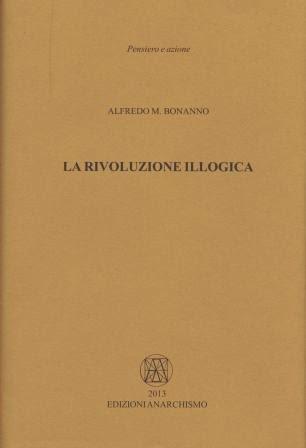
Introduzione alla seconda edizione
Introduzione alla prima edizione
L’equilibrio, il contegno, la verità
Parte prima: La rivoluzione illogica
L’elemento contraddittorio della rivoluzione
Conforto quantitativo e funzione della critica
Le componenti autoritarie del movimento rivoluzionario
Livello spettacolare dello scontro
Le tendenze inverse al processo rivoluzionario
Cosa bisogna intendere per contraddizione
La polarizzazione della realtà
L’illogicità della rivoluzione
L’alzarsi del livello dello scontro
Per un nuovo concetto di radicalizzazione delle lotte
Movimento e violenza rivoluzionaria
La situazione del movimento anarchico
Le caratteristiche dell’attacco armato
Le vecchie malattie del movimento anarchico
II problema degli sbocchi insurrezionali
Per un modo diverso di intervenire nelle contraddizioni sociali
I contorni del quadro generale
DC e PCI. Vecchi e nuovi padroni
Lo stalinismo e la sua tendenza contraria allo scontro di classe
Il fallimento delle strategie quantitative
Il problema dello scontro armato
Verso le nuove forme della controrivoluzione
Sull’organizzazione clandestina
Strategia del potere e scontro di classe
La strategia del potere come fatto unitario
La gestione dell’economia generalizzata
Riprendere in mano le condizioni della propria esistenza
Ridare un senso unitario alla molteplicità delle lotte
Lotta rivoluzionaria e insurrezione
Decentramento e progetto egemonico
Parte seconda: Del fare e dell’agire
Nota introduttiva alla prima edizione
La situazione. Alcuni chiarimenti di metodo
Ancora chiarimenti, questa volta riguardo la metafisica
L’individuo e i suoi rapporti con le cose
L’individuo e i suoi rapporti con le idee
La situazione e il suo punto critico
La polarizzazione di significatività
Azione rivoluzionaria e teoria della liberazione. E viceversa
Introduzione alla seconda edizione
Le tesi contenute in questo libro sono vecchie di quasi trent’anni ma, a mio avviso, mantengono anche oggi, pure in mutate condizioni sociali e personali, mie, prima di tutto, e del mondo che mi circonda, in secondo luogo – tanto per cambiare, un carcere, greco questa volta, – la loro validità. Esagitato e in preda a mille convulsioni fittizie quel movimento, a cui si riferivano queste pagine, non c’è più. Il dinamismo che lo caratterizzava, a volte un volere esserci per dimostrare la propria esistenza in vita, era un processo di disgregamento. Le obiezioni libertarie, contenute anche – fra le tante – in questo libro, non sono state sufficienti a produrre una svolta. Quando qualcosa si è mosso in questo senso, è stato subito richiamato all’ordine, a uno svilimento che agiva nell’intimo di molti compagni e produceva la confortante illusione quantitativa che ho spesso sottolineato.
Illusione distruttrice quanto altre mai, di ogni originalità d’azione prima di tutto, e poi anche di analisi, carenze di pensiero e di azione, insomma. Lo sgretolamento ha fatto tanto rumore, è costato tante vite umane, migliaia di anni di carcere e un’esaltazione acida, una sorta di tiriamo giù le colonne con tutti i filistei. L’avere inseguito la crescita quantitativa, prima di tutto aveva il malcelato scopo di sostituire una coscienza rivoluzionarie individuale che rischiava di frantumarsi in mille sfaccettature. Per questo motivo occorreva solidificarla in qualcosa di visibile, un esercito enumerabile come antidoto alla malattia minacciata, quell’individualismo non ben compreso, spesso calunniato come nichilismo borghese, quasi sempre esecrato ma, in ogni caso, mai scomparso del tutto.
Non essendo un animale da branco, come anche questo libro testimonia, sono stato attaccato da più parti, e questa mia condizione mi estenuava, cospirava accuratamente al mio logoramento ma non è riuscita a farmi abbassare il capo. Mi sono rifiutato di nascondermi dietro l’alibi quantitativo e ho sempre mantenuto il dominio su me stesso. Il rapporto del movimento rivoluzionario con il livello dello scontro era presente nelle mie veglie e nelle mie preoccupazioni ma non mi suggeriva nessuna macchinazione per ingigantire il primo a scapito del secondo.
Queste operazioni erano proprio quelle del partito armato, suggerite da menti spossate, stanche di ostacolarsi sempre con le elucubrazioni più o meno metafisiche e desiderose di dare corpo visibile alle esasperazioni rimasticando le grandi teorie del passato, prime fra tutte quelle marxiste. Avidità e miseria della conoscenza che prende in giro se stessa, degenerando da ipotesi a ricetta culinaria da seguirsi con attenzione e fino in fondo.
Ciò, come ho precisato a suo tempo, produce un abbassamento del livello dello scontro, una bagarre fra rimasugli piantati in asso, un dialogo fra sordi, un bilancio bellico che aspira solo a mostrare i muscoli e a verificare chi ha i bicipiti più forti. Una mentalità malata produce il partito perché – armato o meno – non può cercare altra soluzione, la malattia è la paura dell’ignoto e dell’illogico, da cui deriva la vocazione a contarsi per sentirsi le spalle coperte, al sicuro, e per mettere al sicuro i propri possessi. L’assommazione e il partito sono due facce della stessa figura bifronte, enigmatica e sogghignante.
Paura giustificata. Che ne sarebbe del partito in una condizione autogestita generalizzata? Nulla, il nulla assoluto, verrebbe messo da parte come un ferro vecchio o dovrebbe ricorrere agli antichi metodi, cari ai massacratori di ogni epoca, per frenare l’irragionevole sollevamento di un’idea spaventosa e inaccessibile alla comprensione di piccoli burocrati balbettanti. L’ultima metamorfosi dell’illusione quantitativa è la specializzazione più ristretta possibile, più selezionata, una squadra di massacratori al servizio di un pugno di teorici usciti dalle scuole della politica dominante. In fondo, l’illusione quantitativa si ribalta senza accorgersene in una minoranza dedita alla costruzione dello spettacolo. Non la realtà dello scontro è quella che conta ma la sua trasformazione in apparenza spettacolare, che affascina e che attira tante animelle impaurite ma vogliose di stare accanto a chi ha tanto coraggio da realizzare gigantesche azioni al semplice scopo di dire: oplà, esistiamo.
Non importa quale rapporto queste azioni hanno con il livello dello scontro sociale o di classe, come scrivevo trent’anni fa, quello che conta è la recita e gli spettatori, la produzione di consenzienti e attoniti fruitori di una trama grandguignolesca e inconsistente, farsa e tragedia nello stesso tempo. Orrori e vergogne ma anche errori e buona fede. Non si può fare di tutta l’erba un fascio.
Un errore terribile è stato quello di non essersi resi conto che il partito – armato o meno – è sempre e unicamente riformista, cioè produce un abbassamento dello scontro per renderlo controllabile, spiegarlo nei termini della teoria che è alla base della costituzione del partito stesso, e incanalarlo verso la conquista del potere. Un modello a senso unico che odio con ferocia e verso cui non ho rimpianti di alcun genere. Errori ne sono stati fatti, certamente. Ad esempio non riuscire – malgrado i tentativi – a creare dal nulla un’organizzazione armata efficiente, non centralizzata, autogestita, separata in nuclei di base o in gruppi di affinità, ecc. Un modello più volte affrontato, anche in questo libro, ma mai realizzato fino in fondo. Perché? Risponderò più avanti a questa domanda davvero centrale.
Per il momento mi interessa sottolineare che queste incertezze, come pure le pseudocertezze partitiche, nascondono un tessuto costitutivo eminentemente contraddittorio. Non esistono processi lineari, nemmeno quelli considerati con orrore qui sopra, riguardanti il partito armato. Anche in questo caso ci sono contraddizioni non risolte che non è possibile considerare o guardare con indifferenza. La realtà, ogni realtà, è sempre contraddittoria e applicarle addosso, come un cerotto su una ferita, il metodo dialettico non produce una soluzione o, come diceva Hegel, un superamento. Non mi posso scrollare di dosso le mie contraddizioni proprio come non può farlo l’intero movimento sociale, non c’è una tesi e una antitesi che si risolvono in una sintesi, e questa sintesi non è che un gioco appassionato che ripropone sotto forme diverse ma sostanzialmente immutabili le condizioni di partenza. Non c’è una situazione privilegiata da cui guardare indietro con sufficienza alle lacerazioni lasciateci alle spalle. Vana fatica.
L’impossibilità di fissare una divisione netta a priori nelle nebbie della coscienza di classe in periodi di arretramento dello scontro, porta a vanificare qualsiasi espressione che apparentemente si pone contro lo stato di cose esistente, anche se resta ancorata a una concezione ritardatrice e possessiva di garanzia e di tutela. Questa situazione rende poco fruibile – come credevo un tempo ormai lontano – la tesi della polarizzazione, la priva del respiro che dovrebbe avere, del sangue che scorre ai suoi estremi, negli abissi delle catastrofi storiche, delle repressioni, delle guerre e delle ferocie. Naturalmente, più ci si avvicina agli estremi dei poli e più la visione si fa chiara ma, nello stesso tempo, la si spoglia della sostanza di massa, che non si può non collocare che in una fase meno polarizzata. Lasciarsi trascinare ad azioni da cui non si torna indietro è un buon metodo per evitare di tentennare, ma qualche volta nasconde l’alibi della presenzialità a ogni costo.
La logica della polarizzazione si è deteriorata non a favore di una contraddizione più netta e meno relazionale, al contrario, ha trovato un irrigidimento da cui non è più stata capace di tirarsi fuori e da cui nulla la distrae. È stato costruito un muro tra esclusi e inclusi e poi si è lavorato a svuotare dall’interno la coscienza della propria condizione di esclusi e di inclusi. Dappertutto l’apparenza generalizzata ha preso il posto dell’esistenza fornendo una contrapposizione spettacolare in cui il partito – armato o disarmato – nuota adesso con grande vigore e capacità di recupero. Contraffazione come alibi e come fuga, come mistificazione del divenire storico, come vuoto intimo che proiettiamo all’interno dove leggiamo a chiare lettere le nostre inettitudini e le nostre abitudini a facilitarci la vita.
Un simbolo al posto del nostro cuore? Non ho mai gradito questa sostituzione capace di polverizzare i miei istinti e di darli in pasto alla mia voglia di dominio. In fondo a questo meccanismo c’è la paura che l’alibi non sia sufficiente a tenerci lontani dal fallimento della nostra vita, dello stato di prostrazione che caratterizza la prigione generalizzata da cui quotidianamente alziamo gli occhi ad un cielo corrusco. Nessun alibi è vita vissuta, esso porta con sé in ogni caso la finzione di qualsiasi spettacolo, può ingannare per un certo tempo, poi si rivela per quello che è, solo apparenza.
Anche a voler forzare i nostri giudizi critici e restringerli all’interno di un possibilismo per me non accettabile, non c’è dubbio che un abbassarsi del livello dello scontro produce irreparabilmente la chiusura in alibi individuali e in forme collettive che per amore di semplicità chiamiamo partiti. Vengono i brividi a pensare che questa inevitabile connessione ha anche un movimento inverso, cioè che sono proprio le formazioni chiuse e partitiche, oltre ai nostri alibi impauriti, ad aumentare l’abbassamento dello scontro. Non diventiamo così, noi stessi, i portatori di libertà, fornitori primari della caverna dei massacri? E l’autodeterminazione, il rifiuto della delega, la creatività, la dinamicità, la spontaneità, la gioia, dove vanno a finire?
Qui nasce la vaga intuizione della illogicità della rivoluzione come logica rivoluzionaria. Se lo scontro si alza – gli elementi, non le cause, di questo alzarsi sono molteplici – improvvisamente le stesse forze partitiche che producevano un abbassamento non sono più efficienti, perdono colpi e arretrano davanti al divampare dello sviluppo rivoluzionario. Anche le forze liberatrici, nel vivo di quel piccolo nucleo che portava in seno la tensione verso la creatività, la diversità, la qualità, spesso, vengono travolte da questo innalzare e restano quasi ipnotizzate, si mantengono nel vago, riscoprono titubanze e paure che prima magari non pensavano di avere.
Si può meditare a lungo su simili illogicità ma è questo il nucleo centrale della logica rivoluzionaria. Posso attingere da solo la qualità nell’azione ma posso anche non cogliere il momento in cui masse enormi di sfruttati, di esclusi, disordinatamente si muovono e attaccano obiettivi non ortodossi e lo fanno in modo non ortodosso. Pensare di aspettare la massa in movimento per agire è pura follia. Nello stesso tempo, mentre la nostra azione continua nella qualità, è pura follia cercare di cogliere il senso profondo di quello che accade quando questa massa si identifica con la rivoluzione. A che serve interrogare l’abisso che si è spalancato riguardo la misura della sua profondità e della sua estensione? L’abisso non risponde, inghiotte e basta, è come litigare con il nulla. Il rivoluzionario ha i suoi limiti e con lui ha i suoi limiti la sua logica, la rivoluzione non ha limiti e neppure logica, essa è illogica. Quando la si interroga – in genere al passato – accade esattamente, ma all’in grande, quello che si verifica quando si rammemora un’azione singola. Sia pure circoscritta, essa è infinitamente qualitativa, quindi inaccessibile alla logica delle parole, parla al destino non a noi, anche se siamo stati noi stessi quella azione, così la rivoluzione, non ci traduce la sua logica in termini comprensibili con le parole, essa permane nella sua illogicità.
La rivoluzione, se è tale fino in fondo, è distruzione del mondo vecchio, quindi distruzione anche delle idee rivoluzionarie nate nel mondo vecchio e solo qui aventi un senso diciamo logico. Nella rivoluzione, pertanto, il rivoluzionario non può che festeggiare la propria rovina e la propria rinascita come uomo nuovo. L’autogestione generalizzata è tutto questo, oppure è solo una razionalizzazione continua dei nostri sproloqui, un leccarsi le ferite per tornare a essere nuovamente costretti a sanguinare. La distruzione è un passaggio obbligato non una insana passione per il sangue e la morte. Non sono i rivoluzionari che l’hanno resa necessaria ma la controparte, chiamiamoli ancora capitalisti o, meglio ancora, inclusi. Questi stanno distruggendo il mondo, i rivoluzionari accelereranno – se non vogliono ancora andare dietro ad alibi e intelligenti giochi politici – tutto questo.
È tempo di spezzare le nostre incertezze e trasformarle in azioni, è tempo che da queste azioni venga fuori la distruzione del mondo antico. Ma non è tempo che da tutto questo processo venga una descrizione completa, logicamente soddisfacente. Tutto sarà caotico e illogico, mentre i nostri sistemi, i nostri modelli, avvizziti ed esangui agonizzeranno da qualche parte. Non ci sono antidoti contro una logica che ci resta incomprensibile, tanto vale abituarsi a considerarla come il cuore pulsante e vivo della rivoluzione, non come una deformazione da curare con qualche intervento ortopedico. Siamo stanchi di intrattenerci fra di noi con le nostre domande ben ordinate e predisposte, mentre sappiamo che le risposte non arriveranno in maniera adeguata.
La distruzione non è una ossessione che vuole diventare l’unico sbocco possibile del problema sociale, non è nemmeno una proposta radicale che vuole uscire per forza dalle righe tradizionali delle altre indicazioni salvifiche di cui è pieno il mondo. È una conseguenze strettamente logica – della logica rivoluzionaria che la ragione benpensante definisce illogica con disgusto ma che non c’è motivo di considerarla tale se l’altra è solo l’anticamera della caverna dei massacri – della sequenza di anomalie e di straordinari miracoli che i padroni del mondo continuamente agitano come marionette davanti ai miseri. L’incongruenza di questi pupazzi è fuori discussione. Abbattere il nemico che ci soffoca è una specie di sogno che dura da sempre, da quando l’uomo ha scoperto nell’animo suo quel fondamento atavico di cattiveria che lo spinge a strangolare il suo simile.
Un sogno di libertà però non si alimenta solo di sogni, altrimenti corre il rischio di spegnersi da se stesso, annegato nel proprio brodo. Questo sogno ha innalzato l’uomo al livello del suo Dio, lo ha reso forte e pronto alla lotta, ma lo ha nello stesso tempo investito di tanti dubbi e interrogativi. La libertà non è costituita da una sommatoria di singole libertà. Qui si nasconde un equivoco. La si deve allora rifiutare per accedere a qualche comodità diciamo a mezza strada? Oppure si deve bruciare nel proprio stesso fuoco, fino in fondo, procedendo impavidi nella qualità oltre il punto di non ritorno, incuranti iconoclasti anche dei propri stessi ideali, perché non sono altro che gli ultimi ostacoli, forse i più infidi? Queste domande pongono un confronto radicale. La distruzione del mondo vecchio non è una ipotesi teologica rovesciata, è un problema universale, non si esce da questo problema se non tornando indietro fino ad abbracciare nuovamente e con rinnovato ardore il proprio asservimento. La distruzione è un problema di cui occorre sbarazzarsi realizzandola così come ci si può sbarazzare del problema di Dio realizzando la libertà che lo spazza via come un incubo notturno.
Certo, so bene che questo parallelismo è eccessivo e incongruo ma come si può guardare l’infinito al di là della siepe se non ci si rende conto di essere in grado di trovare il coraggio per lanciare il proprio modesto sguardo incerto e pauroso, nell’infinito sconcertante svolgersi della qualità capace di bruciare in un attimo tutto quello che abbiamo accumulato di cautela e possesso, di controllo e garanzia? E il fondamento morale della distruzione? Esso si colloca nell’essere stati privati della libertà. Lo schiavo è sempre legittimato alla ribellione e non gli occorre chiedersi se la sua rivolta risiede nel territorio della giustizia – quella qualitativamente vera, non l’imbroglio che viene spacciato attraverso questa parola – o in quello nell’immoralità vogliosa e carica di una foga soltanto vendicativa.
Non c’è niente di messianico in questa considerazione, esse non dovrebbero comportare interrogativi o dubbi, eppure ne contengono perché molti uomini dabbene – paurosamente pieni di afflato rivoluzionario paludato in vuote chiacchiere – parlano a vanvera di necessità tattiche o di obiettivi strategici. Le leggi esistono e sono ben visibili, se non altro grazie al manganello del poliziotto, ma esiste molto di più, esiste una incertezza interna, una incrinatura nelle coscienze che in questi ultimi trent’anni si è aperta molto e ha determinato uno scollamento tra risposte adeguate e sfruttamento. L’antico orgoglio si è a poco a poco inchinato alle necessità della sopravvivenza e ha finito per piegare la schiena, la sovrabbondanza di vita è risultata un balbettio da stanza della camomilla, la distruzione appare sempre di più un tema letterario nichilista, riservato a rinsaviti intellettuali che esercitano il proprio talento elaborando colonne di parole. Lasciamoli nel loro morboso bisogno di terribilismo.
Questo mondo non si può salvare. Affermazione estrema che possiamo negare o, almeno, alleggerire? No. Impossibile. Un poco meno teoria e più azioni. Scrivo alla fine della mia vita in una galera greca e non mi sembra di dovere modificare questa affermazione di trent’anni fa. Non voglio dire di essere davanti a una verità folgorante ma nemmeno mi sembra una realtà lontanissima, come invece appare a tanti sapienti che riflettono intorno ai rimedi più avanzati per salvare il mondo vecchio e consentire una costante alimentazione della caverna dei massacri. La rivolta non arriva mai troppo presto e non si lascia cadere senza causare danni nella compagine nemica. Quella individuale e quella collettiva. La rivolta immette nella vita l’essenziale che la distingue dalla morte, la vitalità. Pensarsi vivi ed essere morti è assenza di rivolta, abitudine, decadimento, pazzia coordinata e sapientemente amministrata. La rivolta collettiva corrisponde quindi a un bisogno comune di vivere insieme, di incontrare altre persone che come noi sono vive e non si muovono simili a fantasmi nei cimiteri che oggi costituiscono le nostre affollate città, che passano a capo chino davanti alle ben custodite ma non invalicabili casseforti delle banche pensando a come trovare un lavoro. Questa incapacità è decadenza, è stereotipo elevato a modello di vita, a slogan pubblicitario. Ognuno ha diritto al suo momento di felicità. Ma dove trovarlo se non nella rivolta?
La follia del mondo vecchio che continua a ospitarci ci impedisce di cogliere fino in fondo le sfumature grottesche della nostra reale condizione di sudditanza. Perché non offrirgli uno spettacolo di magnificenza e – se si vuole usare il suo metro di giudizio – di follia? In caso contrario che cosa ci attende? Voltarsi con la testa dalla parte del muro, nel proprio letto, e aspettare la morte che non tarderà a bussare alla porta. Perché questo torpore dovrebbe essere preferito alla vita della ribellione? Per viltà? Per un istinto radicato di conservazione e di possesso che ci spinge a rimuginare sulla nostra fine piuttosto che alzarsi in piedi e affrontare la realtà e guardare le catene che ci tengono avvinti alla schiavitù, studiando la maniera di spezzarle? Forse i barbari sono alle porte e noi non lo sappiamo? Forse i barbari siamo noi stessi, proprio gli schiavi che camminano a capo chino e che potrebbero improvvisamente risvegliarsi e attaccare se non altro per un moto d’orgoglio o per respirare – almeno una volta – una boccata d’aria pura? Chi lo può dire? Quanto tempo ancora dobbiamo riflettere sulle nostre miserie? Quanti altri chiacchieroni dobbiamo ascoltare?
Ineluttabile come il destino è l’attacco che gli schiavi scateneranno contro i dominatori. Gli improvvisatori di espedienti e i noleggiatori di illusioni non riusciranno a fermare questo attacco. Non è una bella prospettiva, l’amore e la fratellanza sarebbero un’utopia se non altro gradevole per mettere i nostri sogni al posto di tutto il sangue che inevitabilmente scorrerà. Quando finirà questa continua alimentazione della caverna dei massacri? Non prima della fine dei dominatori. Chiacchieroni tediosi e utili alla recuperazione organizzata, insistono nell’immaginare altre strade. La violenza? Assolutamente da evitare. Ci stanno rubando anche il diritto di respirare, bene ma non bisogna rispondere con la violenza. E ciò viene affermato da pacifici rifornitori della suddetta caverna, filosofi e storici, scienziati e politici, e altre specie animali diversamente catalogabili. Che volgarità, una violenza che riesce a mettere paura. Meglio restare segnati nel corpo dai colpi della ferula e dal marchio della schiavitù ma non reagire se non con pacifiche – e incomprensibili – manifestazioni di dissenso.
L’attualità impone che le controversie vengano regolate in forma compiutamente istituzionale, cosa che ognuno vede giacere tranquillamente e senza scrupoli nelle mani adunche dei profittatori. È la civiltà democratica che ci insegna questo, siamo diventati fedeli di un Dio sacrosantamente istituzionalizzato nei sanatori parlamentari, bigotti di un proceduralismo amministrativo che ci fa aspettare una riduzione del numero delle frustate come una grande concezione di libertà.
Anche gli anarchici non assolvono al loro compito di cominciare la lotta pure se il livello dello scontro è basso, essi rimangono incagliati nell’attesa di dare il meglio di sé e, nel frattempo, non danno che quello imposto dal generale andamento delle cose, il minimo, cioè un dissenso esangue che non riesce neanche a stare al passo con le modulazioni repressive del capitale e con le modifiche produttive. Retrocedendo dai tentativi passati di avanzare nello scontro colpendo per primi, anche se in misura ridotta e necessariamente minoritaria, si è perso anche la capacità di cogliere la profondità del problema, la decadenza delle scelte ha un andamento miserrimo che colpisce non per la sua rarità nell’attacco o per la sua inefficacia – elementi che non hanno poi una grande importanza – ma per la mancanza di senso, di contenuto, di scelta, di qualità.
Non sto sacralizzando un alzarsi dello scontro o privilegiando la lotta armata – per usare un termine che mi sembra caduto in un meritato disuso – sto sottolineando una sorta di innamoramento per interventi fittizi, capaci di costituire solo un alibi per la propria esistenza in vita, non in grado di colpire il nemico, insomma una ossessione per le cose fatte per bene e con mezzi modesti, adeguati alle nostre attuali possibilità. Quattro chiacchiere sotto l’albero del pane. Tutto ciò costituisce un paradosso avveniristico, messianico, una sorta di appello rivolto al destino. Io semino qui, oggi, la mia piccola manifestazione di dissenso, dunque sono, affermo cartesianamente di esistere, spetterà poi alle forze a venire fare fruttare questo seme e trarne gli opportuni insegnamenti.
Non riesco a ricondurre questo schema sotto un aspetto non dico accettabile ma almeno plausibile. Mi affascina la sua insolubilità, la sua dura scorza di ottusa sicurezza di sé, non mi attrae, mi lascia sorpreso e addolorato. Il nostro intervento anarchico può produrre solo un innalzamento del livello dello scontro se è correttamente impostato, e ciò deve poterci toccare intimamente. Se l’impostazione è scorretta, viene riassorbito nel grande mare dell’opinionismo para-partitico e quindi inevitabilmente porta acqua al mulino dell’abbassamento dello scontro. Non stiamo affrontando il nemico, stiamo solo giocando con un simbolo.
Quando finiremo di cercare di scoprire noi stessi interrogandoci sul che fare nostro? Quando finiremo di guardare a destra e a manca cercando indicazioni tecniche e chiarimenti scientifici per dare una base ragionevolmente comprensibile alla nostra lotta? Quando comprenderemo che il nostro compito è chiaro e sotto i nostri occhi, attaccare il nemico? Invece di chiedere lumi a scienziati e altri procacciatori della caverna dei massacri, perché non studiamo noi gli schemi, non molto difficili da cogliere, per attaccare sul territorio il nemico? Queste affermazioni – più o meno con le stesse parole – trovarono trent’anni fa una risposta concreta, subito soffocata sotto un fuoco incrociato. Da una parte la repressione poliziesca dall’altra le alte grida e le denunce di tanti anarchici impauriti dallo spettro di un quanto meno improbabile loro coinvolgimento in pericolose pratiche. Una tragica commedia venne giocata da molti furbi dietro le quinte, con affermazioni sconosciute ma efficaci, e da pochi imbecilli a gola spiegata per quanto, si può dire col senno del poi, più rumorosi che pericolosi.
Piccole azioni incarnate in un tessuto generalizzato e autogestito? Una follia per quei tempi remoti e anche per i tempi presenti. Ma perché non ripensarla questa follia? Forse siamo oggi più carichi di inquietudini di allora? Non credo. La proposta – badiamo bene inscindibile dal suo cominciamento realizzativo – degli anarchici è sempre un passo avanti al livello dello scontro, un passo geniale e incompiuto. Questo è facile a cogliersi e difficile da realizzare. Molti benpensanti arretrano e gridano ai quattro venti la loro non disponibilità alla follia. Sono anarchici non pazzi. Ma in questa affermazione di saggezza perbenista – incontrovertibile sotto molti aspetti – c’è una frenesia sospetta, un tremare della voce, un accasciarsi che fa sorridere e sospettare che sotto ci sia nascosta una coda di coniglio.
Vedere certi spettacoli pietosi in cui balli in maschera sono affollati da falsi rivoluzionari camuffati da terribilissimi anarchici mi fa venire lo scorbuto. Dove sono gli elenchi di Déjacque? Dov’è Ravachol? Dove Henry? Nei libri, letti e riletti, momenti di fuga e di sfogo allo stesso modo in cui le favole dei Vangeli confortavano, e continuano a confortare, i miseri tenendoli legati alla loro miseria. Che importa che sotto i piedi di tanti terribilisti mangiatori di libri passi un fiume di sangue diretto alla caverna dei massacri? Loro hanno le mani pulite. Ebbene, non è vero. Tutti abbiamo le mani sporche. I nostri vizi parassitari non sono meno produttivi di massacro e miseria di quelli che correntemente, riempiendoci la bocca, definiamo delitti degli oppressori, azione repressiva del nemico. Tanti anni sono passati e stasera, in questa fredda ala di un carcere greco, sento nelle mie orecchie risuonare ancora gli slogan di un tempo. A quando la messa in pratica di tanta truculenza verbale?
Oltre a contrassegnare un abbassamento del livello dello scontro, colpendo la sensibilità dei singoli e la loro disponibilità che sulle prime appare sempre modesta, il partito armato si pone come punto di riferimento, guida, fonte di indicazioni tattiche e perfino strategiche, faro della rivoluzione e tutto il resto. Esso si sposa con una crisi strutturale del processo economico che davanti a ostacoli apparentemente insormontabili – ad esempio, trent’anni or sono, la rigidità produttiva – contribuisce a dar vita ad un movimento rivoluzionario generalizzato di resistenza e attacco, alimentandolo con le proprie impossibilità di accettare anche le più modeste richieste di miglioramenti sociali. Il partito coglie i risultati immediati di questa condizione e li cristallizza in un processo riduttivo, evitando un allargarsi a macchia d’olio che considera incontrollabile in quanto potrebbe sfuggirgli in qualsiasi momento di mano. Non intende avvicinarsi alle sorgenti stesse della resistenza e dell’attacco, non vuole accettare le palpitazioni di coloro che soffrono, preferisce le vie arcane dell’ideologia e salta a piè pari sia il recupero capitalista – si scoprirà più tardi il concetto di flessibilità e anche il modello di attacco generalizzato – e si racchiude con gli occhi iniettati di sangue all’interno di due bastioni, quello quantitativo e quello centralistico.
Lo squallore di questa soluzione organizzativa non può essere rischiarato da nessuna speranza di apertura, tutto piomba così nella scialba avventura del reclutamento, oppure nel cane che cerca di prendersi la coda, un circolo vizioso costituito da azioni-spiegazioni-comunicati-reclutamento-azioni. Tutto si ripete costantemente con un profondo deterioramento di sensibilità rivoluzionaria. Le iniziative non sono creativamente accettate o realizzate in un clima di fraterna collaborazione ma vengono decise dalla direzione strategica che ha un primo assoluto scopo, la crescita quantitativa. L’attacco è certamente inserito in un deterioramento delle possibilità di risposta del nemico, ma deve essere spiegato alle masse. Da qui la grande produzione di incomprensibili comunicati che diventano – quasi sempre e con qualche rara eccezione – una sorta di paratia stagna più che una linea di comunicazione.
Il ragionamento libero, la scelta autonoma e polverizzata sul territorio, l’indicazione di piccoli obiettivi moltiplicabili all’infinito e infinitamente più dannosi per il capitale che non le grandi, clamorose, azioni spettacolari, utili solo al reclutamento, vengono così non solo scartate a priori, ma condannate. La volontà di scelta, di approfondimento, la riflessione autonoma, non solo sugli obiettivi, ma anche sui mezzi per raggiungerli, vengono visti come un deterioramento del potenziale rivoluzionario che si intensifica – nel ragionamento del partito armato – solo accentrando e aumentando la quantità dei militanti.
Non ci si rende conto – nemmeno oggi – e una critica appropriata è ancora da fare – che a essere stato mediato in questo modo è proprio il modello del capitale. Il partito chiama attorno a sé individui che hanno imparato a dimenticare se stessi in quanto tali ed hanno invece appreso a pensare col metodo studiato e imposto loro dal partito. Questa regola è generale e si sposta velocemente verso una sua maggiore rigidità man mano che il partito si chiude a riccio clandestinizzandosi e scegliendo azioni armate spettacolari sempre più visibili nella totale apparenza di un mondo di fantasmi.
A questo punto il modello efficientista del capitale è perfettamente introiettato, lo stalinismo è questo passaggio da un lato all’altro dello schieramento di classe. A venire schiacciata è la tendenza ad alzare il livello dello scontro, a generalizzarlo per quanto possibile. Il pensiero non è un appannaggio di pochi burocrati, sia pure armati o in grado di fare una rapina in banca. Sostenere che questo genere di coinvolgimento contrasti con la mentalità accentratrice e burocratica è pura idiozia. Tutti possiamo essere capaci di fare rapine ma solo pochi abbiamo l’apertura mentale necessaria per immaginare un innalzamento dello scontro attraverso la generalizzazione, quanto più ampia possibile, degli attacchi. Inserirsi in questo progetto aperto, incerto e spesso contraddittorio, è quello che dovrebbero fare gli anarchici. Questi possono – come è stato fatto trent’anni fa – riconoscere, dentro certi limiti, che i partiti armati stalinisti colpiscono il nemico anche con le loro azioni spettacolarizzate e pubblicizzate opportunamente, ma devono ammettere che si tratta di un risultato positivo secondario di fronte alla principale linea che perseguono, la crescita quantitativa esponenziale.
Nella generalizzazione dello scontro, al contrario, non c’è bisogno di spettacolarità né di sponsorizzazione, l’azione parla da sé, è semplice attacco contro il nemico che sfrutta e opprime, non si prefigge altri scopi se non la sua riproducibilità, quando e come nessuno può saperlo, non ci sono indicazioni strategiche, non ci sono priorità tattiche, non c’è nessuno universo chiuso soggetto all’assillo diretto valido per tutti, non ci sono riflessioni assolute che volti attoniti o imbronciati sono costretti ad ascoltare e a mettere in pratica seguendo regole ben precisate. Ciò produce di certo una certa caoticità degli attacchi ma, considerando le cose nel medio periodo, come abbiamo fatto noi a suo tempo con la rivista “Anarchismo”, si è potuto dimostrare che alcune linee d’intervento si andavano cristallizzando da sole, senza nessuna pressione se non quella della realizzabilità e dell’esempio.
Nell’agire generalizzato – antitetico al partito di matrice stalinista – non c’è la cupa atmosfera della necessità ma la fierezza di essere liberi di decidere come, quando e dove attaccare. Il genio dell’individuo appare qui nella sua fierezza e con tutti i suoi limiti. La progettualità non è necessariamente prodotta nel laboratorio ristretto di una direzione strategica ma nasce dalla totalità delle azioni realizzate. L’intensificarsi di un tipo di azione – poniamo, l’abbattimento dei tralicci dell’alta tensione – può portare a una tendenza imitativa ipertrofica, ma non è certo questo un problema. Nello stesso tempo una singola azione diversa – ad esempio, l’incendio di un supermercato – può giacere isolato per mesi e per anni e poi dare vita a una serie impressionante di azioni simili diffuse nel territorio. Quello che conta per chi agisce in questo modo – e a farlo sono quasi sempre gli anarchici – è non restare a guardare aspettando le indicazioni provenienti dall’alto. Basta assimilare alcune tecniche ed ecco possibili attacchi che proprio perché non sono di grande levatura militare sono molto più pericolosi per il potere degli spettacoli pirotecnici del partito chiuso.
Di fronte alle posizioni giustificative di un’organizzazione clandestina, sia pure armata, tutta rivolta a dare spazio alla proprio esistenza – come è stato il caso di Azione Rivoluzionaria – abbiamo, a suo tempo, puntualizzato le nostre divergenze, non per dissociarci da quello che per anni era stato in nuce anche il nostro progetto, ma per soppesare le divergenze che emergevano dalla sua realizzazione. È ovvio che nel fare c’è sempre qualcosa che si perde di fronte all’orizzonte del sogno, ma è anche vero che non si tratta di elaborare la teoria di un sistema aperto contrapponendola alla teoria di un sistema chiuso. Questo esercizio è stato sempre completamente superfluo ed anche un po’odioso. Uno strumento clandestino ha i suoi lati positivi, lo abbiamo sperimentato in alcune occasioni, perfino può diventare a volte insostituibile, ma non è questo il punto. Non può mai accampare diritti di superiorità, ergersi a unico scudo contro il massacro sociale in atto. La pretesa è ridicola.
L’alternativa su cui meditare non è tra l’arroccamento e l’attacco frontale, al contrario è tra la chiusura e l’allargamento dello scontro attraverso l’attacco sul terreno minimale ma esteso al massimo, quindi difficilmente controllabile. Accettare uno scontro militare è stato sempre un suicidio. È nel pantano sociale dalle mille possibilità inverosimili e imprevedibili – ma anche assenti o latitanti per ignoranza o pigrizia ad un certo punto – che lo scontro si fa serio o, meglio, si potrebbe fare serio. Il militante standardizzato, anche non strettamente di posizione stalinista, ha un modo bizzarro di contemplare la verità assoluta della sua idea cristallizzata nella forma chiusa dell’organizzazione clandestina di cui fa parte. Al di là egli vede un individualismo sfrenato e incontrollabile, sparso, caotico, che si impadronisce dei singoli e li soggioga in un isolamento senza prospettive di fronte al frontalismo accentrato delle forze capitaliste da combattere. Le cose non stanno così.
Chi si avventura nello scontro generalizzato non per questo manca di un progetto, non è un martire consenziente destinato a morte sicura. Al contrario, proprio il suo anonimato e la sua polverizzazione nel territorio lo proteggono di più di quanto possa fare una struttura ferrea clandestina. Egli non soffre per la sua idea di libertà indossando una camicia di forza che gli impedisce di respirare, è portato a giocare con la sua vita – e questa è certo una grande sollecitazione – ma è un gioco felice che ogni anarchico sa di poter giocare fino in fondo e che non è precluso da una base di riflessione metodologica. Pertanto questa riflessione non l’angustia, anzi egli si interroga apertamente sulla connessione esistente tra la propria azione e il contesto dello scontro nel suo generalizzarsi e questa domanda resta disillusa. Non c’è una connessione sicura, potrebbero queste azioni che tendono a generalizzarsi non allargarsi mai al di là di qualche esempio isolato, potrebbero nel caos imperante confondersi e contraddirsi tra loro. E con questo? Sono ipotesi che sottolineano lacune evidenti e incidenti di crescita che sono inevitabili in un progetto insurrezionale.
Difatti è di questo che stiamo parlando, gli ultimi trent’anni ci hanno convinto sempre di più della validità di questo indirizzo, senza perciò disconoscere la fondatezza pratica – sia pure limitata – dell’organizzazione armata clandestina. Iniziare un affrontamento frontale conduce al partito armato – l’esperienza di Azione Rivoluzionaria è davanti agli occhi di tutti – o all’unità delle organizzazioni combattenti. È una logica ferrea perché imposta dall’abbassarsi del livello dello scontro che queste stesse organizzazioni causano col loro semplice esistere. Non si tratta di una lenta decadenza o di un arretramento dovuto a sconfitte militari, peraltro ineluttabili se l’affrontamento è collocato su questo solo piano spettacolare ma aridamente improduttivo in termini di coinvolgimento di molti, anzi di tutti, fra quelli che non amano arruolarsi sotto una qualsiasi sigla.
Si tratta di un abbassamento che comincia proprio nel momento in cui si punta tutto sulla carta clandestina armata. Priva di sostegno generalizzato, capace solo di ridurre quell’effetto di allargamento che le prime azioni possono ancora produrre, essa si affloscia su di sé, una lunga, sanguinosa, lotta perduta in anticipo si sviluppa col solo scopo di crescere quantitativamente, di spettacolarizzare lo scontro, di sopravvivere. Fuori di essa c’è un movimento che riceve non stimoli ma imbambolamenti tanto più intensi quanto più appariscenti sono le azioni compiute. Non c’è modo di ipotizzare un’evoluzione positiva della struttura armata clandestina se non sciogliendosi nel movimento e generalizzando lo scontro, cioè evitando proprio quello scontro frontale a cui essa è naturalmente portata per costituzione.
Ogni spettacolo del genere è pertanto una maschera grazie alla quale si cerca di mostrare muscoli militari che sono soltanto apparenti, non reali. Il dramma vero consiste proprio nella scelta dell’obiettivo spettacolare, capace solo di escludere non di coinvolgere. Alla fine, questo obiettivo produce un gigantismo deleterio che, se da un lato è destinato a essere sconfitto dal nemico di classe, dall’altro ha mostrato solo l’inettitudine degli spettatori che, rimanendo a bocca aperta, si riconoscono incapaci, nel loro piccolo, di imitare simili azioni affette da ipertrofiche intenzioni e quindi si mettono in disparte, magari facendo un tifo discreto o preparandosi a raccogliere fondi per i compagni in galera.
Il punto di partenza è un equivoco di fondo. L’organizzazione si crede in grado di difendere il movimento delle lotte generalizzate – non arriva all’assurdo di ipotizzare una possibile insurrezione che la metterebbe fuori gioco immediatamente – ma si tratta di una ipotesi infondata, quando – come nel caso delle strutture staliniste – non di una dolorosa menzogna, una reazione disperata per affermare se stessa di fronte all’allargarsi dell’estraneità che il proprio medesimo progetto ha voluto come condizione essenziale. C’è, nella crescita quantitativa cercata attraverso la spettacolarizzazione dello scontro, una terribile ossessione di sé, un tormento continuo, insomma una malattia.
Peraltro, più una struttura clandestina cresce e più la malattia che la mina al suo interno si sviluppa. Non è possibile clandestinizzare la generalizzazione delle lotte, questa seconda espressione è distorta dalla prima e la struttura chiusa lo sa e ne soffre. I fuochi pirotecnici che mette in scena sono tentativi puerili di insediarsi all’interno della generalizzazione e si svelano in pratica come altrettanti mezzi per distanziarsene e isolarsi sempre di più. La delusione non può essere in questo caso che cattiva consigliera e porta a un ulteriore arroccamento, un sogno egemonico, un partito chiuso, armato, onnipossente, ricco di risorse. Grandiosa ossessione o meschino dibattersi per non affogare in un bicchiere d’acqua?
La sciagura di un eccessivo ravvicinamento tra Stato e capitale conduce a una sorta di scomparsa della merce nel senso tradizionale del termine. Il bisogno essenziale da soddisfare, per lo Stato, è la pace sociale, stendere cioè sulla conflittualità generalizzata un velo funerario. Dal canto suo il capitale avrà problemi produttivi che si possono riassumere nell’adeguamento della produzione alle richieste sempre più pressanti del suo partner economico, lo Stato. Ogni merce avrà così la caratteristica sempre più evidente di contribuire con la propria esistenza alla pace sociale. Questo schema, da noi analizzato trent’anni fa, non era allora molto visibile, il motivo lo si deve rintracciare nell’eccessiva rigidità della struttura produttiva dell’epoca. Era questa che causava un innalzamento dello scontro – malgrado i tentativi al ribasso dei tanti partiti armati più o meno coscienti di questo loro ruolo recuperatore – da qui la richiesta di un sostegno statale di tipo repressivo e una contropartita nell’incorporazione forzata della pace sociale all’interno della merce in senso tradizionale.
Ma perfino le catastrofi non sempre riescono col buco come le ciambelle. Il capitale troverà nella destrutturazione flessibile e nell’automazione una soluzione autonoma che allontanerà la richiesta di uno Stato economista e si avrà così, e continua ad aversi anche ai giorni nostri, la sconfitta di ogni tentativo di resistenza operaia in senso tradizionale. Il capitale ha oggi trovato altre strade per le sue avventure di pirateria – pensate all’impennata fantasmagorica delle operazioni finanziarie astratte in borsa – e lo Stato è andato verso modelli di intervento politicamente adeguati a questa destrutturazione capitalista cambiando la forma dei partiti, la gestione democratica del potere e perfino la partecipazione all’economia in prima persona.
Bloccare questa condizione è ancora possibile solo indirizzandosi verso l’insurrezione generalizzata. Ogni altra strada, presa in considerazione da opportunistiche mezze calzette, è ridicola. L’evidenza è che la produzione è certamente realizzata con l’acconsentimento degli schiavi. Ma come si può non essere schiavi? La risposta è una sola, ribellandosi. Il paradosso di essere un lavoratore sfruttato potrà essere condotto alle estreme conseguenze di una ormai improbabile ricostruzione della vecchia coscienza di classe, ma si tratta di un tormento che non si può più usare in funzione rivoluzionaria. Sarebbe una coscienza vuota perché svuotata dal suo contenuto che era l’appartenenza alla classe sfruttata.
Oggi esiste una schiavitù che è sfruttamento senza coscienza, frammentarietà e flessibilità, discrezionalità e accidentalità, provvisorietà e incertezza, tutti elementi che fanno avvertire la propria appartenenza non a uno schieramento omogeneo ma a una caotica e controversa collettività spesso zeppa di conflitti interni non solo fra le diverse componenti rappresentative – sindacati o partiti – ma nel microcosmo della stessa unità produttiva. Siamo di fronte a una collettività di esclusi che è stata – o sta per esserlo definitivamente – ridotta in schiavitù perché costituita da vinti. Il capitale non ha nessuna pietà per coloro che non insorgono, occorre sfidare non solo le sue regole ma anche la durezza dello Stato ormai ridotto a fantasma repressivo in grado solo di spettacolarizzare le decisioni del suo partner e di proteggerlo nel caso di difficoltà.
Nessuna illusione è concessa, gli schiavi producono capitale e Stato, reggono sulle proprie spalle, e grazie alle catene a cui sono avvinti, l’intera struttura sociale. Eppure non si può torturare all’infinito, e neppure giocare sull’eventualità improbabile di un accomodamento progressivo sperando sulle future soluzioni capitaliste. Prima o poi dagli schiavi potrebbe venire una risposta barbaramente adeguata. Come? Non lo so. La distruzione del mondo vecchio è condizione indispensabile per un mondo nuovo fondato sull’autogestione generalizzata. Solo che non si può fare conto su relitti in balia di una ricerca angosciante di sopravvivenza. Quando gli schiavi si accasciano sono finalmente diventati schiavi sotto tutti i punti di vista, il lavoro del capitale su di loro può considerarsi quasi completato. Ma da qualche parte è rintanata e sonnecchia la rivolta, una plebaglia che non accetta lo statuto perbenista che i ridotti in schiavitù ricevono come contrassegno della propria miseria, ci deve pure essere, ce ne sono segni dovunque, anche se il potere – Stato e capitale stretti in un unico abbraccio – insiste nell’imbellettare la situazione. È su di questa parte ributtante e scandalosamente indegna che bisogna contare.
La critica è distanza semantica, sicurezza che si circonda avvedutamente di elementi di garanzia. Avanza mortificando gli spunti più estremi e si bilancia in recuperi fittizi che fanno un bello effetto. L’odio per il nemico che opprime e massacra è altra cosa, non si conserva inalterato, bolle ferocemente e spesso, purtroppo, ciecamente, ma non può fare altrimenti. L’odio è fuori del tempo, non segue le correnti culturali alla moda, non frequenta fantasmi, non accetta torpori rilassanti, non rinnega quello che ha vissuto, anzi lo rimugina e ne trae altre certezze che alimentano altro odio. Non è mai gran bella cosa a guardarsi, disturba la vista placida ed ebete di chi si aspetta conseguenze automatiche di meccanismi che non è stato lui a mettere in atto, si aspetta – in altri termini – un qualcosa che lavori al suo posto, che faccia gli sforzi più sporchi. Sono belle a osservarsi queste larve mummificate mentre dissertano nei loro luoghi deputati, riempiendo fogli e fogli in attesa di fagocitarsi il mondo.
Si tratta di fantasmagorie epocali che vanno almeno dalla rivoluzione francese in giù, fino ai giorni nostri, tiepidi e miseri al confronto con quei gloriosi esempi. Molti di queste cariatidi pietrificate si sentono Saint-Just in sedicesimo e indicano col dito alzato – pubblici ministeri mancati – il nemico da colpire. Ma la rivolta si alimenta dell’odio e ogni metodo – sia pure quello insurrezionale generalizzato e anarchico, anticamera dell’autogestione anch’essa generalizzata – deve tenerne conto se non vuole diventare essa stessa, in quanto rivolta, una sfilata di fantasmi.
Cercare nell’odio il guizzo della rivolta è smuovere il metodo a dire qualcosa di più del suo freddo dipanarsi. Non è certo di una scimmia sapiente che abbiamo bisogno. L’avvento del mondo nuovo non è l’equivalente del massacro continuo che caratterizza il mondo vecchio, anche se la distruzione non può realizzarsi soltanto nell’immaginazione di sedentari pensatori che vogliono fare rivivere momenti ormai trascorsi. Non si distruggono soltanto le cose ma anche gli uomini. E dov’è la differenza? A me sembra evidente. Uscendo dal palazzo dei fantasmi, mettendo da parte le lunghe e ormai datate diatribe del passato, bisogna impedire che sia il capitale a condurre alla distruzione il mondo vecchio, perché la sua sarebbe una fine senza futuro, una fine e basta, mentre la nostra distruzione apre la via al mondo nuovo.
Lo so che lo scenario che queste tesi aprono è sconcertante, lo so che molti mi leggono e approvano le mie analisi fino a quando queste ultime non arrivano alla conclusione distruttiva. Allora i benpensanti – frequentatori assidui del palazzo dei fantasmi – si bloccano e la mia calma li sconcerta. Non è un caso questa mia conclusione. È nella natura stessa di tutto quello che ho scritto in vita mia e delle azioni che ho portato a compimento, di tutti gli errori che ho fatto e di tutte le cose che non considero errori e che rifarei a occhi chiusi. Una grande idea possedeva questa mia continua ricerca della qualità, l’idea della distruzione del mondo vecchio, solo che di volta in volta modulavo differentemente questo mio obiettivo adattandolo alle condizioni particolari – più o meno ristrette – nelle quali mi trovavo ad agire, senza per questo accostarmi alla singola azione, con l’intenzione codarda di risparmiarmi.
Molte possono essere le scuse per abdicare alle proprie responsabilità, nella ricerca della qualità, nell’oltrepassamento e nell’esperienza qualitativamente diversa, queste scuse non reggono, ogni funerea pretesa di fare un passo indietro è annientata dalla bruciante realtà dell’attimo senza tempo e senza luogo in cui l’azione lascia la sua impronta bruciante sulla pelle. In queste condizioni non c’è scusa a cui aggrapparsi. Il mondo vecchio, anche nelle situazioni ripristinate dalle parole rammemorative – come queste che scrivo ormai vecchio in un carcere greco – appare come un condensato del nulla, qualcosa di inconsistente, troppo affaticato a stare dietro al fare quotidiano coatto per riuscire a concretizzare l’inconcepibile esperienza della qualità. Nulla da dire, solo la follia dell’accumulo modesto e continuativo, pertinace e garantista. Lontano col rumore della risacca, si muove il mare incognito dell’avventura qualitativa e mi chiama a ulteriore amarezza. Il destino è sempre – come ho potuto constatare in questo settantaquattresimo anno della mia vita – una lezione di sarcasmo e di scherno. Una specie di lebbra.
Il futuro prospetta spazi per progetti non codificabili, non riconducibili immediatamente a lineamenti conosciuti e pertanto prevedibili. Anche gli strumenti resistenziali, che ho coltivato per almeno metà della mia esistenza, mi sembrano troppo circoscritti. Occorrerà, in uno sguardo proiettato in avanti, avere una impertinenza che forse non ho mai posseduto, forse sono stato troppo legato a modelli culturali che oggi mi sembrano datati, forse ero io a essere troppo infatuato del mio stesso progetto culturale per vedere quello che veramente mi passava sotto gli occhi, l’origine e la latitudine delle mie stesse esperienze, con l’intero complesso di disastri che esso presupponeva o lasciava prevedere con un piccolo sconto che mi sono rifiutato di fare. Forse si era insinuata in me – nella mia fanciullezza – la tabe del positivismo, fino a rendermi lucidamente e noiosamente troppo sicuro di quello che andavo progettando e realizzando, non cogliendo i suoi limiti, i miei errori, le contraddizioni e le implicite rinunce a volte vergognose.
Ignoro il ruolo che in tutto questo ha giocato la paura. Essa non mi ha mai ossessionato, ma con ciò posso dire di non averla mai avvertita al mio fianco? Certamente no. Mi sono rivolto al destino nell’azione e questo incognito personaggio del caos, senza capo né coda, mi ha risposto dispensandomi una sorta di salvezza negativa. Sul punto di concludere più volte ecco che l’altro mi risparmiava o interveniva qualcuno a tirarmi fuori dai guai. Uso quotidiano dell’incertezza, calcolo fondato sulla circostanza, filosofia dell’approssimazione, metafisica del concreto, chi può soffermarsi su queste ipotesi senza lasciarci le penne? Nessuno. Io sono andato avanti. Il destino mi è venuto incontro nell’azione e l’ho sentito agire insieme a me, e mi sono conformato ad esso. Non l’ho più visto come una conclusione ma come un cominciamento continuo, una polla d’acqua chiara, non una potenza sovrastante e nemica. E ho visto anche i suoi limiti, la sua mancanza di parole, la sua incapacità di rispondere in maniera adeguata alle mie azioni. Poi, nel momento in cui qualcosa sembrava sfuggirmi dalle mani, con le spalle al muro, eccolo lì concretamente realizzato come accadimento impensabile eppure presente, dettaglio fuori di ogni immaginazione, potenza ben al di là di un banale fare, per quanto alimentato da un accumulo mostruoso. Niente che possa essere letto come fatalità e nemmeno come comportamento segretamente e incomprensibilmente demiurgico. Eravamo, e siamo, dirimpettai, io e lui, e fino a un certo punto è lui a dipendere da me. Solo che sto diventando fragile e incerto, nel passo e nelle membra tremanti, non nel cervello, e quest’ultimo, dall’alto della sua risibile supremazia, mi suggerisce una possibile onnipotenza del mio dirimpettaio, una egemonia di possibilità risolvibili o riconducibili in fallimenti e riuscite, non conquiste, che non c’è nulla da conservare o proteggere.
La mia fede nell’agire non è venuta meno, non per coerenza verso la mia canizie, che mi sembra un ridicolo salamelecco, ma perché è sempre nell’azione che ho vissuto la mia vita nella sua veste festiva, nella sua splendida ed eccessiva coscienza di sé, il respiro e l’ambito dell’impossibile mi ha sempre, fin da piccolo, parlato in termini di azione e ciò anche quando – per motivi che sarebbe ingenuo spiegare qua – mi limitavo soltanto ad accumulare conoscenza, ad assommare nozioni su nozioni, parallelamente agli accadimenti quotidiani che potevano, a volte, condurmi sulla soglia della disperazione.
Di fronte al pericolo di perdere me stesso come macchina pensante e come ricettore o accumulatore di conoscenza, pigiavo il piede sull’acceleratore e chiudevo gli occhi davanti ai sentimenti. Poi, un pugno in faccia da parte del mio coinquilino dirimpettaio, mi faceva disinvoltamente vedere il vero volto della necessità, quello della mente, e dovevo piegarmi ad esso, accettarlo nel suo ineluttabile fondamento, pronto comunque a ricominciare daccapo, testardo e ottuso, senza mai cessare di acquisire, come se fosse questa la sola cosa da fare. La sollecitudine alla fine però veniva sempre riproposta dal destino e ciò al di là di qualsiasi apparenza confortante. Se la paura vagava da qualche parte dietro le quinte, facevo finta di non vederla.
Il sogno contenuto nelle pagine di questo libro è stato sognato tanti anni fa e quindi non può essere vissuto oggi come una realtà indubitabile. Molte di queste tesi hanno ormai l’atmosfera di una lotta contro ombre che sono rientrate nell’antro oscuro da cui erano uscite. Ma, allora erano entità sparse che si aggiravano nel palazzo dei fantasmi, quelle apparizioni contro cui lottavo, oggi potrebbero ripresentarsi sotto forma mutata. In un certo senso sono loro debitore di qualcosa, cioè mi hanno fatto comprendere fino in fondo – amaramente quando si trattava di compagni che mi erano stati vicini – quello che non volevo essere, che non potevo essere. Non voglio ammettere la mia gratitudine nei loro confronti perché l’asfissia nei riguardi di qualsiasi esperienza chiusa è stata sempre più forte della mia buona creanza. Non ho, grazie ai loro errori, sperperato le mie poche qualità, ho potuto raggruppare, per me e dentro di me, l’esemplarità di quello che intendevo per azione, la qual cosa, vista da un altro punto di vista da quello del possesso della garanzia, significa che sono stato sempre sull’orlo della perdita e del fallimento.
So di essere sulla linea di una buona tradizione di lottatori, ma quanti ne colgono fino in fondo le implicazioni incise sulla mia pelle? Non molti. Libero di carichi troppo pesanti – adesso che sono vecchio penso anche libero dalla conoscenza come ossessione accumulativa – sono andato avanti a meraviglia, di catastrofe in catastrofe. Ho così compreso il senso della qualità, quello che si coglie nell’attimo fuori del tempo, e questo senso era ed è racchiudibile nella profonda certezza di quanto tutta la mia vita sia stata inutile dal punto di vista del possesso. Non mi sono mai umiliato tanto come quando la gente mi guardava con rispetto per la mia collocazione sociale, e continuo a umiliarmi anche ora, quando qualcuno giustifica le mie teorie con i miei studi o, ancora peggio, con i miei titoli di studio.
Non voglio imbellettare la mia vecchiaia con considerazioni d’altri tempi, adesso vado avanti adagio, direi navigo a vista e non vorrei che qualcuno pensasse che sono un adoratore della sconfitta. La perdita è altra storia, la sconfitta è resa a discrezione, quindi paura e viltà. La perdita è lasciare andare, non accumulare, non fare sfoggio di sé – amaramente constato la difficoltà terribile di quest’ultimo punto – non preoccuparsi della zavorra che si getta a mare per andare avanti, sempre più avanti. Alla lunga ho vissuto le mie gioie, le mie grandi gioie, come un lampo proveniente dal destino, e ciò in particolare nei momenti in cui avrei dovuto apprendere, al contrario, la dimestichezza con la solitudine. Niente posso tagliare via dalle mie esperienze nell’agire, non sarebbe stato possibile l’attuale modo di vedere la realtà se non avessi messo a rischio tante volte il mio trascurabile presente in un intervallo diverso, privo di tempo e di luogo.
Questa familiarità con la perdita me la sono costruita giorno per giorno, non mi è stata regalata, non sono nato con la mia fine predestinata, ho lavorato da sempre alla perdita ed è per questo che appartengo alla genia dei distruttori. Non affermo questo con amarezza ma con vera soddisfazione. È una delle poche cose che stringo ancora fra le mani. Ciò mi rende un privilegiato, una delle non tante persone che riescono a porsi davanti al proprio destino e trascinarlo nella parola non detta perché inesistente, indicibile, eppure pronunciata nella rammemorazione, sparsa in modulazioni che possono sembrare puerili raffrontate all’immane capacità del destino di entrare nella vita e farne strame o esaltarla fino all’inverosimile.
Guardare in faccia questo interlocutore estraneo e orrifico è possibile solo se si è abituati all’oltrepassamento nell’azione, cioè ad andare dentro la foresta cercando il sentiero impossibile che conduce al coinvolgimento, al coraggio di lasciare la garanzia per abbracciare la perdita. Quale sarebbe stata per me l’alternativa? Inabissarmi nel fare quotidiano, coattamente amministrato. Se avessi scelto, fin dalla mia gioventù, questa strada, evitando, solo per dirne una, la lunga fatica dell’accumulo conoscitivo, sarei stato un’altra persona, una persona comme il faut, ma non avrei vissuto la mia vita, sarei stato, senza saperlo, solo un viandante in attesa della morte, in attesa di scomparire senza lasciare traccia, come un battito di ciglia.
Mi rendo conto che ho soltanto scalfito la realtà nemica che pretendo fronteggiare in armi. Non posso ordinare il disordine né fare l’inverso, in un modo o nell’altro riesco solo ad aprire spiragli, interstizi, visitare sentieri, rinvenire segnature, leggere epitaffi alle intenzioni male assortite e peggio fiorite. Formule oltrepassate dalla velocità del nemico mi ingombrano la mente, non potendo più ostacolarmi le braccia. Lamentarmi non è mio costume e sono sordo ai ritmi della tragedia umana che urla nel corridoio qui accanto mentre scrivo queste righe.
Nel corso dei decenni – ormai troppi – la mia sensibilità si è acuita e rigetta le geremiadi di chi teme per il proprio possesso minacciato dal caos, nessuna commiserazione né durezza ma solo uno sguardo al movimento complessivo della vita che non accetta dilettantismi universalistici. Nessuno ha il monopolio dei guai, nemmeno quando ho affrontato la tortura ho pensato di essere veramente un suppliziato. Andiamo, ognuno fa il suo mestiere, come quando accadeva di presentare il conto, non potevo riflettere a lungo sul cattivo impiego della vita di chi mi stava di fronte. Perché considerarmi alla fine? Questo libro – ai suoi tempi – era forse un principio? No. In tutti e due i casi c’è un processo circolare in corso che non posso osservare mantenendo separate, abdicando alle mie decisioni prese una volta per tutte. Non mi rassegno, il mio cuore batte, quindi sono vivo. La mia mano trema perché sono vecchio ma sono ancora vivo, il nemico non è riuscito ancora ad ammazzarmi.
Sono più o meno in una condizione che si avvicina pericolosamente a quella di un relitto ma il mio cuore batte, non ho più le grandi ambizioni conoscitive dell’accumulazione giovanile, ma non sono deluso, resto lo stesso aggressivo, anche se il mio passo è incerto e le mie braccia deboli. Se fossi stato un conquistatore adesso sarei amareggiato, la megalomania mi accecherebbe, invece guardo in faccia il mio interlocutore privilegiato, il destino, e non la sventura. Non ci sono fatti sventuratamente negativi, nessun fatto può mettermi fuorigioco tranne la morte, ma la morte quando verrà avrà piuttosto l’aspetto di un non accaduto, certamente non di un fatto, oltrepassata quella soglia niente potrà più interessarmi, come niente avrò da abbandonare. Nessuna melanconia può sfiorarmi. Se ho perduto tutto è perché l’ho voluto perdere non perché il destino me lo ha tolto, ed è perdendo tutto che il destino mi ha dato il massimo, in caso contrario avrebbe lesinato consegnandomi all’ignoranza del bello e al disprezzo della qualità.
Ecco perché vivo nel passato e nel presente allo stesso modo e contemporaneamente perché sono privo di bagagli, dentro di me c’è un fiume che scorre spumeggiando e, travolgendomi nei suoi gorghi improvvisi e gelidi, mi ricorda che sono vivo e che la mia conoscenza accumulata con tanta fatica si è sciolta come polvere nell’acqua del fiume della vita. Nessuna delusione può sfiorarmi se non la mancanza di alcune presenza fisiche, la mia donna, il mio bambino, ma non sono fatto di ferro, sono un eroico traditore delle mie stesse pretese di coraggio, spesso mi ritrovo con gli occhi pieni di lacrime che non vogliono scorrere via e non è per i miei ricordi ma per la costante compresenza di presente e passato.
Le mie teorie, i miei pensieri, mi ronzano nelle orecchie, sono trascinati via da quel fiume impetuoso, cerco di amalgamarli con le mie sofferenze – dolori fisici, letteralmente parlando, difficoltà, ostacoli, piccole inceppature di ogni genere, malattie, perdita progressiva della vista – poi mi rendo conto che si tratta di due filoni separati, di due movimenti contrastanti, uno superiore e dominante, l’altro inferiore che deve essere ricacciato indietro a denti stretti, si tratta della vita, della mia unica vita, ed è di questo che parlano le mie teorie e i miei pensieri, come pure è di questo che urlano le mie sofferenze.
È inutile immergersi in un accumulo di orrori, anche se è proprio di una inflazione di questi aborti viventi che sono quasi circondato, come è altrettanto inutile considerarmi un indifferente Capaneo. Ho pulsioni così forti che mi rendo conto di essere fuori tempo, come uno che ha voluto attraversare un deserto ed è rimasto impastoiato da qualche parte nel quartiere di Allah. Ma è proprio in questo torrido orrore che sono vivo, ed è per questo orrore che mi sento capace di andare avanti, malgrado e contro tutti.
Per descrivere la composizione intrinseca del nemico, che alla lunga rimane una faccenda noiosa e ripetitiva, si deve rompere la barriera dell’orrore, distogliere gli occhi dall’abisso e decidersi ad agire. C’è gente che ci costruisce sopra la propria esistenza e crede con ciò di fare della vita una crociata contro il male denunciandone con accanimento gli aspetti periferici e spettacolari, una inflazione di terribili spaventi, di sofferenze arcinote, di inferni moltiplicati più del necessario. Ma quando si parte per l’azione, per trasformare la monotonia del fare che rassoda e rende possibile l’obbrobrio? Vivere denunciando una comodità come un’altra, si accatastano da un lato benemerenze e dall’altro si aspetta una catastrofe a venire per moto spontaneo, come se nella realtà ci fosse un mostro immane che divora se stesso destinandosi in tale modo alla scomparsa.
Questo significa vivere nell’apparenza, immaginare la propria esistenza come qualcosa che non esiste per cui finisce pure per non esistere sia questo qualcosa che la stessa esistenza. Il regno dei fantasmi prende piede e dilaga. L’aria asfissiante del fare coatto viene così respirata come aria pura in attesa di essere strappati via da una forza esterna – e benefica – inconcepibilmente capace di risolvere lo scontro fittizio in una prospettiva concreta. I fantasmi sono pieni di fantasia. Chiacchierare per farsi ascoltare da un numero ristretto di confratelli, tutti dediti alla medesima perversione parolaia, scambio di invettive contro la fonte di tutti i mali, l’oppressione che mai molla la sua presa.
E l’azione? Per il momento ci si limita a fare, ad accumulare conoscenza nella migliore delle ipotesi, il resto verrà dopo, si vedrà. I sacrifici che si fanno in questa attesa senza senso sono patetici. Bisogna decidersi a mollare gli ormeggi e a buttare a mare la zavorra. Ma come arrivare a questo coinvolgimento? Non certo per via di convincimento ragionevole. La rivoluzione ha sempre un fondamento illogico che costituisce la sua logica e che è comprensibile solo alla luce del mettere tutto insieme, senza risparmiarsi, nell’oltrepassamento. Restando imbambolati in attesa, facendo collette per aiutare i compagni in carcere o cose del genere – benemerite cose visto che mi trovo in carcere – si rimane sul molo e non si alzano mai le ancore. Ci si dissangua a poco a poco aspettando una catastrofe che da sola non può arrivare perché se dovesse arrivare senza la nostra partecipazione sarebbe a noi del tutto estranea, incomprensibile.
Lamenti e rimpianti non valgono un soldo bucato, le sollecitazioni a resistere, a stringere i denti, ad andare avanti restano prive di eco perché nessuno sa dove andare se non tiene presente la necessità del coinvolgimento nell’azione. Stare a rimuginare sulle azioni del passato, ormai ridotte a icone storiche è straziante attitudine puerile, come la passione per i romanzi di avventura. Se non possiamo leggere il passato in funzione dell’azione futura da realizzare è meglio non leggerlo, lasciare perdere. Quelle azioni non derivarono mai dall’attesa o dalla titubanza, ma da una stupefacente creatività, ed è per questo che ci affascinano, ma questo fascino invece di stimolo ad agire può capovolgersi in un alibi per continuare a fare le brave cose del nostro caro vecchio piccolo mondo antico.
L’azione, pure partendo da un coinvolgimento che sovverte tutti i soppesamenti della logica dell’a poco a poco, quindi presentandosi come illogicità pura, si racchiude in una logica di tipo diverso, la logica del tutto e subito. È premeditata questa logica? Lo è di certo, ma si tratta di una premeditazione metodologica che rovescia ogni possesso e ogni garanzia, che sgorga nell’oltrepassamento, quindi nella qualità, dove ogni atteggiamento conservativo è incomprensibile, dove ogni raffinata accortezza non è altro che un freno e una vigliaccheria.
L’azione, nel suo realizzarsi, rompe con la quantità, con le spiegazioni, con il tempo e il luogo. Queste prigionie vengono interrotte nel lampo in cui essa si realizza, nel momento in cui la sua illogica esperienza qualitativa si incide sulla pelle di chi la vive. La rammemorazione raccoglie parole che dicono qualcosa di diverso, tradendo la loro matura conglobazione, aprendosi ad interstizi sconosciuti, rompendo cristallizzazioni secolari, rendendo informi concordanze che sembravano resistere all’eternità dei tempi. Recependo da queste parole nuove indicazioni, fattivo possesso e cauta garanzia, è la follia del massacro che facciamo tornare all’opera. Eterna vergogna dell’uomo e della sua storia.
È la perdita che consegna come un di più indispensabile un particolare talento per porsi di fronte alla rammemorazione, non rimanendo sradicati dall’assenza dell’automatismo che fissa l’interpretazione normalizzata del fare. La perdita è l’effetto più immediato e tangibile dell’esperienza della qualità. Il fare si accartoccia in forme contrastanti con pretese di indipendenza, rifiuta di sottoporsi alle relazioni di causa ed effetto, si esilia e suggerisce una possibile vertigine da cui non è facile riaversi. Certo, la qualità non può essere agevolmente raggiunta, richiedendo un coraggioso coinvolgimento che non tutti riescono a mettere insieme, ma la condizione limite che richiede – l’oltrepassamento – una volta realizzata non ha confini, trascina via al di là di ogni illusione di fatalità o, per converso, di ragionevole recupero.
Tortuosamente si fa strada un percorso diverso, mai immaginato perché impensabile, dove le solitudini si condensano una sull’altra azzerando tempo e luogo, contraendo il visibile in immagini che non danno indicazioni quantitative, distanze o consistenza, ma libertà, uguaglianza, giustizia, bellezza, l’invincibile caos della libertà che non ha limiti né suddivisioni né costrizioni. Prolungare queste esperienze è mortale, ma che importa? Rifiutarsi di rispondere alla domanda, tutto qui?, non fa andare necessariamente al di là del punto di non ritorno. Per fare ciò occorre un progetto che si rivolge al destino. È uno sforzo mostruoso ma necessario, staccarsi dalla libertà assoluta è come morire due volte, è come disincarnarsi, strapparsi il cuore dal petto, si resta per un attimo attoniti. Poi la rammemorazione viene in aiuto e si ricomincia il progetto attivo di sana pianta.
In effetti non ci sono vuoti intermedi, e ciò anche quando si ritorna al fare coatto, con cui la rammemorazione fa a pugni, ma al cui mondo comunque appartiene. Si tratta di una strana appartenenza. Non solo le parole hanno significati provvisti di ridondanze mai udite ma anche la vita non è più esattamente schiava del fare. La coazione è incrinata, non è facile affermare di essere in grado di realizzare un fare non coatto, ma c’è una frattura, il crearsi di una ricca serie di interstizi dove si possono individuare molte reti di sentieri nella foresta, molti sentieri con incise delle straordinarie segnature. Nessun annullamento radicale del fare – il che equivarrebbe all’oltrepassamento del punto di non ritorno – ma una nuova ostilità che nessuna storia concordata e prefigurata può riassettare fino in fondo.
L’azione è un’esperienza diversa, fatta con l’ausilio di una coscienza diversa in un mondo diverso, quello concreto dell’essere che è ciò che non può non essere, un mondo remoto all’apparenza del fare quotidiano che tutti ci riduce a nebulosi fantasmi. Perdere significa spogliarsi di tutto per agire, abbandonare sicurezze e possessi, garanzie e difese. Molti paurosamente avvertono questa remota possibilità ma si mantengono distanti per paura e la considerano come una sorta di malattia. Vivono costoro racchiusi nel loro bozzolo di certezze e non sono disposti a venire fuori o, quando lo fanno, si tratta di timidi passi nella foresta da cui fuggono dopo brevi esperienze del tutto insignificanti.
Vorrebbero, molti usufruitori passivi di sensazioni forti e spettacolari, avere la qualità a buon mercato, a prezzi stracciati. Non è possibile. Il suo prezzo permane alto ed è giusto che sia così. L’ineluttabile perdita li sconvolge e restano eternamente sospesi senza sapersi decidere. Ho conosciuto molti di questi uomini – e in un certo senso questo libro, scritto all’epoca di mie più ampie speranze di quelle che la vecchiaia mi consente di alimentare oggi, resta indirizzato a loro – uomini che corrono il rischio anche oggi, visto che la loro categoria semmai si è ingrossata non certo estinta, di adattarsi alla propria sorte, di non vederne più i limiti e di non avvertire più la sofferenza del fare coatto. Nessuno può garantire le proprie incertezze per l’eternità, alla fine, dopo un certo tempo, esse si consumano e si modificano in certezze. È l’ora della nostalgia, della pena per quello che si poteva essere e che non si è stati. Ma anche i rimpianti perdono la propria forza, non luccicano per molto tempo, prima o poi si spengono o avvizziscono. Si tratta allora di ridipingere le mura della prigione dove si soffre per cercare di ridurre un poco questa sofferenza. Nulla è più triste di una riverniciatura.
Il rivoluzionario non può pensare in modo conservativo, anche i suoi progetti, che devono avere un fondo metodologicamente razionale, finiscono per sboccare tutti nella distruzione del mondo vecchio. Se il suo orgoglio si colloca nel banale tentativo di trarre profitto dalle proprie tesi o, peggio ancora, dalle proprie azioni, cacciato dalla confrontazione col nemico da questo improvviso ritorno della fiamma possessiva, deve rituffarsi subito nella distruzione se non vuole diventare un ultimo, disperato, baluardo di ciò contro cui sta lottando. L’urlo e lo strazio dell’attacco, in caso contrario, rientrano nel canone della normalità fattiva con tutto il corteggio dell’amarezza e della solitudine. Venendo a mancare gli eccessi rimangono soltanto le buone intenzioni, piaghe che stentano a cicatrizzarsi, che imputridiscono e puzzano.
Non ci sono ex rivoluzionari ma solo attuali apparizioni, fantasmi che sembrano possedere ricordi di un passato glorioso ma che non mostrano altro che il proprio abbassamento, prima di tutto morale, un decadimento che li allontana per sempre da ogni sogno della qualità. Ho visto molti inaridirsi a poco a poco, distaccarsi, racchiudersi in se stessi come un fungo maligno, preferire l’anonimato della sopravvivenza perché ormai incapaci di guardare quel cielo che avevano sognato di scalare. La mediocrità è un pantano che inghiotte a poco a poco, rigettando alla propria superficie una maschera di bonario accomodamento. E ho visto molti di questi professionisti della disillusione sputare con il proprio fiele tracce di un pietoso sarcasmo che non poteva fare altro che sottolineare la loro dedizione a ombre proiettate sulla parete della caverna dei massacri. Le nuove generazioni non possono che sorvolare queste tracce purulente e guardare al futuro, alle nuove lotte che le attendono, ai nuovi progetti. In genere, non sono disponibili a lasciarsi impantanare da una garbata chiacchiera filosofica, vanno avanti perché non sono inaridite, perché sono esse la vita che mai cessa di scorrere.
Indirizzo loro queste tarde righe stese con mano malferma.
Finito nel carcere di Korydallos (Atene), il 9 novembre 2010.
Alfredo M. Bonanno
Introduzione alla prima edizione
Questo libro l’abbiamo costruito insieme, negli ultimi anni, pezzo per pezzo, con quello che abbiamo sognato, pensato, fatto. Adesso lo consegno alla freddezza delle pagine: un riflesso di quello che avrei voluto con i sensi e con la ragione.
Povera cosa, comunque sia. L’ordine grammaticale rinnega il bisogno di liberazione e ribadisce la logica segregativa del testo. Tenendo conto di ciò desidero suggerire una lettura d’insieme. Per motivi editoriali il lavoro, pur mantenendo una sua organicità, è stato diviso in tre libri separati: La rivoluzione illogica, seguito da Teoria e pratica dell’insurrezione [prima edizione 1985, seconda edizione 2003] e da Chi ha paura della rivoluzione? [prima edizione 1986, seconda edizione 1990].
La rivoluzione illogica è incentrato sul problema della contraddizione. Continuamente tessiamo una tela che qualcuno (e noi stessi) scuce subito dopo. Ambivalenza in quello che facciamo e ambivalenza della realtà su cui operiamo. Pochi, non possiamo agire, crescere all’infinito non è possibile. Modificare va bene ma poi bisogna fermarsi, nessuno sopravvive a lungo col coltello tra i denti. Comprendere, ma non lasciarsi avvolgere nel lenzuolo funebre della teoria. Sapere agire ma anche sapere aspettare. Riconoscere la propria identità ma non considerarsi i soli depositari della fiaccola rivoluzionaria. Criticare gli altri, ma non soffocare i tentativi che vanno nella giusta direzione. Riconoscere questo senso evitando di farsi coinvolgere da forze avverse. In ogni azione rivoluzionaria si coglie quindi un limite negativo, un’apertura possibile alle forze di recupero. Allo stesso modo, in ogni progetto repressivo si individuano un difetto e un’approssimazione che consentono il prossimo sviluppo rivoluzionario. L’anarchismo, in questa prospettiva, non è mai neutrale. Deve, di volta in volta, riproporsi fin dall’inizio. Non si può dare per scontato. Non si può dire, è l’ideologia di cui si suppone la fondatezza. L’analisi stessa, nelle sue estreme conseguenze, lo vanifica. Lo dimostra, appunto, ideologia. Ma tutto il processo dimostrativo è dissacrante. Il risultato può essere anche un punto vuoto, in quanto spesso la periferia di un discorso contribuisce a racchiudere un centro mancante. Noi stessi non ci raccapezziamo con le parole. Le tradiamo e queste ci tradiscono. La conoscenza che raggiungiamo con l’analisi si ritorce, ad un certo punto, su se stessa, diventa conoscenza impossibile. Ci aggiriamo all’interno dell’oggetto e non possiamo far altro che tornare indietro. Riconfermiamo così, al soggetto, quello che egli non solo supponeva ma sapeva in modo sicuro. La novità apportata non consiste quindi nei territori sconosciuti dell’oggetto – che tali resteranno – ma nel processo medesimo della conoscenza. Le contraddizioni di questo processo sono l’esperienza vitale del soggetto, il suo unico modo di agire e non revocano in alcun modo in dubbio l’unicità e l’individualità dell’oggetto.
Teoria e pratica dell’insurrezione sviluppa il lavoro costruttivo del rivoluzionario, il suo impatto con l’immediato. L’organizzazione e i rapporti con le forze politiche sono al centro di questo libro. Chi si ribella? Perché ribellarsi? Le minuzie del dettaglio non apportano nulla di veramente importante se non il tentativo in quanto tale. Non è la proposta in sé che risolve il problema immediato dello scontro di classe. Essa può anche essere la più adeguata possibile ma è sempre lontanissima dalla realtà. Comunque resta necessaria. Gli effetti della sua azione sono inquietanti. Vanno sempre al di là della limitatezza che l’ha dettata. Guai a cadere nell’equivoco. Il fantasma quantitativo è sempre dietro l’angolo. L’organizzazione è massa proletaria in movimento che si aggrega, ma è anche unione specifica di alcuni uomini attorno ad un progetto. Le due cose non si escludono a vicenda, anzi si completano. Allo stesso modo la proposta quantitativa entra nell’agone politico ma non con la prospettiva della crescita all’infinito. Essa si arresta allo scopo immediato dell’aggregazione, non ha filtri specifici che la trattengano per un tempo indefinito e quindi la trasformino in partito. Il contrasto con le forme usuali del politico non potrebbe essere più stridente. Ma è proprio questo far violenza a se stessa che mette in risalto la componente ribellistica della stessa aggregazione quantitativa, differenziandola da altre forme apparentemente simili. Il percorso dell’analisi, anche questa volta, sembra girare a vuoto. Perché mettersi insieme se non si può procedere oltre? E nel ritorno della delusione si riconferma l’apparente vanità del fatto rivoluzionario. L’inconcludenza del progetto si ribalta però nel valore del percorso, di ciò che ne è stato dei rapporti con le altre forze politiche, di ciò che sarà dei singoli individui legati insieme dalla stessa esperienza ben al di là di un giuramento sull’improbabilità del futuro. A questo punto le indicazioni programmatiche assumono l’aspetto del gioco. Un piacevole intermezzo tra un’azione e un’altra. Ciò dispiace profondamente al perbenismo rivoluzionario che giura sempre sulla validità delle proposte organizzative, amministrate in vista della riproduzione quantitativa. Da questo gioco può venir fuori il progetto insurrezionale se in esso, ma principalmente al di là e qualche volta contro di esso, il ribelle si riconosce. Ma il ribelle è uno che sa giocare con la società, con se stesso ed anche con la propria vita. Non è il tetro macinatore di contrasti, il rissoso raccoglitore di antiteticità. Come non è l’eterno indeciso, in ansiosa attesa del segno positivo dei cieli, del responso degli àuguri.
Chi ha paura della rivoluzione? passa in rassegna, in una prima parte, i diversi aspetti della paura: il rifugio nel sogno e nella fantasia, la superficialità, la chiusura dogmatica, il mercanteggiamento bottegaio, l’infamia pura e semplice, l’ignoranza che serve da fondamento al discorso del potere, l’incertezza, l’animo catechistico chiuso ad ogni riflessione critica, il sogno naturista che studia come accomodarsi con lo sfruttamento. Tutte le forme vecchie e nuove della paura di fronte all’avvicinarsi dell’evento rivoluzionario. In una seconda parte invece il libro ripropone e sviluppa il tema dell’ottusità. Evitare l’imbroglio delle contraddizioni, il mito dell’oggettivo organizzabile. Se il primo momento negativo si contrappone al secondo con aspetti positivi, successivamente il percorso si ripresenta allargato, sempre sulle tracce del nemico, ma in forma diversa. Ripetizione e novità si sovrappongono. La prima cerca di sottrarre l’oggetto all’ambito del significato, proponendolo all’infinito uguale a se stesso; la seconda cancella ogni formalismo e ripercorre sensi sempre identici composti da elementi tutti diversi fra loro. I risultati che si costruiscono non vengono dati a priori, certi come un’imbalsamazione profetica. Il senso della sconfitta prende il sopravvento solo quando l’illusione quantitativa della presa del potere è penetrata fino in fondo. Altrimenti l’inutilità del gioco si ripropone intatta ed enorme nella sua profonda unità con la vita, con tutto ciò che di assolutamente dispersivo e superfluo c’è nella prodigalità del vivere di tutti i giorni. L’ottusità non è quindi cieca ripetizione, irriducibile aderenza ad uno schema per quanto riuscito possa sembrare. Il fallimento o l’acquisizione del risultato non possono decidere la validità del progetto e delle sue singole azioni. Quello che deve sollecitare l’intervento critico è soltanto il percorso, oltre alle conseguenze sia sull’obiettivo che sulle forze che si sono sapute coagulare nello svolgersi del percorso stesso. La ripetizione agisce non solo sulla realtà, ma su ciò che di modificato si trova in essa. In caso contrario non sarebbe più ripetizione ma astratta tautologia. In questo cambiamento il progetto si muove in modo diverso, sempre diverso. Non restituisce dettagli alla memoria collettiva – che non ne ha bisogno – ma ricompone un tessuto disponendolo all’immediata scucitura. Il significato della ripetizione non è quindi nel ricordo di quanto fatto in passato, ma nel vivere della resistenza attuale che si incontra, nell’emergere delle nuove contraddizioni. In questo discorso differente non c’è nemmeno pericolo di dimenticare il passato. Semplicemente non c’è come passato, ma solo come elemento in continua modificazione del progetto che si muove, che diventa, appunto, movimento.
L’imbroglio dialettico
Mi sembra necessario continuare ancora un poco questo breve colloquio col lettore in quanto, come è buona abitudine di molti partigiani dell’inverosimile, tutto il discorso precedente potrebbe essere scambiato per un riammodernamento della impalcatura dialettica. Malauguratamente la divisione in tre volumi di tutto il presente lavoro si presta ad un simile equivoco, mentre ritengo utile mantenerla perché chiarisce in che modo si sviluppa lo scontro tra positivo e negativo quando il processo non è imprigionato nel labirinto manicheo.
Il lettore è quindi pregato di scordarsi i luoghi comuni della dialettica. Il rapporto tra contraddizione e proposizione organizzativa è certo antitetico, ma non nel senso che la prima manchi nella seconda o la seconda sia priva delle lacerazioni della prima. Il luogo dello scontro non è altrove, ma è nel percorso stesso che ambedue questi momenti realizzano, e quindi nel loro essere fallimento e vittoria, contemporaneamente.
La realtà è insieme di strutture ma è anche una forma, e in quanto forma viene intuita dalla nostra coscienza. Nella stessa intuizione la coscienza cresce e vede se stessa e la realtà non più come due cose separate (uno specchio su cui si riflette l’immagine deformata di una persona), ma come la stessa cosa. La coscienza si prende (coscienza sociale) prendendo la realtà. Nel suo disporsi iniziale il vuoto che la coscienza mantiene in se stessa è riempito (il tempo non ammette vacanze) da ciò che il potere fornisce, fin nei minimi dettagli. Non possediamo per niente una nostra vita privata, un cantuccio dove restare soli. Il controllo ci insegue dappertutto. Ma questo stesso gioco del tempo che ci viene rubato è l’inizio della coscienza, della presa di coscienza. Nella mancanza di tempo appare quindi l’angoscia della vita, il fluire velocissimo di qualcosa che ci appartiene e che altri gestisce a suo modo e nel suo interesse. Questa inutilità viene colta come l’esterno, tutto un insieme di cose che ha bisogno dei nostri giudizi di valore per assumere significato, altrimenti resta indistinto: una serie di fatti. Per spezzare questa serie indistinta inseriamo i nostri valori, costruiti comunque altrove, nelle sale delle accademie del potere. Ma questa costruzione del nemico non è perfetta, minaccia continuamente di cadere in contraddizione. Il tempo può essere rubato ma non cancellato. Nessuna cosa può trasformarci in automi. Un battito del cuore ci riporta spesso alla vita, alla nostra vita. Poi diventiamo capaci di un gesto, di un pensiero, di un progetto. Abbiamo coscienza di ciò che facciamo e cominciamo ad avere coscienza di ciò che viene fatto fuori di noi, contro di noi. Poi apprendiamo che altri viaggiano nella nostra stessa direzione. Riflettiamo allora sulla nostra precedente intuizione, convinti che essa non è la totalità delle cose possibili, non corrisponde ad una necessaria resa, che c’è sempre qualcosa da fare per modificare la realtà. L’intuizione iniziale diventa coscienza piena, supera l’astrattezza del non sapere che fare e si struttura nell’intervento, in seno alla proposta, nell’organizzazione.
Pensare negativo il primo momento, può avere un’utilità solo metodologica in quanto, com’è facile capire, tutta una serie – praticamente infinita – di negatività e positività si raccoglie al suo interno in un groviglio di relazioni. L’intuizione di essere espropriati divenuta coscienza di sé non comporta comunque una cristallizzazione definitiva. L’espropriazione può continuare in mille altri modi. Anche il partito ci ruba il senso profondo di noi stessi, mentre le armi che abbiamo per combatterlo spesso sono andate perdute nella prima fase dello scontro, quando lottavamo di fronte a mostri più visibili e conosciuti.
In un altro senso anche il positivo del secondo momento è diffuso in un territorio di negatività. L’organizzazione appare come il destino degli uomini in quanto al di qua di essa il caos impedisce le più elementari forme di vita; ma al di là si può concepire tutto un orizzonte diverso di forme aggregative di cui non abbiamo oggi cognizione. La struttura che suggeriamo manca sempre di qualcosa. In essa c’è un elemento falso che disturba la nostra intuizione precedente, che ci fa stare male. Ma è proprio nella sofferenza davanti all’ineluttabile imprecisione, che il qualcosa che ci sta davanti ci parla di altro, di quell’altro che viene dopo e si collega a quanto sapevamo prima. La stessa riflessione sul positivo, gli elementi del dettaglio, la circumnavigazione dell’acquisito, non danno sicurezza. L’analisi è solo presunta, in effetti non sa dire quello che vorremmo sentir dire. Ogni cosa nel semplice fatto ci rimanda all’intuizione iniziale, quando nell’oscura validità della nostra coscienza priva di sé, decidemmo di venir fuori, di agire, di scontrarci col mondo, di scovare ad ogni costo il nostro nemico. Il punto di riferimento non è unità d’intenti, ma solo espediente aritmetico per convenienze di massa. Un codice facilmente aggredibile dall’interno dei singoli interessi e bisogni, proprio perché programmato – artigianalmente e spesso pateticamente – su medie facilmente ricavabili dall’osservazione empirica della realtà.
Ecco perché dall’incontro delle contraddizioni, diventate coscienza, con le strutture che non riescono a raggiungere lo scopo per cui sono nate (e quindi scatenano altre contraddizioni), nasce il mistero della ripetizione che comprende in se stesso quello della fine. Nessuno ama andare avanti all’infinito, ogni cosa cominciata deve arrivare ad un termine, positivo o negativo non fa differenza. L’uomo commisura le cose a se stesso e quindi le annega nel mare della causalità. Il ragionamento diverrebbe alogico negando questa indispensabile premessa e metterebbe a repentaglio la sicurezza che viene dal sentirsi controllati. Ribelli, se si vuole, ma controllati. L’intuizione senza fine è follia. Pura pretesa del tutto. Nessuno la reggerebbe a lungo. Per questo ricominciamo. Per avere la certezza di un fine cui siamo giunti. Insoddisfacente, se vogliamo, ma punto fermo da cui ripartire.
Riflettendo meglio, il fine si trova a essere confine, cioè delimitazione. Il positivo lo ricaviamo come struttura che si differenzia (e quindi si pone in relazione) col negativo. Questa relazione ci sfuggirebbe se non la vivessimo nello stesso momento come apertura e chiusura, come cifra e caos, come libertà e limite.
Una immensa rete senza livelli, senza orientamenti di marcia, a parte quello che la distribuzione dei rapporti sociali impone – ad un dato momento – alla realtà. In questo senso il dominio si contrappone alla creatività, ne succhia il senso vitale, si rigenera, va avanti. La struttura attinge le sue componenti dal dominio, diventa essa stessa territorio del dominio, vi dà corpo e ne riceve significato. La forma della vita vi si contrappone in una lotta senza quartiere che però vede la possibilità sufficientemente durevole di identificare un confine, una delimitazione sempre in movimento. Questo non ha nulla a che vedere con la dialettica.
L’equilibrio, il contegno, la verità
In effetti non so da quale parte possa pendere la bilancia. O se esiste una bilancia, o uno o più lati da cui pendere. In un momento qualsiasi di un giorno come gli altri può arrivare la morte e mettere fine alla mia certezza del luogo ove si annida il nemico. Ma la mia morte non sarà la contropartita della sua scomparsa. Cosa che, per altro, mi interesserebbe ben poco. Questa relativa estraneità di me stesso al conflitto di classe mi riporta di colpo al centro dello scontro, all’impegno totale, solo che diventano relative tutte le mie relazioni, i miei rapporti, la mia vita.
Per questo sono privo di contegno. Non mi limito. Non seguo la pesantezza di coloro che sanno. So di sapere pochissimo. Pertanto sono probabilmente (anzi certamente) uno degli uomini più sapienti che oggi riescano a far funzionare il cervello. E non perché so di non sapere (vecchissima favola filosofica), ma perché non ho contegno, limiti, pudore.
Le parole l’hanno per me. Purtroppo non riesco a strappare loro i vestiti. Qualcuno li ha cuciti sulla pelle. Se le denudo non hanno quasi significato. Perciò molti strillano per la poca chiarezza di quello che scrivo (come se lo scrivere potesse mai essere chiaro in modo definitivo).
Ho tanto poco contegno da sembrare (e da essere) a volte lugubre. Come è funereo il pagliaccio che ride degli altri dopo aver riso di se stesso. Dopo tutto la realtà è veramente una cosa da ridere. Solo che per farlo fino in fondo bisognerebbe essere saggi. E nessuno lo è fin quando è diviso in due dal conflitto di classe. Per ridere dentro di me, nella felicità del pieno godimento, dovrei possedere quello che mi è stato strappato via, e l’altro, il mio sfruttatore, per ridere pienamente (e quindi vivere), dovrebbe possedere realmente quello che ha rubato e non solo simbolicamente. Nei fatti accade invece che il furto di classe diventa estraniazione, trasformazione in cosa dell’oggetto reale, quindi anche del mio tempo e della mia vita. E di una cosa nessuno può gioire. Lo statuto dell’oggetto è diverso dalle voluttà del soggetto.
Ecco perché non posso proiettare una luce sulla realtà, non posso mettere in risalto una qualsiasi verità. La mia indagine si aggira nei particolari, descrive contingenze, si ferma sui confini e sulle contraddizioni. La passione è altro. È da essa che bisogna partire. Altrimenti le parole resteranno puri segni sulla carta, riconferme stampate dei luoghi comuni della memoria. Dentro ognuno di noi c’è però un sogno tumultuoso che attraversa il corpo senza consentirci di dare un senso immediato alle intuizioni. Ci aggiriamo nel futile, nel frammentario, ma sappiamo che esiste qualcosa di essenziale. È da questa conoscenza comune che bisogna cominciare a leggere e non da quelle certezze che di volta in volta riesco a dare l’impressione di possedere.
Una serie di parzialità può apparire ininterrotta, ma presenta sempre un senso, la sua polarizzazione nel reale è sufficientemente costante per essere colta dal nostro occhio analitico. Dobbiamo seguire questo itinerario di sofferenza, angoscioso perché riconfermante l’inutilità dello sforzo. Questa è l’unica verità che possiamo rintracciare e la sola cosa su cui riesco a orientarmi. La mia bussola e il mio credo.
Sono eccessivo proprio per questo. Perché ritrovo sempre il filo della contingenza al di là del generale e l’inimmaginabile orizzonte al di qua del parziale. L’eccessività della vita è data proprio dalla capacità di trovare l’incredibile nel posto dove tutti pensano debba trovarsi l’ordine della ripetitività, e la ripresentazione ottusa dove tutti suppongono l’inventiva e il sogno.
Il sacro recinto
Non c’è modo di difendersi dagli imbecilli. Per loro non esistono che regole fisse. Mangiano a orario, misurano con esattezza ciò che respirano. Guardano e controllano secondo un meschino modo di sentire tutto quello che gli altri fanno. Sulla microscopica scala dei loro valori stendono le pulsioni degli altri e fanno una santa crociata del proprio compito di sottoporle ad autopsia.
In genere capiscono poco e quel poco lo colgono solo nella parte superficiale delle cose. Di questo poco capire se ne fanno una ragione di vita e di ordine. Riportano tutte le dissonanze all’armonia prestabilita del loro universo. Conciliano l’impossibile nel breve tracciato della loro cultura e alla luce dei lampi rarissimi della loro intelligenza.
Io sono perennemente afflitto da individui del genere. Metto qui questa nota per impedire che i miei libri piacciano a loro. Me ne sentirei danneggiato, perfino vergognoso.
All’interno del sacro recinto dell’imbecillità non è questione di bandiera ma di cuore. Le ragioni non sono mai sufficienti a smontare un castello così difeso. Occorrerebbe non darsene pensiero. Ma tanta saggezza forse non è di questo mondo.
Londra, 28 marzo 1984
Alfredo M. Bonanno
Parte prima: La rivoluzione illogica
L’elemento contraddittorio della rivoluzione
Conforto quantitativo e funzione della critica
Una delle reazioni più immediate e naturali nei confronti delle difficoltà dello scontro di classe è quella di affidarsi al conforto del quantitativo, dell’immediatamente visibile, del riscontro oggettivo. Per quanto possiamo criticarlo o respingerlo, non riusciremo mai ad eliminare del tutto un simile istinto, tipicamente bottegaio.
Verso di esso ci spinge la paura di smarrire l’identità della nostra azione, di vederci coinvolti in una dimensione che consideriamo soltanto soggettiva, mentre tutto attorno a noi parla di accumulazione e di progresso, di perfezionamento, di fini immediati, di fatti concreti. Sentiamo quasi il panico dell’utopia. E nella paura di perdere il mondo ci convinciamo che l’unica soluzione sia quella di legarci ad esso con la catena della schiavitù.
Possediamo, a dire il vero, una sufficiente chiarezza nel nostro universo ideologico, e quando siamo abbastanza sicuri di noi stessi, quando non sentiamo il terreno franare sotto i piedi, discutiamo anche delle prospettive critiche in cui questo universo può e deve svilupparsi o modificarsi. Ma nel caso in cui le vicende esterne si fanno caotiche e convulse, mentre la tensione sociale cresce e l’urgenza della chiarezza diventa inderogabile, allora ci affidiamo al nostro universo come a cosa salda e definitiva, dimenticando i buoni princìpi critici, le buone intenzioni.
Ci trasformiamo in cerberi paurosi e scostanti, attorcigliamo la lunga coda su qualsiasi ipotesi che si discosti dalle nostre sacrosante idee fisse, ed avvinghiamo e condanniamo senza misericordia. Ci mummifichiamo, dimenticando noi stessi in una fissità da tragedia greca. La rivoluzione diventa un progetto concluso in tutte le sue parti, la nostra rivoluzione, la rivoluzione anarchica non ammette discussioni. Chi non è con noi è contro di noi.
Certo, chi non è con noi è contro di noi. Siamo uomini di parte pur non essendo uomini di partito. Non abbiamo mai parlato in favore di una fratellanza universale che travalichi le classi. Siamo fermamente convinti che gli uomini possono essere pacificati attraverso il fatto rivoluzionario solo dopo una lunga serie di dolorosi e sanguinosi eventi, per cui la rivoluzione non è altro che l’evolversi, forse lento, di questa serie di eventi. Ma ciò non toglie che ci pare troppo netto e troppo artificiale un progetto che parta dall’ipotesi discriminatoria che chi non è con noi è contro di noi.
Se non fosse così, se davvero potessimo partire da tanta chiarezza di distinzioni, il nostro sarebbe uno splendido isolamento, ma sempre un tragico e desolante isolamento. Chiusi nella torre d’avorio del nostro anarchismo vedremmo la realtà deformata dalla distanza che, per ragioni di sicurezza ideologica, saremmo costretti a mettere tra noi e il resto del movimento rivoluzionario.
Al contrario, scopo della critica è accorciare le distanze – per quanto possibile – da quelle forze che si muovono nel senso rivoluzionario anche se si tratta di forze che presentano un progetto diverso dal nostro. E ciò non per fissare superficiali alleanze o difficili convergenze che finiscono poi per danneggiare il nostro lavoro di anarchici, mentre si traducono a tutto vantaggio delle altre componenti del movimento rivoluzionario, ma soltanto per consentirci di arrivare ad una migliore comprensione delle condizioni oggettive del processo rivoluzionario.
Movimento e processo
Nel suo insieme il processo rivoluzionario è dato dal diverso disporsi del movimento rivoluzionario nei confronti del livello dello scontro di classe. Abbiamo quindi che processo rivoluzionario e scontro di classe non sono sinonimi: il secondo comprende le vicende sociali nella visione più ampia delle relazioni conflittuali tra individui all’interno delle classi e tra classi all’interno della società, il primo comprende le strutture autorganizzate degli sfruttati e le strutture specifiche rivoluzionarie in senso stretto.
Considerando, fra l’altro, che ogni militante fa contemporaneamente parte di una struttura del movimento rivoluzionario e si trova a vivere in una certa situazione all’interno dello scontro di classe, e considerando anche che non è per niente vero che questa differenza non esiste (come per tanto tempo è stato affermato) e che il compagno è prima di tutto sfruttato fra gli sfruttati, si ha che le cose si complicano in misura notevole.
All’interno della società ogni individuo si pone in relazione con diverse situazioni (individui, idee, strutture, forme, ecc.) che vanno dallo Stato alle espressioni spontanee dell’organizzazione degli sfruttati (assenteismo, autogoverno, sabotaggio, esproprio, renitenza, ecc.). Questo immenso territorio di relazioni che costituisce lo spazio sociale, è anche il luogo dello scontro di classe. Una parte significativa di queste relazioni – quella che poi ha la prevalenza qualitativa e finisce per caratterizzare il resto – è costituita dalle relazioni di classe. Essendo lo scontro di classe un evento che si sviluppa non solo nel tempo ma anche nello spazio sociale, abbiamo che si può parlare di livello dello scontro, e che questo livello può essere più alto o più basso a seconda che a prevalere siano le classi sfruttate o le classi sfruttatrici e ciò per il fatto che noi allo scontro di classe diamo una connotazione positiva, lo consideriamo un evento liberatorio. Quindi il suo innalzarsi, per noi, corrisponde a un prevalere (non a una vittoria, ma a un prevalere) delle iniziative e delle azioni delle classi sfruttate.
Per quanto alto possa essere il livello dello scontro, e quindi anche in quelle condizioni oggettive che normalmente definiamo rivoluzionarie non si potrà mai verificare, nell’insieme di iniziative e di azioni provenienti da parte degli sfruttati, un’omogeneità tale da potere essere condivisa o rigettata in pieno da parte di una specifica componente del movimento rivoluzionario. Accadrà sempre che la stessa multiforme capacità di espressione degli sfruttati, l’eterogeneità dei loro bisogni, la creatività che scaturisce dalle iniziative prese che consentono un’espressione prima impossibile, renderà la realtà dello scontro di classe cosa molto diversa dai modelli d’intervento del movimento rivoluzionario.
Ma quest’ultimo, proprio perché rivoluzionario, non sarà mai qualcosa di totalmente diverso da quella realtà. Esso sarà sempre qualcosa di parzialmente diverso, cioè qualcosa che sente l’influsso di quella realtà, ne assorbe i condizionamenti, le motivazioni e le indicazioni, per trasformarli in modelli d’intervento sulla realtà stessa, allo scopo di modificarla e indirizzarla verso obiettivi ritenuti validi a priori sulla base di un’analisi a forte contenuto ideologico.
Nell’interazione tra movimento rivoluzionario e livello dello scontro di classe, in quel disporsi del primo verso il secondo e del secondo verso il primo, in pratica nel processo rivoluzionario, si determinano reciproche influenze. Il movimento rivoluzionario cerca, tramite i suoi modelli d’intervento, come abbiamo detto, di modificare il livello dello scontro e quindi di avanzare nello spazio sociale facendo in modo che si ricavino sempre maggiori territori di agibilità sottraendoli alle forze della repressione; ma le condizioni dello scontro stesso influiscono, a loro volta, sul movimento rivoluzionario e ne condizionano l’attività, accentuando le sue differenziazioni e sottolineando le diverse sfumature ideologiche.
Le componenti autoritarie del movimento rivoluzionario
È di grande importanza capire che le componenti autoritarie del movimento rivoluzionario (marxista-leninista, stalinista, e le sfumature più o meno autonome), ricevono una vera e propria investitura dal livello dello scontro. Più questo è basso, più queste componenti, dallo stalinismo più ortodosso alle forme più complicate di marxismo che cercano un improbabile matrimonio con l’autonomia, ricevono credibilità e forniscono indirizzo ideologico. Il punto di riferimento è la concezione del partito. Un livello basso dello scontro rende logico il ricorso al partito e, per un altro verso, il partito contribuisce a mantenere basso il livello dello scontro. Le cose non possono andare diversamente. Il partito tende a porsi come serbatoio delle esperienze del movimento, mentre non è altro che un punto di riferimento delle concezioni più arretrate del movimento stesso, concezioni legate alla delega e alla guida, alla centralizzazione (più o meno democratica), alle strutture permanenti e professionali. Il partito agisce sempre come deceleratore del processo rivoluzionario. Veicolando le analisi dal centro alla periferia, finisce per far penetrare alla base del movimento il germe dell’attesa, dell’accumulabilità delle esperienze, del “non è il momento”, del tentennamento, della politica, della crescita quantitativa. Ma quella parte del movimento rivoluzionario che mette in moto una simile decelerazione del processo non è per questo estranea al processo stesso, non può considerarsi come qualcosa imposta dall’esterno e quindi assolutamente controrivoluzionaria. Azioni realmente provenienti dall’esterno del movimento rivoluzionario sono quelle promosse dal nemico di classe, dal detentore attuale dei rapporti di produzione, dal manipolatore attuale dei privilegi, dal programmatore attuale delle ideologie di potere. Tali azioni influiscono sul movimento rivoluzionario attraverso lo scontro di classe e non direttamente, in caso contrario anche le forze reazionarie farebbero parte del movimento rivoluzionario e si verrebbe a perdere la specificità di quest’ultimo. Le forze della reazione (Stato in primo luogo) partecipano dello scontro sociale non del movimento rivoluzionario, ma sono in relazione con quest’ultimo attraverso la loro partecipazione alle alterne vicende del primo.
L’effetto negativo (di decelerazione) che le componenti autoritarie del movimento rivoluzionario (partiti armati in primo luogo) hanno sul livello dello scontro di classe è una conseguenza della interazione tra esse e il livello dello scontro. Un certo livello produce effetti che favoriscono la loro crescita, a loro volta queste componenti contribuiscono ad abbassare il livello portando a situazioni che risultano ancora più favorevoli alla decelerazione e quindi all’estensione della componente autoritaria stessa.
Livello spettacolare dello scontro
Bisogna intendersi bene su questo fenomeno e sulla reale portata dei suoi singoli momenti. Per prima cosa abbiamo quindi chiaro che le componenti autoritarie (nelle loro possibili espressioni partitiche) non sono qualcosa che cade dal cielo e non sono nemmeno il prodotto della decisione di un vertice di rivoluzionari professionisti. Sono invece il risultato di una interazione molto complessa fra movimento rivoluzionario nel suo insieme (e quindi non solo le componenti autoritarie) e livello dello scontro. Abbiamo anche chiaro che l’azione svolta da queste componenti tende ad abbassare il livello dello scontro. Di più, possiamo dire che questa azione quanto maggiormente cerca di alzare quel livello – con azioni preparate e realizzate dalla minoranza militare del partito – tanto più il livello si abbassa. E ciò è comprensibile solo se si pone attenzione alla differenza che passa fra livello sostanziale dello scontro e livello spettacolare. Il primo è un rapporto conflittuale complessivo fra classi sfruttate e classi sfruttatrici, il secondo è un rapporto conflittuale parziale fra una parte del movimento rivoluzionario e una parte delle classi sfruttatrici, o meglio, alcune delle strutture specifiche che queste classi si danno per esercitare lo sfruttamento. Il partito cerca così di scavalcare il livello dello scontro. Tale operazione potrebbe essere legittima solo se fosse diretta a promuovere la crescita del processo rivoluzionario nel suo insieme e, in sott’ordine, del movimento rivoluzionario, ma risulta invece operazione di decelerazione effettiva del livello dello scontro in quanto pretende di porre come parte del conflitto in corso non le classi sfruttate ma il partito stesso. Agendo così, ogni tentativo di spingere in alto il livello dello scontro si traduce costantemente in una spinta verso il basso e quindi in un rafforzamento del partito che prelude ad una ulteriore crescita fittizia che darà vita ad una nuova spinta reale verso il basso e così all’infinito, almeno fin quando non sopraggiungeranno situazioni qualitativamente diverse, capaci di interrompere il processo di decelerazione messo in moto.
La distinzione fra livello sostanziale e livello spettacolare dello scontro è molto importante perché può sembrare strano che la crescita delle forme autoritarie del movimento, le quali spesso danno vita a manifestazioni eclatanti (appunto, spettacolari), tali da richiamare l’attenzione di tutti anche perché opportunamente sottolineate dal potere, possano corrispondere a un abbassarsi del livello dello scontro. Ma non dobbiamo dimenticare come il partito costituisca una fuga davanti alla realtà dello scontro, un ripiegarsi in se stessi di quei militanti rivoluzionari che sentono fortemente lo stimolo a fare parte di un insieme oggettivo in cui potersi annullare. Più il livello dello scontro si abbassa, più queste forme di ricerca dell’oggettivo si fanno evidenti e clamorose. Più il livello si innalza, più esse si diluiscono in una generale tendenza rivoluzionaria che rende superfluo il modello suggerito dal partito.
Le tendenze inverse al processo rivoluzionario
Non è possibile fare ricorso alla categoria dell’oggettivamente controrivoluzionario per qualificare in modo negativo il modello d’intervento autoritario e la dimensione del partito. Certo si tratta di un contributo negativo al livello dello scontro, ma resta pur sempre un contributo interno. Esso pertanto non può dirsi controrivoluzionario, a stretto rigore di termini, ma dovrebbe definirsi di tendenza inversa allo svolgersi del processo rivoluzionario.
Allo stesso modo sono di tendenza inversa tutte quelle forze che cercano di organizzare gli sfruttati in vista di “migliorare” la loro situazione, cioè le forze riformiste. Purché siano nella condizione di partecipare alla delimitazione degli spazi di agibilità e non siano ancora state assorbite integralmente nello spazio sociale della gestione attuale del potere, esse, pur non facendo parte del movimento rivoluzionario, hanno un’influenza sul processo rivoluzionario perché influiscono sul livello dello scontro di classe. Il rapporto che queste forze hanno con le forme autorganizzate degli sfruttati è lo stesso che si realizza fra componenti autoritarie e componente libertaria all’interno del movimento rivoluzionario. Si tratta di un rapporto contraddittorio ma non privo di relazione. I sindacati e i partiti cosiddetti dei lavoratori svolgono una potente azione di freno nei confronti delle istanze autorganizzative di lotta degli sfruttati, alimentano anche loro quella ricerca dell’oggettivo che fa desiderare il rifugio nel partito. Infine essi sono partiti molto simili al partito armato, modificandosi solo gli strumenti impiegati nella ricerca dello scopo, che è quello di imporre il proprio modello d’intervento con cui si cerca di influire sul livello dello scontro. Ma oltre all’azione di freno i sindacati e i partiti ne svolgono un’altra positiva, identificabile nella loro funzione di costruzione del consenso e produzione della pace sociale, per cui non possono fare a meno di contribuire a produrre spazi di agibilità all’interno dei quali è più facile muoversi di quanto non accada in situazioni di maggiore repressione. Ma anche questo rapporto è sempre da considerarsi come un processo in corso. Infatti, le forze della reazione che corrispondono, come abbiamo visto, a un’attualizzazione del potere, vivono anch’esse una loro specifica contraddizione, sono dilaniate tra una tendenza che le spinge verso un ripristino di forme arcaiche e chiuse di dominio, con venature dittatoriali, centralizzate, fortemente coperte di ideologizzazioni nazionaliste e razziste, e una tendenza progressista, più aperta, più viva e più adeguata ai tempi, la quale insiste per una ristrutturazione del dominio sulla base della decentralizzazione democratica, fino ad arrivare alle forme parziali di autogestione che costituiscono il massimo della raffinatezza delle teorie del dominio (autogestione periferica e controllo centrale). Il prevalere di una o l’altra di queste tendenze, o l’emergere di aspetti intermedi, mediatori dell’una e dell’altra, corrisponde a un certo livello dello scontro di classe e, a sua volta, ha influenza sulle future modificazioni del livello stesso. Qui non c’è molto da dire in merito alla funzione conservatrice delle due tendenze, anche se lo spazio di agibilità che esse lasciano è diverso, maggiore per la tendenza democratica, minore per quella dittatoriale, ambedue risultano esterne al processo rivoluzionario, per quanto, come si è visto, attraverso le modificazioni che causano sul livello dello scontro non si possono dire a esso estranee.
Cosa bisogna intendere per contraddizione
Ogni singola realtà logica di cui discutiamo, processo rivoluzionario, movimento rivoluzionario, livello dello scontro, spazio sociale, classi sfruttate, classi sfruttatrici, viene qui considerata come definita e circoscritta solo per facilitare l’approfondimento del problema. Nella pratica ciò non accade. Almeno non più di quanto accada di riscontrare la realtà individuo o la realtà forma, struttura, situazione, rapporto, relazione, ecc., le quali sono tutte fatti relazionali, cioè processi in perenne modificazione di cui non è possibile cogliere fotograficamente la vera consistenza in un dato momento del loro svolgimento.
Ognuna di queste realtà relazionali ha, nel suo interno, un processo contraddittorio di cui, all’esterno, cogliamo solo i segni dei diversi momenti relazionali che si ricollegano ai rapporti con le altre realtà. Ad esempio, il movimento rivoluzionario è una realtà che si sviluppa e si modifica nel tempo e nello spazio sociale, rendendosi identificabile in forme, strutture, situazioni, individui ben precisi, solo nei diversi momenti in cui si realizza a livello di relazione. Un gruppo armato clandestino, poniamo di matrice autoritaria marxista-leninista, non rappresenta di certo il movimento rivoluzionario nel suo complesso, ma nello svolgersi delle sue azioni, delle sue analisi, del suo disporsi nello scontro col potere, nell’insieme delle sue decisioni, come nei suoi errori, nelle sue valutazioni giuste e realistiche, nelle sue velleità di impadronimento del potere, come nelle sue fantasie di rappresentare forze reali della classe degli sfruttati; in tutto questo insieme partecipa del movimento rivoluzionario, mettendo a debito di quest’ultimo la negatività delle proprie realizzazioni e a suo credito la loro positività. Anche il gruppo di questo tipo è quindi una realtà logica ricca di contraddizioni. L’insieme di queste contraddizioni si riflette all’interno del movimento rivoluzionario che appare così come il prodotto dell’insieme contraddittorio di varie realtà. In più, poi, la somma delle singole realtà contradditorie è qualcosa di diverso della realtà del movimento rivoluzionario, cioè quest’ultimo ha contraddizioni proprie che caratterizzano la sua realtà e che possono essere diverse, sia qualitativamente che quantitativamente, da quelle delle singole realtà. Non solo, ma contraddizioni presenti in un certo modo nella struttura, nella forma, nell’individuo singolo, proiettate nel movimento rivoluzionario assumono una valenza diversa e sono causa di conseguenze diverse. Tornando al nostro esempio del gruppo armato clandestino di matrice autoritaria, questo si pone sostanzialmente come partito, però il suo porsi come partito entra in contraddizione con la necessità specifica della lotta armata, della clandestinità, del progetto di coinvolgimento di forze diverse, della collaborazione con realtà differenti, tutte cose che spingono il gruppo a presentarsi come il nucleo di un futuro partito più che come partito vero e proprio. Si tratta di una contraddizione lacerante che spesso scatena contrasti fortissimi di natura analitica ma anche pratica, con conseguenze davvero tragiche. Portata a livello di movimento questa contraddizione assume il significato più ampio del contrasto tra componente autoritaria e componente libertaria del movimento stesso. Ma vista in questo modo si tratterebbe di una contraddizione puramente ideologica, semplice riflesso delle contraddizioni delle diverse strutture, forme, individui, situazioni che si riflettono nel movimento nel suo insieme. Accanto al gruppo armato di matrice autoritaria vi possono benissimo essere gruppi armati di matrice libertaria, portatori di contraddizioni rovesciate, ma non per questo diverse. In pratica, all’interno del movimento, la contraddizione si colloca tra la tendenza verso il partito e le sollecitazioni che provengono dal livello dello scontro, da una parte, e tra la tendenza alla negazione del partito e le sollecitazioni che provengono sempre dal livello dello scontro, dall’altra parte. A un livello piuttosto basso (nel senso sopra specificato) corrisponde una contraddizione meno acuta nei riguardi della tendenza partitica e una contraddizione più acuta nei riguardi della tendenza libertaria, a un livello più alto dello scontro la contraddizione si capovolge e diventa meno acuta nei riguardi della tendenza libertaria e più acuta nei riguardi della tendenza autoritaria.
Il processo rivoluzionario è quindi un processo contraddittorio senza essere, per questo, un processo che si autonega da un punto di vista logico. Il suo svolgimento non consiste in un progressivo e sistematico superamento delle contraddizioni, come l’analisi dialettica tradizionale ci insegna, ma al contrario in un costante e continuo autovalorizzare le contraddizioni all’interno di uno schema relazionale sempre più ampio e contraddittorio.
Bisogna negare l’assurda affermazione che la verità sia sinonimo di identità. Dire A=A non significa dire la verità, significa non dire nulla, cioè significa ripetere la stessa cosa, come qualsiasi meccanismo automatico e qualsiasi pappagallo fanno più o meno bene. La verità o è la realtà o non è nulla, e se è la realtà essa è contraddittoria, essa è lo scontro delle contraddizioni in corso. Ogni tentativo di sanare queste contraddizioni in una sintesi più o meno alta, significa che le contraddizioni si considerano come una cosa negativa, mentre la sintesi è vista come il solo momento positivo, il momento in cui si raggiunge la pace. Ora non vediamo perché si debba partire dalla pace dei cimiteri per dare inizio a un’azione produttiva di modificazioni reali e non si possa invece partire da una situazione contraddittoria, che è poi la vera situazione reale e quindi l’unico punto di partenza per modificare la realtà.
Ne deriva quindi che realtà e contraddizione sono sinonimi.
La rete delle contraddizioni
Lo spazio sociale come territorio delle relazioni è coperto da una fitta rete di rapporti che si intersecano in tutti i sensi, dall’alto verso il basso e viceversa. Rapporti fra individui, fra forme sociali, fra strutture istituzionali, in una rete molto complessa su cui intervengono anche i rapporti culturali da un lato e i rapporti naturali dall’altro.
Non è questo il luogo per approfondire l’insieme di questi rapporti e le interrelazioni che ne derivano. Ci basta fare capire come ognuno di questi rapporti sia contraddittorio, in quanto in caso contrario non darebbe vita ad una interrelazione ma si concluderebbe come rapporto isolato, ripetizione all’infinito dell’identità affermativa. Ne deriva che la rete dei rapporti che copre lo spazio sociale è corrispondente alla rete di contraddizioni, la quale ne riflette l’intimo significato, il senso del movimento, la più profonda realtà.
La natura di queste contraddizioni è varia e molteplice. Si può andare in su verso le contraddizioni più ampie e complessive e scendere in giù verso le contraddizioni più periferiche e marginali.
Ogni realtà, sia essa l’individuo o una struttura estremamente complessa come lo Stato, è costituita, a sua volta, da una rete di contraddizioni, anch’essa estremamente complessa e varia, la quale si sviluppa e comprende contraddizioni ampie e articolate e contraddizioni piccole e molecolari.
Questa rete di contraddizioni cresce praticamente all’infinito, comprendendo le contraddizioni del passato e dando vita a sempre diverse contraddizioni. Non è possibile isolare in modo netto una contraddizione se non per facilità di analisi. E ciò perché non ha significato parlare – come fa la dialettica – di risoluzione delle contraddizioni in una contraddizione “superiore”. Le contraddizioni in effetti non contraddicono la realtà, ma semplicemente la costituiscono. Quelle più evidenti o più facilmente percepibili, non esauriscono la totalità delle contraddizioni presenti nella singola realtà, in quanto, quest’ultima, è data dall’intera rete delle contraddizioni che pur non emergendo ai diversi livelli in cui la realtà stessa si può idealmente scomporre, o non emergendo con la stessa forza, determina conseguenze e quindi sviluppo e allargamento ulteriori della stessa rete delle contraddizioni nel suo complesso.
Se una singola realtà contenesse solo alcune contraddizioni, queste ultime non la costituirebbero, ma si limiterebbero a partecipare alla sua costituzione accanto ad altre parti, facenti con essa una somma di cose separate. Si avrebbe come conseguenza immediata che le contraddizioni contraddirebbero la realtà e avrebbero bisogno di una risoluzione, cioè del passaggio a un momento superiore in cui la loro scomparsa, o il loro assorbimento, consentirebbe lo svolgimento del processo relazionale senza cui la realtà sarebbe impossibile.
Non si ha quindi superamento di contraddizioni perché queste non vengono assorbite, messe da parte, e riassunte in un superiore livello. Esse restano presenti all’interno della rete dei rapporti che copre lo spazio sociale. Di volta in volta la realtà focalizza questa o quella parte della rete delle contraddizioni perché assume una importanza e un significato maggiori ai fini dell’azione in corso, e allora il resto della rete sembra non esistere più, sembra svanire nel nulla. Si tratta dello stesso meccanismo per cui ci si convince dell’oggettivazione assoluta di una realtà fuori di noi, circoscritta e razionalmente codificata. Ciò fa star meglio, dà forza e sicurezza, conforta nella speranza di mettere ordine nelle nostre cose, se non proprio ora almeno in avvenire. Ma appena riflettiamo un poco dobbiamo ammettere che un’operazione del genere è possibile solo per assurdo. Non esiste una realtà oggettiva che non sia legata in mille modi con realtà soggettive. Da questo legame vengono fuori realtà molto più difficili e più ricche di contraddizioni di quella circoscritta realtà che pretendevamo oggettivamente localizzabile.
Il meccanismo per cui selezioniamo le contraddizioni è in pratica una specie di autodifesa che però ha una conseguenza negativa, ci fa vedere la realtà come difettosa e si presenta come lo strumento adatto a sistemare le cose. Ammettendo invece la compresenza totale della rete delle contraddizioni e il suo riflesso reciproco (e contraddittorio) sulla rete dei rapporti che copre lo spazio sociale, non escludendo da un lato i rapporti culturali e dall’altro i rapporti naturali, abbiamo che la localizzazione di un gruppo di contraddizioni assume il significato di un espediente per meglio capire la realtà, per procedere alla sua trasformazione. In questo modo parliamo di contraddizioni sociali, contraddizioni naturali, contraddizioni culturali e, via via approfondendo, parliamo di contraddizioni dell’individuo, contraddizioni delle forme sociali, contraddizioni delle strutture istituzionali e così via. Si tratta di un procedimento analitico che spesso siamo portati a trasformare in fatto reale, proprio per quel bisogno di oggettività che spinge a semplificare le cose, a vederle non per quello che sono ma per quello che vorremmo che fossero.
La polarizzazione della realtà
Caratteristica costante della realtà è quella di orientarsi verso due poli contrastanti, antitetici l’uno all’altro. Sarebbe troppo facile, ma fuorviante, ricorrere all’esempio della rotazione della terra e all’esistenza del polo Sud e del polo Nord. In effetti la polarizzazione avviene con un movimento conflittuale che fa nascere la nuova contraddizione come ripresentazione di tutte le contraddizioni che sono presenti nella rete complessiva dei rapporti, per cui si ha che la singola contraddizione è polarizzata in se stessa ripresentando così la polarizzazione della rete complessiva dei rapporti sociali e, pertanto, indirettamente, della rete complessiva delle contraddizioni.
Focalizzando un gruppo di contraddizioni ne isoliamo artificialmente la polarizzazione che allora ci appare immobile, procedendo oltre ci accorgiamo però che ogni lato della polarizzazione è, a sua volta, contraddittorio e presenta una ulteriore polarizzazione e così via.
La realtà è quindi sempre polarizzata. Questa frase non ha significato se viene considerata in un certo modo e può significare molto se viene vista in modo diverso. Guardando la realtà come qualcosa di percepibile in modo statico, o sia pure come un processo che presenta, via via, dei momenti facilmente identificabili a causa della loro sufficiente omogeneità, dire che la realtà è sempre polarizzata non significa nulla se non che la si può cogliere come oggettività, ed in questo modo imbalsamarla, o come attività, ed in questo modo vivificarla, non sfuggendo nell’una o nell’altra ipotesi alla legge deterministica della risoluzione delle contraddizioni. Al contrario, se la realtà è, come abbiamo detto, l’insieme, la totalità relazionale di tutti i rapporti che si realizzano nello spazio sociale, comprendendo anche i rapporti culturali e i rapporti naturali, e se questa totalità è una rete che trova corrispondenza nella rete delle contraddizioni, la realtà è anche questa rete di contraddizioni, per cui abbiamo che realtà, contraddizione, relazione, rapporti, interazioni, ecc., sono concetti diversi per illustrare lo stesso fenomeno complesso visto da focalizzazioni diverse.
Continuando. Se la realtà è contraddizione, è anche polarizzazione, anzi questa è la caratteristica conflittuale della realtà. In altri termini considerando la conflittualità come polarizzazione si elimina il residuo impaccio che deriva dal pensare contraddittoria la contraddizione.
La notevole importanza del concetto di polarizzazione si capisce non appena si considera la differenza con il concetto di divisione. La realtà non è divisa ma è polarizzata. Non possiamo, quindi, parlare correttamente di divisione di classe (se non per una concessione ad un termine entrato ormai nell’uso comune), ma dobbiamo parlare di polarizzazione di classe. La divisione è un’operazione astratta che soltanto per le nostre limitazioni mentali, spesso alimentate dalla cultura dominante, ha un significato concreto. Non è infatti possibile separare una cosa dividendola, la separazione avviene sempre polarizzandola, e ciò perché le parti in cui la cosa viene “divisa” mantengono fra loro una interazione che praticamente non cessa mai. Gli sfruttatori sono polarizzati verso una parte della stratificazione sociale e gli sfruttati verso l’altra, ma tra di loro non esiste una divisione netta e i rapporti che esistono non sono soltanto quelli di partecipare entrambi, da una diversa posizione, al processo di produzione, ma dal condividere entrambi – almeno in una certa misura – la responsabilità dello sfruttamento stesso, gli uni con la volontà di perpetrarlo, gli altri con il consenso prestato. Di più, per restare in argomento, all’interno di ogni polo si determina un’altra polarizzazione di contraddizioni, tra la decisione soggettiva allo sfruttamento e al consenso e lo svolgimento oggettivo del processo di produzione, e così via.
Privilegiando uno dei poli si può costruire un’analisi dettagliata ma priva di vita e di significato. Tutto diventa rigido e contraddittorio. Non bastano più le contraddizioni interne al polo che si è preso in considerazione a dare un senso a quello che si sta facendo, in quanto queste, prive delle conseguenze determinate dall’altro polo, che si è deciso di non tenere in considerazione, sono intimamente prive di senso.
Ma è tempo di ritornare al problema della rivoluzione. Rinviamo l’approfondimento dei problemi della contraddizione ad altra sede. Adesso siamo in possesso di alcuni strumenti che mi sembrano importanti, in primo luogo lo strumento logico della polarizzazione che consente di capire in che senso intendiamo la contraddittorietà della contraddizione.
Rivoluzione e polarizzazione
Il processo rivoluzionario, in quanto rapporto tra movimento rivoluzionario e livello dello scontro di classe, è fatto contraddittorio. Come processo tende ad uno sviluppo nel tempo e nello spazio sociale, ma questo sviluppo non è orientato sempre in senso positivo, può deviare, tornare indietro, trasformarsi in un regresso.
Occorre fare una piccola parentesi. Riteniamo che il peso e la significatività dell’elemento individuale all’interno del processo rivoluzionario, abbiano maggiore importanza che non nella determinazione del livello dello scontro di classe. Ciò per un motivo molto semplice. Il movimento rivoluzionario ha una coscienza di sé più chiara di quanto non accada all’interno delle singole classi, e quindi di quanto non accada all’interno dei processi che determinano il livello dello scontro di classe.
Tralasciando di approfondire il problema della coscienza di classe, occupiamoci solo della polarizzazione delle contraddizioni all’interno del processo rivoluzionario. Il compagno avverte la necessità di oggettivare questo processo, di riconoscersi in una sua quantificazione, in una sua crescita. Ciò è più che comprensibile. Come pure è comprensibile che nei momenti di sviluppo del processo si sia meno portati verso i problemi dell’oggettività del processo rivoluzionario, tanto questo appare evidente, come un fiore che sboccia a primavera e investe chi gli sta d’intorno col suo profumo e i suoi colori. Nei momenti del regresso il compagno si aggrappa all’oggettività, gli diventa insopportabile quella specie di dissolvimento non facilmente definibile, cerca di salvarsi nella struttura istituzionale.
Non solo il processo rivoluzionario appare allora come un fatto oggettivo, massiccio, non contraddittorio, ma anche il movimento rivoluzionario finisce per assumere lo stesso aspetto, mentre scompare la tensione attraverso cui si era prima espresso il livello dello scontro. Quest’ultimo diventa scontro-divisione, lotta tra opposte forze ineluttabilmente legate alle vicende oggettive (a seconda dei gusti) della storia, dell’economia, della biologia, ecc. Più questo esteriore diventa determinato e chiaro, più il soggetto agente si rinchiude in un’oscura prospettiva d’azione, più la sua volontà diventa inefficace e velleitaria.
Tutte le vicende dell’oggettività reificata si collegano con un filo conduttore, partito, autoritarismo, utilizzazione delle forze nemiche a scopo rivoluzionario, dittatura, terrore, classe dirigente, meccanismo dialettico, determinismo storico, ineluttabilità della rivoluzione, ecc. Si tratta di una catena che pretende, in nome della logica, di negare la contraddizione della realtà e finisce per diventare illogica esaltando appunto una contraddittorietà fittizia che l’affermazione della contraddizione reale avrebbe evitato.
La rivoluzione è un processo che sta di fronte a me, quindi è un fatto oggettivo, che ha una sua storia, una sua tendenza (si sviluppa e regredisce), suoi rapporti, sue interelazioni. Ma non è soltanto ciò. È anche la coscienza di sé che ogni individuo (e quindi anche me stesso), ogni forma sociale e ogni struttura (ad esempio, un partito o un gruppo o un’organizzazione specifica) che sono all’interno del movimento rivoluzionario, hanno e sulla base della quale sviluppano la loro azione. La polarizzazione di questo fascio di contraddizioni, così focalizzato, costituisce un aspetto del processo rivoluzionario, senza dubbio l’aspetto più immediatamente evidente. A sua volta, e procedendo nello stesso modo, il livello dello scontro costituisce un riferimento oggettivo per il processo rivoluzionario, mentre come coscienza di classe (posseduta dalle componenti partecipanti allo scontro) è il processo rivoluzionario a costituire l’elemento oggettivo. Quindi anche qui una polarizzazione.
L’oggettività del processo rivoluzionario è un punto di riferimento che rende leggibile la mia soggettività rivoluzionaria, ma può diventare un alibi e una fuga. L’assenza del primo elemento annegherebbe la mia volontà d’agire in una cieca sentimentalità, in una vagante curiosità alla ricerca di qualcosa di concreto. La subordinazione assoluta della soggettività al processo oggettivo renderebbe quest’ultimo il luogo della rigidità, della disciplina, dell’autorità, dell’esteriorità strutturale.
L’individuo non è composto esclusivamente di volontà – concezione individualistica che sottolinea uno dei due poli e che finisce per idealizzare l’azione a scapito della sua incisività e della sua concretezza – ma è polarizzazione di soggettività e oggettività. Considerato come soggettività o come oggettività soltanto è contraddittorio, considerato come contraddizione che si polarizza tra soggettività e oggettività non è più contraddittorio ma profondamente logico, oggettivo e soggettivo nello stesso tempo.
Lo stesso per le altre realtà. Una struttura autoritaria, ad esempio un partito armato, che tende, nei fatti, come abbiamo visto, ad abbassare il livello dello scontro di classe, sviluppa questa tendenza in modo oggettivo, perché è nella sua natura causare conseguenze del genere, perché si tratta di struttura di rifugio e di fuga, perché si tratta di struttura di conservazione. Fin qui nulla di particolare. Ma c’è dell’altro. C’è il livello dello scontro nel suo insieme, come totalità di contraddizioni, quindi come fascio di contraddizioni polarizzate, che esercita sulla struttura un’azione precisa, che la investe del compito di abbassare se stesso rendendosi possibile. È nella considerazione contemporanea di questi due elementi (che poi sono una ulteriore polarizzazione di contraddizioni) che scompare la contraddittorietà di cui si è colpiti a una prima valutazione. Difatti, in una prima analisi, appare legittimo chiedersi: se questa struttura (partito armato, ad esempio) abbassa il livello dello scontro di classe è una struttura contraddittoria e quindi controrivoluzionaria. Ma considerando le cose dal punto di vista della totalità, cioè della polarizzazione delle contraddizioni, si vede che quella struttura non è più contraddittoria, ma è adeguata al livello dello scontro, anche se di tendenza contraria al processo rivoluzionario nel suo insieme.
Facciamo il ragionamento inverso. Prendiamo in considerazione una struttura libertaria, ad esempio un’organizzazione anarchica che contribuisce a sviluppare l’autorganizzazione della classe sfruttata. Si tratta della struttura organizzativa libertaria più semplice e più ortodossa. Può prefiggersi di usare strumenti diversi, dalla controinformazione all’attacco armato contro responsabili dello sfruttamento o contro strutture della repressione e della produzione padronale, ma ha come scopo di servire da stimolo, non da guida e neppure da serbatoio delle esperienze del movimento. Questa struttura contribuisce ad alzare il livello dello scontro, e lo fa in modo oggettivo perché stimola l’autodeterminazione e il rifiuto della delega, perché sviluppa la coscienza autonoma della classe, perché esalta tutti gli elementi della creatività, della spontaneità, della dinamicità, della gioia, ecc. Certo tutto ciò è giusto, ma c’è anche l’altro polo verso cui si orienta la realtà, il livello dello scontro. L’azione svolta da questa struttura può non riuscire, può non fare alzare il livello dello scontro. Ma, anche in una eventualità del genere, si tratta lo stesso di un’azione rivoluzionaria concreta, reale, non contraddittoria e, quindi, adeguata al livello dello scontro, proprio perché non tende a staccare solo una parte delle contraddizioni (cadendo nella contraddittorietà ideologica), ma imposta il proprio intervento sulla contemporanea considerazione dei due poli verso cui si orienta il fascio di contraddizioni polarizzato.
Riassumendo. A un dato livello dello scontro di classe una struttura autoritaria può risultare adeguata a questo livello e quindi contribuire ad abbassarlo, a un altro livello (più alto) la stessa struttura può risultare meno adeguata e quindi essere meno significativa e meno pericolosa, pur continuando a svolgere la sua funzione (relativa) di abbassamento. A un differente livello dello scontro di classe una struttura libertaria può risultare adeguata a questo livello e quindi contribuire ad innalzarlo, a un altro livello (più basso) la stessa struttura può risultare meno adeguata, cioè meno significativa e meno utile pure svolgendo sempre la sua funzione (relativa) di alzare il livello dello scontro.
Su queste considerazioni, che ci sembrano adatte a costituire le basi per un ulteriore approfondimento analitico, si può intraprendere una critica concreta della componente autoritaria del movimento rivoluzionario. Limitarsi, come qualcuno continua a fare, a una semplice condanna ideologica significa ritagliare una parte della polarizzazione delle contraddizioni all’interno del processo rivoluzionario.
Qualcuno ha avuto interesse a confondere queste preoccupazioni critiche con il confusionarismo ideologico, con il fiancheggiamento acritico, con l’opportunismo collaborazionistico. Speriamo che questo libro possa contribuire a fare tacere le balordaggini dei soliti imbecilli.
L’illogicità della rivoluzione
Dicevo all’inizio che i sognatori dei processi ordinati si trovano sempre a disagio di fronte al processo rivoluzionario. Su tutto essi hanno le idee chiare, che poi sarebbe un modo diverso per dire che hanno le idee fisse, preordinate e non sottoponibili a discussione, sullo Stato, sulla società, sulle classi, sull’individuo, sull’anarchia e, infine, sulla rivoluzione. Ma non si accorgono che, ridotta a oggettività solidificata, questa realtà non è altro che un modello fortemente ideologizzato della realtà stessa. È anche vero che partendo da un simile modello si riesce a vivere piuttosto comodamente, a svolgere un’attività politica e a illudersi di contribuire anche alla rivoluzione, ma, come si sa, nel mondo dei fantasmi tutto è possibile.
Una delle cose più strane che costoro affermano con aria di grande sicurezza è che se una componente del movimento rivoluzionario, con la sua azione, determina un abbassamento del livello dello scontro, l’azione stessa è condannabile, si deve considerare controrivoluzionaria e quindi cercare di impedire o, al minimo, condannare dissociandosi da essa.
Come si spiega che un’azione che va contro l’obiettivo rivoluzionario di alzare il livello dello scontro non si possa considerare controrivoluzionaria? Non si nasconde una illogicità all’interno di un’affermazione del genere?
Si tratta di una illogicità che sussiste solo se si tiene conto di una parte del fascio di contraddizioni polarizzate intorno al rapporto tra componente autoritaria del movimento e processo rivoluzionario. Considerando invece la polarizzazione nel suo insieme – sulla base dell’analisi fatta nelle pagine precedenti – si vede che non siamo davanti a una logica contraddittoria ma a una contraddizione perfettamente logica.
In questo modo la rivoluzione illogica si converte nella logica della rivoluzione.
In conclusione la rivoluzione ci appare, di volta in volta, logica se ci poniamo dal punto di vista della contraddizione nel suo insieme (polarizzazione) e illogica se ci poniamo dal punto di vista della negazione della polarizzazione, cioè se pretendiamo una divisione netta della realtà in due parti separate.
Certo può accadere che anche la polarizzazione venga oggettivata in un tutto immobile, sublimata in un’ipotesi di processo ed estraniata dalla sua propria realtà che è, appunto, conflittuale. In questo caso è proprio l’approfondimento della componente oggettiva, non più di una parte, ma dello stesso insieme globale delle contraddizioni, che conduce al fallimento, al soliloquio di una volontà egoistica che rifiuta di vedersi come elemento di contraddizione e, per paura delle conseguenze che ritiene portatrici di illogicità, cade nella concreta illogicità che non è più quella del processo rivoluzionario (capace di convertirsi in una nuova logica) ma è quella del solipsismo che si nasconde dietro il dito dell’oggettività a tutti i costi.
Le sigle, le strutture, i simboli, le bandiere, le ideologie, si avvolgono allora in una falsa oggettività, si isolano nella cosa, rappresentanti di un senso che si è smarrito essi non rappresentano più nulla, sono scorie di una lavorazione che avviene altrove e di cui il soggetto non è partecipe. Nella grande officina del capitale, come non luogo del valore e campo di concentramento del processo di valorizzazione, l’impacchettamento si realizza in una meccanica ripetitiva che produce significato generale inutilizzabile, antagonismo della totalità, raffigurazione del parziale. Cediamo allora la nostra unità organica, il nostro senso che ci viene dalla polarizzazione tra soggettività ed oggettività per asservirci alla crescita quantitativa, al travestimento del valore in processo, al camuffamento della funzione vitale. Ci aggrappiamo all’oggettività. Strilliamo contro il partito, ma finiamo per farne parte, per essere noi stessi un partito, o per trasformare nella miseria del partito il piccolo gruppo di pulsioni umane che ci circonda. Stringiamo forte la nostra bandiera, ma essa per noi non rappresenta più nulla, è il simbolo della disperata ricerca dell’oggettività in cui annegare i dubbi, è un pezzo di stoffa per coprire le nostre nudità.
La massa degli sfruttati, proprio nell’accezione più veritiera di questo termine, diventa allora il concetto interlocutorio più corrente. L’azione valida è solo quella di massa, la violenza valida è solo quella di massa, l’opinione valida è solo quella di massa, la teoria valida è solo quella che incontra il consenso della massa, l’organizzazione valida è solo quella che raccoglie la massa. L’analisi non è più uno strumento per prepararsi all’azione e per meglio collocare quest’ultima nella realtà dello scontro, cioè per adeguarla al livello dello scontro, ma diventa un modo per rivestire di concetti quello che si ritiene la massa creda, voglia, desideri, ambisca, comprenda, solleciti. L’azione rivoluzionaria diventa una vetrina in cui si espongono gli interessi più disparati purché siano espressi dalla massa. Ci si avvia così ad una mesta illogicità, il soggetto ha estratto il proprio oggetto in una rarefazione contraddittoria e con ciò si è precluso ogni vera e propria possibilità di intervento. Adesso vaga in una dimensione rovesciata che scambia per realtà dello scontro. L’illogico è la misura di valutazione della logica, la logica diventa processo opacizzante della realtà.
L’efficacia come elemento di trasformazione, misurabile a posteriori, in base allo sconvolgimento massiccio delle condizioni apparenti della realtà, può trarre in inganno sulle influenze effettive riguardo il livello dello scontro. Molto spesso la produzione di senso di un’azione è effetto di una ridondanza costruita e preordinata dal potere, in un’orchestrazione degli effetti che fa vedere l’efficacia in modo distorto. La metafora ideologica diventa allora una lente deformante. L’attenzione risulta focalizzata nel luogo del non possibile, del meramente fantastico. Effetti altamente illusori vengono spacciati per elementi di intervento positivo sul livello dello scontro. Ma è proprio l’esaltazione di una efficacia addirittura catastrofica che ci indica con maggiore chiarezza in che modo il progetto spettacolare riesce ad abbassare nella realtà il livello dello scontro, ben al di là delle stesse capacità negative dell’azione in se stessa. Più questa efficacia viene esaltata, più viene ricavata solo una parte della polarizzazione delle contraddizioni che la riguardano, più sprofonda nell’illogicità dell’apparenza. Solo un ripristino del rapporto contraddittorio globale, l’analisi concreta dei legami che esistono tra azione e livello dello scontro, possono superare la spettrale ritualità di un’efficacia fittizia, riconsegnando il processo rivoluzionario alla sua vera e propria logica.
Se dal livello dello scontro mi proviene una indicazione, una investitura, una qualificazione, in un flusso continuo, come risposta la mia azione risulta determinata, obbligata, circoscritta. Faccio, ma il mio fare è integrazione al messaggio pervenutomi, al confine assegnatomi. Il problema è certamente grosso. Racchiude il nucleo centrale dell’illogicità della rivoluzione e ci indica il ritmo del passaggio alla sua fondazione logica.
Ci sono due modi di avvertire il messaggio che proviene dal livello dello scontro. Un primo modo, miseramente povero di senso, piomba nella compattezza della mentalità autoritaria e vi risuona come semplice autorizzazione, polo separato di una contraddizione di cui si ha paura e per sfuggire alla quale si accettano automatismi che finiscono per mangiarsi da sé. La struttura si irrigidisce, puntella le periferie del suo agire razionale, diventa una cittadella di simboli di segregazione. Poi c’è un altro modo, ricco di significati, che accoglie nell’opulenza della libertà, nel senso profondo del sentirsi anarchici, il messaggio proveniente dal livello dello scontro che suona come autorganizzazione della realtà esterna, come polo in rapporto con l’altro polo, come polarizzazione in atto, come valorizzazione delle contraddizioni. La componente libertaria diventa passione attiva, travolgente, elemento capace di coinvolgere all’interno della propria vitalità anche il messaggio stesso del livello dello scontro. Essa si rifiuta davanti alla pretesa di quest’ultimo di cristallizzare il rapporto, di tagliarlo in due. Impone un coinvolgimento che minaccia il senso teoretico che la religione della logica a tutti i costi vorrebbe imporre. Annuncia i canoni dell’illogicità, li fa propri. Si dichiara disposta al rischio, all’assurdo, al pericolo di smarrirsi nel riconoscimento della polarizzazione delle contraddizioni. E, proprio su questa via, ritrova la sua logica, la logica della sua azione, e la logica della rivoluzione.
I più gravi problemi dell’illogicità della rivoluzione nascono sul terreno dell’azione libertaria. Gli autoritari, proprio per quel loro rapporto istituzionalizzato e rigido col livello dello scontro, nascono, progrediscono e muoiono quasi senza accorgersene, facendosi, di volta in volta, gli assertori e i critici dell’accentuazione o della riduzione della rigidità e della corrispondenza della loro risposta all’investitura proveniente dal livello dello scontro. Anche quando assumono la veste di terribili dispensatori di morte, quando imbastiscono e mettono in atto processi contro responsabili dello sfruttamento che si concludono con sentenze di morte, anche quando distruggono clamorosamente realizzazioni della classe sfruttatrice, anche quando dialogano col potere (quasi da pari a pari), impiantando una guerra che appare una faccenda fra “bande rivali”, non sono altro che ragazzi usciti dalle biblioteche. La loro truculenza fa un poco sorridere non appena si pensa alla vastità e alla radicalità dei progetti distruttivi del popolo insorto. Non sono gli omicidi e le condanne a morte ad affascinare coloro che realmente cercano di comprendere il problema dello scontro di classe, non sono le grandi dichiarazioni di guerra a meglio orientare la loro azione. Dopo tutto si tratta di bravi ragazzi che, come tutti i bravi ragazzi, sono dei massacratori. Lucidi, freddi, conseguenti, ragionieri della rivoluzione, cioè di qualcosa a cui è stato imposto il calcolo freddo della contabilità in partita doppia. Ed è questa eminente loro logicità che li rende coerenti per il potere, che li fa vedere come unici rappresentanti di un processo rivoluzionario che invece si avvia verso altre direzioni. Ma lo svolgimento della loro logicità non è attingibile attraverso il cerebralismo ideologico di una critica formale delle loro azioni, o attraverso le congetture accartocciate di un’etica perbenista che inorridisce davanti ai cadaveri degli sfruttatori. Questi bravi ragazzi massacrano con scientifica accuratezza. Nelle biblioteche hanno appreso la scienza della morte e non hanno avuto cura di approfondire che quella scienza, elevata a strumento di preteso dominio, è la scienza prediletta dai padroni. L’accuratezza del massacro corrisponde alla bilancia del giudice, alla toga dell’avvocato, agli articoli del codice che il pubblico ministero sfoglia nel corso della requisitoria, alla mano del boia che tira la corda, abbassa la leva, stringe la vite, preme il grilletto. L’ineluttabile massacro degli sfruttatori non è detto che debba passare attraverso la piatta accuratezza della partita doppia. Presenteremo il conto a lor signori, su questo non c’è dubbio, ma non registreremo il numero delle teste che cadranno, non perderemo tempo a stabilire con squisitezza giuridica la latitudine e la longitudine delle loro responsabilità. Quando colpiremo non saremo massacratori, e nemmeno vendicatori, ma rappresenteremo lo sviluppo coerente e impensabile, materialmente certo e assolutamente fantastico, della passione rivoluzionaria nel pieno del suo scatenarsi.
Lo scontro generalizzato
Abbiamo visto come l’identificazione dello scontro di classe non può passare attraverso elementi ideologici, ma deve realizzarsi attraverso il momento sociale. Gli sfruttati sono disponibili all’attacco solo quando dallo sfacelo delle coperture ideologiche, che per tanto tempo hanno costituito una barriera alla comprensione, si arriva ad una più netta identificazione del nemico.
La disponibilità alla lotta è quindi non solo proporzionale allo sfruttamento, ma anche proporzionale alla compattezza degli strumenti ideologici. Più questi appaiono compatti, più vengono indette grandi crociate contro il nulla, e più la realtà dello sfruttamento resta intatta, più sono deboli, e più gli sfruttati ritrovano da soli la strada della lotta, la coesione di classe, gli obiettivi dello scontro.
Il livello dello scontro
Può essere definito come l’insieme delle condizioni in atto che caratterizzano lo scontro di classe. Conoscere queste condizioni è molto importante.
Esse sono in gran parte date e non dipendono né dai nostri gusti né dalle nostre aspirazioni personali, sono il risultato di una rete immensa di interazioni, in cui si inseriscono anche i nostri personali contributi, le lotte, gli errori, i gusti e le aspirazioni, ma solo come elementi di un quadro di gran lunga più ampio.
Non è possibile fissare una graduatoria di merito nei riguardi delle condizioni che determinano il livello dello scontro. Sarebbe, infatti, come privilegiare le condizioni dell’economia, sottovalutando, ad esempio, quelle dell’ideologia. La presenza di certe analisi, la scelta di certi mezzi, il rifiuto di certe prospettive, il diffondersi di certi disincanti, sono condizioni altrettanto importanti. Il mito svolge il suo ruolo (pensiamo al mito del partito, al mito della grande madre, al mito dello sciopero generale, al mito della violenza), ma quando cade ciò non vuol dire che cessa di svolgere un suo ruolo, al contrario, comincia a svolgere un ruolo diverso, appunto quello della caduta del mito.
L’alzarsi del livello dello scontro
Ogni momento storico ha il proprio livello di scontro. In un certo senso, la storia è storia in quanto riesce a tracciare il susseguirsi di questi livelli e a dar conto delle condizioni che li determinarono.
Una modificazione nel livello dello scontro è fatto normale, in quanto nessun fenomeno globale può mai irrigidirsi in una formula statica. Ma, spesso, queste modificazioni sono di tipo ondulatorio, si spostano attorno ad un asse che sembra restare rigido, come ancorato a qualcosa che non muta pur nel continuo cambiamento.
La polarizzazione delle contraddizioni si sviluppa nel pieno del suo significato, ma qualcosa permane, ripresentandosi in modo quasi costante. In quel caso si hanno fenomeni di solidificazione della struttura ideologica del potere. Ciò rende più agevole il reperimento del consenso per periodi medio-lunghi, cosa che in caso contrario farebbe correre il rischio, non trascurabile, della necessità di cambiamenti bruschi.
Qualche volta le capacità di autoriproduzione dell’ideologia si guastano e il perno centrale comincia a incrinarsi. Non tanto per incapacità tecnica degli ideologi di mestiere (che di capacità ne hanno veramente tanta), al contrario perché qualcuna di queste oscillazioni non ha seguito il corso adeguato previsto dalla struttura istituzionale. Ciò può determinare la nascita di condizioni nuove o di modificazioni repentine delle vecchie condizioni, con notevoli spaccature nelle barriere ideologiche.
A mettere in difficoltà il processo di controllo ideologico possono essere sia le condizioni oggettive dello sfruttamento, che si radicalizzano per il degenerare di precisi rapporti interni al capitale, sia le realizzazioni concrete a livello rivoluzionario, cioè quelle forme di autorganizzazione che il movimento – anche confusamente – riesce a darsi.
Spostare il proprio impegno solo al livello fittizio dell’ideologia, investirsi del compito di tutori del patrimonio ortodosso della rivoluzione, significa, spesso, smarrire il concreto terreno delle lotte, il solo su cui ogni considerazione teorica è valida, in quanto non si differenzia più dalla sua realizzazione pratica.
In qualsiasi modo si considerino le cose, il ragioniere, nel chiuso della perfezione aritmetica del suo fortilizio logico, si sente sicuro di lavorare per la rivoluzione. Quando questa sicurezza gli viene meno, al suo posto è costretto a sostituire la sicurezza del partito. Immiserito di ogni umanità, di ogni ricchezza di sentimenti, di ogni gioia, la sua stessa miseria lo sospinge nel ghetto dell’oggettivamente valido, dell’onnipresente simulacro che lo fa vivere al di là del proprio annichilimento come persona. Il ragioniere della rivoluzione assiste alla vicenda dei problemi che gravano su di lui. Il rivoluzionario sconvolge l’assetto delle cose proprio ponendosi dei problemi. Il primo subisce la realtà, il secondo agisce per trasformarla.
Ogni parziale considerazione della realtà corrisponde sempre ad un irrigidimento ideologico, in quanto nessuno si limita nel proprio impegno analitico per semplice mancanza di mezzi intellettivi. Gli strumenti della comprensione sono ormai altamente raffinati e disponibili praticamente per tutti. Il chiudersi è quindi una scelta ideologica, la quale corrisponde ad un abbassamento del livello dello scontro di classe. Da un altro punto di vista, ogni turbamento nell’apparente coerenza del meccanismo ideologico si può tradurre in un innalzamento dello scontro stesso.
Tutte le chiacchiere che sono state fatte in questi ultimi anni sulla non legittimità dell’uso della violenza rivoluzionaria, sono state funzionali al potere che le ha adattate, di volta in volta, sia nell’aspetto democratico della discussione assembleare (vedi Convegno di Bologna del 1977), sia nell’aspetto della repressione più netta (lager statali, intimidazioni poliziesche, tribunali e leggi speciali, migliaia di arresti, condanne e torture).
Non è la discussione sulla violenza che innalza il livello dello scontro, non è il dibattito su quale tipo di violenza si può accettare e quale si deve rifiutare, che conduce gli sfruttati verso la liberazione. Nessuno potrà, su questo argomento, insegnare qualcosa a coloro che subiscono ogni sorta di repressione da secoli. Cadendo il sipario ideologico, resta la scena della cruda realtà, quella dello scontro di classe, che vede da una parte gli sfruttati e dall’altra i servi degli sfruttatori a far da codazzo ai loro padroni.
Quando abbiamo parlato della necessità della violenza non l’abbiamo fatto per convincere gli sfruttati. Questi lo sanno benissimo da soli, e la mettono in atto ogni volta quando ne hanno l’occasione, con tutti i mezzi possibili. L’abbiamo fatto per contribuire a indicare con maggiore chiarezza il nemico di classe, nemico che molte volte si nasconde sotto le spoglie del fratello e del compagno. E il discorso sulla violenza è un elemento di grande importanza – venuti i nodi al pettine – per constatare da quale parte stanno tutti coloro che prima, al momento delle parole, erano tanto bravi a spaccare il capello in quattro, stabilendo quale violenza era giusta e quale era sbagliata, pretendendo imporre agli sfruttati i modelli di una violenza “giusta” da loro considerata tale in base a giudizi ideologici.
Alzandosi il livello dello scontro tutti i discorsi diventano, nello stesso tempo, inutili e determinanti. Sono inutili perché lo scontro reale li rende superati e stupidi; sono determinanti perché fanno cadere le ultime illusioni, rendono palesi le imbecillità, denunciano i tentativi di sfacciato recupero. Abbassandosi il livello dello scontro i discorsi ridiventano pesanti e pericolosi. Pesanti perché contribuiscono a gettare le fondamenta della prossima ripresa rivoluzionaria, pericolosi perché consentono agli imbecilli e ai recuperatori di ritrovare credibilità.
Parole chiare
In quanto anarchici siamo per la rivoluzione sociale, cioè per l’abbattimento immediato e definitivo dello Stato. Siamo quindi per la logica rivoluzionaria che, prima di ogni altra cosa, è logica distruttiva.
Siamo per la distruzione dello Stato, ciò significa che siamo per la distruzione fisica (non verbale) di quelle istituzioni e di quelle persone che lo Stato rappresentano e realizzano. Siamo contro i poliziotti, contro i magistrati, contro i burocrati, contro i sindacalisti, contro i padroni, contro i mafiosi. Non siamo soltanto contro il controllo poliziesco, contro la giustizia borghese, contro la tecnoburocrazia, contro il sindacalismo, contro il capitalismo, siamo, proprio in forma concreta, contro quelle persone e quelle cose che, nella realtà di tutti i giorni, realizzano le strutture, facendole diventare strumenti di repressione. E questo nostro “essere contro” deve tradursi in atti precisi, in atti di attacco, non solo parole, ma azioni. Se siamo contro i poliziotti, non dobbiamo lasciarci attirare nella trappola ideologica di coloro che in nome di un malinteso pluralismo, in nome di un illuminismo retrogrado intendono dare spazio e agibilità al nemico, affermando che tutti hanno diritto di esprimersi, quindi anche i poliziotti i quali, esprimendosi, lo fanno a colpi di manganello. Se siamo contro i magistrati, contro i burocrati, contro i padroni, contro i sindacalisti servi dei padroni, contro i mafiosi, non dobbiamo aspettare che qualcuno ci dica: questo padrone qui si è macchiato di una particolare colpa, questo sindacalista qui è colpevole di tale cosa, questo magistrato qui è particolarmente reazionario. No! Tutti, senza distinzione, senza mezzi termini, senza differenziazioni ideologiche, tutti i poliziotti, tutti i magistrati, tutti i burocrati, tutti i sindacalisti, tutti i padroni e tutti gli altri loro servitori, sono colpevoli e vanno attaccati con ogni mezzo, in ogni momento, a qualsiasi costo.
Il fondamento morale si trova nel fatto stesso dello sfruttamento. Chi subisce da secoli la pressione mostruosa del lavoro, chi ha costruito il mondo pur sapendo che non potrà mai vivere una vita decente, non ha bisogno di aspettare un segno di particolare cattiveria dall’altra parte. In qualsiasi momento è autorizzato ad attaccare, a colpire, a uccidere, come in qualsiasi momento i padroni e i loro servi, attaccano, colpiscono, uccidono.
Il problema della strategia
Che si possa discutere sui modi e sulle forme migliori di condurre questo attacco è un problema che esula dal fondamento morale.
Ogni discussione del genere diventa, quindi, un problema di strategia, di valutazione di mezzi, di raggiungimento di scopi. Non può mai essere impostata sul metro del giudizio ideologico. Cioè non può dirsi, ad esempio: “gli anarchici non fanno certe cose, perché...”. Questo discorso è privo di senso. Quello che gli anarchici fanno in quanto tali deve valutarsi nella realtà, non nell’astrattezza della teoria, in quanto diversamente l’anarchismo si trasforma da negazione di ogni mistificazione ideologica, in ideologia mistificante al pari delle altre.
Certo, le scelte strategiche non sono separate dall’analisi di fondo che, in quanto analisi anarchica, una volta legata alla realtà diventa elemento indispensabile dell’intervento rivoluzionario stesso. Ma, nel caso in cui questa analisi si staccasse dalla realtà delle lotte e venisse prodotta da qualche mente illuminata, meglio dotata delle altre, e trasformata in catechismo per militanti, entrerebbe subito nel parco delle ideologie e risulterebbe funzionale a quel potere che pretende attaccare.
In questo modo tutte le volte che sono state avanzate critiche al preteso ruolo rivoluzionario del partito militare armato, quando queste critiche avevano fondatezza e validità e non erano banali preclusioni ideologiche, si è sempre cominciato da un’analisi anarchica che teneva conto delle condizioni reali del conflitto di classe. Non c’è dubbio però che non basta essere anarchici per dire cose giuste riguardo una lotta in corso di svolgimento. Occorre essere inseriti all’interno di una prospettiva concreta, occorre essere disponibili per lo scontro rivoluzionario, occorre aver valutato bene cosa significa tutto ciò, sia a livello personale, per ognuno di noi, sia a livello globale, per tutto il movimento rivoluzionario.
Quando, ad esempio, ospitavamo sulla rivista “Anarchismo” i documenti delle organizzazioni di lotta armata agenti in Italia, abbiamo sempre evitato di soffocare i documenti stessi sotto pesanti cappelletti ideologici diretti a prendere le distanze dalle varie tesi autoritarie che più o meno (cioè con diverse sfumature) quasi tutti quei documenti contenevano. Abbiamo invece tracciato spesso le linee essenziali di una critica delle posizioni del partito militare chiuso, critica che si inseriva in quella più ampia diretta a considerare la visione teorica realizzata dal marxismo. Allo stesso modo non abbiamo, di volta in volta, quando questi compagni venivano attaccati dal potere, quando venivano perseguitati e schiacciati, quando venivano ingiuriati da altri compagni di cervello corto, non abbiamo mai usato la bilancia del farmacista. Non abbiamo, cioè, preteso, di volta in volta, di misurare le distanze che ci separavano da loro. Ciò perché queste distanze, indubbiamente presenti e significative, avrebbero potuto essere indicate solo sulla carta e risultare, quindi, banale questione ideologica. Tutto ciò ha spinto diversi compagni anarchici a valutazioni errate nei nostri confronti, alimentando una falsa polemica che non avrebbe avuto ragione di esistere se questi compagni, anziché perdersi dietro questioni di lana caprina, avessero ritenuto più urgente impegnarsi in prima persona nella realizzazione di quelle differenze che pretendevano individuare soltanto a livello ideologico.
I motivi per cui abbiamo dato spazio ai documenti del partito armato in questi ultimi anni sono da ricercarsi nel fatto che ritenevamo utile tutelare quegli spunti di azione rivoluzionaria, per quanto contraddittori e pericolosi potessero essere, e ciò perché era importante la strada intrapresa, strada che poteva svilupparsi in un’altra direzione, quella della lotta armata di massa, quella del comportamento armato generalizzato, sviluppo che avrebbe negato ed eliminato, automaticamente, le condizioni stesse della lotta clandestina fondata sul partito militare chiuso.
Schierarsi, fin dall’inizio, contro questi compagni, come hanno fatto tanti supersapientoni, sarebbe stato un contributo alla repressione statale nei loro confronti e avrebbe impedito, subito, una possibile evoluzione della lotta in senso libertario. Attenzione. Non uno sviluppo in senso libertario dei partiti militari chiusi, ma uno sviluppo della lotta armata in generale, e quindi di tutti quei compagni che si impegnavano in questa direzione, sviluppo indispensabile, tenendo conto delle disillusioni (puntualmente verificatesi) a cui la strategia del partito militare doveva condurre.
Le disillusioni, recenti e meno recenti, stanno spingendo un gran numero di sfruttati a chiudersi in se stessi. Le esperienze embrionali di comportamento illegale generalizzato sembrano dimenticate. Ma possono sempre riprendere. Il nostro compito è quindi quello di rintuzzare le critiche stupide e malevoli per impedire il realizzarsi di una tattica repressiva globale auspicata dal potere, e inoltre, in quanto anarchici, è quello di contribuire a chiarire attraverso quali metodi è possibile riavviare un processo di generalizzazione dello scontro armato, evitando per il futuro di fare ricorso a modelli strategici e politici che la pratica di questi ultimi anni ha dichiarato superati.
L’insurrezione
È nella prospettiva della lotta armata generalizzata di massa che l’insurrezione assume un senso libertario, segnando, nello stesso tempo, la critica definitiva di ogni tentativo “chiuso” di organizzare la gestione dello scontro di classe.
Ma questo progetto di massima non vivrebbe mai, oltre che nelle illusioni dei sognatori, se non si riuscisse a realizzare una serie di tentativi di dimensioni più ristrette ma altamente significativi per lo sviluppo della lotta.
Molti compagni hanno avanzato dubbi riguardo le possibilità insurrezionali oggi, in paesi a capitalismo avanzato. Altri hanno sottolineato i limiti di tentativi parziali del genere, oltre che le conseguenze negative e drammatiche per tutto il movimento rivoluzionario.
Personalmente la penso in modo contrario.
Lo scontro armato generalizzato è lo sbocco naturale dello scontro di classe. Gli sfruttati possono avvertire questa necessità con maggiore o minore chiarezza, facendola propria con una serie di comportamenti antistituzionali più o meno chiari, ma ciò non toglie che la strada sia quella giusta. Anche quando l’obiettivo sembra più lontano, il mezzo non può rivelarsi sbagliato.
In quanto rivoluzionari sappiamo molto bene che allo stato attuale delle cose si rende necessario sia lo strumento della lotta minoritaria e clandestina, beninteso fondata sulla strategia anarchica, che la lotta minoritaria di tipo insurrezionale, quanto più ampia possibile. Queste forme di lotta producono effetti positivi ed elevano il livello dello scontro, ma possono anche presentare aspetti negativi, involuzioni autoritarie. Nessuno di noi chiude gli occhi davanti a questo problema. Il nostro lavoro è proprio quello di agire, evitando, per quanto possibile, gli errori connessi all’azione.
Quando abbiamo parlato di insurrezione, in passato, molti compagni sono andati subito, col pensiero, agli esempi storici: alla banda del Matese, alla cospirazione di Pontelungo, e altri fatti del genere. Da ciò l’accusa di “romanticismo rivoluzionario”, di “essere fuori della realtà”, di essere “oggettivamente pericolosi”. Queste accuse sono assurde. L’insurrezione è il tentativo che viene posto in atto in vista della rivoluzione. Come anarchici l’insurrezione resta il nostro elemento privilegiato. Essa deve essere generalizzata a livello di comportamento illegale quanto più ampio possibile, ma anche quando ciò non si può realizzare, in una dimensione più ristretta, resta sempre lo strumento di lotta fondamentale su cui basarsi.
Per un nuovo concetto di radicalizzazione delle lotte
Fino a poco tempo fa [1976] appariva corretto parlare di radicalizzazione delle lotte in modo oggettivo. Lo scontro di classe appariva sufficientemente chiaro. Da un lato i padroni, i loro servi, i loro sicofanti e, purtroppo, quella parte di sfruttati che aveva accettato il ruolo imposto dal capitalismo avanzato, cioè dal consumismo, ruolo che, con maggiore o minore approssimazione, avevamo definito “ceto intermedio”. Dall’altro i veri sfruttati, gli schiavi legati alla catena, i tagliati fuori dalla salarizzazione, i diseredati in assoluto, i carcerati, i pazzi, le donne, ecc.
Notevoli processi di ristrutturazione hanno modificato l’aspetto superficiale del fenomeno, facendo parlare di recupero in senso definitivo e totale. In sostanza, il dilagare del consenso nasconde un più profondo e sotterraneo aspetto di dissenso che però non è percepibile attraverso i tradizionali elementi analitici.
L’acutizzarsi dello scontro si misurava ieri dalla sempre maggiore difficoltà di indurre al consenso la fascia che coagulava, in sé, una grossa potenzialità rivoluzionaria, con tutte le contraddizioni derivanti da un individualismo di origine borghese non eliminabile a questo grado dello sviluppo sociale. Questa fascia poteva essere inglobata solo attraverso una grossa spinta in avanti del tasso di profitto capitalista, cosa che avrebbe determinato miglioramenti oggettivi nella detenzione (carceraria e psichiatrica), nel ruolo delle donne e nel ripristino di una tagliata salarizzazione.
Ciò non è avvenuto. Il recupero si è realizzato attraverso una ulteriore ghettizzazione delle donne, attraverso un aumento della repressione utilizzando l’alibi terroristico, attraverso un sempre più massiccio ricorso alla riduzione della produttività. Ma fin quando questo sistema di recupero potrà durare? È esso un vero e proprio recupero?
Capovolgendo il ragionamento, il capitalismo si trova davanti a persistenti riduzioni del tasso di profitto. Potrà continuare la sua gestione ricorrendo ancora al consenso, ma dovrà continuare con i suoi tagli nel corpo proletario. Sempre maggiori fette del tessuto sociale andranno verso l’aleatorietà dell’improbabile salarizzazione. Ciò ci porta inevitabilmente verso una nuova forma di radicalizzazione dello scontro di classe. Solo un ritorno a tassi di profitto ragguardevoli potrebbe alleviare lo scontro, riportando la parte tagliata all’interno della fascia di salarizzazione e ricoprendo con riforme gli “emarginati estremi”, i carcerati, i pazzi, le donne, e così via.
Ciò permane impossibile. Nemmeno l’intervento terapeutico del Partito Comunista potrebbe fare qualcosa, ed i primi a saperlo sono proprio i comunisti. Certo, il PCI ha subito le trasformazioni che l’avvento della struttura tecnocratica del potere richiedeva, adesso è un partito di tecnocrati capace di far fronte a problemi di ristrutturazione dello sfruttamento, ma non può risolvere il problema di fondo, cioè cosa fare per quella parte di uomini condannati al macello.
In queste mutate condizioni torna sempre il problema dei “compiti” del movimento anarchico e quindi, per un altro verso, il problema corrispettivo di che cosa si debba intendere per movimento anarchico. Più avanti, in questo stesso libro, approfondiremo a lungo il problema, per adesso ci basta notare come le idee in merito siano il più delle volte confuse e superficiali. Alcuni sostengono (prescindendo da sigle ed altre facezie del genere), che il movimento sia qualcosa di individuabile in modo preciso e in senso quantitativo, altri, al contrario, che il movimento anarchico, oltre a essere traducibile in forza politica è qualche cosa di più, a un livello qualitativo. Non si tratta di questione oziosa.
L’illusione quantitativa è presente all’interno del movimento e deforma, secondo me, l’ottica interpretativa della realtà sociale, deformazione tanto più grave quanto più questa realtà risulta in via di radicalizzazione. Un movimento anarchico numericamente forte (in uomini e gruppi, in mezzi e strumenti d’espressione), non corrisponde necessariamente a un movimento anarchico capace di incidere in senso libertario nell’indirizzo che la radicalizzazione delle lotte prende a seguito di una serie di fatti che spesso non possono essere tutti sottoposti a riscontro analitico. E questo ci pare un elemento di riflessione da non trascurare.
Ma, dall’altro lato, se intendiamo la presenza qualitativa come il frastuono insensato di un pugno di intellettuali che elaborano le loro tesi, spesso anche interessanti e originali, non abbiamo fatto altro che cadere da un guaio grosso in uno ancora più grosso.
Il movimento anarchico ha un compito ben preciso, produrre all’interno degli sfruttati quelle condizioni necessarie che rendono, via via sempre più probabile, l’indirizzo sociale e libertario della futura rivoluzione. Quando la radicalizzazione dello scontro di classe diventa meno visibile, come è appunto nel momento che attraversiamo, le condizioni di sofferenza in cui il movimento si trova possono sembrare meno gravi e ci si può illudere per una sua improbabile crescita futura, in mutate condizioni d’ambiente. Ma, in effetti, la reale radicalizzazione dello scontro, anche se nascosta, deve corrispondere con una crescita immediata e oggettiva del movimento, nel caso in cui questo non avviene, qualcosa non funziona e non è più lecito attendere miracoli. Occorre ricominciare daccapo.
L’autodisciplina
È uno dei grandi problemi della rivoluzione. L’anarchico se lo pone in modo lacerante. La contraddizione si scatena tra la dirompente passione rivoluzionaria, che travolge tutti i limiti, i confini, gli ostacoli, le norme, i valori, e l’oggettività proveniente dal livello dello scontro, con le sue specificità, le sue connotazioni di tempo e di spazio sociale, le sue interrelazioni.
Se mi affidassi esclusivamente alla mia soggettività, lasciandola liberamente scorrere come flusso coerentemente estraibile dalla mia vita globale, costituirei senz’altro uno straordinario avvenimento di liberazione, ma sarei sterile e isolato esempio di quello che si può essere quando si posseggono alte qualità di coerenza e di forza. Ma questo ideale di vita e di comportamento anarchico si trova raramente nella realtà. Molto spesso si hanno tentativi di approssimazione in cui l’esaltazione della soggettività è, via via che si affrontano i problemi minuti della quotidianità e si accumulano i compromessi, sostituita dall’egoismo e ottenebrata dalla paura. L’individuo che orgogliosamente poteva aver deciso di non tener conto della polarizzazione delle contraddizioni, disvelando in un punto focale la propria supremazia su tutto e su tutti, scade miseramente in una progressiva accettazione di quanto di contraddittorio c’è nella realtà, senza che ciò lo possa portare all’accettazione dei termini effettivi delle contraddizioni. Il dio che aveva sognato la gloria del gesto unico e irripetibile, si nasconde nell’ombra tiepida e nauseabonda della bottega.
Occorre quindi che veda con esattezza il mio scopo, che non mi illuda sulle mie forze, che consideri ambedue i poli della contraddizione. Lo scopo non mi viene imposto dal livello dello scontro, ciò accadrebbe solo se mi pervenisse filtrato attraverso una struttura costituita per immagazzinarlo, memorizzarlo, una struttura che di regola si chiama partito. Ma io sono anarchico, quindi questo scopo lo costruisco da me. Non al di sopra di quello che il livello dello scontro mi suggerisce. Nessuno può salire sulle proprie spalle, almeno nei fatti e nella concretezza rivoluzionaria. Nel caso pretendessi imporre un livello diverso, spacciandolo per scopo, verrei ad essere penalizzato. Nella mia azione cerco pertanto il livello dello scontro, e questo mi viene incontro indicandomi una realtà. Spetta a me autodisciplinarmi a quella realtà. L’indicazione è l’oggettività, la mia autodisciplina è la soggettività, insieme costituiscono una contraddizione polarizzata, l’inizio illogico del processo rivoluzionario.
La rivolta
Chiariamolo una buona volta per tutte, senza mezzi termini e senza condizioni, gli anarchici sono per la rivoluzione sociale. Tutti, senza eccezione, rifiutano la logica riformista, il patteggiamento col padrone, il compromesso con i partiti e con i partitini. Su questo punto, fra gli anarchici, non ci sono discriminanti, non ci sono sfumature, non ci sono malcomprensioni.
E diciamolo anche con chiarezza, gli anarchici sono per la rivolta. Non soltanto verbale ma concreta. Non si contentano di criticare questo e quello, ma sono pronti a lottare contro tutti coloro che intendono garantire la persistenza dello sfruttamento, sotto qualsiasi forma e nome.
Quindi gli anarchici sono ribelli. Si ribellano contro lo Stato, contro il Governo, contro la magistratura, contro l’esercito, contro la polizia, contro i padroni, contro i partiti, contro i sindacati. Sono alleati e compartecipi soltanto della sorte degli sfruttati.
Ma gli anarchici non sono belve scatenate che come vedono un padrone lo azzannano e lo fanno a brani, o come vedono un carabiniere prendono di mira la fiamma che porta sul berretto. No. Gli anarchici sono persone ragionevoli. Ritengono giusto ammazzare il padrone e il poliziotto, ma sono dell’opinione che questo vada fatto in modo produttivo ed efficace, organizzato e significativo dal punto di vista del raggiungimento dello scopo della rivoluzione sociale.
Che senso avrebbe, infatti, andare in giro ad ammazzare poliziotti a ogni angolo di strada, a squartare padroni davanti a ogni piccola fabbrica, a impiccare funzionari davanti a ogni ministero? Oddio, il senso l’avrebbe, in quanto sarebbero sempre poliziotti, padroni e funzionari di meno, ma ve lo immaginate voi tutto questo spettacolo di sangue e di violenza, col risultato di avvalorare, poi, la tesi padronale che gli anarchici sono mostri sanguinari con la bava alla bocca?
Per altro gli interessi degli anarchici sono vastissimi. Sanno leggere, scrivere e far di conto. Editano libri e giornali e, spesso, sono anche uomini di cultura.
Ora, come si sa, altro è il dire e altro è il fare. E gli uomini di cultura amano molto dire e poco fare. Quando sono sicuri dell’incolumità si lasciano andare a lunghe tirate sulla violenza (astratta), come quando cantano in coro le vecchie canzoni anarchiche piene di bombe, di dinamite, di coltellate ed altre amenità. Ma poi, rientrando nella realtà, riprendono le giuste misure e stabiliscono la differenza tra le vecchie canzoni e il compito di ogni giorno.
Tutto ciò è segno di grande assennatezza. La lotta sociale non è un vano dibattersi. Occorre serietà e organizzazione. Quindi bisogna dedicarsi a studiare e approfondire la situazione, onde dare vita alla migliore delle organizzazioni possibili, quella più idonea a raggiungere gli scopi della liberazione definitiva.
Chi potrebbe trovare qualcosa da ridire? Quando qualcuno si azzarda a sollecitare l’azione, ora e subito, è immediatamente messo a tacere, e quando non vuole stare zitto lo si fa tacere dicendo che la sua è un’azione “oggettivamente provocatoria”.
Ma poi sono sorti i dubbi. Che questa grande assennatezza finisca per nascondere una volontà di non fare nulla? Che la ricerca testarda e bizantina della migliore organizzazione, sia un modo accorto di organizzarsi per non fare nulla?
Un poco meno teoria e più fatti.
La rivolta attiene all’individuo e alle organizzazioni. Non è la rivoluzione, ma la rende possibile. Senza la rivolta continua degli individui coscienti, sarà possibile solo la rivoluzione traditrice dei nuovi padroni che strumentalizzano le parole d’ordine della lotta di classe. E la rivolta è coscienza di se stessi, del proprio impegno, dei sacrifici che si devono poter fare, delle proprie speranze, delle gioie a cui si può accedere, dei miglioramenti e dei possibili pericoli. La rivolta caratterizza la vita di ognuno di noi. Nei momenti di grande tensione sociale, quando esplodono le contraddizioni della struttura del capitale, emergono le conseguenze dei piccoli compromessi e delle piccole debolezze che avevamo finito per accettare come fatti normali, nel precedente periodo di stasi. L’opportunismo che scava la sua strada fra le nostre fila, l’opportunismo che trova parole astute per nascondersi, per giustificarsi, per contrabbandare se stesso come una raffinata tattica rivoluzionaria.
Cominciamo a chiarire ciò all’interno di noi stessi, nei rapporti con i compagni che ci sono più vicini, nei rapporti con le organizzazioni a cui apparteniamo.
Non è poi tanto difficile. Il nemico ci fronteggia con tale durezza che è semplice individuarlo. E se lo individuiamo lo dobbiamo colpire. E se lo colpiamo dobbiamo essere pronti a pagare le conseguenze dei nostri atti. Noi e le nostre organizzazioni. Questi gli impegni che ci attendono.
I nostri discorsi devono essere paralleli alle nostre azioni. Che gli altri apprendano a considerarci per quello che facciamo e non per quello che rappresentiamo come tradizione o altre amenità. Il potere deve avere paura degli anarchici non perché eredi di Ravachol e di Henry, di Durruti e di Mackno, ma perché capaci di dar vita ad organizzazioni di attacco e non soltanto a gruppi di studiosi sociali che producono brillanti analisi sui problemi del giorno.
Ancora oggi le nostre possibilità, sul fronte dello scontro rivoluzionario, sono intatte. Non abbiamo fatto errori grossi, nel recente passato, tali da metterci in cattiva luce. Non li abbiamo fatto anche perché quello che abbiamo realizzato era troppo poco per contenere errori significativi, comunque non li abbiamo fatto. Per un altro verso la più profonda disillusione attraversa il campo autoritario. I marxisti-leninisti sono tutti in balia di se stessi. La critica all’ipotesi rivoluzionaria fondata sulle pretese autoritarie dilaga e sconfina nella disillusione e nell’abbandono. Possiamo rappresentare negli anni futuri un punto di riferimento, un punto di coagulo sia per gli sfruttati, sia per molti militanti rivoluzionari che provengono da organizzazioni autoritarie ed hanno vissuto il grave trauma degli errori compiuti. Solo che il confronto deve avvenire, questa volta, partendo dalle nostre capacità di nuove realizzazioni concrete. Non dimostriamo la solita paura che ci fa chiudere perché, tanto, con gli autoritari, con i marxisti c’è ben poco da fare. In questi ultimi anni si è andata diffondendo una forte coscienza antiautoritaria in molti gruppi di compagni, oltre che in alcuni strati di sfruttati particolarmente sottoposti ai processi di criminalizzazione. Evitiamo di contribuire proprio noi a spegnere questa coscienza.
Impostiamo correttamente ogni possibile rapporto. Noi siamo anarchici e, come tali, siamo per l’azione antiautoritaria. Non crediamo nei partiti e nelle strutture centralizzate, ma crediamo nella necessità di attaccare subito il potere, a tutti i livelli e con tutti i mezzi. Su questo argomento possiamo misurarci.
[Per i primi cinque paragrafi del presente capitolo, cfr. “Verso la generalizzazione dello scontro armato”, in “Anarchismo” n. 18, novembre-dicembre 1977, pp. 322-327. Per il paragrafo Per un nuovo concetto di radicalizzazione delle lotte, cfr. “Radicalizzazione delle lotte”, in “Umanità Nova” n. 32, dell’11 settembre 1976, p. 5. Per il paragrafo La rivolta, cfr. (Collettivo redazionale), “Gli impegni che ci attendono”, in “Anarchismo” nn. 16-17, luglio-ottobre 1977, pp. 193-195].
Movimento e violenza rivoluzionaria
La svolta del ‘77
Con tutti i loro limiti, gli avvenimenti del 1977 hanno segnato una svolta nella lotta antistituzionale in Italia, sia per il sorgere di nuove forme di attacco, sia per il diffondersi delle prime perplessità nei confronti dei modelli di scontro che ormai stavano dimostrandosi superati.
Il ricorso allo scontro frontale, pure restando all’interno di un discorso minoritario, presentava la possibilità di uscire dal ghetto dell’ortodossia clandestina e, se ben programmato, avrebbe potuto portare a quei risultati di generalizzazione che tutti i rivoluzionari auspicavano.
Le cose non sono andate così anche perché non si sono avute le idee chiare, pretendendo di affidare tutto all’improvvisazione e allo spontaneismo. Per uno strano ibrido, forse mai visto prima, la rigidità ideologica dello schema leninista si sposava con l’individualismo più sfrenato, producendo un incredibile guazzabuglio e quindi impedendo lo sviluppo di risultati positivi.
Esamineremo qui alcuni problemi legati a questo fenomeno, sotto certi aspetti grandioso e tragicamente sprecato anche a causa dell’ottusità di molti compagni. Quando si era in tanti e, nelle strade, si attaccava e non ci si limitava a subire il cordone di vigilanza delle autorità costituite, allora ci si illuse che il processo sarebbe stato a noi favorevole in modo decisivo, che ormai era irreversibilmente avviato verso la vittoria.
Un’illusione più che legittima per chi andava a manifestare la sua rabbia. Meno legittima per tanti compagni che avrebbero dovuto meglio valutare le proprie posizioni. Al contrario, di fronte all’entusiasmo dei molti si ebbero due posizioni precise da parte dei pochi, la posizione centralista, che avrebbe dovuto guidare all’esterno le forze del movimento, verso gli obiettivi della conquista del potere, e la posizione ipercritica, che vedeva in tutto quello che si andava facendo un errore di avventatezza, un’errata accelerazione di presunti processi evolutivi del fatto rivoluzionario. Ambedue queste due posizioni erravano, sia pure per motivi diversi. Ad avere ragione era, evidentemente, l’entusiasmo di chi affrontava lo scontro. Solo che non sempre chi ha ragione riesce ad avere la meglio. Accanto all’entusiasmo occorrono pure i programmi dettagliati (dentro certi limiti) e la chiarezza delle idee.
Il campo dello scontro
Le diverse anime del nuovo movimento rivoluzionario, sviluppate nel 1977, tutte produttrici di forti contraddizioni e spunti stimolanti, si riflettevano nel livello dello scontro tra le forze del capitale e le forze di liberazione. Non si può affermare che gli anarchici abbiano saputo cogliere subito la necessità di collocarsi all’interno di questo movimento, senza storcere il naso davanti alle contraddizioni.
Occorreva una coscienza della propria situazione contraddittoria, senza che questo significasse un abbandono dell’identità antiautoritaria che da sempre ha caratterizzato il nostro movimento. Occorreva gettare nella bilancia la nostra effettiva presenza nelle lotte degli sfruttati e non solo le sigle e le tradizioni, i simboli e le bandiere. Occorreva nei quartieri, nelle scuole, nelle università, all’interno delle roccaforti culturali gestite dai sapientoni del PCI, nelle fabbriche, nelle campagne, nelle miniere, dappertutto dove i lavoratori cadono a decine e a centinaia, sul fronte della guerra civile che il capitale ha dichiarato nella speranza di sopravvivere e di continuare lo sfruttamento, occorreva, anche all’ombra della clandestinità, fare balenare davanti agli occhi attoniti degli sbirri, dei magistrati, dei deputati, dei giornalisti e di ogni altro servitorame, il lampo della dinamite, il breve sparo della pistola, la raffica del mitra e il bagliore del coltello.
Ciò è stato fatto, ma con metodi e scopi che, il più delle volte, non ci trovavano d’accordo. Il campo dello scontro di classe è molto esteso e, nelle sue parti più avanzate, sviluppa processi di autorganizzazione su cui noi dovevamo contare di più. È là che dovevamo insistere, con un minimo di progetto e di idee.
Per contro abbiamo dovuto tacitare mille vocette stridule che risuonavano da ogni parte. Dubbi e perplessità nei confronti della violenza rivoluzionaria. Vecchi discorsi che, in quei mesi, andavano forse messi da parte. Non era però possibile considerarli come non esistenti. Facevano molto danno, gettando il dubbio e l’incertezza in tutti quei compagni che agivano perché ritenevano giusto farlo.
L’azione diretta, l’attacco contro il nemico di classe è una ineluttabilità della storia. Non l’abbiamo deciso noi, non l’abbiamo mai considerato una bella cosa. Altre sono le bellezze della natura e dell’uomo, la fratellanza, la pace, l’amore. Cose possibili, belle a sognarsi, ma che non possono più essere tenute presenti quando il nemico attacca. In caso contrario si fa il suo gioco, si cade nel suo tranello, non si capisce il progetto strategico del capitale che è quello dell’annientamento totale di ogni dissenso, di ogni rivolta, di ogni aspirazione alla libertà.
La lotta che conduciamo, in questa guerra civile, con alti e bassi, con momenti di sviluppo e momenti di ristrutturazione repressiva, non può dividersi in settori. Non possiamo dividerla in una “lotta pulita”, quella che si fa davanti alle fabbriche, nei quartieri, nelle scuole, e una “lotta sporca”, quella che si fa nella clandestinità. Siamo tutti sotto il tiro del fucile del poliziotto, manovrato dalla mano del capitalista e del funzionario delle multinazionali.
Non si illudano i compagni. Il progetto reazionario che si sta concludendo in questi ultimi tempi non potrà ridarci spazi di agibilità che erano stati solo il prodotto delle nostre lotte. Alla guida della repressione si pone il PCI. Alcune delle sue armi le conosciamo, altre ci sono ignote. Il futuro attacco contro questa manovra che intende chiuderci definitivamente all’interno del ghetto, deve gettare adesso le sue basi. Nel momento in cui il progetto statale non è del tutto realizzato.
Molti compagni che hanno militato, più o meno direttamente, nei cosiddetti partiti militari combattenti e che sono annegati all’interno di una ideologia autoritaria, quella del partito chiuso, di tipo leninista, adesso devono rivedere le proprie posizioni. Questi compagni hanno sviluppato un modello chiuso di azione, operando una scelta strategica che, a nostro avviso, era perdente. Adesso, o dentro un breve periodo di tempo, devono decidersi. Il futuro delle lotte deve per forza passare attraverso il progetto anarchico della guerriglia e attraverso le metodologie insurrezionali.
La situazione del movimento anarchico
In momenti di particolare impegno nelle lotte è sempre sorto il problema di dare connotazioni critiche al movimento anarchico. In altri termini, di fronte allo scontro si è sentito di più il bisogno di capire cosa fosse veramente questo movimento, se una struttura organizzata fondata su sigle, congressi, pubblicazioni e altro, oppure anche una forma rivoluzionaria capace di agire. Queste riflessioni furono molto approfondite proprio nel 1977, davanti all’alzarsi del livello dello scontro.
In che modo il movimento anarchico si pose di fronte alle varie realtà emergenti che presero il nome di “nuovo movimento”? Quali erano, al sorgere del fenomeno, le forme di circolazione delle idee e le strutture esistenti? Come reagirono le federazioni? Ci furono fenomeni di dissenso? Gli stessi fatti vennero interpretati in modo diverso? Quali resistenze vennero esercitate nei confronti delle forze interne al movimento anarchico le quali cercavano di spingere all’esterno ogni tentativo di partecipare alle lotte?
Senza dubbio il movimento anarchico come struttura specifica venne a trovarsi in difficoltà davanti al sorgere delle nuove forme di lotta. Molti compagni si preoccuparono subito di un eventuale aumento della repressione, di possibili intimidazioni, non potere più stampare giornali, pressioni sui tipografi, controlli finanziari. Per un altro verso non esistevano vere strutture di difesa del movimento anarchico nel momento in cui la lotta si alzava e gli scontri si andavano generalizzando in tutto il Paese. In che modo i compagni anarchici scendevano in piazza? Con quali forme mentali e con quali strutture tecniche? Non si aveva neanche un minimo di efficienza, non da paragonarsi a quella – all’epoca, per altro, approssimativa – del potere, ma nemmeno simile a quella che le componenti autoritarie del movimento rivoluzionario possedevano.
Il comportamento che si andava generalizzando finiva per negare il concetto stesso di movimento in quanto struttura, la vera e reale “resistenza” a questo stimolo, giusto, se si vuole, ma pericoloso, doveva essere fondata sulla tutela di determinati strumenti di difesa e di attacco. Al contrario essa si sviluppò tutta su condanne di massima e ripetizione di luoghi comuni. Ad esempio, il movimento anarchico aveva un comitato di difesa, ma cosa significava? quali funzioni svolgeva? quali compagni vi facevano parte? in che modo lavorava? Esso rappresentava, sostanzialmente, uno strumento di repressione all’interno del movimento anarchico stesso. Verso l’esterno la sua attività era irrisoria. Quando in Sicilia ci trovammo ad affrontare questioni delicate nel fronteggiare la mafia, situazioni in cui si correva il rischio di rimetterci la pelle, alcuni elementi di questo comitato, da noi espressamente interpellati, ci risposero che non potevano in alcun modo difenderci o sostenerci.
Si può concludere che molte strutture del movimento anarchico non erano adeguate al livello dello scontro di classe così come si andava delineando a seguito delle azioni realizzate dal “nuovo movimento”.
Anche la stessa idea di “livello dello scontro” e delle relative modificazioni, era confusa e incerta. Si tenevano presenti fatti specifici, la manifestazione di un certo giorno, un certo affrontamento di piazza, ecc. Non si guardava alle modificazioni intervenute nelle interpretazioni, nelle reazioni infrastrutturali, psicologiche degli sfruttati. Il livello dello scontro era più alto non perché si verificavano certi fatti, una situazione di piazza, un carabiniere morto, ma perché si andava verificando un differente e particolare modo di considerare l’attacco e la risposta; una particolare disposizione di tutti noi, del cosiddetto proletariato giovanile e meno giovanile che si recava in piazza.
Con quale animo ci andavamo? Con quello del ’68, del ’72, o in modo ancora diverso? Che cosa ci andavamo a fare? E se questo animo era modificato, quali cose, invece, restavano immutate all’interno del movimento anarchico pur nella sua non omogeneità?
Certo il movimento anarchico non poteva scendere in piazza armato. Almeno non poteva farlo nelle condizioni di approssimazione e spontaneità che si andavano verificando. Inoltre non poteva farlo senza un’accurata preparazione, cosa che per tanti motivi era impossibile a realizzarsi. Invece poteva lavorare nel senso di facilitare le condizioni dello scontro, creando quelle strutture di supporto che avrebbero sviluppato il fenomeno. Occorreva quindi che il movimento anarchico avesse l’intelligenza di trovare strumenti idonei, mezzi adeguati per potersi difendere e quindi anche per potere attaccare. Non si trattava di andare sulle strade e mettersi a sparare, ma di generalizzare questi tentativi embrionali e parziali.
Invece il movimento anarchico dimostrò, fino in fondo, tutta la sua contraddizione interna, cercando di cogliere, in questa contraddizione, solo la parte che meglio poteva garantire la sua sopravvivenza. Le elefantiasi, le piante ornamentali, i catechismi, tutto partecipò e agì come freno. Solo una parte dei compagni, quelli impegnati in specificità territoriali, parteciparono alle lotte, mentre il movimento nel suo insieme appariva sempre più distante, talmente dissociato dalla realtà dello scontro da sembrare patetico.
Perché perdersi dietro una lunga e penosa discussione diretta a giustificare l’attacco armato contro le organizzazioni repressive? Questo è sempre giustificato a causa della situazione specifica che può essere quella del ’77 ma poteva anche essere quella precedente. Eppure anche prima, nel ’72, quando sostenemmo la necessità dell’attacco armato, ci si accusò di essere provocatori, ecc. Questa ambiguità il movimento anarchico l’ha sempre avuta, come quando condannava le azioni armate che si conducevano in Italia negli anni ’50, ma considerava eroiche le stesse azioni, nello stesso periodo, se venivano condotte in Spagna. Perché la Spagna era “terreno di caccia” autorizzato e, conseguentemente, là si poteva giustificare la lotta armata, ma non si poteva giustificarla nella “democratica” Italia.
Eppure una volta che si è d’accordo sull’esistenza della repressione, dato che è inutile discutere su vecchi e nuovi padroni, il problema resta sempre quello, la giustificazione morale esiste sempre, da quando esistono gli schiavi. Di conseguenza, l’attacco contro lo Stato è giustificato sia dal punto di vista morale che dal punto di vista strategico.
La giustificazione strategica proveniva dal livello dello scontro e dal suo innalzarsi, oltre che dall’aumento abbastanza visibile della sensibilità politica e rivoluzionaria di una parte della massa proletarizzata. In questi casi, andare troppo per il sottile è molto pericoloso, in modo particolare per gli anarchici.
Pericoloso non perché il movimento anarchico resta indietro riguardo il livello dello scontro, cosa questa che è connaturata all’essenza della struttura organizzata, ma è pericoloso perché gli anarchici non assolvono al loro compito storico tradizionale, indicare un allargamento delle lotte, un punto di riferimento più ampio, un obiettivo più significativo al di là del poliziotto.
In queste situazioni di lotta vi possono essere – e vi saranno anche stati – fenomeni di provocazione, poliziotti avranno sparato magari su altri poliziotti. Ma la provocazione può essere superata solo attraverso un’accettazione della logica dell’attacco, attraverso una strategia dello scontro contro lo Stato. Lasciandosi frenare dai pericoli, svolgendo il compito di censori e controllori, la provocazione – se c’è – dilaga a macchia d’olio, diventa incontrollabile, mentre altre strutture, altre organizzazioni, altre ideologie prendono la direzione delle lotte.
Il discorso armato era quindi giustificato, non solo moralmente, ma anche strategicamente e quindi anche militarmente. Ma andava fatto con chiarezza e, quel che è più importante, criticamente. Una critica chiara, giusta, completa e onesta non è mai stata fatta.
Molti compagni ci hanno rimesso la pelle, altri sono andati in galera per secoli. Ma tutto ciò non può farci chiudere gli occhi davanti alla necessità della critica. Anche se le parole non contano molto, devono essere oneste e chiare, proprio nei confronti dei compagni che hanno pagato di più. Una visione strategica di tipo stalinista è perdente in partenza contro uno Stato democratico che fonda il proprio potere sulla decentralizzazione delle funzioni.
La nostra visione dello scontro armato è molto differente ma non per questo è immediatamente attingibile come l’altra faccia della medaglia. Non è vero – come è stato affermato – che noi concepiamo la lotta armata come esattamente il contrario del progetto stalinista. In queste cose non c’è nulla di scontato, occorre approfondire continuamente il problema.
Le caratteristiche dell’attacco armato
Non è giusto affermare che la lotta armata è lo strumento principale dello scontro di classe. Ogni sacralizzazione di metodi e strategie è un fatto negativo. Non esiste una sola carta vincente, non si può demolire lo Stato con qualche colpo di pistola. Attraverso lo scontro clandestino e gli attacchi nelle piazze non si possono coalizzare le forze del lavoro, né tentare una ricomposizione del tessuto sociale produttivo.
Il fatto che la lotta armata sia strumento utilizzabile, anche oggi, in situazioni come quella italiana, non legittima il fatto di arrivare a concludere che è il solo strumento da impiegare. Questa affermazione non può partire (o ripartire) dalla decisione di una ristretta minoranza di intellettuali o pseudotali o di persone quanto meglio disposte dal punto di vista psicologico e sociale, che in separata sede, nel chiuso di una stanza, decidono di dare vita a un fenomeno del genere.
Tutto ciò non significa nulla. Ma spiega perché le componenti storiche che hanno sviluppato in Italia la lotta armata in questi ultimi anni erano tutte (o quasi) di matrice marxista. Perché negli anni ’70, quando queste componenti cominciarono ad agire, alla testa delle lotte operaie più avanzate c’erano i marxisti e gli anarchici erano una sparutissima minoranza. Chi fra quest’ultimi si azzardava a dire una minima parola favorevole alla violenza rivoluzionaria, veniva immediatamente escluso dalla possibilità di continuare il suo discorso, tacciato di provocatore. Altrove ciò non avveniva e quindi si coagularono, alla testa delle lotte operaie, formazioni marxiste. Nel defluire delle lotte, verso la fine del 1972, le avanguardie si trovarono tagliate fuori e si videro ridotte all’organizzazione della lotta armata specifica o, ancora peggio, all’organizzazione del partito militare. La prevalenza marxista, teorica e pratica, fu quindi anche frutto delle nostre deficienze teoriche e delle nostre incapacità pratiche di trovarci nelle lotte nel periodo in cui queste si svilupparono.
Si capiscono quindi i motivi che molti anni fa ci spingevano a sottolineare la necessità di “intervenire nella realtà delle lotte”, senza mettersi a discutere, a priori, sulla legittimità di questo o quello strumento da impiegare. Non volevamo sacralizzare il mitra – anche se nella foga polemica potrà essere stata detta qualche parola in più, o sottolineata una simbologia invece di un’altra – volevamo fornire chiarificazioni in merito alla necessità di uscire dall’indecisione. Una volta entrati nell’azione rivoluzionaria, la scelta degli strumenti diventa un fatto legato alla realtà e non una discussione astratta che rischia di non finire più e che molte volte serve da alibi. Nelle lotte ha importanza relativa se l’intervento assume un aspetto caratterizzato in senso anarcosindacalista, autonomo, o se riguarda il territorio, la fabbrica, la scuola, ecc. Di volta in volta sarà necessario scegliere gli strumenti adatti a continuare la lotta. Nel caso in cui questa scelta si orientasse verso strumenti non adatti, la lotta non darebbe risultati. Diventa quindi pensabile che la scelta della lotta armata risulti possibile attraverso decisioni inerenti allo scontro in corso e alla partecipazione allo scontro, senza pretendere discriminanti a priori. Cade così il vecchio discorso, che ha fatto tanto male al movimento anarchico, il quale si fondava sull’affermazione: “oggi non è il momento della lotta armata”. Su che cosa trovava fondamento? Su nulla. Oppure sulla volontà di qualcuno di tenersi da parte, di salvarsi dalle possibili conseguenze repressive. Ma sarebbe stato sufficiente che questo qualcuno avesse parlato chiaramente per evitare danni ed equivoci. L’affermazione legittima, cui si può pervenire attraverso l’analisi, è sempre relativa al livello dello scontro, mai ad una presunta legittimità assoluta di impiego di questo o quello strumento.
Va da sé che se alla testa delle lotte operaie precedenti al sorgere del fenomeno della lotta armata in Italia, ci fossero stati gli anarchici, le cose sarebbero andate in modo diverso. Cioè non basta dire che al posto dei marxisti ci saremmo stati noi, come se fosse possibile una semplice sostituzione di avanguardie marxiste con avanguardie anarchiche. Quest’ultimo concetto è un controsenso. È chiaro che i marxisti, trovandosi alla testa delle lotte, strumentalizzarono quella posizione trasformandosi, sempre di più, in avanguardia militare, ma si tratta di faccende che non ci riguardano. Si potrebbe anche dire che il germe del partito era anche prima del riflusso, e sarebbe affermazione giusta, ma comproverebbe ancora una volta il nostro torto, quello di non essere stati anche noi nel vivo delle lotte. Il movimento ebbe un riflusso, da questo derivò una decisione – assistita evidentemente dall’ideologia marxista – di rinchiudersi, di agire come partito militare. Da qui tutte le conseguenze. Le strutture concrete di lotta armata che si svilupparono furono quelle proprie dei marxisti-leninisti. Gli anarchici, al loro posto, avrebbero realizzato strutture non specialistiche, evitando la formazione del partito militare, fatto da tecnici, che vive soltanto attraverso l’autoriproduzione, l’autofinanziamento tramite la stessa lotta armata.
La lotta anarchica ha quasi l50 anni di esperienza ed è stata realizzata più volte, nella storia più o meno recente. Il militante agisce nella realtà del lavoro, poi prende il fucile per ritornare subito dopo nella sua realtà lavorativa, in caso contrario non riuscirebbe a sopravvivere e non riuscirebbe nemmeno a costituire quelle forme di intervento complessivo che colgono insieme gli elementi dello specifico (lotta armata minoritaria) e del sociale (campo del lavoro e della produttività). Ciò non toglie che questa forma di lotta può anche avere uno sviluppo più accentuato dalla parte della specificità. Si tratta di necessità del momento, di risposte difensive e offensive, di scelte strategiche, ma non di posizioni di principio. Ne consegue che l’eventuale crescita abnorme può sempre essere modificata e fatta rientrare in un equilibrio ideale tra specificità e socialità.
Le vecchie malattie del movimento anarchico
Un’organizzazione rivoluzionaria è di già un punto di arrivo, uno sforzo storico. Un gran numero di lotte e di sacrifici sono necessari per la sua costituzione. In certi momenti essa è la sola cosa a cui si può lavorare. In più essa è senz’altro una delle prime cose a cui bisogna pensare per dare vita alle lotte. A questo aspetto storicamente ricostruibile, visibile e rintracciabile, occorre aggiungere che in generale nulla è possibile fare senza un’organizzazione. Resta quindi importante e fondamentale il ruolo del movimento anarchico come tale e sarebbe illusorio un salto nel vuoto della visione individualista delle lotte.
Molte delle carenze del movimento non sono però riportabili alla struttura del movimento stesso, quanto al suo modo di essere, all’interpretazione che molti compagni danno del suo ruolo nella realtà delle lotte. La critica va condotta in direzione giusta. Le strutture del movimento sopravvivono spesso come realtà sociologiche, volute dallo sforzo di pochi compagni, prive di una effettiva incidenza nello scontro di classe. Servono a riprodurre opinioni, punti di vista, prese di posizione. Il loro scopo principale resta la crescita quantitativa con le relative illusioni.
E le strutture organizzative riproducono i leader che impongono determinate scelte. Si tratta di un fatto ineluttabile. Se c’è una struttura, questa automaticamente produce i leader. Sono persone meglio dotate intellettualmente, che hanno potuto studiare, che sanno parlare meglio, hanno più tempo e partecipano a tutte le riunioni. Sono quelli che in definitiva – bene o male – elaborano le varie tesi del movimento. È inutile affermare fideisticamente che queste cose non succedono fra gli anarchici. Si tratta di un fenomeno che ha conseguenze negative che vanno discusse e che non si eliminano affermando che gli anarchici sono immuni da questa malattia perché antiautoritari. Si tratta di una malattia perché la persistenza, lo stesso nascere di un impegno nella realtà, produce il leader. Attraverso la struttura questo leader si fortifica, perché nella struttura si orientano un insieme di tendenze che trovano origine dalla realtà ma che finiscono per essere distorte e rese più uniformi.
Quando si inizia un lavoro rivoluzionario lo si comincia insieme, con tutti i compagni disponibili. Poi, inevitabilmente, emerge la figura di un compagno che ha più tempo degli altri, una visione più chiara, migliori mezzi culturali. Prima o poi questo compagno finisce per acquisire una posizione che è giusto definire leaderistica. Per ovviare a questo inconveniente, il compagno che intende lavorare in modo libertario e che vede consolidarsi attorno a se stesso una posizione di privilegio di questo genere, è tenuto, deve avere la preoccupazione di costruire, contemporaneamente, le condizioni di distruzione della sua stessa posizione, all’interno della struttura e all’interno della realtà delle lotte. In caso contrario egli costruirà una zona di potere fittizio e farebbe meglio ad indirizzarsi verso altre prospettive politiche, più idonee alla sua indole.
A questa critica devono lavorare tutti i compagni, anche quelli che trovano comodo subire la posizione lideristica di qualcuno che è più bravo degli altri a produrre analisi, documenti, indicazioni. In fondo al senso di sicurezza che questi compagni forniscono si nascondono due errori. Primo, l’efficientismo che ci fa illudere che si fa prima e meglio dando spazio ai compagni più preparati, secondo, la paura di non essere capaci noi stessi di fare quello che alcuni compagni sanno fare così bene.
Spesso abbiamo paura di non riuscire ad adeguare la spinta rivoluzionaria che sentiamo dentro di noi ai compiti immediati, e qualche volta modesti, che la realtà dello scontro ci pone davanti. Ci sentiamo pieni di una grande forza, ma impediti ad attualizzarla in risultati. Ne viene fuori un rifiuto di approfondire un’analisi generale della situazione, a prescindere dalla visione dell’operazione strategica che stiamo realizzando. In quanto individui che agiscono momento per momento, capiamo le singole fasi di questa lotta, in quanto individui che hanno coscienza, ci facciamo sopraffare dai suoi limiti, li sentiamo estranei, non riusciamo a darci un’idea complessiva valida per attivare la tensione rivoluzionaria che pure sentiamo dentro di noi. Quando vediamo il compagno più sicuro di sé, che sembra avere superato questo problema, ci aggrappiamo a lui, accontentandoci di quei singoli momenti in cui ci sentiamo a nostro agio, per poi ricominciare con le nostre crisi e con il nostro bisogno di fuga, e così via all’infinito.
Ma la logica che lega il parziale, nell’intervento di lotta, è la crescita quantitativa. Solo così ci sentiamo meglio quando non siamo capaci di ritrovare la tensione complessiva in quello che facciamo. Ci trasformiamo allora in attivisti del quantitativo. Il nostro proselitismo da fatto positivo e indispensabile si trasforma in orizzonte capace di incarcerare il progetto rivoluzionario. Smussiamo ogni angolo dell’analisi per meglio farvi entrare i gusti di chi ci ascolta. È a questo punto che strilliamo più forte in favore della chiarezza e della semplicità. Se è il leader a vivere questa esperienza di paura e di fuga, egli cerca di consolidare la sua posizione. Guai a chi lo tocca, a chi tocca il suo modo di pensare, perché in quel momento mette a nudo la paura che sta sotto. Allora il leader è pericoloso. Attacca con tutti i suoi mezzi. E se, in aggiunta alla sua condizione di privilegio, è anche un imbecille, le cose si mettono veramente male.
Al contrario dell’illusione quantitativa, il punto di riferimento che dovremmo tenere presente come organizzazione anarchica dovrebbe essere il movimento rivoluzionario generale, inteso non come un luogo specifico, anche se il nostro intervento avviene nello specifico della realtà territoriale, attraverso le contraddizioni capitaliste così come ci provengono dal livello dello scontro di classe. Il movimento rivoluzionario è formato dal movimento degli sfruttati, che è stato diviso, tagliato a pezzetti con operazioni di potere che non è il caso di approfondire qui, ma che esiste e che continua sempre un suo duplice e contraddittorio sviluppo, da un lato lascia vedere delle forme di autorganizzazione, dall’altro persiste nelle forme della delega. Il contrasto tra autorganizzazione e delega è sufficientemente chiaro. Da un lato ci sono le forme di autorganizzazione, dall’altro le forme delegate. È un contrasto che può assumere spesso aspetti diversi. I modelli autorganizzativi (rifiuto del lavoro, resistenza sul lavoro, assenteismo, rivolte spontanee, ecc.) sono forme miste, si intrecciano con i modelli della delega. Non ha senso pensare una separazione netta tra sfruttati autonomi e sfruttati sindacati, da dove diventerebbe facile portarsi con le strutture del movimento anarchico dalla parte autorganizzata. In effetti noi non sappiamo dove andare se partiamo esclusivamente dalla struttura organizzata. Occorre agire attraverso di questa ma in forme sempre diverse, criticamente legate alla struttura, ma, di volta in volta, capaci di nuove idee e nuovi contributi. Sul piano della pesantezza organizzativa non c’è differenza tra il piccolo ghetto che vuole realizzare la totalità della rivoluzione nel microcosmo dell’organizzazione chiusa; e l’altrettanto piccolo ghetto della grande organizzazione aperta, di tipo educazionista, che si limita ad incidere a livello d’informazione. In tutte e due i casi l’accettazione acritica della struttura porta fuori delle lotte. Al contrario, una considerazione della struttura per quello che è, un male necessario, che può limitarsi e controllarsi, porta ad una migliore collocazione all’interno delle lotte, porta a chiedere alla struttura quello che essa può effettivamente dare e non le idee e le indicazioni di lotta che risultano sempre antiquate e ritardatrici.
Sono proprio queste idee creative che costituiscono il senso propulsivo del movimento rivoluzionario nel suo insieme. Esse non possono prodursi se non in relazione al livello dello scontro, ma possono deformarsi per una influenza negativa della struttura organizzata.
II problema degli sbocchi insurrezionali
Cosa significa scendere in piazza? Cosa vuol dire fare una manifestazione? In parole semplici significa che un gruppo di compagni, una struttura, una federazione, decidono di trovarsi in un posto, con le bandiere e un programma sufficientemente delimitato. Per fare questo le leggi dello Stato prevedono una richiesta di autorizzazione. Un responsabile si reca nel luogo deputato e, nel momento dovuto richiede quest’autorizzazione. Il potere stabilisce un percorso. Quel percorso segna i limiti della manifestazione non solo in termini territoriali e fisici, ma anche in senso psicologico. Il compagno che partecipa, dentro quei limiti, nel rispetto dei rapporti di forza che si vengono a contrapporre, si vede davanti una barriera, una soglia psicologica. Non sono molti i compagni che possono superarla facilmente. Nel momento in cui il movimento rivoluzionario è chiamato a sviluppare la sua capacità di intervento nella realtà esterna, in forma macroscopica, nel momento in cui, attraverso la manifestazione, si possono riassumere le posizioni politiche, tutto ciò viene rinchiuso nella capsula necessaria tracciata dal potere. I confini sono determinati dal potere, che assegna il percorso, e dai compagni stessi che si autocensurano e si autolimitano (anche non volendo parlare del compito poliziesco dei tanti “servizi d’ordine”).
Cosa succede se all’interno della manifestazione si verifica un evento imprevisto? Cioè un fatto che non rientra in quel quadro (previsto in collaborazione dal potere e dai compagni). Un gruppo di persone, un gruppo di compagni, operano diversamente da come previsto, sfasciano una macchina, rompono una vetrina, trasformano il sabato della manifestazione in un sabato delle vetrine. In una manifestazione di migliaia di persone i poliziotti, i provocatori, i fascisti, all’interno dei gruppi di dimostranti ci sono senz’altro. Tutto questo sta su un piatto della bilancia, sull’altro bisogna mettere l’azione dei compagni e, in modo particolare, della struttura che ha organizzato la manifestazione.
Il punto principale del discorso è un altro. La manifestazione dovrebbe essere vista come un piccolo fatto rivoluzionario, un piccolissimo fatto. Ma non può essere lasciata all’improvvisazione e alla buona volontà, come non si può gridare alla provocazione per ogni fatto nuovo che viene fuori. Se ci scandalizziamo subito perché all’interno di una manifestazione si superano alcuni limiti, cosa diremo nel fatto rivoluzionario, con le masse in rivolta, in cui i provocatori potrebbero anche essere a centinaia? Il compito del movimento anarchico è quindi quello di andare più avanti, di costruire uno sbocco più ampio, di natura libertaria, a quel piccolo evento che i compagni da soli, spontaneamente, con tutti i loro errori, possono realizzare.
Per questo motivo la manifestazione per come è conosciuta dai militanti che hanno una esperienza delle lotte politiche di questi ultimi anni, diventa una cosa sempre meno utilizzabile. Ormai c’è poco da “manifestare”, cioè di fare conoscere. Occorre andare al di là, verso gli obiettivi insurrezionali.
Per un modo diverso di intervenire nelle contraddizioni sociali
Una manifestazione di controinformazione si può nascondere sotto una sigla più o meno impressionante – spesso per richiamare più gente, in modo particolare le fasce marginali giovanili – ma resta sempre una manifestazione con lo scopo di far conoscere alcune cose. Si può chiamare “bruciamo la città”, ma se si prefigge lo scopo di fornire notizie e nient’altro, resta una cosa utile ma limitata.
Pretendere di partecipare a questo genere di lotte per spingerle, dall’interno, verso obiettivi più estremisti, più violenti, più rivoluzionari, è sbagliato lo stesso. Si tratta del mitico “entrismo” avanguardistico di cui sono stati maestri Lenin e particolarmente Trotskij. Oggi sappiamo perfettamente che l’entrismo è perdente in partenza per gli anarchici. Se non si è d’accordo con una manifestazione puramente controinformativa, è meglio restare a casa.
Davanti alle cariche della polizia, in questi casi, i compagni resistono passivamente, scappano via o si siedono per terra. Chi vorrebbe impiegare altre tecniche di resistenza, e quindi si indigna per il comportamento di alcuni compagni che resistono passivamente, ha torto. Infatti una manifestazione di natura controinformativa non può d’improvviso (tranne rari casi, per nulla documentati) trasformarsi in una insurrezione spontanea.
Chi non è d’accordo con il metodo di restare seduti davanti alla carica della polizia non deve partecipare a manifestazioni del genere, si organizzi, con i propri compagni, per dare vita a interventi di altro tipo.
Ma come devono essere queste manifestazioni diverse? Ecco, qui si pone un fondamentale problema di metodo. Esse devono essere manifestazioni di attacco, cioè interventi in cui si sviluppa il momento informativo, nel corso del quale si portano a conoscenza della gente i motivi per cui si fa la manifestazione, i progetti della repressione, ecc., per poi passare ad un programma abbastanza preciso di coinvolgimento della gente in una struttura di attacco, organizzata prima, preparata con cura, fornita di un minimo di mezzi idonei a ciò che si vuole realizzare.
I compagni quindi non si devono solo fare carico del contenuto controinformativo ma anche del discorso di coinvolgimento, che non può essere fatto con lo stesso mezzo con cui si veicola il primo. Ad esempio, se un volantino (o un manifesto) bastano a trasmettere i temi principali (brevi e condensati) della controinformazione, non bastano più a dare indicazioni operative alla gente. È molto più importante che queste vengano date con scritte sui muri, fatte all’improvviso, o con cartelli o striscioni fatti vedere in un dato momento, o con un breve discorso volante, anche fatto con mezzi di fortuna. Il coinvolgimento è fatto emotivo e immediato che si lega al contenuto controinformativo e analitico ma ha necessità sue per mettersi in moto.
Il processo di coinvolgimento può comunque tardare a verificarsi. Occorre allora passare alla terza parte dell’azione: l’attacco minoritario, esemplificativo, realizzato su un obiettivo preciso, studiato prima, con la massima cautela possibile per evitare che esso venga preventivamente supercustodito dalle forze di polizia. In questa prospettiva anche l’attacco contro la polizia che sta caricando ha un suo significato e può essere un momento della spinta al coinvolgimento.
Ma questa fase dell’attacco minoritario non può considerarsi fine a se stessa, né slegata totalmente dall’andamento della manifestazione nel suo complesso. Cioè, non può né essere programmata in modo che poi la si deve realizzare per forza, perché tanto tutto è ormai pronto e non si può sprecare l’occasione né il modo per fare vedere quanto si è bravi, estremisti, violenti e coraggiosi. Tutto ciò rischia di non avere significato.
L’attacco minoritario è un passo ulteriore nel discorso di coinvolgimento. Non bisogna dimenticare che tutta la manifestazione è finalizzata alla trasformazione dell’attacco minoritario in attacco generalizzato, cioè attacco che è riuscito a coinvolgere la gente.
Se si vede che la partecipazione è scarsa e distaccata, se si vede che lo stesso contenuto controinformativo resta estraneo alla gente, il tutto può essere sempre bloccato anche prima dell’attacco minoritario. In fondo gli anarchici non hanno interesse alcuno a realizzare in proprio mini-rivolte che sono burrasche in un bicchiere d’acqua.
Lo scopo di ogni scontro è la sua generalizzazione. Essa non è mai prevedibile in assoluto, ed è per questo che molte volte gli attacchi minoritari finiscono sconfitti sul piano militare. Occorre comunque valutare bene le condizioni della loro realizzazione. Quando sono assolutamente negative, allora è meglio desistere.
La manifestazione di cui stiamo tratteggiando alcune caratteristiche possiamo quindi definirla di tipo insurrezionale e presenta i seguenti momenti:
a) momento in cui viene veicolato il contenuto controinformativo;
b) momento in cui si sviluppa il discorso di coinvolgimento della gente;
c) momento dell’attacco minoritario;
d) momento dell’attacco generalizzato.
I due ultimi momenti non si sviluppano necessariamente dai precedenti, ma possono anche non realizzarsi, pur essendo indispensabile che i compagni preparino tutto quanto è necessario come se essi fossero assolutamente certi.
[Per il paragrafo Il campo dello scontro cfr. [Alcuni compagni] “Nota redazionale a Nuovo movimento e violenza rivoluzionaria”, in “Anarchismo” nn. 16-17, luglio-ottobre 1977, pp. 196-197. Per i paragrafi La situazione del movimento anarchico, Le caratteristiche dell’attacco armato e Le vecchie malattie del movimento anarchico cfr. i miei interventi contenuti nel volume: Aa.Vv., Gli anarchici e il nuovo movimento, Torino 1977. Per il paragrafo Per un modo diverso di intervenire nelle contraddizioni sociali cfr. (“Insurrection”) “Stop the city”, in “Anarchismo” n. 42, marzo 1984, pp. 22-24. Lo stesso articolo è stato pubblicato anche su “Insurrection” n. 1, aprile 1984, col titolo: “From information to attack”]
Critica del partito armato
I contorni del quadro generale
Il capitale internazionale ha saputo costruire da tempo una specie di fascia di salvaguardia nei confronti delle economie più traballanti a esplosione ritardata, come appunto quella italiana. Su questa fascia viene fatto assegnamento per continuare il progetto, da diversi anni accarezzato, di operare un passaggio indolore da una forma di sfruttamento che si sta rivelando sempre più arcaica, ad un’altra più moderna e dinamica, vestita di ideologia sinistroide, e governata dai burocrati meccanizzati del Partito Comunista.
Questa situazione ha richiesto una radicalizzazione d’intervento, da parte del potere, tale da garantire i quadri istituzionali esterni al meccanismo economico, allo scopo di non far perdere troppi privilegi a quelle classi che in passato l’avevano fatta da padroni in modo assoluto. Le inevitabili disfunzioni produttive hanno determinato, e sempre più determineranno in futuro, una non facile controllabilità della fascia salarizzata, con la conseguenza di accelerare il fissarsi di rapporti intensi tra questa fascia e quell’altra – molto amorfa – caratterizzata dalla mancanza della salarizzazione: disoccupati, sottoccupati, casalinghe, studenti, ghettizzati, emigrati in balia della mafia del lavoro nero, e cosiddetti criminali in servizio permanente. Questa seconda fascia sono riusciti a mantenerla dentro limiti di tranquillità apprezzabili, facendo ricorso a sistemi di reperimento del consenso che si sono rivelati efficaci, come pure accettando le condizioni di un’economia assistenziale che altrove mostra la corda. Quanto potrà durare questa situazione?
Parallelamente all’evolversi delle vicende della struttura economica italiana, si è maturata una parabola discendente delle illusioni degli stalinisti di ogni specie e composizione. Da quelli coscienti, della vecchia guardia del partito armato, a quelli incoscienti che – sotto varie sigle e definizioni – perseguivano in sostanza lo scopo della costruzione del partito operaio, ognuno secondo i propri gusti e interessi. Il fallimento di questa prospettiva si inquadra nell’insieme di una crisi generale della strategia riformista di avvicinamento al potere, strategia sposata da gruppi che apparentemente si dichiaravano rivoluzionari mentre, in sostanza, hanno costituito l’ultimo baluardo della controrivoluzione sempre in atto.
Fortunatamente il nucleo principale del movimento degli sfruttati è rimasto intatto, con tutte le sue contraddizioni interne, con tutte le sue limitazioni, ma anche con tutta la sua carica sovvertitrice. Ciò non significa, però, che questo nucleo principale sia disponibile, subito, per la realizzazione dello scontro rivoluzionario o per una risposta nuova e in termini diversi alle ristrutturazioni statali. La fascia di tolleranza produttiva, sapientemente governata dal capitale, può rivelarsi l’ostacolo decisivo, capace, se non si opera accortamente, di inglobare – e questa volta chissà per quanti decenni – le capacità di rivolta delle masse sfruttate, all’interno di un progetto nuovo di marca socialdemocratica.
Riassumendo abbiamo:
a) un progetto del capitale di passaggio indolore a una “sinistrizzazione” del sistema produttivo;
b) un fallimento delle strategie quantitative di matrice stalinista e di tutti i loro sottoprodotti più o meno coscienti;
c) la persistenza della omogeneità di un nucleo di classe a caratteristiche rivoluzionarie, costituito da quelle fasce che, in un modo o nell’altro, sono state staccate dalla salarizzazione, per quanto la loro reattività possa essere più o meno smorzata da espedienti vari della gestione capitalista.
A questi tre elementi corrispondono altrettante illusioni politiche, alcune in corso, altre definitivamente tramontate:
a) l’illusione del Partito Comunista e consoci di gestire il passaggio, assicurandosi il comando della produzione;
b) l’illusione del partito armato di impostare ancora una volta il progetto stalinista a lungo termine sulle basi della dittatura del proletariato;
c) l’illusione che il nucleo di classe rivoluzionario intenda farsi strumentalizzare da una manovra politica, fosse pure quella dell’autonomia organizzata.
Per completare il quadro indichiamo tre compiti che si aprono davanti all’intervento degli anarchici:
a) denunciare e attaccare il Partito Comunista, in quanto organizzazione e in quanto accozzaglia di somari meccanici al servizio del nuovo capitale;
b) denunciare i difetti e gli errori del progetto stalinista di lotta armata, tragicamente conclusosi con i vari fenomeni di pentitismo, dissociazione, richieste di amnistie, ecc.
c) sollecitare lo sviluppo delle capacità creative di lotta del nucleo di classe rivoluzionario, senza dare alcuna possibilità a organizzazioni autoritarie, di insistere nella vecchia operazione di inquadramento sul modello ormai superato della vecchia resistenza proletaria.
DC e PCI. Vecchi e nuovi padroni
Attaccare e denunciare il Partito Comunista. Questo compito è fondamentale, sebbene non isolato dal vecchio lavoro consistente nell’attaccare i luoghi e le persone che restano legati alle strategie superate della politica economica del capitale. Le obiezioni in materia sono di due tipi:
a) non essendo ancora del tutto realizzata l’unità di interessi fra queste due fazioni politiche, corrispondenti a due visioni gestionarie del capitale, bisogna aspettare che le cose siano più chiare;
b) la denuncia deve essere limitata alle “malversazioni” che eventualmente dessero la possibilità di fissare meglio il parallelo DC-PCI (uguali padroni – uguale sfruttamento) o fatto più avanzato – alle nuove intraprese del PCI, al suo nuovo clientelismo, alla sua nuova visione del capitalismo, alla sua lontananza dalla realtà dello scontro proletario, ecc.
È chiaro che queste obiezioni non reggono. La prima cerca di prendere tempo per rendere il nemico talmente chiaro da evitarsi la fatica di spiegare agli sfruttati quali sono le sue intenzioni prima della loro realizzazione.
La seconda ha paura di attaccare violentemente, anche sul piano dello scontro armato, il Partito Comunista, perché si porta dietro il residuo del frontismo resistenziale.
Lo sviluppo dello scontro potrebbe rendere più chiare le posizioni reazionarie del PCI. Da parte nostra possiamo dimostrare la sua inefficacia nelle lotte e la sua funzione di sostegno del capitale, spingendo gli sfruttati all’impiego della metodologia insurrezionale tutte le volte che sarà possibile.
Anche quando parteciperemo a lotte di massa in cui il Partito Comunista potrebbe essere costretto, dalla risposta della base proletaria, ad accodarsi ai nostri metodi e agli obiettivi da noi scelti, ciò non sarà mai il ripristino di un frontismo che ormai è fuori del tempo. Lo schieramento resistenziale è una conseguenza dell’ideologia padronale o neo-padronale della distruzione dello “Stato borghese” e della costruzione dello “Stato proletario”. All’interno di questo schieramento albergano tutte le alienazioni che travagliano il mondo della “sinistra”, insieme a tutti gli istinti più meschini di potere e di dominio.
Le occasioni fornite a suo tempo dall’antifascismo, oggi andrebbero viste molto criticamente. La destra in sostanza non rappresenta nemmeno più gli interessi del capitale multinazionale, ma solo una estrema valvola di sicurezza, di tanto in tanto oleata e mantenuta in vita per eventuali usi, fiore all’occhiello della parte nostalgica della burocrazia governativa che del suo ordine serba un ricordo indelebile. Quelle occasioni sono state salutate in passato come ottime per ricercare e raggiungere quell’unità del movimento rivoluzionario che in nessun altro modo sembrava possibile. E, di fatto, nelle piazze, in occasione di un riaffacciarsi del pericolo fascista, i compagni ci sono andati, si sono battuti, insieme alla gente. Anche quest’ultima, in fondo, risultava meglio mobilizzabile sulla base delle parole d’ordine antifasciste – almeno nelle zone a tradizione rossa – ma nessuno si è posto criticamente il problema del senso profondo di questa grossa capacità di mobilizzazione che, invece, su altri temi, altrettanto importanti, non si riusciva a realizzare.
Non si può non mettere nel conto che certi atteggiamenti acritici nei confronti dell’antifascismo, hanno finito per giovare proprio a quella strategia capitalista che aveva generato sia il fenomeno fascista (gestendolo spesso direttamente), sia il fenomeno di lotta resistenziale al fascismo (facendolo gestire alle fasce estremizzate della sinistra, con il paterno atteggiamento da poliziotto del Partito Comunista e l’equivoca copertura del Partito Socialista).
Insistere ancora su questa strada, che per certi aspetti può sembrare ancora aperta nelle zone sottosviluppate dell’estremo Sud, ci sembra controproducente. Le organizzazioni fasciste sono organizzazioni del capitale del tutto simili alla DC, al PCI, al PSI, alla Chiesa e alla mafia. Non è possibile individuare un capro espiatorio che possa raccoglierci tutti sotto l’insegna resistenziale, per farci approdare alla soglia interclassista di una collaborazione coi partiti della “sinistra”, allo scopo di combattere un nemico che è alimentato proprio dal PCI e dai suoi degni compari, in quanto ormai facenti parte del corpo statale.
Il solo discorso che noi possiamo fare è quello di una possibile collaborazione, su obiettivi comuni, concreti e non soltanto ideologici, con la base proletaria del Partito Comunista, e solo in quelle condizioni specifiche in cui questa entra in disaccordo con i controlli e le direttive di partito.
In ogni altra occasione parlare di differenza tra DC e PCI significa imbrogliare le cose. A proposito dell’antifascismo, in effetti la DC non ha mai avuto la spudoratezza di parlare del “suo” antifascismo. Quando lo ha fatto ha sempre schiacciato l’occhio in segno d’intesa, per fare comprendere a chi di dovere che si trattava di un modo come un altro per gestire la cosa pubblica e per stabilire le necessarie alleanze. Il Partito Comunista, al contrario, il suo antifascismo lo ha gestito per intero, vivendoci di rendita per trent’anni, evitando accuratamente di spiegare in che modo e con quali responsabilità abbia distrutto, a suo tempo, la carica rivoluzionaria della resistenza, svendendola agli interessi dell’equilibrio USA-URSS.
Comunque, adesso le cose sono più chiare, i due schieramenti del potere – DC e PCI – sono le due strutture, la prima più arretrata, la seconda più avanzata, della razionalizzazione dello sfruttamento.
Lo stalinismo e la sua tendenza contraria allo scontro di classe
Il flusso costante del processo capitalista subisce, in questi periodi, delle variazioni di intensità nello sfruttamento, corrispondenti a modificazioni qualitative di notevole intensità. Queste modificazioni producono, a loro volta, cambiamenti nelle forme della resistenza proletaria, una sostituzione delle forme vecchie e superate dal livello dello scontro con forme del tutto nuove.
A un certo momento il capitale, spogliandosi del suo aspetto avventuroso, caratteristico della pirateria inglese e della nuova frontiera americana, si manifesta nella cruda evidenza di se stesso, come flusso ininterrotto di produzione in grado di dare vita a strutture di potere attraverso il necessario ruolo dell’economia. In questa fase esso è pronto ad eliminare una struttura intermedia del mercato – quella dei portatori di denaro – sostituendovi una struttura di tipo diverso, quella dei portatori dell’organizzazione Stato, che si accentra in una dimensione totalitaria, assommando al salario nominale degli sfruttati, il salario reale aggiuntivo che corrisponde alla pura ideologizzazione del rapporto produttivo.
Mentre nella fase precedente, quando il capitale, essendo legato alle necessità di un mercato non facilmente controllabile, aveva fatto accedere nell’area dei consumi signorili anche le fasce proletarizzate; si verificava una gestione scarsamente ideologizzata del potere, reificandosi questo mistero ideologico nella merce stessa che veniva consumata e in tutto l’apparato sacrificale del capitalismo, con l’inizio della fase successiva, quella del controllo reale, il consumo del simbolo merce viene sostituito dal consumo del simbolo ideologizzato. Se prima l’operaio viveva una vita di stenti per acquistare l’automobile, il frigorifero, la televisione, ecc., dopo continua a vivere una vita di stenti per acquistare un minimo di sicurezza contro un insieme di pericoli immaginari che viene continuamente agitato come minaccia.
Altrettanti sacrifici vengono chiesti da coloro che propongono una strada diversa alla conquista del potere, la strada del fatto rivoluzionario visto sotto l’aspetto del modello stalinista.
Niente, in concreto, gli sfruttati ricevevano prima – trattandosi di mera apparenza nel regno del fittizio il fatto di consumare merce – e niente ricevono a seguito dell’ideologizzazione di un processo che non è neanche iniziato.
Non bisogna pensare che siano pochi gli sfruttati che hanno sentito scattare dentro di loro una molla di liberazione nel constatare che qualcosa si muoveva in campo rivoluzionario. Anche se le avanguardie del partito militare sono rimaste isolate, hanno smosso parecchi sentimenti di ribellione e molti cuori sono rimasti, come si dice, sull’altopiano. I loro errori non possono cancellare quelle poche cose buone che sono riusciti a realizzare, malgrado la miopia congenita dei modelli prescelti. E queste cose buone sono riassumibili nell’attacco alle strutture di potere. Solo che il ruolo giocato dallo stalinismo in questi avvenimenti è stato tutto particolare. La sua tendenza contraria allo scontro di classe ha determinato un abbassamento del livello relativo dello scontro, abbassamento che era prevedibilissimo, non perché tra stalinismo e fascismo non ci sono differenze, come molti compagni anarchici affermano con un giudizio che è, nello stesso tempo, sbagliato e giusto. Si tratta di un modo di facilitare le cose, ma è un modo errato. Le differenze ci sono e corrispondono anche a diverse fasi dello sviluppo capitalista.
È proprio nel non cogliere queste differenze che, tante volte, non si comprendono bene le origini di alcuni errori che sono stati fatti in passato e che si possono anche fare domani e che, genericamente, si riferiscono al problema della “collaborazione” con le organizzazioni autoritarie. Su questo punto ci sembra necessaria una riflessione più approfondita.
In questo momento il fallimento del modello di lotta armata, realizzato da queste organizzazioni, è generale e presenta anche aspetti patetici e tragici che non è il caso di analizzare. Ma quello che quasi nessuno riesce a mettere in discussione criticamente è il progetto stalinista nel suo complesso, mentre molte analisi sottolineano questo o quell’errore, senza vedere la malattia nel suo insieme.
Lo stalinismo segna il corrispettivo politico della crisi estrema del capitale, la crisi rivoluzionaria. Nel momento in cui le contraddizioni interne al meccanismo economico e la circolazione delle idee conducono le masse ad una rivolta definitiva e ad uno scontro radicale, il sussulto burocratico del partito-guida, con un colpo finale di bacchetta magica, recupera lo slancio rivoluzionario delle masse, imponendo la nuova gestione di potere. Perciò, in una situazione diversa da quella che abbiamo definito di “crisi estrema”, lo stalinismo è destinato a fallire pur continuando a svolgere il suo ruolo inverso alla tendenza dello scontro di classe.
Però la suprema fase di recupero, riflettendo bene, nel momento particolare dell’insurrezione armata generalizzata, o subito dopo, non potrebbe essere portata a buon fine se non venisse preparata con accuratezza prima, nella fase precedente, in cui i progetti di ristrutturazione del capitale sono ancora in corso. È quindi in questa fase che le compagini staliniste si organizzano e cercano di avere i loro risultati. Ed è anche in questa fase che emerge la straordinaria capacità di preveggenza del capitale. Pur non potendo programmare i termini dello scontro di classe, esso continua il suo gioco socialdemocratico delle riforme, continua anche quello della repressione più spietata e insiste nell’utilizzo delle forze reazionarie, ma non abbandona del tutto quella estrema “sinistra” che costituisce un serbatoio di rivoluzionari, al momento della sconfitta vuole riportarli al loro ruolo di guida e di punto di riferimento, cioè, in altre parole, al loro ruolo di recuperatori. Perciò è sempre disponibile ai discorsi dei pentiti, dei dissociati e di coloro che si sbracciano a chiedere amnistie o altri provvedimenti di condono.
Qui bisogna intendersi bene. Non è che il capitale finanzi le organizzazioni staliniste, o stabilisca con esse rapporti diretti di impegno politico. Queste ipotesi costituiscono ben povera base per un’analisi critica del fenomeno. Le condizioni che determinano la collaborazione tra capitale e stalinisti sono ben altre. Prima di tutto il capitale fornisce il modello dell’intervento politico, basato sul controllo capillare, sullo schema del partito, sullo spirito quantitativo e di vendetta. Questo modello viene assorbito dalle organizzazioni staliniste al punto da costituire, queste ultime, dei veri Stati in miniatura, con compiti specifici che mimano quelli dello Stato che si intende abbattere.
Inoltre il capitale fornisce il modello generale del rapporto minoranza-massa. Tutto quello che esso ha pensato riguardo l’ottusità, la necessità di guida, l’incapacità e l’idiozia delle masse, viene passato di peso nell’analisi stalinista, dove subisce un’elaborazione, generalmente limitata a un’accurata sostituzione di alcuni termini con altri più idonei alla nuova prospettiva politica.
Questi due modelli costruiti dal capitale, si riassumono nella pretesa di utilizzare i mezzi del vecchio sistema di potere – una volta accaduta l’espropriazione generale – per stabilire il nuovo ordine di cose, dopo un periodo temporaneo (dittatura del proletariato), periodo non ben definito in quanto a durata, ma ben chiaro riguardo i compiti di guida e di comando della minoranza costituita dal partito “rivoluzionario”.
Si vedono adesso chiaramente le differenze tra fascismo e stalinismo. Il primo stabilisce contatti diretti col potere del capitale, per poi andare avanti, secondo l’evolversi degli interessi di quest’ultimo, il secondo, ponendosi come negazione del capitalismo, non fissa rapporti precisi – se non quelli che provengono dallo scontro di classe – per poi, in concreto, trovarsi ad avere rapporti altrettanto intimi, imposti tramite il processo di ideologizzazione.
Il compito finale dello stalinismo sarà quello di uccidere l’iniziativa spontanea della rivoluzione popolare, impostando i termini del nuovo potere della tecnoburocrazia pseudorivoluzionaria del partito-guida.
Il fatto che ora si sia ben lontani dai giorni delle grandi azioni clamorose dei partiti armati, non significa che il modello abbia cessato di possedere tutte le sue pericolosità, per cui resta indispensabile una critica quanto più completa possibile.
Guardando bene la realtà dello scontro, ci si accorge che le organizzazioni staliniste possono anche subire modificazioni apprezzabili e non presentarsi sempre sotto l’aspetto del partito chiuso. L’intensità di questi cambiamenti può arrivare anche ad una critica apparente del partito e a una pretesa di controllare indirettamente il movimento. In generale possiamo dire che per il partito stalinista ortodosso, per le sue modificazioni leniniste e per le altre forme di burocratizzazione rivoluzionaria, poniamo gli archinovisti o gli anarcosindacalisti, si tratta di individuare le differenze nella intensità di pericolo per le sorti della rivoluzione sociale.
Si tratta di valutare bene la nostra posizione nei confronti di queste organizzazioni che, pur ponendosi sul terreno della lotta contro il capitale, per uno strano gioco delle parti, finiscono per costituire l’ultima e definitiva difesa del capitale stesso.
Prima di sviluppare questa tesi occorre fare una distinzione tra organizzazioni reali e organizzazioni fittizie. Le prime sono nel concreto delle lotte, le seconde si trovano in un momento puramente ideologico e non svolgono altra funzione che quella di dare sfogo alle alienazioni personali di coloro che vivono in maniera non adeguata il proprio rapporto di classe. È evidente che un’organizzazione fittizia, come potrebbe essere l’odierno movimento anarcosindacalista, non costituisce di per sé un pericolo più grande di qualsiasi altra forma di simbolizzazione o mitizzazione del vissuto. Al contrario, quando questa organizzazione prendesse piede realmente, inserendosi nella realtà delle lotte, e venisse a contrastare il compito che oggi svolgono i sindacati confederali e autonomi, svolgerebbe un ruolo controrivoluzionario, e lo svolgerebbe in concreto, invece di sognarselo semplicemente. Ciò per il semplice motivo che presentandosi come forza di riferimento per le lotte operaie, prima o poi, finirebbe per recuperarle negli interessi del capitale, interessi che in quella fase non sarebbero più sufficientemente protetti dai sindacati tradizionali.
Lo stesso si può dire per gli stalinisti allo stato puro. I partitini dell’estrema sinistra, ad esempio, svolgono una funzione di reggicoda del riformismo del Partito Comunista, con aggiunte alcune funzioni specifiche come quelle poliziesche di denuncia dei compagni alla polizia, ai partiti, ai sindacati. Le Brigate Rosse, da parte loro, si sono inserite nella realtà dello scontro, costruendo un partito armato che intendeva attaccare lo Stato nei suoi punti nevralgici allo scopo di disarticolarlo. Tra questi parenti stretti (in linea ideologica) corre una notevole differenza pratica, per cui i primi risultano nemici dei secondi, come sempre accade fra coloro che si trovano a condurre una battaglia nella realtà dello scontro di classe e coloro che vivono le proprie esperienze nell’alienazione ideologica.
Per gli anarchici che amano racchiudersi nel fumo dell’ideologia e preferiscono il fittizio al reale, la conclusione del discorso è una sola: le organizzazioni combattenti vanno condannate in blocco e sulla sola base della loro posizione teorica. Infatti, per chi mangia teoria è questa la sola pietra di paragone, il resto non conta. Questo ragionamento non ammette prove in contrario per il semplice fatto di essere una ripetizione, come dire: ciò che è sbagliato non può essere giusto. Così il problema non possiede un contributo di serio approfondimento.
Restano gli anarchici che cercano – in tutti i modi e ricorrendo a tutti i mezzi rivoluzionari a disposizione – di attaccare il nemico di classe, quei compagni che malgrado la situazione di sfacelo, stanno ricostruendo, a poco a poco, un minimo di intervento rivoluzionario. Questi compagni anarchici debbono porsi il problema di come valutare il lavoro fin qui svolto dai partiti militari e non solo alla luce dei loro fallimenti o della brutta fine che tanti militanti super-efficientisti hanno fatto. E porsi il problema significa rinunciare ad una condanna immediata e senza appello, ad un rifiuto aprioristico delle loro realizzazioni, a una chiusura ideologica. Significa accettare quelle azioni e quelle analisi nei limiti che presentano, per proporre un futuro avanzamento dello scontro attraverso la critica.
In queste affermazioni non si deve leggere una nota diversa da quanto dicevamo prima in merito alla funzione dello stalinismo. E ciò proprio perché l’utilizzazione che il capitale ha fatto (e potrebbe fare negli anni che verranno) di questo modello organizzativo, resta un fatto contraddittorio che deve essere verificato (nelle sue potenzialità negative e nei suoi possibili errori di percorso), proprio nel momento in cui il livello dello scontro torna a rialzarsi, nel momento insurrezionale, mentre non può essere considerato un dato assoluto provocato in base a una discriminante ideologica.
Occorre studiare bene il meccanismo totalizzante realizzato dal capitale. Ogni parte di questo meccanismo presenta aspetti positivi per il capitale stesso ma non può fare a meno di presentare effetti di disturbo, a volte marginali, a volte più significativi. Basta pensare allo sfruttamento per rendersi conto dell’importanza del fenomeno. Se da un lato lo sfruttamento rende possibile l’accumulazione del capitale, dall’altro rende possibile la presa di coscienza da parte degli sfruttati e quindi la lotta per la liberazione definitiva. I grandi mezzi di comunicazione, ad esempio, se da un lato rendono possibile una più omogenea integrazione delle grandi masse, dall’altro educano alla conoscenza di alcuni problemi (per quanto si tratti di conoscenza mistificata) e rendono più agevole il formarsi e l’agire di una minoranza rivoluzionaria agente in seno alle stesse grandi masse. Così per lo scontro tra Stato e organizzazioni di lotta armata a struttura stalinista. Se da un lato queste organizzazioni costituiscono un elemento della futura controrivoluzione, dall’altro possono costituire una fase dell’attacco contro lo Stato. Il fallimento di cui si è avuto prova in questi ultimi anni non nega questa affermazione, come non ci garantisce contro una futura ripresentazione del fenomeno sotto i medesimi aspetti di ieri. Ecco perché non possiamo ridurre l’analisi anarchica della lotta armata ad una semplice condanna delle strutture militari chiuse, ma dobbiamo considerare il fenomeno nel suo complesso con una cauta attenzione.
Quando parliamo di “cautela” lo facciamo non nel senso di avanzare “cautamente” una critica ideologica, parlando dall’altezza del pulpito, ben lontani dall’atmosfera surriscaldata dello scontro. Il termine va riferito alla necessità di soppesare i giudizi negativi, facendo attenzione non solo al quadro ideologico di fondo, ma anche alle ipotesi strategiche in quel quadro contenute, ed evitando di lasciarsi coinvolgere in giudizi avventati. La critica deve quindi partire da realizzazioni concrete di lotta che, nella loro stessa capacità di trasformazione, costituiscano elementi di analisi cauti e ponderati.
Il fallimento delle strategie quantitative
I risultati di questi ultimi tempi, le tristi esperienze dei pentiti, dei dissociati, degli elemosinatori di amnistie e favori, sono uno degli aspetti del fallimento del quantitativo. Gli altri aspetti non sono ancora sufficientemente chiari ma non mancheranno di esserlo in seguito. Un bisticcio fondamentale tra quantità e rivoluzione è praticamente evidente per tutti. Anche il lavoro politico tradizionale è entrato in crisi, la vecchia crescita in tempi medi e lunghi, il concetto federativo del movimento, il germe del partito operaio o del sindacato più o meno rivoluzionario, tutte queste cose sono andate in fumo.
A fallire è stato il progetto di incolonnare il popolo sotto l’insegna di un programma ideologico, con tutte le relative conseguenze. I primi a cadere in questa mistificazione sono stati proprio i mistificatori. Dopo averle provate tutte, adesso anche i modelli più sofisticati sono entrati in crisi. Ciò è accaduto per l’autonomia proletaria che, pur restando tale, cioè autonoma, avrebbe stranamente dovuto trasformarsi in un ulteriore partito, o in qualcosa che somigliasse ad un partito. È chiaro che l’autonomia proletaria è quella dei produttori e non quella degli ideologizzatori del rapporto di produzione. Ogni tentativo di inquadramento delle lotte autonome all’interno di schemi provenienti da un passato di tristi esperienze, presenta per forza delle caratteristiche controrivoluzionarie. La verità di un’affermazione del genere balza subito evidente non appena si pensa alla strumentalizzazione che è stata fatta, da elementi e organizzazioni che nulla avevano a che fare con i princìpi teorici dell’autonomia proletaria, del concetto di autonomia, strumentalizzazione che non è fra le cause ultime di grossi guai pratici e confusioni analitiche.
Anche la diversione soviettista, che ad un certo momento sembrava volesse trovare uno sbocco diverso da quello del partito tradizionale, non è stata altro che un ulteriore imbroglio ideologico. L’organizzazione nei luoghi di specifica azione della classe proletaria, attraverso gli organismi autonomi, come momento transitorio, non può non concludersi in una rivalutazione futura del ruolo del partito. La scelta soviettista è stata dettata da una certa impossibilità di continuare nella direzione di sempre, dal rifiuto della realtà di farsi modellare secondo i canoni del marxismo-leninismo e secondo i relativi testi sacri. Si trattava, quindi, di una pratica di ripiego, resasi necessaria dopo il fallimento di una metodologia che, però, nello stesso tempo, indicava anche il fallimento del progetto della crescita quantitativa all’infinito. Il non avere approfondito questo aspetto ha portato alla considerazione delle pratiche assembleari e del radicamento nei cosiddetti “luoghi della classe”, come scelta politica e non come ultimo fronte della persistente illusione quantitativa. Al momento preciso, quando la repressione cominciò a riorganizzarsi su schemi diversi, proponendo allettanti riduzioni delle pene per chi collaborava, i segni del riflusso vennero imputati solo ad un cattivo funzionamento del modello del partito (che per altro venne tenuto “sospeso” e mai messo in discussione), ma non si sviluppò anche una critica delle strutture assembleari e territoriali in cui il movimento dell’autonomia si era dispiegato. Non vennero neppure indicate le analogie e i reciproci riferimenti, i passaggi dei progetti organizzativi e gli errori analitici. In molti casi quei momenti assembleari vennero ricordati come qualcosa di diverso, dove effettivamente si agitava un fantasma che avrebbe potuto mettere in crisi il capitale e che non riuscì nel suo intento per semplici errori di percorso. Nessuno che si preoccupasse di sottolineare in che modo in quelle assemblee si realizzasse l’azione, in quale misura le pesantezze ideologiche, le strutture residue di partito, le strutture clandestine, agissero e producessero deformazioni e disastri.
Anche il movimento anarchico ha finito per pagare le conseguenze della sua inadeguatezza a svolgere una certa funzione storica che gli sarebbe stata congeniale. Lo spettro della costruzione del “partito operaio anarchico” gli è rimasto appiccicato addosso e non ha potuto liberarsene. Spesso si è verificata la comica situazione che erano proprio gli anarchici gli elementi meno avanzati in certe occasioni di lotta, gli elementi che invitavano alla calma, alla ponderatezza, alla verifica delle condizioni dello scontro, all’attesa della crescita del movimento, alla maturità delle strutture organizzative. Per quanto possa sembrare incredibile, in questi ultimi anni, molti fogli anarchici hanno sistematicamente svolto una funzione controrivoluzionaria che sarebbe interessante un giorno dettagliare con riferimenti precisi, risultando puntualmente arretrati nei confronti del livello delle lotte, ricorrendo a incredibili funambolismi per recuperare il terreno perduto, quando certe tematiche finivano per radicarsi talmente nel movimento da sembrare assurdo non parlarne. In questi ultimi anni gli anarchici invece di spingere alla rivolta hanno cercato spesso un’aria respirabile giustificandosi con l’affermazione che “nulla garantisce un risultato positivo”. Cosa aspettavano? Forse una cartolina precetto? Compito dei rivoluzionari anarchici è quello di sensibilizzarsi sulle condizioni dello scontro, non quello di acchiappare l’ultimo treno sugli argomenti del giorno per evitare di fare, fino in fondo, una magra figura.
Con ciò non si vuole recriminare contro qualcosa o qualcuno, ma solo riaffermare, come tante altre volte, che questo modo di agire, di gestire certi modelli organizzativi, presenta tutte le caratteristiche negative di quella malattia del quantitativo che è proprio l’indicazione più interessante della pratica rivoluzionaria di questi ultimi anni. Non porvi rimedio attraverso un’approfondita autocritica sarebbe veramente grave.
Il problema dello scontro armato
Un importante elemento pregiudiziale, che è entrato in tutte le analisi sulla lotta armata fatte in questi ultimi anni dai compagni anarchici, è stato il seguente: essendo lo scontro armato contro lo Stato il momento culminante del fatto rivoluzionario, per impegnarsi in esso si deve essere certi che la fase storica sia almeno una fase pre-rivoluzionaria, in caso contrario si finisce per essere schiacciati dalla macchina repressiva e si distruggono anche le altre forme d’intervento, il lavoro politico che il movimento conduce da sempre, il lavoro di controinformazione e così via.
I risultati più recenti ottenuti dalla repressione sembrerebbero avvalorare la fondatezza di questa tesi, ma solo ad una prima analisi superficiale. Approfondendo il problema ci si rende conto degli errori.
Cerchiamo di dare un contributo a questa analisi, scoprendone i lati deboli e le mistificazioni:
a) la posizione personale dei compagni che elaborano alcune analisi non può essere considerata estranea all’analisi stessa,
b) la posizione dell’organizzazione cui questi compagni appartengono costituisce un ulteriore elemento dell’analisi, anche se spesso non appare.
c) c’è un equivoco logico nel fatto di affermare che la lotta armata necessita della fase prerivoluzionaria, in quanto non ci pare possibile negare che questo tipo di lotta dia il suo contributo proprio alla formazione della fase prerivoluzionaria stessa,
d) non è pensabile una considerazione uniforme di ciò che comunemente viene detto fase prerivoluzionaria,
e) alla base di questa obiezione c’è un ulteriore equivoco, volere prendere come esempio di lotta armata quello che viene fuori dalla strategia della presa del potere da parte di una minoranza di rivoluzionari professionisti.
Una corretta metodologia materialista dovrebbe partire dal presupposto che non è possibile alcun distacco dalla propria realtà, nei termini in cui ci viene proposta dal vissuto quotidiano, e le riflessioni che sulla realtà si fanno, per quanto possano essere ampie e generalizzate, o riguardare fenomeni apparentemente distanti dalla dimensione quotidiana che subiamo, risentono di quella vicinanza. Un chiarimento del genere renderebbe più semplice e più valida l’analisi, specie quando coinvolge non solo valutazioni politiche, ma anche decisioni a carattere personale. In tutti i sensi, il periodo dell’analisi acritica è tramontato. Non è possibile continuare ad accettare formulazioni costruite lontano dalla concretezza dell’impegno di lotta.
Facciamo un esempio. La svalutazione scolastica di questi ultimi anni ha determinato nei compagni più giovani una notevole crisi antintellettualistica, portandoli a un sospetto, non sempre fondato ma comunque molto significativo, per le belle analisi letterarie. Mentre una strategia del capitale distruggeva il contenuto strumentale dell’insegnamento scolastico, le nuove generazioni di giovani che uscivano dalla scuola si trovavano con sempre meno mezzi intellettuali, con una deludente esperienza “assembleare” fatta di parole e di luoghi comuni, ma, nello stesso tempo, con una crescente esperienza pratica derivante dalla sostanziale posizione di disoccupati, di sottoccupati e di emarginati. Questa situazione ha consentito l’accumulazione di una notevole carica distruttiva nei giovani, mentre da parte del potere ha determinato la necessità di ricorrere ad una serie di processi di recupero che sono tuttora in corso, come, per esempio, musica, sport, droga, ecc. Però, nel momento in cui sarebbe stato necessario possedere le analisi adatte alla realtà dello scontro, proprio quel rifiuto precedente, le condizioni predisposte dal capitale e il generalizzato disgusto per le pratiche intellettuali, hanno sottratto a molti compagni la possibilità oggettiva di vederci più chiaro.
È un fatto che nella maggior parte dei casi a sviluppare le analisi e ad occupare la maggior parte dello spazio dei nostri fogli militanti sono stati proprio i compagni appartenenti alle generazioni precedenti, i quali ebbero modo di costruire la loro formazione intellettuale e politica in altre situazioni dello scontro di classe. Questi compagni, sia perché hanno potuto avvantaggiarsi dell’utilizzo di certi strumenti forniti dalla scuola, sia perché hanno trovato una situazione di debutto più favorevole, sia perché hanno sostato di meno alle porte della salarizzazione, oggi si trovano a svolgere, nella quasi totalità, una funzione all’interno della struttura produttiva. Chi è professore, chi è giornalista, chi è funzionario, chi è impiegato, chi è operaio specializzato, ecc. Ora, questa composizione di classe deve essere tenuta presente, in quanto è un elemento non trascurabile dello sviluppo dell’analisi che questi compagni svolgono.
Al contrario, la maggior parte dei compagni più giovani, anche se con provenienza di classe eterogenea, si trovano accomunati in una struttura più omogenea, data proprio dalla loro ghettizzazione, dalle difficoltà spesso insormontabili di trovare un lavoro, difficoltà che alimentano fortemente un comportamento antiproduttivo, antiautoritario, antintellettualistico e, se si vuole, un comportamento genericamente distruttivo.
A volte questi compagni sono bloccati proprio dalla mancanza o dalla difficoltà di reperire gli strumenti idonei a formulare le proprie analisi, anche se spesso hanno le idee chiare su dove si collochi il nemico di classe e su come bisogna colpirlo. Quello che manca è spesso la forma esteriore dei concetti. Sono così bloccati e si chiudono respingendo ogni approfondimento, oppure accettano elaborazioni che in fondo condividono solo in parte. La pratica di vita di questi compagni è antiautoritaria, certamente di più della pratica di vita di coloro che una incancrenita tradizione ha finito per delegare alla produzione del materiale analitico.
Un secondo discorso è quello relativo alla posizione della struttura organizzativa e al peso che essa ha nell’analisi. I contenuti di quest’ultima sono infatti fortemente influenzati da una strategia esterna all’analisi stessa, che non è quella del suo estensore in quanto individuo, ma quella dell’organizzazione cui l’estensore idealmente o praticamente si richiama. Ora è chiaro che questa strategia sarà tanto più a lungo termine quanto più l’organizzazione non si sente pronta ad assolvere al suo reale, o presunto, ruolo rivoluzionario. Ne deriva che l’analisi finirà per contenere molti approfondimenti sulle scarse possibilità di realizzare quegli obiettivi e molte giustificazioni per spostare nel tempo un qualsiasi progetto d’intervento, ritenendo che nel futuro si possano realizzare le condizioni ottimali che consentiranno all’organizzazione di agire con possibilità di successo.
Così, ad esempio, in un’analisi sulla lotta armata la quale si mantiene su posizioni che si possono riassumere nelle parole “sparando si perde”, di colpo, senza necessità alcuna, emerge un riferimento all’anarcosindacalismo, all’educazionismo, al pacifismo, all’ecologismo, al moralismo, ecc.
Riassumendo questi due punti, entrambi contribuiscono ad avanzare due elementi strategici, il primo individuale e il secondo organizzativo, che non possono essere trascurati nella valutazione dell’analisi. Personalmente sono portato a ridurre i tempi strategici dell’intervento rivoluzionario e della distruzione del nemico. Ma questa considerazione non tiene conto di un progetto in corso. Nel caso che mi veda costretto a fare una valutazione quantitativa, poniamo in un’ottica insurrezionale anche circoscritta, devo pure fare delle scelte strategiche. Bisognerà allora vedere se quello che più mi sta a cuore è la potenza distruttiva del mio operare, in seno alla struttura organizzata, oppure il persistere della struttura (e quindi la salvaguardia di quest’ultima) in vista di future possibilità, tutte da verificare.
Veniamo al quarto e quinto punto, cioè alla contraddizione logica dell’affermazione che la lotta armata necessita di una fase pre-rivoluzionaria. E con la critica a questi punti entriamo anche nel sesto. In un’affermazione come la precedente è insita una supervalutazione dello strumento organizzativo armato di fronte ad altri strumenti d’intervento contro la repressione. La cosa è più che naturale in quanto dipende dal fatto che lo Stato dedica maggiore attenzione repressiva alle realizzazioni delle organizzazioni di lotta armata di quanto non ne dedichi alle realizzazioni in altri settori d’intervento. Ma in questi ultimi mesi il rapporto si è capovolto e fra poco si potrebbe intensificare in senso inverso. Lo Stato ha fermato il dilagare degli interventi armati riducendo il tutto al livello spettacolare e attribuendolo solo alle iniziative delle organizzazioni etichettate.
Ma si tratta di una strategia repressiva elaborata dai servizi di sicurezza. Il fenomeno della lotta armata è stato formato solo in minima parte dalle realizzazioni delle organizzazioni cosiddette storiche, quelle che trovavano modo di portare a termine azioni eclatanti, anzi, al contrario, è stato costituito da un vastissimo comportamento illegale e antiautoritario che potrebbe riprendere, diffondendosi per altre strade e in modi differenti. Lo Stato sa benissimo ciò, come lo sanno bene tutti coloro che sotto camuffamenti diversi hanno cercato di cavalcare la tigre di questo comportamento in via di generalizzazione. Ridurre il problema della lotta armata, come si è sviluppata negli anni scorsi in Italia, a quello che hanno fatto le diverse organizzazioni armate è privo di senso. Significherebbe riproporre, con tutta l’autorità dell’analisi rivoluzionaria, lo schema di ragionamento che è tornato tanto utile alla gestione spettacolare che del fenomeno lo Stato ha cercato di imporre riuscendovi, purtroppo, perfettamente, forse anche al di là delle sue stesse aspettative.
È solo nei termini in cui questo comportamento antiautoritario e illegale tende a generalizzarsi che ci si avvicina alla fase che si vuole definire prerivoluzionaria (e adesso ne siamo certamente lontani), e non, come si vuole sostenere, che questa fase renda logico quel comportamento. Il guaio è che molti compagni, tanto bravi a individuare il peccato autoritario negli altri non sono poi altrettanto bravi nel vedere il vizio del proprio ragionamento, pur essendo questo vizio della stessa natura autoritaria che temono tanto negli altri. Infatti questi compagni, quando fanno riferimento alla necessità che la lotta armata trovi giustificazione solo nella fase prerivoluzionaria, hanno in mente un modello organizzativo clandestino che è proprio quello che è stato realizzato dalle organizzazioni combattenti.
Torna quindi sempre indispensabile l’attacco, armato o meno, contro le strutture della repressione e i suoi responsabili, indipendentemente dal livello dello scontro (che poi sarebbe un modo diverso di definire la “fase” di cui parlavamo sopra). Oggi non saranno più possibili le realizzazioni di ieri, ma si può sempre ricominciare daccapo. Allo stesso modo non sarà più possibile commettere gli errori di ieri. Abbiamo quindi elementi negativi ma anche elementi positivi. Il nostro scopo resta però sempre quello del coinvolgimento diretto alla generalizzazione dello scontro.
Verso le nuove forme della controrivoluzione
Modificatesi le condizioni dello scontro non sono cambiate solo le forze rivoluzionarie ma anche la composizione del nemico di classe. A far parte dello schieramento reazionario sono entrate, con maggiore evidenza, forze che ieri si nascondevano dietro atteggiamenti progressisti e sulle quali molti di noi si erano illusi.
Ad un certo momento del suo sviluppo la combinazione capitale-Stato riesce ad ottenere una razionalizzazione del progetto di sfruttamento. Si arriva quindi a un occultamento progressivo dei contrasti produttivi, a un aumento della presenza ordinatrice dei processi politici.
È, dentro certi limiti, il momento che stiamo vivendo.
Alla repressione pura e semplice (che non viene accantonata del tutto) subentra la ricerca del consenso.
Si tratta di nuove forme repressive che occorre studiare bene, allo scopo di elaborare un intervento rivoluzionario che non resti legato a modelli del passato che ormai rischiano di essere fuori del tempo.
Il consenso assume varie forme. L’appello elettorale a tutti i livelli (dal parlamento alle regioni, dalle università e dalle scuole alle unità sanitarie locali, ai comuni, ecc.) è un primo aspetto.
C’è poi il consenso attraverso il dissenso.
Si tratta di un modo non proprio nuovo di coinvolgere che però è adesso sviluppato in forme originali e altamente pericolose.
Lo Stato permissivo, pur restando sempre dissuasivo (cioè pur restando sempre armato del mitra del poliziotto), tende a discutere, a consentire uno spazio di agibilità e di autoregolamentazione, purché sia controllabile a tutti i livelli. Quello che ci vuole per ottenere la pace sociale non è tanto un adeguamento totalitario e uniforme a modelli fatti piovere dall’alto, quanto un comportamento differenziato, sufficientemente diverso, qualche volta anche creativo, purché restante al di dentro della sfera di controllo degli organi statali. Così il ruolo controrivoluzionario giocato dal cosiddetto dissenso è di grande importanza per il mantenimento dell’ordine e per la continuazione dello sfruttamento. Allo stato attuale delle cose i padroni e i loro servitori fanno affidamento più su queste forme di recupero che non sull’efficacia repressiva pura e semplice dei corpi armati, per quanto, ovviamente, questi corpi vengano considerati elemento ultimo e convincente d’intervento repressivo.
Così lo Stato chiede al movimento rivoluzionario una “collaborazione” per la realizzazione e il mantenimento della pace sociale.
Non è solo la richiesta che è stata fatta nelle carceri, e prontamente accettata in modo massiccio dagli ex-combattenti, ma anche fuori dalle carceri il progetto è lo stesso. Quello che si vuole ottenere è la desistenza.
Non ci si deve meravigliare davanti a richieste del genere. Lo Stato può chiedere quello che vuole, sta a noi capire se stiamo per essere coinvolti all’interno di una manovra consensuale, oppure se il nostro dissenso continua ad avere una funzione di rottura. I progetti statali sono per loro natura continuamente sottoposti a modificazioni. Oggi alzano il muro repressivo, domani diventano meno duri e depenalizzano comportamenti che il giorno prima erano considerati reati e perseguiti con accanimento. Per il capitale e lo Stato non esistono modelli morali di condotta. Essi si adattano, secondo la tesi machiavelliana, a impiegare oggi la forza del lione e domani l’astuzia della golpe.
E oggi potrebbe essere la volta della zampa vellutata della volpe.
Quello che fa molto comodo nella situazione in cui ci troviamo, quello che consente di dare alla ristrutturazione capitalista l’aspetto di un processo spontaneo di aggiustamento, è proprio la presenza – anche massiccia – di un “dissenso”. Occorre che ci sia chi dice no. Fanno passare la legge antioperaia sulla scala mobile con la complicità sindacale, occorre chi dice no. Mettono i missili a Comiso, occorre chi dice no. Finanziano il padronato a spese degli strati più miserabili della società, occorre chi dice no. Costruiscono carceri speciali su tutto il territorio, occorre chi dice no.
Occorre che questo no ci sia e che venga gridato ai quattro venti, purché resti nei limiti di un “no” platonico, una semplice dichiarazione di dissenso. Esso non deve travalicare in azioni dirette a contrastare il progetto nemico, ma deve semplicemente restare una manifestazione “minoritaria” di diniego. Spetterà poi alle stesse forze governative spiegare l’impossibilità pratica di quel no anche se fondato su motivi di “alto valore morale”. Un modo come un altro per prendere in giro la gente, per spegnere il potenziale di aggressività che si va continuamente accumulando, per indirizzare questa carica di ribellione verso attività apparentemente di dissenso ma in fondo controrivoluzionarie.
È quello che oggi viene chiesto al movimento pacifista, ed è quello che il movimento pacifista sta fornendo. Il pacifismo stesso, come ideologia, si presta molto ad essere sfruttato per la produzione di pace sociale. Un miscuglio indigesto di sacrificio cristiano e fideismo millenarista è molto gradito allo Stato come mezzo di coinvolgimento. Anche le manifestazioni pacifiste che tanto impressionano in senso favorevole compagni che dovrebbero meglio approfondire certi problemi, sono elemento gradito nella cornice spettacolare del processo di sfruttamento. L’innocuità di queste manifestazioni va al di là dello scontro – anche fisico con la polizia – che può esserci e anche non esserci, ma viene recuperato da tutt’e due le parti a causa della sua sporadicità e passività per quanto riguarda lo Stato e a causa della sua estraneità all’ideologia di base per quanto riguarda lo stesso movimento pacifista.
Questi nuovi preti, che restano aggrappati all’altare del proprio sacrificio, risultano incomprensibili alla gente che vorrebbe partecipare alle lotte ma non per questo è disponibile ad abdicare al proprio patrimonio di attacco proletario violento contro lo Stato. Ed è su questa loro “incomprensibilità” che lo Stato fa affidamento, consentendo anche manifestazioni di dissenso che ad altri sono vietate, ma intervenendo immediatamente quando si rendono visibili i segni di una presenza estranea all’interno delle organizzazioni pacifiste.
Lo stesso discorso si deve fare per le lotte sindacali, anche quelle autonome, autogestite o condotte sotto la guida delle poche organizzazioni anarcosindacaliste o sindacaliste rivoluzionarie. Anche ad esse lo Stato chiede il mantenimento della pace sociale. La loro inefficacia è garanzia della loro stessa possibilità di continuare. Inefficacia rivoluzionaria che si trasforma immediatamente in adeguamento alle richieste controrivoluzionarie dello Stato. La loro funzione è oggi quella di rendere credibile, almeno per le fasce più sensibili, il processo di ristrutturazione in corso, spegnendo i pericolosi tentativi di azioni di attacco isolate e assolutamente in disaccordo con ogni tipo di rappresentatività sindacale.
Le antiche critiche al sindacato (anche rivoluzionario) sono oggi ancora più pregnanti in quanto aumentano di gravità nella prospettiva di questa nuova richiesta che il nemico avanza, cioè la compartecipazione al mantenimento della pace sociale. Lo Stato è disponibile a dare ascolto alle richieste sindacali, quasi certamente nei prossimi anni anche alle richieste delle microscopiche centrali anarcosindacaliste, vuole però che si controllino i gruppi minoritari che non accettano la logica rivendicativa, vuole in cambio il controllo del movimento rivoluzionario reale. È nella logica sindacale accettare questo scambio. In caso contrario occorrerebbe gettare a mare il sindacato e tutte le lotte rivendicative nel campo del lavoro, occorrerebbe indirizzarsi verso i nuclei autonomi, la conflittualità permanente e, quindi, verso la lotta vera e propria.
Su questo argomento bisognerebbe vedere meglio la funzione che ha svolto, in questi ultimi anni, la CNT in Spagna, le sue prospettive e la sua situazione attuale.
Nel campo di un sindacalismo cosiddetto di attacco, occorrerebbe anche vedere con maggiore chiarezza la funzione svolta in Polonia da “Solidarnosc” e in che modo siano stati controllati dapprima e repressi poi tutti i tentativi spontanei di attacco all’ordine costituito a partire dalla realtà produttiva delle fabbriche.
Allo stesso modo sarebbero necessarie documentazioni in merito alla funzione controrivoluzionaria del movimento delle nuove comuni, delle tendenze vegetariane ed ecologiste, dei movimenti dell’antipsichiatria e, in genere, di ogni tendenza che cerchi di settorializzare il contrasto reale contro il potere o cerchi di ridurlo al solo aspetto del dissenso platonico e di principio.
Esiste, ad esempio, un antirazzismo che sconfina spesso nel razzismo, una serie privilegiata di popoli che vengono posti in una luce esclusivamente positiva la quale finisce per coinvolgere – spesso senza accorgersene – anche le politiche guerrafondaie e razziste che i governi di quei popoli, in nome loro, propugnano e realizzano. Gli Ebrei sono uno di questi popoli. Non c’è dubbio che la politica aggressiva di Israele non è stata sufficientemente inquadrata sotto l’aspetto del razzismo di ritorno, mentre molte decisioni di questo Stato, il quale pretende rappresentare il popolo ebraico, sono esse stesse decisioni razziste. In tale prospettiva le posizioni classiche dell’antirazzismo finiscono per diventare funzionali alle nuove forme di razzismo e consentono di aprire la strada a interventi repressivi accettati come inevitabili.
Per un altro motivo possiamo considerare funzionale al potere ogni elemento formale di dissenso, ogni tentativo che si limiti a dividere lo scontro di classe in tanti settori e, all’interno di ognuno di essi, a prendere posizione “contro”. È proprio quello che vogliono il capitale e lo Stato.
A cadere in questo equivoco sono compagni in buona e cattiva fede.
I migliori, quelli in buona fede, sono soltanto poco informati o semplicemente stupidi per mancanza di capacità analitiche. Sono quelli che ritengono oggi utile una lotta per l’amnistia, che si limitano alle grandi dichiarazioni di principio contro i missili a Comiso, che sono astensionisti ogni qual volta cade la scadenza delle elezioni, o distribuiscono un volantino contro le carceri speciali per poi tornarsene nel proprio buco ad aspettare la prossima volta quando torneranno a ripetere il rito ormai sacralizzato dell’eternamente ovvio.
I peggiori, quelli in cattiva fede, sono gli scettici che hanno perso l’entusiasmo di una volta perché hanno capito tutto della vita, e gli arrivisti che cercano di guadagnare il proprio orticello di potere e seminarvi i propri intrallazzi. Da un lato i superintelligenti che guardano dall’alto in basso chi si limita a continuare la lotta, dall’altro coloro che fanno carriera andando a baciare la mano dei socialisti o dei cattolici del dissenso. La nausea che mi prende guardando i primi è pari soltanto a quella che sento vedendo agire i secondi. C’è modo e modo di guardarsi l’ombelico o di fare carriera, ma questi modi sono fra i peggiori.
Alla nuova controrivoluzione che avanza cercheremo di opporre le nostre modeste forze. Prima di tutto un approfondimento analitico.
È tempo ormai di smetterla con le incertezze e con i pudori. È tempo di dire le cose fino in fondo. L’offerta che lo Stato ha fatto a molti compagni (anche dal glorioso passato) è molto allettante. Speriamo che alcuni di loro non accettino e che anche questo libro possa contribuire a farli riflettere.
La lotta è altrove. Le belle dichiarazioni da consegnare alla storia non bastano più, anzi sono diventate merce di scambio per il potere. Occorre seriamente impegnarsi in una nuova lotta, organizzata ad efficace, munita di un progetto rivoluzionario e capace di individuare obiettivi e mezzi di realizzazione.
[Per il parafrafo I contorni del quadro generale cfr. “Di alcuni problemi fra i tanti”, pubblicato su “Anarchismo” n. 21, maggio-giugno 1978, pp. 137-147. Per il paragrafo Verso le nuove forme della controrivoluzione cfr. (Alcuni compagni) “Verso le nuove forme della controrivoluzione”, pubblicato su “Anarchismo” n. 43, giugno 1984, pp. 20-22. Lo stesso articolo è stato pubblicato anche su “Insurrection”, n. 2, agosto 1984, col titolo: “New forms of counter-revolution”]
Sull’organizzazione clandestina
Continuando nella critica delle organizzazioni combattenti staliniste e leniniste, ci sembra interessante chiarire ancora alcuni punti prendendo anche spunto dall’analisi del documento più ampio redatto da Azione Rivoluzionaria (Appunti per una discussione interna ed esterna):
a) non è vero che l’organizzazione clandestina chiusa abbia come alternativa solo il ritorno a vecchie forme, sia pure rispettabili, di individualismo,
b) non è vero che analizzare questo problema, quindi criticare un certo modello organizzativo, corrisponda ad un indebolimento del movimento rivoluzionario,
c) non è vero che con il concetto di “generalizzazione” della lotta armata si intenda la negazione dell’organizzazione,
d) non è vero che il rifiuto del modello chiuso di organizzazione, o se si preferisce del modello tradizionale, comporti automaticamente un “esporsi ad un massacro”,
Se non si discute il fatto che le strutture organizzative sono indispensabili perché in caso contrario, sul piano pratico-militare, si va incontro ad un disastro, è viceversa più che discutibile il fatto che sia una di queste strutture (o un gruppo di strutture) a “vincere”, e che la cosa abbia aspetti positivi solo perché queste formazioni corrispondono a raggruppamenti non leninisti. A vincere deve essere il proletariato armato, l’insurrezione e la rivoluzione delle masse, non le minoranze organizzate in strutture specifiche che, per la naturale conseguenza delle ideologie e della stessa distribuzione dei rapporti di produzione, saranno sempre piuttosto differenti le une dalle altre (anche all’interno della stessa matrice “non leninista”). E la vittoria delle masse insorte sarà non un accadimento accidentale, un fatto che viene dal caso o dalla determinazione automatica dei processi di sfruttamento; quanto invece un progetto che si costruisce giorno per giorno, con la ribellione immediata, con la generalizzazione dello scontro, con l’azione delle minoranze armate e con la critica.
Non è vero che abbiamo negato validità all’organizzazione armata, ma abbiamo detto – riteniamo con sufficiente chiarezza e in diverse occasioni – che essa non è tutto. “Dare una risposta alla questioni decisive della rivoluzione” non significa necessariamente partire dal rafforzamento di una specifica organizzazione clandestina anarchica, anche se consideriamo di estrema importanza la costituzione di una struttura di questo tipo. Per chi voglia cogliere una contraddizione in tutto ciò, ricordiamo che il nostro scopo non è la conquista del potere, ma la lotta contro il potere per la sua eliminazione definitiva ed immediata. Ne consegue che, se nel corso di questa lotta di lunga durata, siamo obbligati ad utilizzare strumenti, come le organizzazioni clandestine (appunto per evitare di restare schiacciati subito o perché la situazione non consente alternative immediate), ciò non vuol dire che abbiamo esaurito il nostro compito nel rafforzare queste organizzazioni, spingendole fino al punto che diventa possibile capovolgere il rapporto di forza esistente sia con le strutture leniniste, sia col potere in carica.
Va da sé che se non ci interessa la “vittoria” delle organizzazioni clandestine anarchiche, non siamo, per questo, partigiani di una loro sconfitta. In effetti, fin quando si avrà necessità di questa forma di lotta organizzata, dovremo batterci per costruirla e rafforzarla, ma nel momento decisivo, nel momento in cui dalla fase dello stimolo rivoluzionario si passerà alla fase dell’insurrezione e della rivoluzione, il nostro obiettivo non sarà più quello, ma ci rivolgeremo al rafforzamento delle forme di lotta che la massa insorta vorrà darsi. Qualsiasi cosa possa avere affermato in merito Mackno, mi sembra che oggi, dopo l’esperienza ucraina e l’esperienza spagnola, questo punto deve essere discusso più accuratamente di quanto non si possa fare partendo dalle dichiarazioni (a posteriori) di Mackno, o (a caldo) di Durruti.
Col nostro concetto di generalizzazione dello scontro, anche armato, non intendiamo (come qualcuno ha voluto capire) la negazione di ogni struttura organizzativa per lasciare che tutto cresca spontaneamente. Non intendiamo affidarci alla buona volontà orizzontale dei compagni. Ma, al contrario, critichiamo le intenzioni di chi eventualmente vorrebbe ricondurre a obiettivo di tutto un movimento una semplice sigla o una specifica struttura.
Dopo le dure lezioni di questi ultimi anni non abbiamo persa la fiducia nella funzione di un’organizzazione clandestina anarchica capace di assolvere ai suoi compiti e priva di velleità che non le possono essere proprie. Ma queste strutture non nascono per la buona volontà di pochi individui. Si sviluppano quando le condizioni oggettive dello scontro le richiedono. Allora, però, la volontà, anche di pochi individui, diventa elemento fondamentale. Ne deriva che è d’importanza assoluta stendere per tempo una serie di rapporti che possano consentire il reperimento di quelle affinità indispensabili per la costruzione di una struttura che non sia il semplice portato di alcune dichiarazioni ideologiche.
Il punto di massima efficacia rivoluzionaria si dovrebbe quindi cogliere nel momento in cui queste strutture saranno capaci di esportare il proprio potenziale rivoluzionario all’esterno, contribuendo, insieme ad altre componenti, alla costruzione delle situazioni insurrezionali e quindi alla successiva generalizzazione dello scontro.
La coordinazione di questo lavoro, il superamento di mille equivoci, l’approfondimento della critica, sono cose molto più importanti della semplice crescita e del rafforzamento di una organizzazione clandestina anarchica.
[Cfr. “Sull’organizzazione clandestina”, in “Anarchismo” nn. 26-27, marzo-giugno 1979, pp. 141-144. Per il documento fondamentale di “Azione Rivoluzionaria” cfr. “Contributo per un progetto rivoluzionario libertario” in “Anarchismo” n. 25, gennaio-febbraio 1979, pp. 3-27. Lo stesso documento, con le modificazioni riguardanti il testo pubblicato dalla rivista “Controinformazione”, in Azione Rivoluzionaria, Contributi alla critica armata libertaria, Edizioni Anarchismo, Catania 1980, pp. 40-90. Seconda edizione, Trieste 2000, Terza edizione, Trieste 2013. Inserito anche in Aa.Vv., L’ipotesi armata, Edizioni Anarchismo, Catania 1984]
Strategia del potere e scontro di classe
La strategia del potere come fatto unitario
Il progetto repressivo del potere si sviluppa con una organicità che non si era mai vista in passato. Si tratta di una coerenza di fondo che rende fortemente centralizzato, nella realtà, un dominio che si esprime in forme decentrate, nell’ideologia.
L’essenza di questo nuovo tipo di fascismo è data dal non aver più bisogno dei fronzoli della forza fittizia, in quanto possiede le basi della forza reale che può camuffare da libertà fittizia.
Il capitale, radicandosi nella sua realtà, considera superate le metodologie dell’estrazione forzata del guadagno, della miseria come garanzia dell’accumulazione. La violenza repressiva emerge per altra via, come differenziazione all’interno della divisione di classe, come temporaneità e inefficienza di un dominio che si proietta verso la totalità e contro cui bisogna combattere prima che sia troppo tardi, prima cioè che il processo di criminalizzazione e ghettizzazione venga suggellato in modo irreversibile.
Nella fase di assestamento, fase che è tuttora in corso, si manifestano contraddizioni potenti all’interno della strategia del potere, ed è su di queste che bisogna fare leva per spezzare il progetto repressivo. Se la tesi della riduzione al mero sostentamento per garantire il massimo tasso di profitto è tramontata, ciò non significa che il socialprotezionismo sia diffuso in forma omogenea. Il punto finale del progetto capitalista sarebbe quello di chiudere i valori contraddittori, merce-denaro e produzione-consumo, all’interno di una dimensione capace di ripresentare l’estrazione del profitto in forma modificata, non accumulazione del capitale, ma persistenza delle condizioni oggettive del potere, condizioni di pace sociale. Spogliandosi delle instabilità dei flussi del tasso di profitto e delle accumulazioni, il capitale si ripropone a un livello più rarefatto, e quindi più omogeneo, il livello del potere puro. A questo livello il tasso di profitto diventa solo uno degli elementi di un complesso insieme che si potrebbe definire produzione della pace sociale, accumulazione di potere in termini di rarefazione del conflitto di classe.
In una situazione produttiva in cui le merci avevano il loro significato primario di mezzi per soddisfare bisogni, il capitale viveva la sua stagione fittizia attraverso la merce di “raccordo”, cioè il denaro. In una situazione produttiva in cui le merci diventano significative solo perché indirettamente garantiscono la produzione di una ulteriore merce, la pace sociale, la stagione del capitale perde la sua frammentarietà, il suo legame con le vicende alterne del tasso del profitto, per radicarsi realmente nel potere, in una rarefazione assoluta che minaccia di diventare inattaccabile se non si agisce subito e nel modo più deciso.
La gestione dell’economia generalizzata
Al progetto unificante sopra descritto corrisponde una gestione politico-amministrativa del potere che si può definire di economia generalizzata. Non esiste più, o tende a scomparire definitivamente, una distinzione tra gestione del potere politico e gestione economica. L’assorbimento dell’economia all’interno della struttura di potere, ha trasformato questa e quella. Ha reso diretta al mantenimento del potere anche l’economia che prima svolgeva solo una funzione indiretta. E, nello stesso tempo, ha trasformato l’obiettivo dell’economia, che dall’accumulazione del profitto si è orientato verso il mantenimento del potere.
Ciò consente l’impiego generalizzato del modulo socialprotezionista. Lo Stato interviene nella produzione, produce in proprio. Lo Stato intervenire nella gestione politico-amministrativa, gestisce in proprio. Al massimo grado dell’accentramento reale del potere corrisponde il massimo grado di decentramento formale. Partiti, sindacati, fabbriche, scuole, campagne, quartieri, dibattiti, referendum, giornali, opinioni, chiacchiere, pornografia, sport, tutto subisce un processo di liberalizzazione esattamente corrispondente al processo di perfezionamento del controllo. Meglio si riesce a coordinare le forze dell’organizzazione politico-amministrativa e dell’organizzazione produttiva e più si può dare loro un aspetto formale di libertà, purché restino all’interno del progetto riproduttivo del dominio di classe. Uscendo da questo progetto la repressione è tanto più violenta e feroce quanto più la trasgressione agli stessi creatori del progetto del dominio totale appare come impensabile e pazzesca.
In una gestione di economia generalizzata la lotta e l’attacco proletari sono distruzione del progetto totalizzante del capitale. L’attacco contro il lavoro, contro la sacralità della produzione, contro le strutture produttive, contro gli uomini del potere, contro i servi del potere, contro l’ideologia del rinvio all’infinito della lotta, per la costruzione di una strategia di vita che spezzi i condizionamenti e sviluppi la creatività e la gioia, tutto ciò è produzione di distruzione, è produzione di guerra sociale.
Riprendere in mano le condizioni della propria esistenza
Ma per fare ciò bisogna possedere una grande dote, la coerenza rivoluzionaria. Al di là dei flussi e dei riflussi, delle mode e degli allettamenti del potere, la lotta contro l’oppressore si ripresenta sempre identica nella costante varietà delle sue modificazioni. Siamo più spesso noi che ci stanchiamo e ci scoraggiamo. Più spesso siamo noi che cerchiamo i segni di quei colpi dati in passato, e non essendo capaci di rinvenire crepe e cedimenti, ci abbandoniamo all’ineluttabilità del dominio. È proprio su questo che fa affidamento il nostro nemico, sulla mancata coerenza, sulle paure e sullo scoraggiamento.
Retrocedendo crediamo di andare alla radice dei problemi più vicini a noi, di cogliere le condizioni della nostra esistenza, ma non ci accorgiamo che nel microcosmo dei nostri fatti personali quello che si riflette è solo la conflittualità dello scontro di classe. Crediamo di avere trovato una soluzione costruendo una piccola nicchia dove rinchiuderci con le nostre paure e i nostri problemi.
Spesso la lotta sembra prendere le forme della ripetizione, inutile e vana. Il potere riesce a bloccare tutte le iniziative, ci toglie man mano gli strumenti che ci siamo costruiti con fatica, rinchiude nelle carceri e uccide i compagni, rende tutto uniforme e opaco. Allora ci sentiamo inefficienti e stupidi ripresentando sempre il nostro obiettivo, le nostre analisi, i nostri strumenti. Ma è proprio in quel momento che dobbiamo renderci conto che non solo la continuazione della lotta e l’invenzione di sempre nuovi strumenti sono le condizioni per non venire definitivamente cancellati, ma costituiscono il più grosso ostacolo al progetto egemonico del potere. È proprio ciò che la nostra capacità di continuare significa, un punto di riferimento per tutti gli sfruttati e il segno che la vittoria del capitale non è ancora definitiva e che tutto può essere rimesso in discussione. E nel ripresentare intatta e rinvigorita la nostra volontà di lotta riprendiamo realmente in mano le condizioni della nostra esistenza di uomini e di rivoluzionari.
Il movimento rivoluzionario
L’espressione organizzativa delle lotte proletarie si riassume nel movimento rivoluzionario. Le contraddizioni interne ad esso sono di vario genere ma principalmente di due tipi: a) quelle derivanti da un diverso progetto; b) quelle derivanti dal tentativo di una parte di egemonizzare il tutto. È chiaro che le prime sono produttive di stimoli positivi, in quanto concorrono a sviluppare un dibattito sui metodi da impiegare, i mezzi da approntare e gli obiettivi da raggiungere. Le seconde sono semplicemente la squallida espressione di uno stalinismo fuori del tempo che ha continuato ciecamente a riproporre modelli del passato col terrorismo intellettuale tipico dell’ortodossia.
Per lo sviluppo futuro della lotta rivoluzionaria è indispensabile denunciare i limiti e i pericoli dell’azione di chi persegue un’egemonia mortale e stupida, corrispondente a una errata considerazione della realtà del movimento rivoluzionario. Quegli stessi motivi che appena ieri facevano commettere errori di prospettiva a molte organizzazioni combattenti, adesso portano al pentimento, alla dissociazione, alle richieste di amnistia e di condono.
Per chi considera l’insieme delle forze che lottano contro il dominio del capitale e lo sfruttamento come un tutto strutturato rigidamente, come una memoria della classe, capace in modo automatico di conservare il potenziale delle lotte, diventa logica la conquista di una egemonia all’interno dello “strumento”, perché suo tramite si realizza una egemonia sulla classe. Allo stesso modo diventa logica una “resa”, perché obiettivamente impossibili i traguardi che prima si consideravano realizzabili.
Per chi considera invece il movimento come l’insieme delle forze oggettive e soggettive, collettive e individuali, che lottano contro il dominio del capitale, insieme che ha bisogno della più larga capacità di sviluppo e di espressione e che svolge una funzione di raccordo della classe nel senso di un aumento della sensibilizzazione davanti alle iniziative del capitale e non nel senso di memoria statica, per chi considera così il movimento rivoluzionario, ogni tentativo di egemonizzazione di una sua parte a spese del resto significa castrazione e morte.
Ridare un senso unitario alla molteplicità delle lotte
Rifacendo all’indietro il cammino repressivo del capitale si possono individuare ed attaccare tutti i punti fermi, tutte le conquiste del dominio, ribaltando una logica totalitaria che concedendo riprende e sigilla, che decentrando e democraticizzando riassorbe all’interno dello Stato il dominio reale del capitale.
Il progetto rivoluzionario si contrappone così al progetto della pace sociale. Come progetto di guerra deve attaccare nei singoli punti in cui la guerra sociale si combatte, quindi deve disperdersi per poi ritrovarsi. Deve spezzare il fronte degli interventi ma non deve dimenticare che solo un senso unitario può dare significato rivoluzionario allo scontro di classe. Le lotte nelle fabbriche contro l’automazione e la ristrutturazione, contro i licenziamenti e la cassa integrazione, contro la mobilità e il decentramento produttivo, le lotte per la casa, nella scuola contro la chiusura degli spazi conquistati, la denuncia e le lotte contro il sindacato e i partiti, la denuncia del ruolo e dell’evoluzione della magistratura, della polizia, della mafia, la denuncia degli accordi repressivi internazionali, l’analisi e l’attacco contro la nuova repressione militare, contro gli strumenti della comunicazione di massa, le lotte nelle carceri, tutto ciò si ricompone e assume un senso unitario e profondo nel progetto complessivo del movimento rivoluzionario.
I nuclei autonomi di base
Strumento minimo d’intervento nella realtà delle lotte, il nucleo autonomo si adatta perfettamente alla settorialità degli interventi e costituisce il rapporto organizzativo più indicato a ricomporre l’insieme delle lotte in una dimensione unitaria complessiva.
È stato uno strumento che ha dato risultati positivi ma ha incontrato l’ostacolo della sua anima sindacalista rivoluzionaria, cioè la rivendicazione. Oggi, in un clima mutato, forse può riproporsi meglio come strumento di attacco, singolo mattone di un edificio perennemente in costruzione.
Ma questo mattone deve avere caratteristiche precise. Lo scopo che ci proponiamo è ancora la rivoluzione. Le nostre lotte, per quanto settoriali e parziali, come abbiamo detto, debbono assumere un senso unitario proprio nella ricerca dell’obiettivo rivoluzionario. Ma questa ricerca non può essere solo un fatto verbale, deve andare nel concreto.
E la realizzazione del processo rivoluzionario in concreto non può essere fatta diversamente che come intervento costruttivo della minoranza agente. Il nucleo autonomo svolge così il compito di minoranza, sia nel partecipare alle singole lotte, sia nel dare loro una omogeneità in vista del progetto rivoluzionario.
Lotta rivoluzionaria e insurrezione
Non è un problema terminologico. Tutta la seconda parte di questo lavoro che, come abbiamo detto, per motivi editoriali, ha trovato sistemazione in un volume separato (Teoria e pratica dell’insurrezione, seconda edizione. Trieste 2003) è dedicata a questo argomento. Quando parliamo di rivoluzione dobbiamo considerare che la costruzione reale delle condizioni che la rendono possibile passa attraverso tentativi parziali. In fondo, anche la singola lotta settoriale è un tentativo di realizzare la rivoluzione, ma non é sufficiente. Ad un livello superiore si colloca il tentativo insurrezionale, sia come sbocco della lotta stessa, sia come tentativo minoritario diretto a colpire uomini, beni e progetti del capitale.
L’insurrezione è l’elemento che rende possibile la rivoluzione, la prepara anche quando fallisce come tentativo isolato, anche quando finisce per determinare un acutizzarsi della repressione. Senza questo doloroso e sanguinoso processo, senza una lunga serie di tentativi, la rivoluzione resta un mito e un sogno.
Sono dell’opinione che è meglio un’insurrezione fallita che molti tentennamenti i quali fanno sfumare l’occasione buona per fare esplodere le condizioni rivoluzionarie. Sono anche dell’opinione che il movimento ha ancora notevoli capacità in questo senso e che gli ostacoli più gravi gli vengono non dalle sue limitatezze in uomini e mezzi, ma dalle perplessità di coloro che si sono arrogati il diritto di dichiarare sconfitta una lotta che non poteva non essere di lungo periodo.
Dopo tutto l’uccello di Minerva esce solo quando calano le tenebre.
[Cfr. “Strategia del potere e scontro di classe”, in “Pantagruel” n. 3, ottobre 1981, pp. 66-78. Si tratta del testo dell’intervento al Convegno sulla repressione tenuto a Milano il 30-31 maggio 1981. Una ristretta tiratura ciclostilata di questo articolo è stata distribuita nel corso del Convegno. Lo stesso è stato pubblicato in Atti del Convegno sulla repressione, Milano 30-3l maggio 1981, Milano 1981, pp.19-20].
Contro la pace sociale
Decentramento e progetto egemonico
Come abbiamo detto nel capitolo precedente oggi [1981], in Italia, siamo davanti a una reale situazione di regime fascista. La gestione del capitale viene impostata con l’intervento correttivo dello Stato e sulla base di concrete possibilità di recupero e ristrutturazione. La dimensione economica diventa quindi generalizzata, e ciò proprio nel momento in cui perde la sua vecchia centralità, almeno nell’aspetto dell’operaismo classico.
Non sarà mai detto abbastanza sulla funzione che hanno avuto i sindacati in questo periodo. Proprio quando sembra che abbiano perso una parte del loro potere contrattuale, obbligati ad accettare una grave imposizione sulla scala mobile, sono all’apice della funzione di recupero che storicamente hanno sempre assolto. I sussulti del movimento autonomo sono praticamente spenti. Covano invece le potenzialità. Ma questo è un altro discorso. Chi aveva avuto l’impressione che il potere si dividesse tra capitale e servi del capitale, deve disilludersi. Chi è nato servo tale morirà. I sindacati hanno un vasto potere, ma sempre subordinato all’operatività del capitale, e la riassunzione di questo meccanismo avviene attraverso due poli, uno (esterno) dato dal controllo politico esercitato dai partiti della sinistra, l’altro (interno) dato dal fatto che il movimento di base, una volta svenduto, non può più essere usato come elemento di pressione.
Questo modello d’intervento repressivo e di controllo delle forze intermedie di gestione, è visibile nella scuola. Qui le possibilità operative di ieri (movimento degli studenti, comitati di lotta, gruppi politicizzati, ecc.) si sono ristrette a causa di due fenomeni, accettazione del controllo interno da parte della struttura scolastica (incapacità di ribaltare l’astratta negazione della meritocrazia sul piano concreto dell’attività lavorativa) e rivalutazione di un professionalismo che però viene limitato a piccoli gruppi, dopo che la grande massa era stata sottoposta per anni ad un incredibile processo di “ignorantizzazione”. Il privilegio reale che così si è venuto a costituire per una ristretta minoranza con maggiore professionalità, serve da elemento di ricatto per la massa studentesca, a sua volta terrorizzata dal dilagante fenomeno della disoccupazione giovanile, e apre la strada al controllo delle forze intermedie (strutture scolastiche, sindacati, partiti, movimenti di sinistra, ecc.). A loro volta queste strutture non possono contrapporsi al progetto egemonico del capitale, neanche in nome di una loro reale area di potere, proprio perché non hanno l’uso di quel movimento di massa che esse stesse hanno distrutto.
Un problema simile si è aperto per il settore delle comunicazioni di massa. Irregimentando la totalità della stampa all’interno di un regime di controllo diretto, si è ottenuto il grosso risultato di dare al fascismo in atto quella patina di democrazia di cui ha bisogno per non sconvolgere larghi strati sociali abituati a subire, ma non abituati ai simboli stomachevoli di un fascismo esteriore ormai superato. Ma la falsificazione di massa delle notizie non sarebbe stata possibile se non fosse stata preceduta da un decentramento fittizio del potere decisionale riguardo l’elaborazione e la diffusione delle notizie stesse. Qui risiede l’essenza del nuovo regime fascista. Teoricamente si è potenziata la struttura della comunicazione di massa, finanziando partiti e capitalisti, petrolieri e magnati dell’industria, perché ognuno potesse dar aria al proprio giornale, televisione o radio, con l’affermazione fatta ai quattro venti che ciò serviva per un più ampio pluralismo delle opinioni e un dibattito più aperto verso il grande pubblico. In realtà la cosa è servita a legare maggiormente le varie situazioni produttive del settore al centro del potere reale. Ne risulta pertanto una effettiva indipendenza quando si tratta di situazioni che non possono danneggiare il grande Leviatano, ma una sottomissione assoluta, in alcuni casi addirittura incredibile, quando si toccano i settori più delicati, come ad esempio quello della repressione contro le fasce in corso di criminalizzazione.
Questo modello di gestione fascista, che possiamo definire decentrato-accentrato o modello di economia generalizzata, cioè capace di inserire le regole del processo economico nel più ampio raggio d’azione del processo sociale, presenta una grande utilità per il dominio reale che il capitale vuole portare a conclusione, esso dà la possibilità di un controllo piramidale immediato, capace di agire, attraverso una serie di controlli intermedi, delegati ma non autonomi, pervenendo ad un controllo generalizzato della base. In una fase internazionale che cerca di chiudere ogni scompenso perfezionando i sistemi settoriali produttivi di pace sociale, non sarebbe stato possibile un progetto di potere che mettesse in pratica un decentramento effettivo. In questo il Partito Comunista, con la sua doppia faccia di decentratore ideologico e accentratore pratico, rappresenta la punta più avanzata, lo strumento più efficace nelle mani del capitale, la chiave per garantire il passaggio al dominio reale.
Ulteriori probabili incrementi repressivi faranno gridare sempre meno alla scandalo, via via che verrà interiorizzato il modello fascista in corso di perfezionamento, purché questi interventi si facciano verso una fascia criminalizzata e vengano accoppiati con apparenti processi di liberalizzazione.
Lo Stato come grande azienda produttiva della pace sociale non ammette filiali, succursali e dipendenze, non tollera concorrenze. Il centro decisionale del potere tende a restringersi man mano che ci si avvia dal dominio formale al dominio reale del capitale. Per assurdo, possiamo dire che nel fascismo vecchio stampo, in cui si aveva per corrispettivo un dominio ancora imperfetto (formale) del capitale, il potere era molto più decentrato (realmente) di quanto non lo sia ora, in un fascismo di nuovo stampo che ha come corrispettivo un dominio del capitale meno imperfetto e quindi molto più reale.
Il tramonto della merce
È in corso di realizzazione, da parte dello Stato e dei cosiddetti padroni dell’economia, un progetto di trasformazione radicale dei rapporti sociali. Le tecniche dello sfruttamento, così come sono state approntate in questi ultimi anni, stanno subendo ampi perfezionamenti. Il capitale si trova davanti a nuove difficoltà nel mantenere un tasso, sia pur minimo, di profitto. Ciò accade sia nelle grandi strutture produttive che in quelle intermedie. Da qui la necessità dell’intervento statale. Oggi la strada verso cui si pone questo intervento è quella del controllo totale. Non la repressione totale, ma il controllo. L’ideale di Stato moderno non è quello totalitario, ma la democrazia, lo Stato che si decentra sempre più per spezzare all’infinito la macchina del potere.
Come abbiamo visto la chiave di questa operazione si trova, in Italia, nelle mani del Partito Comunista.
Nello stesso tempo avviene, all’interno del processo produttivo, una modificazione sostanziale, il tramonto della merce. Per dare la massima libertà apparente ecco uscire dalla dimensione del passato, dalla penuria, dalla miseria, dalla legge dei salari. Ma ciò non può realizzarsi senza un opportuno progetto economico dello Stato, perché l’economia non è più un fenomeno separato, essa si è generalizzata. La paura della grande crisi aveva fatto aprire gli occhi, ben prima della seconda guerra mondiale, su quelli che potevano essere i rischi del mito del “lasciar fare”. E, con ciò, finiva il mito liberista, nascendo, sulle basi teorizzate da Keynes e da altri economisti, il progetto di uno Stato nuovo che interviene nel processo produttivo abbinando lo strumento della produzione allo strumento politico-amministrativo. Oggi assistiamo a un notevole livello di realizzazione dello Stato economista mentre tramonta lo Stato “cassiere”, lo Stato semplice cane da guardia dell’economia.
Ora, se lo Stato diventa economista, se produce in proprio, se controlla, se dirige il processo economico, è chiaro che il passo tra produzione e amministrazione, tra economia e politica si accorcia. Accorciandosi, il capitale è costretto a seguire la direzione del progetto che si riassume nel controllo totale. La merce non è più diretta allo scopo per cui fu inizialmente prodotta, cioè a soddisfare bisogni, e vede quindi diminuire il suo valore d’uso. Ma di fronte a questa riduzione non si ha un corrispettivo aumento del valore di scambio. L’intero meccanismo capitalista, al di là dell’aspetto spettacolare della pura e semplice sottrazione di tempo agli sfruttati per impedire loro qualsiasi altra attività, non ha più significato. L’accumulazione si è trasformata in mito, svaporandosi nell’inutilità dei reciproci saldi contabili. Quello che cresce è un altro tipo di valore d’uso, fornito dalla produzione di un’altra merce, una merce che possiamo definire pace sociale. Ogni singola merce oggi viene prodotta non per soddisfare bisogni ma solo per rendere possibile la produzione di una ulteriore merce, un immane processo produttivo cui tutte le singole merci partecipano. Certo, ogni singolo oggetto prodotto non ha perso del tutto il suo significato d’uso, ma quest’ultimo si va riducendo progressivamente. Il più delle volte viene mantenuto in vita, a livelli minimi, con accorgimenti spettacolari. Il resto è attestato in una nuova capacità. Il bisogno che si soddisfa non è quello del consumatore, ma quello del produttore. La grande arte del secondo è di far credere al primo che il bisogno sia suo e che la merce acquistata provvede a soddisfarlo.
Alla fine il capitale si unisce completamente allo Stato, il controllo diventa pace sociale, la produzione diventa produzione di pace sociale, l’amministrazione e il decentramento diventano le premesse per l’accentramento definitivo in vista del controllo.
Fortunatamente si tratta solo di una tendenza. Compito del rivoluzionario è quello di inserirsi in questa tendenza, spezzarne i fili (che sono moltissimi e minuti). Il progetto dello Stato, infatti, pur sviluppandosi nella perfezione dell’utopia capitalista, se è perfettamente logico dal punto di vista dei teorici del dominio, non è realizzabile. La principale ed insanabile realtà resta sempre quella tra sfruttati e sfruttatori. Il capitale può superare le sue contraddizioni (persistenza del profitto, necessità imprenditoriali, incapacità di razionalizzare il decentramento in tempi utili, imperfezioni tecnologiche, ecc.), ma non può superare le tante contraddizioni umane. In fondo l’elemento umano, anche nei momenti di maggiore sconforto e cedimento, ha una caratteristica costante, pone ostacoli di ogni tipo allo sfruttamento.
Ciò vuol dire che dobbiamo considerare centrale lo spazio produttivo? Dobbiamo ancora parlare di centralità della classe operaia? Certamente no. Non l’abbiamo fatto in momenti in cui la faccenda era di moda e non c’è motivo di farlo proprio ora. Ma questa negazione non significa il rigetto del fondamentale discorso di classe, purché si parta dall’individuo come soggetto sovversivo.
Esistono in circolazione molte varianti dell’interpretazione dello scontro di classe e della centralità operaia, ma sono tentativi di penetrare con iniezioni di soggettività all’interno di un marxismo che non può e non riesce a fare a meno del mito centralista, del mito dello Stato che si usa, del mito della dittatura del proletariato. Con queste spinte alla soggettività, specie in un momento di riflusso e di disillusione, si vuole dare coraggio e infondere una fiducia nei supremi destini del proletariato. In fondo è questo uno dei compiti dell’ideologia e del partito.
C’è un fatto però, molto semplice, nessun salto hegeliano, nessun gioco metafisico può negare la partecipazione della classe operaia al processo capitalista. Il capitale, senza la classe operaia, non esiste. Il fatto che la classe operaia producendo capitale produca contemporaneamente la negazione di quest’ultimo, è un salto qualitativo non provato, un salto che ha bisogno di un ulteriore puntello. I puntelli comunemente usati sono tutti di tipo soggettivistico.
È curioso notare che molte volte nelle polemiche fra chi è più soggettivista e chi lo è meno, l’accusa di anarchismo viene rimbalzata dall’uno all’altro lato. È il marxista che accusa il fratello marxista, il quale si è permesso di dare un poco di spazio al soggettivismo, di essere anarchico, confusionario, ecc. È una variante della tipica arma marxista con cui si intende intimidire tutti coloro che non sono “socialisti scientifici”.
In effetti non è che la classe operaia non esista più a causa della cassa integrazione o delle strutture partitiche e sindacaliste che la imbrigliano nelle sue capacità di attacco. Il fatto è che essa ha subito una trasformazione radicale a seguito della stessa trasformazione del capitale. Se il capitale non riesce a mantenere il tasso di profitto, anche la classe operaia si trasforma, in quanto quest’ultima è componente fondamentale del capitale. Le modificazioni profonde che il capitale subisce oggi sono anche modificazioni della classe operaia. L’inefficienza del capitale nel produrre profitto, corrisponde all’inefficienza della classe operaia nell’attaccare il capitale.
Per una maggiore chiarezza è quindi necessario che gli anarchici costruiscano un’analisi che sia capace di sbarazzarsi definitivamente di alcuni degli elementi marxisti che invece restano disseminati dovunque. In modo particolare ciò accade per l’analisi economica. Non è vero che si possono “usare” le analisi economiche che i marxisti hanno costruito e si accingono a costruire. In questo Bakunin sbagliava, quando considerava valide le conclusioni economiche di Marx. L’analisi economica marxista è strettamente consequenziale alla pratica marxista. Ma per avere risultati utilizzabili dobbiamo ancora lavorare a lungo.
[Per il paragrafo Decentramento e progetto egemonico cfr. “Lettera di un compagno della redazione catanese di ‘Anarchismo’”, in “Contrattacco”, aprile 1981, pp. 22-23. Per il paragrafo Il tramonto della merce ho utilizzato la registrazione su nastro di una mia conferenza tenuta alla Facoltà di Lettere dell’Università di Torino nell’aprile del 1981]
L’acqua sporca e il bambino
Il palazzo dei fantasmi
È vezzo corrente battersi con i fantasmi. Non che non esistano avversari concreti e ben individuati, solo che gli avversari stanno (per definizione) fuori di noi, mentre i fantasmi sono anche dentro di noi, nello scongiurare quelli degli altri, gettiamo sale e aglio anche sui nostri.
Ognuno di noi ha il suo bravo gruzzolo teorico da mettere a profitto. In tempi di svalutazione della teoria, il gruzzolo si è molto ridotto. I più ricchi hanno qualche idea meno peregrina e si vantano come di un tesoro da petrolieri, facendo spuntare, qua e là, dietro le quinte, affermazioni, citazioni, mazzate storiche e frustate analitiche. Ognuno giura sul proprio corano e non gli importa nulla di scendere un gradino più sotto, di verificare i fondamenti dei postulati teorici su cui giura, di indagare sull’origine degli stessi e sulla loro maggiore o minore validità. Basta assestare il colpo nel modo più netto, avanzare la propria tesi con la maggiore sicurezza possibile, e quindi esprimere una condanna senza appelli e un verdetto senza processo. Chi non è con noi è contro di noi. Ed è contro di noi non perché vuole esserlo veramente, ma perché non ha saputo cogliere fino in fondo la verità delle nostre analisi ed è finito per perdersi in posizioni “oggettivamente” errate. Da ciò deriva che essendo certa la coincidenza di verità e rivoluzione, le posizioni errate devono per forza essere controrivoluzionarie.
L’insieme di questi postulati, che si aggirano senza posa nelle nostre analisi, abita in un palazzo metafisico dove tutto è ora bianco e ora nero, non esistono colori sfumati, mezze tinte, e gli stessi colori fondamentali sono sconosciuti. I fantasmi non hanno mai dubbi sulla propria identità. Sono la verità, l’astratta verità del nulla che non trova mai modo di avere contraddizioni o ambasce.
Prendiamo il fantasma della politica. Lo si fa muovere come si vuole. Si hanno prigionieri “politici”, strutture “politiche”, movimenti “politici”, comitati “politici”; si ha la “politicizzazione” di alcuni soggetti che prima non lo erano, e si ha anche la “politica-in-armi” che intende egemonizzare il movimento per realizzare una rivoluzione “politica”.
Con lo stesso procedimento si costruiscono altri fantasmi. Ad esempio, ciò è accaduto con la lotta armata, che qualcuno ama scrivere “lottarmata”, che è anche meglio per chi si interessa di progetti fantastici. Questo fantasma ha avuto una sua vita assai curiosa. Ha rappresentato qualche volta una tendenza del movimento rivoluzionario, oppure una cosa oggettiva, altre volte invece si è trattato solo di un’ideologia, una visione politicamente inquinata della lotta di classe. In qualche altro caso ha anche rappresentato l’aspetto insurrezionale o della sovversione generalizzata. Spesso si è ridotto solo alla clandestinizzazione, al partito armato. Nel palazzo dei fantasmi le mascherature sono ininterrotte e sempre differenti.
Un altro bel fantasma è il “movimento” rivoluzionario che si muove secondo come vuole il burattinaio di turno. Ora è un povero infermo che ha bisogno della tutela della minoranza specifica, ora è un onnipotente demiurgo che mangia tutto come il sommo padre Urano. Ora, invece, è astioso alibi con il quale si vogliono rigenerare tutte le organizzazioni specifiche rivoluzionarie dando loro il crisma della purezza e la forza del senno proletario.
C’è poi la vicenda romantica del fantasma della “vita quotidiana”, misura di tutte le cose, di quelle che sono perché sono e di quelle che non sono perché, tanto, non sono. Questo fantasma ha un aspetto mondano, ma si tratta sempre di una maschera. Gioca e si diverte, ma ha l’occhio costantemente fisso sul quadrante storico della rivoluzione. Così finisce per avere un’aria bieca e contorta. Viene però presentato come lo strumento di misura dell’intensità rivoluzionaria. Guai a fare qualche cenno alla tragicità del quotidiano e del suo lasciarsi vivere, il fantasma rifiuta opportunamente simili complicanze e ripresenta la propria maschera, stereotipo contrapposto a quello della eccezionalità della clandestinizzazione, fantasma anche questo e non meno buffamente mascherato.
Inoltrandoci nelle sale del palazzo facciamo poi conoscenza con uno strano personaggio fantastico, si tratta del fantasma di un fantasma, bipolare creazione della fantasia di alcuni letterati in vena di ricostruzioni storiche. La ricetta per usare questo personaggio è facilissima. Si prende un dato concreto, storicamente accertato, ad esempio il dato della “rappresentazione”, e lo si prende nei due aspetti, specularmente contrapposti: quello di “rappresentazione della realtà” e quello di “mistificazione nella rappresentazione della realtà”, ambedue aspetti ugualmente lontani dalla trasformazione, che poi sarebbe il giusto luogo dello svolgimento della conoscenza. Una volta messi insieme i due aspetti, si accede al concetto di “spettacolo”, che è poi il fantasma (spettacolo) di un fantasma (la rappresentazione della realtà). Questo concetto può essere usato in diversi modi, come mistificazione che fa il potere per deformare i processi rivoluzionari di trasformazione della realtà, come struttura della stessa realtà nei termini imposti dal potere, e anche come struttura di quei processi che hanno la pretesa di liberare dal potere partendo da una dimensione sempre di potere (partito armato, ecc.). Viene accuratamente vietato l’uso del concetto di spettacolo nell’unico senso logico possibile, quello di visione parziale della realtà, e quindi come rottura del flusso complessivo delle contraddizioni del sociale. Sarebbe proprio quest’uso a impedire la proliferazione del fantasma spezzando uno degli specchi che ne riflettono l’immagine all’infinito. Si dovrebbe ricordare al situazionismo letterario (ma è mai esistito un situazionismo non letterario?), che il senso di “parzialità” è ineliminabile dalla dimensione dello spettacolo, proprio perché solo chi assiste da spettatore ad un aspetto della realtà non viene coinvolto se non appunto nei termini cristallizzati di spettatore. Se lo spettacolo da parziale dovesse diventare totale lo coinvolgerebbe in veste di attore e cesserebbe di essere spettacolo per diventare realtà.
Continuiamo il nostro viaggio nel palazzo dei fantasmi.
In un simile fantastico miscuglio fa bella figura il fantasma della “critica”, fantasma loquace e di molti interessi. Mette becco dappertutto, su tutto impone la propria opinione, taglia su misura e scorcia a occhio. È amico stretto di un altro fantasma – più dimesso e più schivo – il fantasma del “metodo”, che gli serve quasi da segretario, reggendo il moccolo di una pretesa complicità teorica, palleggiando una conoscenza reale che, appunto per i fantasmi, non ha significato, essendo fuori del mondo della concretezza. Il fantasma della critica è spesso indicato come “critica critica”, ma si tratta dello stesso personaggio che si vuole mettere in parte in cattiva luce illudendosi di riqualificarne solo l’aspetto della semplice critica. È un fantasma molto attivo, certe volte s’interessa di armi, ammazza, fa saltare in aria qualcosa, sequestra e giustizia, allora lo si definisce come “critica delle armi”, indicando un passaggio – all’interno sempre dello stesso ectoplasma – da alcune pretese “armi della critica” alla “critica delle armi”.
Al fantasma della “critica” viene attribuita la straordinaria facoltà di chiarire tutti i problemi, di penetrare in tutte le questioni, la realtà non ha segreti per questo profondo indagatore. Sa anche benissimo come essere “in sé” e come essere “altro da sé”. Sa, ad esempio, come rifiutare ogni identificazione con una certa realtà che si vuole negare. Per fare ciò gli basta negarla in modo “radicale” e la realtà scompare di colpo, come per incanto. Quale grande potenza hanno le facoltà critiche dei fantasmi!
Un tipico atteggiamento del fantasma della “critica” è quello di pretendere di sapere trovare subito il punto di vista “radicale” da cui esercitare la sua funzione. Di regola questo punto di vista ha una collocazione spaziale che lo vuole “al di fuori” della cosa su cui esercita la sua attività critica. Poniamo, la critica dell’economia è veramente “radicale” – secondo il modo di procedere di questo fantasma – solo quando viene esercitata “dal di fuori” dell’economia stessa, purché si sia sempre “al di dentro” delle esigenze e delle necessità dell’uomo. Questo essere “al di fuori” o “al di dentro” di qualcosa è comportamento tipico dei fantasmi che, come si sa, passano anche attraverso i muri e non hanno difficoltà a deambulare nello spazio. Le concretezze, invece, hanno da sempre grossi problemi per collocarsi “al di dentro” o “al di fuori” di qualcosa, in quanto hanno bisogno di un punto di riferimento che li individualizzi e non basta loro un astratto “essere in sé”.
Considerando nel suo insieme il palazzo dei fantasmi e riflettendo sulle caratteristiche dei suoi abitanti, c’è da dire che la regola prima di convivenza è che tutto quello che è reale deve tenersi lontano per essere “interpretato” alla luce della logica fantastica dell’impalpabile. Per far ciò lo si deve uccidere, anatomizzare, trasformare in un rudere di concretezza, in una realtà disfatta e molle, qualcosa che comincia a rassomigliare a quella materia inconsistente di cui, si dice, siano fatti i fantasmi.
Per questo risultato esiste un metodo universale.
Il metodo del macellaio
Il macellaio ha un metodo suo, che gli consente di vendere carne a piccoli pezzi, secondo il taglio e la qualità, soddisfacendo i gusti dei vari acquirenti. A chi chiede filetto egli serve filetto e a chi chiede dietrocoscia egli serve dietrocoscia. Di regola si astiene dal tenere ai singoli acquirenti una conferenza sull’origine e il significato dei vari pezzi di carne che affetta e incarta, una volta che si trovavano nell’insieme vivente chiamato bue. La cosa, difatti, susciterebbe scarso interesse nei clienti e non farebbe alzare le vendite. Il metodo del macellaio, di squisito stampo bottegaio, è altamente razionalista. Si basa infatti sulla ragionevolezza del senso comune, non ha pretese rivoluzionarie e incontra il consenso della gente che preferisce non avere problemi e portarsi a casa un pezzo di carne invece di una riflessione filosofica.
Bisogna tenere nel massimo conto lo spirito costruttivo della gente dabbene. La loro logica trascina il mondo, costituisce la base del progresso, scrive la storia e garantisce lo sfruttamento. È stupefacente la disposizione di spirito con cui la quasi totalità della gente si dispone a mangiare una bistecca: trasformata in cosa, in oggetto ben definito, di forma più o meno codificata, non ricorda per nulla il cadavere da cui si è dipartita, la gente si rifiuterebbe di mangiare pezzi di cadavere, e il macellaio chiuderebbe bottega.
Il ragionevole filisteo fonda il proprio senso comune sulla “verifica”, sulla disponibilità a correggersi degli errori e a fare meglio. Per far ciò gli serve una sola cosa, che la realtà gli sia approntata davanti a pezzettini, possibilmente avvolti in carta pulita, senza che nulla ricordi il duro travaglio che hanno sopportato per essere strappati alla totalità del reale e trasformati in cose.
La logica dell’approssimazione progressiva, della verifica e dell’aggiustamento parte dal dato fondamentale che il mondo esterno è conoscibile per gradi. La sua unità di fondo – seppure viene ammessa – resta assolutamente inefficace. La conoscenza è strumento progressivo e corrisponde all’interpretazione (rappresentazione) che ci si fa del mondo della realtà. Questa è costituita da “fenomeni” e da “cose”. I primi sono dati dagli effetti che le cose determinano nei loro reciproci rapporti. Le seconde sono e basta, ma di questo non ci si preoccupa molto.
Le tecniche (scientifiche) della conoscenza intervengono nella realtà e la “conoscono” attraverso un processo di approssimazione che corrisponde a una parcellizzazione del reale. Questo viene sezionato, classificato, diviso, catalogato e interpretato. Gli strilli dei materialisti contro questo procedimento sono arrivati lontano ma non sono stati elemento sufficiente a trasformare le cose.
Prendiamo i marxisti e tutti coloro che si sono allontanati dall’antica ortodossia per approdare a lidi interpretativi sempre più confusi. Il fatto fondamentale che l’unica conoscenza possibile della realtà è data dalla sua trasformazione e non dalla sua interpretazione, è stato annegato in un mare di frazionamenti (ad esempio, le colossali stupidaggini sull’economia marxista, sulla metodologia marxista delle scienze, sulla sociologia marxista, ecc.). Non solo, ma anche quando è stata rifiutata la classificazione accademica per una “critica” più globale, insistendo sulla pericolosità di un “conoscere” che intenda dividere la realtà, si è finito sempre per cercare un punto fermo nella divisione stessa, nel particolare. Basti pensare alla funzione del concetto di “proletariato” e alle sue recenti [1979] vicissitudini in materia di “fabbrica diffusa”.
Il particolare serve come punto di riferimento per darci notizie sul globale, sulla realtà. In quanto tale, il particolare annuncia la fine di ogni buona volontà rivoluzionaria per darci la strada dell’accumulazione progressiva, dell’esperienza che si misura con l’esperienza, del mosaico che si pretende ricostruire pezzo per pezzo, come ogni uomo ragionevole ha fatto da quando mondo è mondo e non, pazzamente, pretendendo gettare a mare tutti i pezzi e insistendo per avere il mosaico tutto in una volta.
Su questo gravissimo problema ci sarebbe molto da dire. La dialettica, nella forma hegeliana come in quella marxista, presenta il pericolo di contrabbandare una falsa totalità per legittimare quei processi di frazionamento che rendono “assennato” il comportamento del “rivoluzionario” che invoca la “dittatura del proletariato”. In che altro modo, infatti, si poteva giustificare la “fase di transizione”? Col metodo del tutto e subito si correva il rischio dell’anarchia ora e sono ben pochi coloro che se la sentono di assumersi questa responsabilità.
Nella logica hegeliana si assiste al travaso all’interno del ceppo secolare della filosofia filisteo-accademica, della fiorente e viva tradizione popolare e alternativa della logica del tutto e subito, quella logica che aveva da un lato alimentato le insurrezioni contadine in Germania, nel sud della Francia, in Vandea e in mille altre contrade e, dall’altro, aveva segnato le caratteristiche essenziali di quei contributi culturali che erano stati emarginati e distrutti fisicamente dal potere in carica, oppure squalificati (alchimia, magia, stregoneria, ecc.). In questo travaso la dimensione della totalità rivoluzionaria che aveva attraversato i secoli come un fiume sotterraneo, viene alla luce ed è fatta affluire nel pensiero canonico delle università, arrivando fino a razionalizzare la suprema vergogna dell’uomo, lo Stato. È in questa veste che la logica hegeliana viene rielaborata da Marx per servire da fondamento alle rivoluzioni autoritarie di domani. Senza il lavoro intermedio di Hegel non sarebbe stato possibile un utilizzo diretto della logica del tutto e subito in una prospettiva autoritaria.
Infatti, mentre la dimensione popolare dell’anarchia e del comunismo immediati, assume la realtà come un tutto che non può essere migliorato ma deve essere distrutto di sana pianta se si vuole la fine dello sfruttamento, la dimensione mediata della rivoluzione, quella che vive l’esperienza dell’avanguardia, assume la realtà come un processo di avvicinamento alla liberazione, processo caratterizzato, a volte, da fatti distruttivi, ma solo in senso progressivo e sempre parziale. La fine dello sfruttamento sarà il concludersi di questo processo, non la realizzazione di qualcosa ora e subito.
Il metodo del macellaio si insinua dappertutto. La sua negazione porta dentro il problema della logica della rivoluzione ora e subito, dell’anarchia oggi e non dell’avvicinamento per gradi a un ideale che si allontana sempre più. Ciò corrisponde a una negazione dell’aggiustamento ragionevole, del compromesso logico.
Tutto e subito
Cosa vuol dire accettare la logica della totalità rivoluzionaria e negare quella dell’aggiustamento progressivo, quella del buon senso filisteo?
In un mondo che della ragionevolezza si è fatta una garanzia per lo sfruttamento, la metodologia più accettabile è quella che pretende l’impossibile, la realizzazione della totalità nell’immediato.
A questa prospettiva metodologica di massima, che serve come indicazione di comportamento, allo scopo di evitare equivoci e speranze mal fondate, si aggiunge la valutazione metodologica degli strumenti di trasformazione della realtà. Questi strumenti hanno una capacità d’azione molto diversa se vengono impiegati nella prospettiva del tutto e subito o nella prospettiva del progressivismo.
Nella valutazione dell’impiego di questi strumenti, nelle considerazioni riguardanti la loro consistenza e la loro validità, non deve mai essere persa di vista la dimensione globale della realtà. Se è possibile individuare diversi strumenti d’intervento nella realtà (modi diversi di considerare la lotta rivoluzionaria), ognuno di questi strumenti può sempre entrare in contraddizione con la realtà senza che ciò significhi per forza una impossibilità di ulteriore utilizzo. Salvo che non si voglia seguire la singola azione dello strumento (astrattamente considerato) e dividere la sua contraddittorietà dall’insieme del reale in cui si trova ad agire. Occorre quindi prendere gli strumenti di trasformazione della realtà, in modo diverso che a uno a uno, cioè collocarli in una dimensione globale nei confronti dello scontro di classe. Ciò è possibile solo nella prospettiva logica del tutto e subito.
Fatto ciò appare con grande evidenza che solo dalla reciproca interazione di tutti questi strumenti nasce la contraddizione con la realtà, nel senso già approfondito nel primo capitolo di questo libro. La contraddizione che appare può essere vissuta come inadeguatezza, e spesso può anche portare ad esasperazioni efficientiste nell’uso dello strumento, ma tutto ciò si può correggere facilmente con un approfondimento critico. Essa non è mai un vuoto da riempire con progressivi miglioramenti o con “aggiunte”, ma resta una differenza qualitativa leggibile esclusivamente dall’interno dell’insieme dei diversi strumenti d’intervento. Una conseguenza della interrelazione dei singoli strumenti all’interno della loro globalità e dei diversi rapporti, continuamente in via di modificazione, che si determinano sempre in seno alla stessa globalità.
Il fatto serio, produttore di conseguenze notevolissime, è che noi, nel momento in cui ci accingiamo a “riflettere” sul problema dei singoli strumenti, noi stessi, noi come individui singoli, la nostra vita, la nostra attività, non possiamo essere considerati come qualcosa di estraneo allo strumento d’intervento che prendiamo in “esame”. Insomma, noi non possiamo chiamarci fuori dalla realtà. Quando lo facciamo, come avviene nelle migliori tradizioni accademiche, quando accettiamo il metodo cosiddetto “obiettivo” di una falsa scienza al servizio dei padroni, non facciamo altro che permanere dentro, fornendo sostegni a quelle forze che reprimono e distruggono gli strumenti di cui ci occupiamo.
In un modo o nell’altro non possiamo venire fuori dal nostro essere dentro. L’unica cosa da fare è porre con chiarezza e onestà le condizioni di questo essere dentro. Quelle che sembrano le strettoie di un obbligo che ci soffocava, risultano allora gli elementi essenziali della comprensione. Se la realtà è soffocante, il mezzo per trasformarla non è quello di “immaginarsi” la realtà liberata, ma quello di cominciare a riconoscere le condizioni che ci fanno partecipi della soffocazione. Bisogna vedere in che modo noi stessi siamo la soffocazione di cui ci lamentiamo, e in che modo il nostro non volerla vedere o il nostro immaginarci una liberazione fantastica sia, anche questo, un ulteriore espediente per essere la nostra stessa soffocazione.
Se la mia capacità critica non vuole essere un abitante del palazzo dei fantasmi, essa, sia come generica facoltà di comprendere, sia come specifica capacità di selezionare i contenuti della realtà in funzione di un fine, deve essere anche nella realtà, deve essere non solo me ma anche “altro da me”. Ma questo “altro da me” non può essere il luogo astratto di riappacificazione tra me e la realtà (superamento fittizio delle contraddizioni), per arrivare alla tacitazione di quello che mi bolle dentro, delle mie paure e delle mie frustrazioni. In questo modo non solo la mia capacità critica sarebbe fuori della realtà, ma anche me stesso. Sarei io stesso ad essere la vera contraddizione con la realtà, con la mia contemporanea volontà di cercare e sfuggire davanti alla trasformazione. Sarei l’incarnazione dello spirito bottegaio che vorrebbe (a parole) mettere a ferro e fuoco il mondo intero, senza oltrepassare la soglia della bottega.
Inoltre, se la mia capacità critica, uscendo dal palazzo dei fantasmi, si riconosce come elemento della realtà, ed è quindi essa stessa reale, ciò non è ancora sufficiente perché io possa farla diventare una componente effettiva del mio modo di agire, almeno non definitivamente. In altre parole, non posso rubare il fuoco sacro una volta per tutte. Come elemento della realtà, la mia capacità critica è un fenomeno complesso che viene colto solo quando riesce a diventare “altro da sé”, cosa questa che richiede ulteriormente il mio intervento critico, sia per riconfermare la realtà di quello che faccio, sia per darmi un orientamento nel palcoscenico delle mistificazioni. Solo così la mia capacità critica e la realtà sono entrambi elementi di una possibile trasformazione, non baloccamenti di interpretazioni eternamente contraddittorie. Solo così esse sono, nello stesso tempo, la mia realtà e la realtà obiettiva, la mia identità e la mia alterità, l’identità della realtà e la sua alterità.
Ma la realtà, nel suo complesso svolgersi, non ha cognizione della mia realtà e del fatto inoppugnabile che questa mia realtà costituisce elemento insopprimibile della sua alterità. La mancanza di questa cognizione trasforma il suo svolgersi in un apparente dominio del caso che assume ora l’aspetto del preteso meccanismo deterministico della natura, ora l’aspetto relativistico della probabilità. Però questo apparente dominio non riesce completamente a nascondere a un’analisi più approfondita, l’unità completa dei due elementi e la loro partecipazione all’unità con tutte le altre realtà a sé stanti e pur tuttavia indissolubilmente legate in un rapporto costante. Lo stesso concetto che siamo in grado di farci della realtà, l’interpretazione che spesso, inevitabilmente, siamo portati a dare, non è altro che una componente di quell’insieme di cui cerchiamo disperatamente di avere cognizione.
La realtà è quindi l’unità di questi rapporti, nel senso della loro compresenza e della loro interrelazione. È questa la realtà che possiamo trasformare, in quanto possiamo conoscerla, anche senza arrivare ad avere cognizione dei suoi dettagli e senza potere superare la rete di contraddizioni che la costituiscono.
Così la realtà ci sta davanti allo stesso modo in cui noi stiamo davanti alla realtà. Questo stare l’uno di fronte all’altra non è il risultato di uno svolgimento, di un processo per gradi, o per livelli (meccanismo dialettico), è invece il solo modo di avere cognizione della realtà e, nello stesso tempo, è la realtà stessa. Si spiega così il dilemma del progresso che non progredisce e quello della staticità che si muove. L’avere cognizione non è più il semplice “interpretare”, ma diventa trasformazione. Il lottare per la liberazione non è più pacificazione delle contraddizioni, ma è liberazione esso stesso, liberazione e basta.
La realtà è pertanto il campo delle lotte ed è anche il luogo di resistenza alla lotta, il luogo della reazione e dell’inganno. Ogni strumento d’intervento, pure agendo nella prospettiva rivoluzionaria, sfugge alla calma e all’obiettività esclusivamente illusorie dei fantasmi ed entra nella critica complessiva degli strumenti del reale. Diventa coltello a doppia lama, che bisogna sapere usare bene se non ci si vuole tagliare una mano. Solo nelle fantasie del fittizio sono esistiti strumenti perfetti ed esenti da pericoli, solo nelle chiacchiere della dottrina filistea sono esistiti, ben collocati nel tempo, i luoghi della rivoluzione e quelli della reazione, i buoni e i cattivi, i falsi e i veri, i bianchi e i neri.
Ciò non significa che la realtà sia fusione di contrasti, riappacificazione interclassista, notte oscura che fa apparire grigie tutte le vacche. Non significa che non sia possibile individuare una linea di delimitazione, anzi solo dalla cognizione profondamente vissuta della compresenza del nero e del bianco emerge la coscienza di essere nero o bianco, se si avesse solo la “notizia” dell’esistenza del nero separato dal bianco non si avrebbe mai una vera coscienza di essere questo o quello, ma solo la notizia di essere “come questo” o “come quello”, ripetizione di simboli astratti e niente di più. Il nemico non lo individuiamo perché qualcuno ci dice che sta qui o là, perché abbiamo letto in un libro che indossa tale uniforme o si schiera sotto tale bandiera. Il nemico lo individuiamo perché sta accanto a noi, insieme a noi, dentro di noi. Lo conosciamo perché è come noi, vive le stesse nostre sensazioni, non è “altro” da noi. Solo quando abbiamo capito ciò abbiamo finalmente capito ogni azione del nemico e possiamo colpirlo, altrimenti colpiremo il simbolo del nemico, un “quasi-nemico” indicatoci dal fantasma della critica.
Il fatto che l’“altro da noi” possa essere determinato da noi stessi, perché siamo, nello stesso tempo, noi e altro da noi, ha, come conseguenza, che solo nella condizione spettacolare possiamo operare una frammentazione, per cui l’altro da noi lo vediamo separato e lontano, luminosamente diverso. Ciò fa capire come molte volte bellissime analisi o bellissime azioni, siano assolutamente spettacolari proprio perché pretendono indicare l’esistenza di un “altro” senza affermare la contemporanea compresenza del “noi” all’interno dell’altro e viceversa. In questo senso, come abbiamo detto, lo spettacolo è il momento della negazione dell’unità del reale.
La possibilità del “tutto e subito” e quindi anche quella dell’anarchia ora e subito, è legata a questa dimensione del reale. Come negazione della spettacolarità (e quindi della parcellizzazione), è negazione del concetto simbolico di progresso, di aggiunta, di miglioramento, di aggiustamento razionale e di ogni altra panacea del genere che i filistei hanno accumulato nei secoli. In senso positivo essa è poi il primo gradino della logica della liberazione, è liberazione in atto.
L’acqua sporca e il bambino
La critica è un’arma notevole ma presenta pericoli. Quando diventa unilaterale e cerca di porre chi critica al di là del criticabile, in una zona fuori discussione, diventa non solo “critica critica” (espediente verbale di scarsa consistenza), ma principalmente diventa strumento di deformazione della realtà. Svendendo la propria capacità di penetrazione, si abbassa al livello di descrizione astratta di un avvenimento. Nella fretta di gettare l’acqua sporca, butta pure il bambino.
La situazione presente [1979] permette un largo ricorso ai fantasmi e quindi un’analisi che non faccia attenzione a questo pericolo finisce per diventare un inutile sforzo.
I processi di massificazione che il capitale sta perfezionando, realizzando un controllo attraverso l’apparente ripristino della legalità costituzionale dappertutto, passano in seconda linea davanti ai problemi che ci colpiscono più direttamente. Ieri era la lotta armata, oggi i compagni in carcere. Ieri ci si schierava contro o a favore dello scontro armato, oggi ci si schiera contro o a favore delle richieste di amnistia, dissociazione, dichiarazioni di perbenismo democratico, e altre amenità inventate dal potere.
Dello scontro reale che invece avviene nessuno dice qualcosa. Appena qualche balbettio indistinto. Lo sfruttamento persiste. I lavoratori sono davanti alla possibilità di restare senza lavoro. Il meccanismo repressivo si avvia al perfezionamento cibernetico. Il consenso sembra dilagare irrefrenabile. Noi siamo contrari alla resa. Certo siamo anche contrari agli orrori possibili di un irriducibilismo stalinista che non ammette critiche all’ipotesi del partito, del contropotere, del potere rosso, della centralità operaia, ecc. Ma questa posizione non è sufficiente. La realtà è dilatata in una precaria atmosfera di attesa. Non possiamo chiamarci fuori dichiarandoci estranei ai possibili svolgimenti futuri di una situazione che si mantiene esplosiva. La strada per la liberazione è liberazione essa stessa solo a condizione di riconoscere che è la strada che porta verso l’eliminazione dello sfruttamento. Se, viceversa, pensiamo che la sospensione della lotta è il solo indirizzo possibile da prendere, sigilliamo noi stessi le nostre catene.
La funzione della volontà è di primaria importanza in quanto garantisce il mantenimento di quella direzione, di quel processo di distruzione delle strutture autoritarie, mentali e sociali, che non può mai dirsi concluso ma che deve essere sempre vissuto come un movimento in atto, che si sviluppa per gradi spesso contraddittori.
Se la critica ha fatto bene a sottolineare i limiti dello strumento della lotta armata, minoritaria e clandestina, ciò non vuol dire ancora che questo strumento sia diventato inutilizzabile. Allo stesso modo la medesima critica ha sottolineato l’importanza dell’insurrezione di massa generalizzata, ma ciò non vuol dire che bisogna aspettare di vedere il popolo in armi per muoversi. Le due cose, se prese in modo parcellizzato, sono contraddittorie e si escludono a vicenda. Diventano fantasmi, balocchi nelle mani di chi vuole semplicemente continuare a far nulla.
Le organizzazioni specifiche armate libertarie sono strumenti indispensabili per costruire le condizioni rivoluzionarie. Allo stesso modo i tentativi insurrezionali, anche realizzati da minoranze e di modeste dimensioni.
Ma questo è tutto un altro problema.
[Cfr. “L’acqua sporca e il bambino”, in “Anarchismo” n. 29, settembre-ottobre 1979, pp. 260-269]
L’ipotesi armata
Abbiamo tutti più o meno chiaro il problema della lotta armata. Le critiche, le esaltazioni, le condanne, le ottusità, i limiti, gli sviluppi propositivi, le deformazioni. Occorre adesso approfondirne il senso, oggi. Cosa significa parlare dei problemi della lotta armata oggi, dopo le esperienze di questi ultimi dieci anni [1984].
Abbiamo chiarito altrove che il metodo della lotta armata resta fuori discussione. In quanto tale, non è suscettibile di critiche che non abbiano connotazioni concrete, strategiche, oggettive; che non parlino di tempi, di luoghi, di rapporti di forza, di livello dello scontro.
Ma quello che qui ci interessa è un problema diverso. È il problema dello sviluppo futuro dell’ipotesi armata.
Fra le diverse motivazioni di coloro che vogliono mettersi d’accordo con lo Stato, quelli che abbiamo definito neo-contrattualisti, c’è la minaccia di uno sviluppo perverso della lotta armata negli anni futuri, uno sviluppo, appunto, nel senso del partito armato, del progetto leninista, della ripetitività e della unimodalità d’intervento. Sviluppo che è fallito pienamente e che nel suo maniacale ripresentarsi causerebbe danni e sofferenze a tutti e utile a nessuno. Questo pericolo viene collegato da questi nuovi collaboratori del ministero degli interni al fatto che quattromila compagni sono in prigione. Se non ci si mette d’accordo e non si ottiene un’amnistia, la lotta armata continuerà per la sua strada, come prima, insensatamente peggio di prima.
A parte il discorso sull’amnistia, che riteniamo assolutamente negativo in quanto prevede un accordo con lo Stato sul piano di una consegna definitiva di ogni patrimonio di lotta e di ogni individualità rivoluzionaria, crediamo che l’ipotesi armata possa svilupparsi diversamente e che ormai, anzi, il percorso maniacale di cui parlavamo sopra ha fatto tutto il suo iter e non può più presentare in futuro che casi marginali assolutamente privi d’importanza.
In primo luogo occorre che in futuro si ricostituiscano su basi diverse gli organismi specifici d’affinità che possono darsi, a loro volta, gli strumenti minimi indispensabili allo scontro armato. Questo è un lavoro – per certi aspetti limitato – ma indispensabile. Richiede cautela e prudenza, progettualità a media e lunga scadenza, nessuna velleità di risultati immediati.
Una grande compressione sta agendo sugli intendimenti rivoluzionari di molti compagni, da un lato il comportamento dissuasivo della repressione brutale dello Stato, dall’altro il comportamento altrettanto nientificante di coloro che hanno fatto dello scetticismo il nuovo credo della propria sopravvivenza. Da questa duplice pressione vengono fuori mancanza di idee e disamoramento per l’azione. I migliori preferiscono aspettare. La gran parte tentenna, avanza dubbi, vuole prima le prove, vuole riflettere. Quando si propone un’azione, quegli stessi compagni che ieri erano disponibili a mettere il mondo a ferro e a fuoco, adesso sono improvvisamente cauti, hanno sospetti sul comportamento degli altri, in fondo pensano che non è più il momento per certe cose, preferiscono ripiegare nell’attesa e nell’approfondimento dei temi generali del manualismo anarchico. Per questi motivi la ricostruzione di un’organizzazione specifica è lavoro di lunga durata.
L’elemento essenziale di questa specificità è, come tutti sanno, il rapporto personale, l’affinità d’intenti. Si è scritto a lungo su questo argomento, e si è anche approfondito il senso di cosa si dovrebbe pensare quando si parla di affinità. In un qualsiasi momento operativo non c’è altro modo d’azione per gli anarchici che il gruppo d’affinità e il raccordo tra i diversi gruppi della stessa natura. Solo che negli ultimi tempi si è perso il senso di quelle che sono le cose semplici. Ci si vede per anni, ci si sente vicini e uniti, ci si incontra su atti minimali e su progetti di massima, e poi ci si scopre estranei. Nel momento in cui l’azione urge l’estraneità trabocca come un torrente in piena, distruggendo buoni propositi e progetti affascinanti.
L’affinità è fiducia nel compagno, conoscenza di natura personale, intima, profondo rispetto reciproco, certezza della buona fede dell’altro. Non è mugugno dietro le quinte, non è chiacchiera da corridoio, non è attesa sorniona che all’altro scappi la parola o faccia il gesto sbagliato per metterlo in difficoltà. L’affinità è parlare chiaro, a lungo, sinceramente. È condividere le stesse speranze, dibattere l’impiego di mezzi che si possono anche valutare diversamente. Non è subordinazione o bisogno di guida, non è accettazione acritica di un organigramma studiato a tavolino.
La nostra specificità è assolvimento di compiti particolari, indispensabili nel progetto critico dell’insurrezione.
E qui si ricollega l’altro aspetto di ciò che riteniamo possa essere lo sviluppo futuro della lotta armata in paesi come l’Italia, la generalizzazione degli interventi insurrezionali.
In questa direzione possiamo dire che c’è tutto da ricostruire o da riprogettare. Ogni singola lotta intermedia passa per un tentativo di “coinvolgimento” della gente al progetto su cui s’impernia la lotta stessa. Questo coinvolgimento è naturalmente fondato su di un contenuto controinformativo. Non è pensabile minimamente coinvolgere la gente sulla base dell’azione separata dell’organizzazione specifica. Il meccanismo del potere e i suoi grandi mezzi d’informazione, trasformano l’azione stessa nel cosiddetto “terrorismo” e la inquadrano in una prospettiva alienante per chi dovrebbe invece leggere i significati rivoluzionari e di riproducibilità contenuti nell’azione. In questo modo la strada dell’attività autonoma e specifica è praticamente tagliata fuori. In questo senso lo Stato ha fatto un buon lavoro. Ha disseminato dissuasione e sgomento, paura e mitologia, ma, per un altro verso, ci ha fornito la chiave per leggere attentamente la critica, altrimenti astratta, del modello del partito armato.
L’attacco diretto e specifico agli organismi e alle strutture del potere è sempre possibile, ma non può essere agganciato direttamente con la comprensibilità media della gente, con la sua sensibilizzazione che è fortemente sottoposta al gran lavorìo dei mezzi d’informazione e, in particolare, dei recuperatori di professione dei partiti di sinistra.
Occorre invertire il processo. Occorre che all’azione specifica si arrivi per via indiretta, nel corso delle lotte intermedie che hanno lo scopo di coinvolgere la gente.
L’ipotesi armata prende quindi, a nostro avviso, una diversa connotazione. Non si fa carico di costituire il punto di riferimento del movimento reale, il fulcro su cui dovrebbero ruotare le lotte, ma diventa l’ancella, il sostegno, l’umile strumento nelle mani del movimento specifico, per essere tradotta in termini comprensibili alla dimensione effettiva del movimento reale, dimensione che corrisponde più o meno esattamente al livello dello scontro.
Gli aspetti di questo nuovo indirizzo di sviluppo sono diversi e non tutti facilmente comprensibili allo stato attuale delle cose.
In primo luogo, l’organizzazione specifica non può raggiungere livelli di efficienza eccessivi senza una “fuga in avanti” che la porterebbe a ricalcare percorsi perversi ormai fuori discussione. Deve quindi adattarsi a efficienze medie, mortificare in un certo senso la sua anima militare per mantenere il raccordo con le lotte intermedie.
In secondo luogo, questa stessa mortificazione produce un arricchimento di esperienze, di tematiche, di approfondimenti in settori che in caso contrario resterebbero preclusi alla specificità dell’intervento. Per necessità di cose i compagni devono scendere a patti con la vecchia mentalità dello specialista, di chi si interessa di cose “più importanti” e quindi passa in secondo piano le lotte di tutti i giorni. Se si vuole che l’organizzazione specifica abbia un senso, essa non deve “scendere” nelle lotte di classe, come è accaduto qualche volta nei momenti migliori del passato, ma deve adeguare il proprio potenziale alle lotte di massa, seguendole passo passo, commisurando la propria stessa dimensione alla portata e alle prospettive di quelle lotte. Il metro con cui si deve quindi parlare di una futura organizzazione armata è esclusivamente quello del movimento reale.
A qualcuno potrà sembrare strano che uno strumento specifico, per sua natura circoscritto e limitato, quindi condannato ad essere esclusivamente “preludio” di qualcosa, possa mantenere un contatto con il movimento reale. Penso che il problema non si ponga, o si ponga negli stessi termini di qualsiasi altra iniziativa del movimento specifico che arriva – dentro certi limiti – a sensibilizzare il movimento reale, arriva cioè a diventare intelligibile a quest’ultimo. È un problema, se si vuole, di capacità politica, quindi di comprensibilità della nostra azione. Dalla stesura di un volantino alla realizzazione di un attacco contro un’espressione del potere nel corso di una lotta intermedia, si devono non solo misurare le parole, ma anche le azioni. Ogni parola ed ogni azione che d’improvviso risulti al di là del livello di comprensione del movimento reale, diventa dispersiva e controproducente, come, per il motivo inverso, nel caso risulti al di qua, diventa perfettamente inutile.
Non ci si può però nascondere la difficoltà di questo rapporto. Noi siamo dentro il movimento specifico (sia nell’espressione d’intervento adeguata alle lotte intermedie, sia in quella che definiamo di lotta armata) e pretendiamo stabilire un contatto con il movimento reale. Dobbiamo superare una soglia. Questa è in gran parte costituita da un livello di intelligibilità che dobbiamo raggiungere, ma ha anche altri requisiti e altre difficoltà.
Bisogna quindi gettare un ponte all’interno del movimento reale, qualcosa che, da un lato, lo renda intelligibile a noi (che per svariati motivi comprendiamo solo in termini di organizzazione) e, dall’altro, ci consenta di spingerlo verso obiettivi insurrezionali.
Questo ponte è costituito dalle strutture organizzative di base.
Da molti anni parliamo della natura e delle possibilità di queste strutture, e abbiamo anche contribuito a realizzarle nella realtà, quando ciò è stato possibile. Si chiamino nuclei, gruppi, strutture o leghe, sono sempre il legame che ci consente di penetrare all’interno del movimento reale.
La forma e il funzionamento di queste strutture è problema di tecnica dell’insurrezione e, al momento, non ci riguarda, però occorre tenere presente che sono esse il veicolo dell’intelligibile di ritorno, cioè il mezzo attraverso cui comprendiamo quello che il movimento reale ha compreso della nostra azione.
È inutile precisare che i gruppi dell’organizzazione specifica di cui parlavamo prima e queste strutture organizzative hanno forme di sviluppo separate essendo i primi elementi del movimento specifico fuori del movimento reale, le seconde elementi del movimento specifico entro il movimento reale. Qualcuno potrebbe obiettare su questo “essere dentro” e sul fatto che, in linea di principio, nessuno può mai dirsi “dentro” il movimento reale che, per sua natura, ha carattere di estrema fluidità e quindi nega il senso del “qui” o del “dentro”. L’obiezione è giusta ma non tiene conto dell’approssimazione alla realtà dello scontro. Più ci si avvicina alle lotte, più il coinvolgimento si generalizza e più le strutture e i corpi estranei al movimento reale si fanno strada all’interno di quest’ultimo, fino a diventarne corpo costitutivo, elemento propulsore. Al limite anche l’organizzazione specifica potrà diventare elemento del movimento reale, quando il livello dello scontro raggiungerà il limite dell’insurrezione generalizzata, anticamera della rivoluzione.
Comunque, a prescindere da quest’ordine di problemi – che ci sono e sono gravissimi – quello che occorre qui approfondire meglio è il senso diverso in cui si andrebbe a sviluppare l’intervento armato posto in relazione con le strutture viste prima.
Si avrebbe immediatamente una forte riduzione degli aspetti dimostrativi dell’azione. Nessuna, o quasi, gestione politica del fatto, nessun ricorso all’intermediarità dei mezzi d’informazione del potere. Il rapporto dovrebbe essere tra realizzazione esterna e livello ricettivo delle strutture costruite all’interno del movimento reale. Certo queste strutture, specie in senso quantitativo, possono subire atteggiamenti e metodi terroristici dello Stato, diretti ad inquadrare in un certo modo le azioni dell’organizzzione specifica armata, ma il lavoro di decodificazione di questi tentativi di imbroglio dovrebbe potersi realizzare tramite il movimento specifico nel suo insieme il quale è, come si è visto, uno degli elementi delle strutture organizzative interne al movimento reale.
Si comprende adesso l’estrema difficoltà dell’adeguamento delle azioni armate al livello dello scontro e quindi alla portata del movimento reale.
Oltre a questo aspetto merita particolare attenzione il fatto che tutta una serie di azioni, possibili nell’ottica del partito armato, diventano insignificanti nella prospettiva di cui discutiamo. Ad esempio, l’attacco a un rappresentante dello sfruttamento ha un senso se è legato a una lotta in corso nel campo specifico in cui quest’uomo svolge i suoi alti servigi, in caso contrario diventa controproducente. Ma questo stesso attacco deve essere valutato in relazione alla situazione del movimento reale, allo scopo che risulti non troppo in avanti, nel qual caso avrebbe come effetto una disgregazione delle strutture organizzative interne al movimento reale stesso, sia per l’evidente intensificarsi della repressione, sia per la non sufficiente omogeneità nell’accettazione dell’azione stessa.
Un’azione, ad esempio, contro la grande proprietà, diretta a ridistribuire la ricchezza, in certe condizioni del movimento reale, potrebbe essere facilmente gestibile e anche potrebbe presentarsi come modello riproducibile sulla scala dell’illegalità di massa. In quest’ultimo senso anche l’attività del movimento specifico in generale verrebbe diversamente condizionata in quanto, come accade quasi sempre, non ci si preoccupa di spiegare alla gente che cosa è il comunismo anarchico ma si cerca – poniamo – di organizzare l’occupazione delle case. Ciò ha grossi limiti che contribuiscono a rendere incomprensibile una riappropriazione minoritaria e addirittura impensabile uno sviluppo riappropriativo di massa.
Tutta un’altra serie di problemi emerge dal fatto assai semplice che le lotte di massa non hanno uno sbocco in se stesse, ma necessitano di una qualificazione di classe. Ciò è apparso abbastanza chiaro nel settore degli interventi contro il nucleare e contro le basi missilistiche. Le strutture organizzative interne al movimento reale hanno come tendenza quella di selezionare al proprio interno un’aggressività di classe, pur ponendosi come organismi di massa e quindi ad ampia partecipazione. In fondo dovrebbero emergere rapporti abbastanza chiari tra i proletari partecipanti a queste strutture e i compagni del movimento specifico e dei gruppi specifici. In funzione della maggiore o minore significatività di classe di questi rapporti si potrà affrontare il problema di una serie di azioni armate di altro genere, oppure si dovrà ripiegare su azioni più semplici ed elementari.
Una obiezione che potrebbe sorgere spontanea è quella del salto diretto tra proletari partecipanti alle strutture organizzative del movimento reale (con i limiti visti prima) e organizzazioni armate. Si tratta di obiezioni che hanno un apparente fondamento concreto in quanto ci si domanda perché non coinvolgere subito questa disponibilità in un progetto armato. Qui il problema diventa serio in quanto la critica selettiva che avevamo tratteggiato all’inizio, fondata, come si è detto, sulla funzione ancillare dello strumento armato nei confronti dello strumento reale, non è facilmente comprensibile da chi non si trova nel pieno della lotta e, in quanto proletario, si unisce ad altri proletari per mettere mano ad azioni più significative contro il nemico di classe.
Una soluzione potrebbe essere quella di proporre altre organizzazioni armate, altre strutture, sempre transitorie e costituite da elementi con notevole affinità tra di loro oltre che facenti parte della stessa struttura organizzata interna al movimento reale.
Ma a questo punto non è più possibile seguire le ipotesi armate che ne conseguono. Al livello che stiamo ipotizzando ci si trova praticamente alla vigilia dell’insurrezione. Il lavoro di questi proletari non dovrebbe quindi essere quello di individuare obiettivi e colpirli, quanto quello di fomentare la rivolta generalizzata, convincendo gli altri loro compagni, stringendo rapporti sempre più stretti e sempre più chiari con i compagni del movimento specifico e quindi anche con i compagni delle organizzazioni armate. A sua volta il compito del movimento specifico andrebbe a essenzializzarsi sia nel senso dell’informazione che dell’organizzazione stessa dell’insurrezione. La divisione – all’inizio indispensabile – con l’organizzazione armata viene a cadere. In una parola, con l’alzarsi dello scontro – anche settoriale –, con l’avvicinarsi del processo insurrezionale, con l’intensificarsi delle azioni, ci si ritrova tutti all’interno del movimento reale.
Nelle brevi linee di quanto è stato detto, si compendia, a mio avviso, una svolta notevole nei progetti di lotta armata realizzabili in paesi a capitalismo maturo come l’Italia. Questa svolta riconduce il progetto minoritario e specialistico nell’alveo della lotta di massa e libera quest’ultima dalla genericità degli obiettivi che spesso la riducono a semplice momento di ricomposizione del dominio.
Dobbiamo riflettere meglio sul rapporto che passa, anche adesso, dopo questi ultimi dieci anni di chiarificazioni e approfondimenti, tra il dissenso e il recupero. Molti compagni si limitano tragicamente alle grandi dichiarazioni di principio, alle belle parole morali di condanna dell’operato del potere, sembrano più che alla gente come se volessero indirizzarsi alla storia, ad un astratto interlocutore che cataloga il loro punto di vista di grande significato etico.
Sono proprio loro quelli stessi che avanzano una cortina sempre più alta di obiezioni quando qualcuno fra gli altri compagni, qualcuno meno incartapecorito nelle dichiarazioni di alto valore etico, vuole fare qualcosa di concreto per attaccare e non solo per discutere. Sono allora loro i primi ad avere dubbi, ad aspettare indicazioni dalle masse, ad interrogare ansiosamente il cielo in attesa di segni favorevoli.
Anche questi compagni, probabilmente, farebbero bene a cavare subito le zampe dall’acqua o saranno costretti, sistematicamente, ad apparire lunatici e visionari.
Aspettarsi dal lavoro di massa, condotto secondo i canoni che fin qui abbiamo visto, canoni adoperati con grande correttezza teorica, il salto qualitativo che porti allo sbocco insurrezionale, mi sembra pura follia. Indugiare nei grandi discorsi a tavolino e poi precipitare nelle angustie dell’attesa solo perché le masse, come si suol dire, non rispondono, significa tagliare al movimento specifico le sue possibilità di azione concreta. Vogliamo sperare che qualche cariatide, vecchia e meno vecchia, sappia correttamente interpretare queste parole.
L’insurrezione è un fatto specifico che si costruisce secondo regole se non proprio dettagliate e sicure, almeno sufficientemente conosciute e attendibili. Se vogliamo continuare a lavorare con la gente delegando loro le decisioni dell’azione, il momento in cui ci si deve muovere, i modi di questo movimento, allora possiamo praticamente aspettare all’infinito. Quando la gente si muoverà non è detto che ce lo venga a dire in tempo, potrebbe non riconoscerci come compagni di lotta, potrebbe guardarci con giusto sospetto e malcelata avversione.
Una delle prime condizioni da rispettare è quella di non pretendere un avvicinamento nell’ordine politico delle cose. Le strutture organizzative interne al movimento reale, ipotizzate sia pure con una percentuale minima di rappresentatività effettiva, vanno impostate sul concreto delle lotte intermedie: case, fabbriche, quartieri, carceri, scuole, ecc. Anche quando si costruiscono queste strutture su elementi di dissenso più particolareggiati, come l’astensionismo o l’antimilitarismo, il punto di partenza deve essere esclusivamente l’atto del partecipare e non l’interpretazione politica dell’atto stesso.
Questi elementi minimi con cui penetriamo (o facciamo il tentativo di penetrare) all’interno del movimento reale, diventano il fulcro attorno cui ruota l’insieme dell’intervento del movimento specifico nelle sue varie forme come delle organizzazioni specifiche armate.
Qualcuno potrebbe a questo punto avanzare l’ultima e decisiva obiezione riguardo tutto il discorso sull’autorganizzazione del movimento reale. Come mai adesso il “fulcro” diventano queste strutture organizzative che, in definitiva, pur essendo un “ponte” lanciato nel movimento reale, non è detto che vi si collochino immediatamente dentro e possano, specie all’inizio, evitare di essere semplici fantasmi o riflessi delle idee minoritarie dell’universo specifico?
Ancora una volta però questa obiezione confonde il problema che stiamo affrontando con il problema più generale e complessivo della rivoluzione. Se consideriamo il progetto armato di domani – come abbiamo detto – lo possiamo vedere in quanto esclusivo momento di supporto dell’iter del movimento reale. I rapporti tra quest’ultimo e il movimento specifico sono però mantenuti attraverso l’espediente delle strutture organizzate, le quali lungi dall’esaurire la complessità dei meccanismi di cui il movimento reale risulta costituito, formano soltanto un piccolo aspetto, ma il più intelligibile da parte del movimento specifico e delle organizzazioni armate. Chi non ha mai sentito parlare del fatto che i rivoluzionari sono sempre quelli che percepiscono per ultimi le situazioni rivoluzionarie? Ed è più che naturale.
In situazioni però tutt’altro che rivoluzionarie il movimento specifico esprime una sua insostituibile capacità: sviluppa sollecitazioni nei confronti del movimento reale e ciò non intacca o condiziona in nessun modo la potenzialità autorganizzativa di quest’ultimo. Al massimo ne sollecita il funzionamento. Quello che ci distingue dai cosiddetti teorici astratti dell’insurrezione è l’avere sottolineato i limiti e la significatività dell’intervento minoritario accanto e non contro il meccanismo autorganizzativo del movimento reale.
In questa prospettiva l’“ipotesi armata” ha ancora molta strada da fare.
[Cfr. Introduzione a L’ipotesi armata, Catania 1984, pp. 5-16]
Parte seconda: Del fare e dell’agire
Nota introduttiva alla prima edizione
Non c’è un punto da cui partire, un elemento di certezza su cui basarci. Scrivo nella città del vento, e un vento forte scuote i rami del mandorlo davanti alla mia finestra. Ho appena finito di rileggere Del fare e dell’agire, adesso, nella stesura definitiva. La lettura mi ha lasciato impietrito. Dietro le parole, a volte noiose nella loro presunzione di dimostrare, avverto il dolore dei secoli, la sofferenza dei millenni, quello che l’uomo ha causato, il sangue e la cecità, e mi sembra straordinariamente ottusa la mia intenzione di dar conto di tutto ciò, come se al febbricitante corpo di un moribondo si chiedesse il permesso di staccare la spina.
Per capire fino in fondo il rapporto tra “teoria” e “azione” bisogna infrangere la legge. Non quelle piccole sconvenienze che tutti affrontiamo quotidianamente, più o meno un divieto di sosta, ma proprio qualcosa di serio, l’intrapresa di un viaggio inesorabile, destinato non ad una meta da raggiungere, ma ad una celebrazione. La vita di ognuno, ad un certo punto, comincia a scandire poche ore significative, forse nemmeno ore ma minuti, ed è in questo tempo così condensato che occorre celebrarne il rito massimo, cioè vivere. Spezzare la misura è il primo passo per unificare i due estremi dell’agire e del pensare. Restando gomito contro gomito con il giudice di pace non usciamo dalla distinzione, dalla mitologia che separa cercando un luogo dove posare lo sguardo, un luogo della custodia e della tranquillità. Nulla da celebrare in queste località affollate, dove nessuno è disposto a giocarsi la vita.
Chi coglie se stesso nel modo in cui pensa la vita, e nel pensarla la vive, vuole andare lontano, non si ferma alle semplici acquisizioni, alla conoscenza centellinata della quantità che sopravvive a se stessa, egli sa che ogni cognizione è erronea nel momento che viene fissata come una farfalla morta nel proprio loculo tassonomico, sa che occorre troncare la misura che sta di fronte all’oggetto compiuto, iniziare il pellegrinaggio che dal singolo elemento, dalla piccola acquisizione, salpa verso terre lontane, inattingibili, forse, ma ai confini del possibile. Il possedere un dato informativo (quanta involontaria ironia in questa parola che governa il mondo) indica sempre la presenza di un sottostante vuoto, l’orgoglio lo nasconde, ma per quanto deformato il contenuto di miseria che finisce per trapelare. È inutile negarlo.
Se la cultura insegna il rispetto delle istituzioni, non voglio accettarla. Ma non posso metterla fuori di me come le stelle marine fanno col proprio stomaco. Essa rimane dentro e mi arroventa il cuore, parla continuamente di violazione dei diritti degli uomini da parte di una minoranza dominante. Mi spiega i motivi per cui questa violazione è stata perpetrata e continua ad esserlo, mi fa vedere i mezzi con cui questo crimine è stato e continua ad essere commesso. Per un certo tempo l’ascolto, e mi faccio affascinare dalle sue mille deduzioni, dal senso di sicurezza che mi dà, dalle asserzioni apparentemente prive di incrinature, dal modo conseguente con cui mi conduce per mano, con cui attutisce i moti dell’animo, con cui, alla fine, facendomi vedere il male del mondo, mi conforta e mi concilia al di là di ogni possibile equivoco. Se rifiuto le istituzioni devo rifiutare gli uomini che rendono possibili le istituzioni. La cultura mi soffia all’orecchio le responsabilità di alcuni di loro. Ed è una grande cosa. Posso ergermi a giustiziere, ma poi mi accorgo che l’eccesso, l’esuberanza della vita sta altrove. Posso colpire la testa di questa intensità tragica, ma è come se colpissi la coda. Non ci sono né testa né coda. La responsabilità dei crimini continuamente commessi si ripartisce equamente su di tutti. Tutti, anche chi subisce lo sfruttamento e le peggiori angherie, anche quest’ultimo, escluso fra gli esclusi, è responsabile pure lui, se non altro perché non si ribella e, alla fine, se proprio le condizioni della ribellione sono impossibili, perché non si uccide. Vivere da schiavo non è vivere, tanto vale morire.
So che l’eccesso mi acceca e vorrei tornare a vedere, tornare alle mie amate distinzioni. Qui sta il male, là sta la libertà. Non è facile. Per lo stesso motivo dovrei accuratamente distinguere fin dove arrivo con la comprensione di quello che accade e dove comincio ad agire. Questo passaggio non lo vedo, lo cerco ma non lo vedo. Forse non esiste. Che farmene allora della teoria? Se tutti siamo colpevoli, dove sta il nemico? Devo trovare un filo in questo labirinto, aprire fino in fondo la ferita che sta lacerando la mia integrità.
Il riconoscimento del proprio ruolo e della propria responsabilità è il punto da cui partire, la teoria guida, se preferite. Se fosse possibile conservare l’obiettività della distinzione ognuno saprebbe dove colpire, i nemici passeggerebbero per strada con un bel contrassegno sul petto e sarebbero allora perseguibili per decreto. Preferisco il mio isolamento, la cecità che mi blocca sulla soglia della comprensione e mi fa cercare a tentoni un’apertura che sembra non ci sia. Chiamandomi in salvo, dichiarandomi non responsabile dei crimini del dominio, ma solo parte danneggiata, offeso ed escluso (questo soltanto e non altro), mi chiudo alla comprensione effettiva del rapporto di classe e mi trincero dietro le sclerotizzazioni teoriche, posso aspettare che l’azione accada per come deve accadere, che tutti si muovano per com’è “giusto” che sia, nel frattempo posso anche farmi i fatti miei, vivere dignitosamente, mettere su famiglia, ecc. Tutto ciò è scoraggiante.
Colgo il nesso tra teoria e azione solo quando mi penso “in azione”, cioè mi vedo agire, e questo vedere è un pre-vedere, cioè è uno dei momenti teorici che mi assistono quando ormai non ho più nulla da mettere in salvo, essendomi messo a rischio completamente. Se dovessero intervenire prima, se quel pre-vedere fosse una visione temporalmente antecedente, non avrebbe mai fine e diventerebbe una salvaguardia, una sicumera, un alibi.
Il segreto dell’azione è quindi l’unità di teoria e pensiero, di conoscere e agire, unità che ha come contenuto l’oltrepassamento della teoria nell’azione e dell’azione nella teoria. Non un luogo preciso in cui si sono accumulati sufficienti mezzi per agire e nemmeno un momento in cui le azioni, significandosi una con l’altra, forniscono esse stesse una teoria. Se uno di questi due momenti dovesse prevalere, sia quello teorico che quello pratico, sarebbe un “sacrificio” della parte costretta a cedere. E ogni sacrificio è un delitto contro la vita. Ecco perché l’unità di teoria e azione è “incomunicabile”, resta un mistero che può sciogliersi solo mettendosi a rischio senza condizione. Rinunciando a una parte di noi stessi (e perciò stesso salvando l’altra) si è perfettamente compresi, si “dice” qualcosa, si prospetta una teoria (ma non si agisce), oppure si agisce (ma non si prospetta una teoria).
La comunicazione è sempre parzialità, un’ombra sensibile che cala davanti alla realtà, uno schermo che mette a tacere il desiderio senza soddisfarlo. Ecco perché quando sono capìto c’è un qualcosa che lacera, come un senso di vuoto. Non stanno comprendendo quello che io sono, ma solo quello che sono riuscito a dire. L’unità che ero, sia pure per un attimo, si è dissolta a causa della presenza altrui, e si è rivelata accessibile all’altro, una parzialità comunicativa, una blandizia che ha sospeso la messa in gioco, la serietà della messa in gioco. Gli altri capiscono quello che vogliono capire, non si uniscono a me in un agire comune (tranne rari casi), ma mi utilizzano mandandomi avanti come capro espiatorio, animale sacrificale. Anche gli altri cercano l’unità di teoria e azione e anche loro non la trovano se non giocandosi fino in fondo.
Non è agevole restare in bilico, fermi tra rottura e integrità. Bisogna decidersi, non si può lasciare che all’infinito il pensiero trapassi nell’azione e l’azione nel pensiero. L’inesauribile attesa deve sospendersi in un punto di vista, in una fissità che illumina, ma non per questo è meno mortale, o in una agevolezza operativa che conforta, pur restando lo stesso mortale. Insomma ci sentiamo tranquilli solo quando traffichiamo cadaveri. L’azione che ci sta davanti ci pare più semplice e fattibile quando non siamo invasi da problemi teorici (o, peggio ancora, morali) e, viceversa, la teoria che consideriamo comprensibile appare perfettamente delineata quando non ci sentiamo sollecitati a metterla in pratica. So bene che questi punti di vista nascondono un miserrimo relativismo, ma è la nudità delle cose, senza nessun belletto, la nudità delle cose nel loro insormontabile disgusto.
Se spezzo questo cerchio di miseria, se metto sotto tiro il controllo che continua a intristirmi, di colpo le cose cambiano in un prodigioso mettersi in movimento di tutto il mio essere. So bene quello che si prova a giocarsi tutta la posta, tutta in una volta, senza vie d’uscita.
L’azione, puntualmente, comincia qui.
Trieste, 8 giugno 2000
Alfredo M. Bonanno
L’individuo e i suoi atti
La componente più significativa della realtà sociale è l’individuo. Non si tratta di un elemento molecolare, di una minima divisione quantistica, in quanto esso è pur sempre un’organizzazione abbastanza complessa.
Occorre sottolineare che la parte più viva della determinazione logica dell’individuo è proprio la sua diversità all’infinito e non la sua unicità. L’individualità non caratterizza la persona nel senso della sua irripetibilità, nel senso di una qualità che predica in modo irreversibile qualcosa di un soggetto. Al contrario, l’individuo presenta una più o meno ampia varietà di determinazioni che si riassumono in un aspetto, in una capacità, in una potenzialità e in tante altre cose che costituiscono come un condensato delle suddette determinazioni.
Il movimento di queste determinazioni si riassume, in un senso, nell’individuo e, nel senso contrario, riparte per svolgersi all’infinito nella realtà. L’individuo non è mai concluso in se stesso, come la realtà non è mai definita in modo perfettamente circoscritto, ambedue sono in perpetuo movimento e quindi ambedue perdono la possibilità di essere determinati in quanto individuo e in quanto realtà.
L’individuo
La struttura biologica dell’individuo rappresenta, come elemento selettivo e accumulativo, la base di un processo di realizzazioni le quali ultime si possono dividere in sollecitazioni ambientali (fisiche e sociali), in risposte e in attese. Eppure, questa divisione, per quanto cerchi di comprendere i tre momenti della interazione, non tiene conto dell’aspetto fondamentale che coinvolge tutto il movimento di realizzazioni dell’individuo e dimentica il suo stesso fondamento biologico, la coscienza del movimento stesso, la totale compresenza delle varie parti, la spontanea consapevolezza dell’unità dell’individuo da parte dell’individuo stesso.
Quando parlo degli atti che l’individuo compie faccio riferimento ad un campo di situazioni che vedono l’azione simultanea dell’individuo nei confronti delle cose, degli altri individui e delle idee (e viceversa). È questo concetto di simultanea interazione che caratterizza il modo in cui intendo qui l’individuo.
È stato un funesto errore quello di considerare le cose e le idee come elementi passivi del rapporto tra il singolo e il mondo, errore per altro ineliminabile una volta che viene dato spazio alla pretesa scientista di fornire modelli di spiegazione per ogni cosa, interpretazione che per comodità si vuole bloccare a mezz’aria evitando qualsiasi possibile trasformazione.
Si sono costruiti modelli che considerano l’azione delle cose e delle idee sull’individuo e di questo su quelle, ma non si è voluto approfondire il problema di una interazione simultanea perché ciò avrebbe comportato l’ammissione di non potere indicare un modello ben determinato di comportamento, con tutti i rischi che poteva presentare per patriarchi e arciduchi delle nuove chiese e della nuova nobiltà.
L’individuo e le sue capacità di agire non sono elementi di un nuovo progetto di sacralizzazione, trasferimento di armi e bagagli dal cielo in terra, ma sono, rispettivamente, l’elemento propulsore e le infinite, ma determinate, risposte della interazione con le cose e con le idee.
L’individuo agisce sulle cose e sulle idee in base a un complesso di elementi che non sono originari dell’individuo stesso, o comunque non appartengono alla fase estremamente iniziale, in cui l’interazione pur sussistendo è molto rarefatta. Questo complesso di elementi è il prodotto di una serie altrettanto complessa di azioni e reazioni con le cose e con le idee e queste due con l’individuo. Eppure, malgrado la notevole difficoltà di questo groviglio interagente, è possibile cogliere sia il momento dell’azione-apprensione, con cui l’individuo s’impadronisce delle cose e delle idee in funzione di una sua precedente disposizione a fare ciò (disposizione a cui quelle stesse cose e quelle stesse idee non sono estranee), sia il momento dell’azione-valutazione, con cui l’individuo seleziona i diversi modi di entrare in rapporto con le cose e con le idee (anche in questo caso la scelta di un modo è funzione di una certa azione-valutazione che non solo non è estranea alle cose e alle idee, ma neppure al momento dell’azione-apprensione, e viceversa).
Si coglie, a questo punto, il momento dell’azione-decisione, riunione dell’azione-apprensione e dell’azione-valutazione, essa stessa momento generale, non solo successivo (non possiamo qui parlare di “prima” e “dopo”) ma anche antecedente, non nel senso però che quello che c’era prima sia lo stesso di quello che c’è dopo, pur non essendo necessariamente meno perfetto o meno significativo.
L’azione individuale è quindi sempre un complesso sistema di rapporti tra l’individuo, le cose e le idee, e tra queste e quello.
Occorre precisare che l’azione dell’individuo ha sempre uno scopo, cioè egli si aspetta alcuni risultati, quali che siano. In questo si può riassumere l’insieme simmetrico dei tre momenti dell’azione. Anche in quest’ordine diverso, nell’ordine delle attese dell’individuo, occorre dire che l’influenza delle cose e delle idee si realizza attraverso la non perfetta conoscibilità, la qual cosa determina un livello dell’azione-apprensione molto più basso di quello che sarebbe stato nelle ipotetiche condizioni di perfetta conoscibilità.
L’esistenza di questa prospettiva finalistica, dello scopo davanti all’azione, fa sorgere il problema della temporalità, cioè dell’azione che programma nel tempo un suo modo di realizzarsi. Ciò ha fatto sorgere non pochi errori e l’elaborata ma inconsistente tesi di un’azione che viene sviluppata e continuata nel tempo senza interferenze perché impenetrabile nella sua unicità. Mi pare chiaro qui l’equivoco pericoloso che sta alla base di questo ragionamento. L’azione, in ragione del suo momento decisionale, è già progetto indirizzato al raggiungimento di uno scopo (nei limiti visti sopra), essa sarà quindi oggetto di interazioni che determineranno, a loro volta, altre interazioni (tra le quali quelle dell’individuo). Ognuna di queste ultime interazioni (per quanto concerne l’individuo) può essere confusa con una pretesa “continuazione” dell’azione precedente ipoteticamente iniziale che, per errore, era considerata “pura” o esente da interazioni, un’azione-cominciamento del tutto inesistente.
Sul piano logico non è molto importante approfondire il problema della maggiore o minore incidenza dell’individuo, delle cose o delle idee sui processi di interazione. Le conseguenze di una (ipotetica) “non-azione” possono essere altrettanto significative delle conseguenze di un’azione, e questo perché una vera e propria “non-azione” non esiste.
Il tempo come esperienza
Sorge immediatamente il problema di come considerare il tempo.
L’uomo “vive” il tempo in molti modi. La vita di ogni giorno è scandita dai ritmi temporali sulla cui durata arbitraria ci si è messi d’accordo (o quasi) una volta per tutte. Gli aggiustamenti astronomici, per quanto significativi, vengono considerati cosa di poco conto nell’ottica macroscopica delle faccende sociali e, sotto questo aspetto, è forse bene che sia così. Ne deriva che siamo portati a considerare il tempo come qualcosa di oggettivo, un elemento della nostra vita. Ciò non è per niente fuori discussione. Anzi, tutti gli approfondimenti in merito, per chi avesse voglia di farli, arrivano, invariabilmente, a incredibili conclusioni.
Per il momento, mi interessa qui l’aspetto, più semplice, di porre il tempo in relazione con l’esperienza.
Noi non possediamo una nozione fissa di tempo. Quella astronomica è una delle tante nozioni aritmetiche che vengono vissute dall’individuo in modo diverso cioè in relazione alla sua situazione. In altre parole, il tempo è un problema relazionale. Anche la distinzione, certamente possibile, tra “durata” e “tempo”, non sfugge a questa constatazione, la quale è tutt’altro che psicologica ma, al contrario, “sociale”. È la situazione sociale che condiziona la percezione del tempo, come per altro qualsiasi altra “percezione” dell’individuo. E ciò, ovviamente, nei limiti e nelle forme in cui questo condizionamento avviene, non nelle chimere e nelle fantasie dei deterministi e dei meccanicisti.
Ad esempio, se una maggiore o minore disponibilità di tempo libero è certamente da porsi in relazione ad una certa collocazione di classe (maggiore tempo libero per le classi più elevate, mediamente, s’intende), si verificherà che gli appartenenti a queste classi svilupperanno una dilatazione dell’unità temporale percepibile, sempre sulla base del condizionamento comune prodotto dal modello astronomico, la quale sarà più ampia per gli appartenenti alla classe privilegiata e più ristretta per i miserabili costretti a passare la loro vita nel chiuso di una fabbrica. Questo esempio può essere rivoltato in mille modi, ma non può essere disatteso. Certo, il frenetico manager che fa mille cose raccorcia la sua dilatazione del tempo fin quasi a non accorgersi di vivere, ma l’intelligente benestante, il raffinato cultore delle cose belle, il delicato sfruttatore che sa riconoscere i limiti della propria attività e cerca di non superarli, questi riescono bene a dilatare la propria unità temporale. Osservate un proletario mentre mangia. Difficilmente mangerà lentamente. Non perché abbia fame (almeno, non sempre), ma perché non conosce altro modo di “vivere” il suo pasto. Il suo tempo, dilatandosi, gli impedirebbe quasi di gustare quello che mangia, mentre, come si sa, è proprio mangiando lentamente che si gusta di più il pasto. Ma una vita o, se si vuole, diverse generazioni di fame, non possono modificare le cose. Il suo gesto resterà veloce e famelico, anche quando il processo culturale, con sforzi considerevoli, riuscisse a imporre un rallentamento.
Per un altro verso, è solo il razionalismo delle classi superiori che ha imposto una valutazione positiva del tempo, principalmente in termini quantitativi. Questa classe, abituata a comprare il tempo altrui, si è fatta distributrice del concetto negativo della “perdita di tempo”, imponendo alle classi inferiori, sfruttate, un modello culturale di produttività e ordine che non trovava, se non parzialmente, riscontro nel proprio modello di comportamento basato per altro su una dilatazione dell’unità temporale, su di uno scandire del decorso del tempo fatto da minuti se non proprio oziosi, certamente ovattati e attutiti, quasi lenti, come se li si volesse gustare uno per uno, fino in fondo. Non occorre che mi si ricordi il baratro dell’angoscia, tante volte aperto davanti a questo modo di dilatare il tempo (fino a non sapere cosa fare nell’attimo ampliato a dismisura), ma si trattava, quasi sempre, di un difetto stesso del razionalismo, che era filosofia dell’azione e non della contemplazione. Questo pensiero immetteva quindi nella classe stessa che lo propugnava e rinvigoriva, una straordinaria malattia, l’incapacità di vivere una vita diventata a dismisura sempre più ampia e ricca. Dall’altra parte della barricata, la miseria e le ristrettezze spingevano ad un uso raccorciato del tempo, poche ore per dormire, il resto passato lavorando, aspettando, camminando, viaggiando e consumando un breve pasto.
Molti anni fa scrivevo su questo problema ponendolo in relazione all’esperienza. Il tempo è divenire, dicevo, ma occorre intendersi sul concetto di divenire, per evitare di collocare quest’ultimo, come un fatto ovvio e scontato, all’interno del modello di progresso storico. Né può essere accettato senza critica il pur grande tentativo di Agostino di inserire il tempo nel processo del divenire della coscienza. In questo modo si capovolgeva il problema precedente, della mistica religiosa, la quale aveva considerato il tempo come la più accessibile interpretazione dell’idea di Dio. Le posizioni critiche più moderne, che hanno posto in termini problematici l’idea di tempo, hanno dato un nuovo aspetto al concetto di realtà, indicando meglio i limiti e le indeterminazioni di quelle illusioni di certezza che in passato sembravano incrollabili. Il tempo appare oggi come la figurazione più convincente dell’instabilità, della precarietà del reale, condizione che coinvolge in pieno l’uomo e le sue vicende.
Il suggerimento di staccare il tempo in una specie di zona “franca”, separando il suo processo (come misurazione e come decorso) dalle condizioni soggettive in cui si realizza la vera e propria coscienza del tempo, può essere un modo come un altro di aggirare il problema. La situazione quotidiana spazializza il tempo negandone l’elasticità che invece i processi della volontà vi individuano e vi esaltano. L’indifferenza del tempo, attraverso la lente deformante della situazione quotidiana, stacca gli eventi dalla volontà e li colloca in una sfera del necessario, del determinato. Le cose agiscono su di noi con il ritmo che è loro proprio, noi le subiamo con un ritmo che ci è proprio, in quanto esseri dotati di volontà e quindi in grado di realizzare (dentro certi limiti) le nostre possibilità di modificazione. Nel tempo “t”, il fenomeno della volontà perde il suo significato liberatorio (se mai lo ha posseduto in termini assoluti), restando imprigionato nella fittizia oggettività di un presupposto teorico che si trasforma da pura supposizione logica a manifestazione evidente e tangibile.
Nessuno allora ha più il coraggio di mettere in dubbio l’oggettività del tempo. Tutti retrocediamo impauriti mentre imperversano orologi e metronomi. Taylor (in camice bianco da matematico) tarda a morire nelle fabbriche della morte, mentre la musica non riesce a sbarazzarsi dalla tirannia del ritmo. Ma gli operai in rivolta, nel corso della Comune di Parigi, sparavano contro gli orologi, simbolo concreto della loro schiavitù e della tirannia del capitale.
Nella nostra concezione storica del tempo, cioè per come abbiamo avuto modo di cristallizzare in noi e nelle nostre cose il concetto dello scorrere degli eventi e dei pensieri, il futuro è il riferimento verso cui si indirizzano le determinazioni possibili del passato. Nel suo costituirsi come passato, per l’appunto, il tempo si identifica con l’esperienza, nel suo potersi immaginare come futuro, invece, si identifica con la costruibilità dell’azione. Ma l’esperienza non si trova ancorata stabilmente alle determinazioni quotidiane del tempo. Sarebbe una concretezza mal posta, che non ha riscontro effettivo nella realtà. L’esperienza si produce nell’ambito della possibilità dell’azione. Qui diventa lotta, cioè possibilità. Ma può anche diventare sconfitta, cioè impossibilità. Il tempo ha quindi un significato per l’individuo solo in quanto è proprio attraverso la sua lettura che si può avere la dimensione dell’esperienza, cioè la possibilità (o l’impossibilità) dell’azione.
L’esperienza, come elemento della possibilità d’azione, si sviluppa nell’individuo con un movimento molto simile a quello che vedremo prodursi nelle forme sociali. Si tratta di un movimento che non possiede una linearità di sviluppo e non può quindi essere confuso con il concetto ideologico di progresso. La dimensione della totalità orienta l’esperienza verso la realtà concreta, che è fatto formale e spaziale. In questo modo, la mette in grado di passare dall’intuizione della totalità alla sua concreta attuazione nel dominio della parzialità, cioè della realtà possibile, in altre parole dell’azione.
L’esperienza è quindi un mezzo di concretizzazione reale del tempo. Non bisogna illudersi però che essa costituisca un patrimonio di cultura e di progresso, di lavoro e di tecnica ben determinato e inattaccabile alle sempre pressanti riprove del limite della possibilità stessa. La volontà si proietta nella possibilità futura, ma non di rado cade vittima dell’impossibilità passata, che è ripetizione e abitudine, suicidio nel tentativo di chiamarsi fuori. Il tempo è quindi, attraverso l’esperienza, la chiave della totalità. È qui che si è collocata, fin dai tempi più lontani nelle speculazioni di popoli delle più diverse origini, nei problemi di individui vissuti in altri climi e sotto altri bisogni, la necessità di dare corpo, simbolo o sostanza, alla persistenza ciclica, alla ripetizione cocciuta e, nello stesso tempo logica, all’eterno ritorno. Nella totalità l’esperienza è circolare. Questa si spezza al contatto con i limiti propri dell’individuo, delle cose, delle idee e, spezzandosi, produce la possibilità dell’azione. Ma il tempo partecipa di questa e di quella dimensione. Come una striscia di Möbius esso è, allo stesso modo, infinito e limitato.
L’azione-apprensione
Isolando, per convenienza, questo momento, risulta chiara la componente del bisogno come stimolo, se non originario, in quanto sarebbe una schematizzazione, almeno costitutivo. L’apprensione diventa quindi processo di interazione tra sollecitazione genetica ed esperienza sociale. Vedremo che se a certi livelli sociali (o di sviluppo della società) il primo di questi due elementi ha il sopravvento, ad altri livelli è il secondo a prevalere. In questo modo, l’insieme sociale sembra subire un processo di modificazione con caratteristiche genetiche e con un equilibrio pressoché inesistente a causa dei processi di permeabilità, processi che accelerano fino ad annullarle le fasi intermedie. Ciò rende più chiaro il momento dell’azione-decisione, per quanto (come ho detto) non sia possibile determinare separatamente questo livello.
Si capisce così anche il rapporto, che sarà saturo di conseguenze, tra il momento dell’azione-apprensione e le oggettive possibilità (astrattamente considerate) che l’individuo ha di realizzare il suo scopo. Infatti, queste possibilità sono, da un lato, il prodotto del rapporto tra potenzialità genetiche e potenzialità sociali, mentre, dall’altro lato, hanno effetti sulla stessa specificazione del bisogno, oltre, naturalmente, sul momento dell’azione-valutazione. È chiaro, infine, che persistenze nelle delusioni dell’apprensione non possono non determinare interazioni che, a loro volta, finiscono per rendere sempre più differenti i rapporti stessi di interazione complessiva.
L’azione-valutazione
La scelta dei modi è sempre funzione di interazioni in corso, ma non per questo non possiamo qui, come per l’azione-apprensione, ipotizzare l’isolamento di questo momento valutativo al fine di vedere se risulti essere caratterizzato da qualcosa in senso specifico.
Pare sufficientemente evidente che in questo momento intervengono, più che altrove, i processi culturali di accumulazione simbolica, per cui la valutazione si orienta in funzione del processo di interazione tra sollecitazione culturale ed esperienza sociale. In questo caso avviene quanto visto prima, più in generale, a proposito dell’esperienza e del suo rapporto col tempo. A certi livelli sociali (o di sviluppo della società) un elemento prevale sull’altro e viceversa. Lo stesso dicasi per il fenomeno di accelerazione della permeabilità nelle fasi intermedie.
Fermo restando il fatto che l’azione-valutazione, come elemento di un sistema complesso di interazioni, funziona come un elemento del sistema relazionale di cui fa parte l’individuo, le cose e le idee, bisogna precisare che questi rapporti hanno caratteristiche di maggiore o minore vischiosità, cioè presentano ritardi di fronte alle sollecitazioni modificative, oppure reagiscono in modo talmente minimo che se sotto l’aspetto logico non mutano le ipotesi di fondo, sotto l’aspetto operativo dimostrano persistenze ed esitazioni notevoli. In altri termini, la struttura dell’universo culturale risente della necessità di presentarsi con modificazioni più lente, o comunque provviste di un ritmo loro, pena la stessa emarginazione dal campo delle interazioni a causa di una sopraggiunta incodificabilità determinata anche dall’eccessiva velocità delle modificazioni.
Spesso, tentativi volontaristici di determinare accelerazioni culturali, causano polarizzazioni dei processi di interazione col risultato di aumentare la vischiosità dei processi culturali.
Questo momento dell’azione appare quindi come quello che meglio qualifica l’azione stessa, intervenendo sulla base di un più ordinato contesto (quello culturale) a segnare limiti e a prospettare evoluzioni al momento apprensivo che, nella contraddizione tra sollecitazione genetica ed esperienza sociale, rischia di accelerare troppo i processi di polarizzazione delle fasi intermedie, disturbando un corretto sviluppo della permeabilità.
L’azione-decisione
Momento generale e non esclusivamente successivo (nel senso del rapporto tempo-esperienza), questo dell’azione-decisione è l’elemento di maggiore livello intuitivo dell’azione, pur tenendo presente che in esso non mancano le presenze riflesse o analitiche derivanti dall’insieme dei processi di interazione in corso, come non mancano balzi intuitivi negli altri momenti in cui in teoria l’azione si divide.
Siamo davanti alla potenzialità d’apertura dell’azione, la quale, nella sua interezza inestesa e a-temporale, si presenta al di qua dello sviluppo puntuale della interazione, quello che l’individuo è, in funzione di quello che crede di essere, in funzione di come crede stiano le cose e le idee. Altro che regno dell’errore. Altro che regno della fantasia e dell’illusione. Il bieco empirismo non può che riportare tutto alla realtà unica del fenomeno, ripresentando continuamente uno stesso modello analitico che rinvia in avanti promettendo solidità, ma nascondendo la reale incapacità di raggiungere un punto di approdo. Quando questo viene individuato, il livello in cui ci si arresta è già stato (anche se non lo si vuole ammettere) più o meno fissato a priori, con una decisione intuitiva. Non che qui si voglia rigettare la validità dell’analisi per chiudersi in un misticismo intuitivo che è fuori della mia intenzione, come è fuori del tempo. Voglio solo indicare che la strada della rivoluzione è rintracciabile sulla carta analitica della teoria, ma deve sempre essere vissuta attraverso l’apertura intuitiva di quell’altra forma di comprensione della realtà che mal indossa gli abiti dell’analisi. In questo senso l’anarchia, lungi dall’essere una teoria scientifica, è un ideale di libertà.
Quindi, apertura dell’azione attraverso la comprensione dell’intero processo interagente come possibilità che preesiste all’azione stessa, come effetto stesso dell’interazione nel suo insieme. Procedendo in questo modo può sembrare poco chiaro l’ambito di significatività, l’elemento oggettivo di questa apertura o potenzialità di apertura. Può sembrare infatti un tentativo di sacralizzare il momento intuitivo che pure ha sue caratteristiche di creatività e di originalità le quali, per l’appunto, garantiscono la sua intima forza.
La situazione
L’individuo e la situazione
Abbiamo visto che l’azione dell’individuo, inserita in un rapporto di interazione con le cose e le idee, forma l’elemento fondamentale dell’intero processo sociale. Vediamo adesso come essa non resta allo stato molecolare, ma presenta costanti che danno vita ad una situazione.
Queste costanti non sono uniformi di per se stesse, cioè non presentano caratteristiche di classificabilità a priori, valide per tutti gli individui inseriti nel rapporto di interazione ma, al contrario, hanno specifiche peculiarità soggettive che emergono proprio a seguito dell’azione che il singolo realizza. In verità, queste costanti sono quasi sempre dei fatti, dei dati, delle risorse, dei fenomeni, dei soggetti attivi, individuali e collettivi, espressioni della forma sociale come pure della struttura istituzionale. Hanno quindi una loro reperibilità e una loro tassonomia, come pure posseggono un rintracciabile contesto sistematico sociale. Ma tutto questo non appare nella situazione. Le costanti intervengono nell’esclusiva angolazione del soggetto che realizza l’azione e vengono vissute da questo come elementi di un orientamento possibile della propria azione stessa, in vista di determinati scopi.
La situazione dell’individuo nello spazio sociale è un problema che riguarda la delimitazione del proprio percorso in funzione delle condizioni offerte dalla forma sociale. Le costanti diventano pertanto gli elementi che rendono possibile l’azione del soggetto, in quanto sono investite da quei significati specifici che il soggetto stesso trae dall’insieme delle sue interazioni all’interno della forma sociale.
Questa prima approssimazione non può essere considerata valida in assoluto, ma ha molti elementi di sostegno. I momenti fondamentali in cui si specifica l’azione individuale, pur essendo causa di un notevole numero di interazioni ad effetto combinato di un altro numero altissimo di interazioni che si incrociano con le precedenti, non c’è motivo perché debbano considerarsi assolutamente non rapportabili tra loro e all’interno delle diverse azioni. Al contrario, si deve poter supporre che il rapporto genetico-sociale che sollecita una certa apprensione sia abbastanza costante per caratterizzare in modo sufficientemente uniforme tutta una serie di apprensioni e quindi di azioni dell’individuo. Lo stesso dicasi per gli altri momenti.
Abbiamo quindi che le azioni di ogni individuo presentano, grosso modo, alcune uniformità, come se egli stesso, al di là del valore specifico di ogni atto realizzato su stimoli e prospettive che conosciamo, volesse disegnare un altro aspetto di se stesso, un aspetto più complesso e più comprensivo, capace di cogliere una situazione che è in corso di sviluppo, una situazione non statica perché prodotta sempre da un flusso costante di interazioni, ma avente caratteristiche tali da rispondere a quella necessità dell’individuo di sentirsi agire in conformità a ciò che la situazione all’interno della quale agisce gli va delineando.
Le sue azioni costruiscono attorno all’individuo un bozzolo che assume significati di grande importanza per lui, come pure per le situazioni degli altri individui.
Da notare che il rapporto più o meno parallelo e corrispondente tra le costanti individuali e le uniformità situazionali garantisce proprio quel senso di conformità che viene percepito, in un modo più o meno forte, dall’individuo agente.
L’interazione tra situazioni
Quello che ogni individuo si aspetta che un altro individuo faccia a seguito di una propria azione non è un rapporto diretto tra questa azione e la presupposta azione dell’altro, ma è un rapporto mutuato a livello delle due situazioni. Ciò contribuisce a chiarire meglio il concetto di interazione individuale. Infatti, l’interpretazione della propria e dell’altrui situazione non corrisponde mai alla reale composizione delle interazioni di fondo, intervenendo tutta una serie di ritardi, di attriti e di ostacoli, con in primo luogo i processi preordinati dell’ideologia, per cui l’individuo agisce nei confronti della situazione altrui partendo da presupposti intorno a quella e alla propria situazione che sono il risultato delle interazioni globali con le cose e con le idee.
Non bisogna confondere il concetto che stiamo elaborando con quello di “status” e di “ruolo”, i quali, essendo correlati tra loro, possono ingenerare confusione. All’interno della situazione esistono in numero enorme, ma determinato, “ruoli” e “status”. Non è peraltro vero che l’interazione possa significativamente ipotizzarsi a livello di “ruoli” e di “status”, e ciò non perché a questo livello (che qui tralascio) non si verifichi, ma perché viene immediatamente riportata al livello complessivo, che è appunto quello della situazione nel suo insieme.
Occorre aggiungere che questo nuovo livello cui siamo pervenuti, pur collocandosi nel rapporto di interazione che abbiamo visto con le cose e le idee, non deve confondersi col livello individuale, in quanto la situazione ha significati, sul piano sociale, che l’individuo isolato non possiede. Siamo davanti alla soluzione del problema, tanto dibattuto, se l’individuo possa collocarsi alla base della struttura sociale. Evidentemente la risposta affermativa è per l’individuo in situazione.
La situazione. Alcuni chiarimenti di metodo
L’avere introdotto il concetto di situazione mi obbliga ad alcuni chiarimenti. Per prima cosa non accetto l’ipotesi esclusivamente “teorica” di una situazione che si possa cogliere, a seguito di una precisa analisi fatta in sede scientifica, in termini di condizione oggettiva in cui si trova l’individuo. Questa concezione è legata ai luoghi comuni dell’equilibrio scientifico che una mentalità, fortunatamente in via di scomparsa, pretendeva imporre alla realtà rifiutando costantemente le lezioni che quest’ultima impartiva ai diversi modelli interpretativi. Lo sviluppo di scienze come la fisica, la matematica, la geometria e l’economia, in questo secolo [Novecento], è ulteriore riprova della non validità del modello di equilibrio.
Ma c’è un altro modo di considerare la situazione, il modo filosofico in senso stretto, cioè il modo che riporta il suo significato al rapporto col mondo in generale in quanto limite delle possibilità dell’individuo. Karl Jaspers scrive: «Una rappresentazione plastica ci pone davanti agli occhi la situazione come collocazione delle cose e delle loro relazioni spaziali in un ordine topografico. Seguendo le direttrici prospettiche di questa rappresentazione spaziale, ci si fa un’idea della situazione come di una realtà a cui un soggetto è, col suo esserci interessato, e per il quale la situazione è limite e campo d’azione». (Filosofia, tr. it., Torino 1978, p. 676). Interessante formulazione che comunque si penalizza da se stessa subito dopo. Infatti, Jaspers apre alcune possibilità. La nozione di spazio, quella di campo, quella stessa di limite e quella di senso potrebbero portare ad uno sviluppo del problema della situazione in senso sociale, invece si ha un ripiego in senso metafisico. Il fallimento è proprio nel concetto di limite. Si scopre che questo concetto non è “una parte” della situazione, e quindi un elemento che rende possibile una sua migliore comprensione e visualizzazione, ma è in se stesso una situazione “particolare”, una “situazione-limite” che condiziona le possibilità (leggasi la volontà) dell’individuo. Egli così conclude: «Non possiamo quindi reagire sensatamente alle situazioni-limite elaborando piani, o facendo calcoli per evitarle, ma dobbiamo affrontarle con un’attività di tutt’altro genere, e precisamente, realizzando in noi l’esistenza possibile; infatti, diventiamo noi stessi solo se entriamo ad occhi chiusi nelle situazioni-limite. Le possiamo conoscere solo esteriormente, perché a coglierle nella loro realtà è solo l’esistenza». (Ib., pp. 678-679). Noi possiamo, al contrario, costringere la realtà a modificarsi in funzione delle nostre intenzioni. In questo progetto talora falliamo, ma non per questo desistiamo dal continuare. È in questa ottusa attività che si realizzano le nostre possibilità e si mette in evidenza la qualità suprema dell’individuo, la sua volontà. La conclusione di Jaspers è ancora più malinconica, almeno riguardo il limite: «Il limite svolge così la sua autentica funzione, e cioè quella di essere nell’immanenza, un rinvio alla trascendenza». (Ib., p. 679).
La parcellizzazione della situazione in sotto-situazioni è un procedimento spazializzante che denuncia i limiti della concezione di Jaspers. Con lui tutto un modo di considerare la realtà viene quindi posto nell’ottica di quello che ho chiamato la logica dell’a poco a poco. Che la realtà sia divisa in parti è un fatto imposto dal senso comune. Che queste parti siano catalogabili ed enumerabili è anche questo un altro prodotto della tirannia del senso comune. Per fare queste operazioni tassonomiche e aritmetiche dobbiamo usarci violenza, dobbiamo ipotizzare separazioni che, di fatto, non esistono e che non corrispondono nemmeno all’uso immediato e diretto che noi facciamo delle cose. La vita quotidiana, nel suo molteplice dispiegarsi, è un fatto continuo e non può restare schiava di un modello “discreto” che è stato costruito artificialmente per motivi non sempre “puliti”. Ciononostante, l’invadenza della saggezza spicciola, l’isterica ragionevolezza della logica bottegaia, impone un modello ragionativo diverso. Jaspers, senza dubbio per questo – e per altri aspetti – resta il tipico prodotto dell’ideologia tedesca del suo tempo. La situazione confinaria non esiste. Anche ipotizzando l’esistenza di un limite alla dimensione totale della realtà, si riduce questa dimensione all’interno di un concetto circoscritto, cioè del concetto di situazione. Ma qualsiasi situazione, per quanto la si possa immaginare amplissima, rinvia ad un’altra situazione, ad un’altra serie di situazioni, ecc. Il confine delle situazioni è dato da altre situazioni. La situazione è confinata da una diminuzione di significatività. In effetti, i confini che percepiamo sono i limiti del processo di percezione delle significatività del messaggio relazionale. Migliorando questa percezione i limiti si estendono. La nostra sensibilità crescendo allarga la situazione, la sviluppa, e questo si può ipotizzare come un processo all’infinito. Non esistono limiti all’allargamento delle situazioni, per quanto poi, considerando questo meccanismo nei fatti, ci si rende conto di quanto è miseramente modesta la nostra capacità di pervenire a cogliere i significati delle situazioni, quanto attivamente coercitivi risultiamo nell’assegnare limiti, confini, muri di prigioni, barriere, alla nostra situazione. Ma questo non ha praticamente nulla a che fare con la realtà nel suo insieme. La possibilità di identificare origini e fini, cause ed effetti, è semplicemente un fatto legato alla realtà situazionale, alla realtà di campo, all’interno della quale il processo di significatività agisce polarizzando i confini. Questo lo possiamo percepire.
Parimenti fallimentare la posizione di Sartre. Egli scrive: «La realtà umana è, in effetti, l’essere che è sempre al di là del suo esserci. E la situazione è la totalità organizzata al di là di questo stesso essere». (L’être et le néant, ns. tr., Paris 1943, p. 634). Occorrerebbe qui mettersi d’accordo con Sartre sul concetto di “essere”, cosa che non è stata mai fatta in modo chiaro. Se la realtà è un al di là che deve venire raggiunto ad ogni costo, ma che non viene raggiunto mai se non come nientificazione della possibilità di andare avanti, rassegnazione e morte, allora la situazione è ancora una volta il segno delimitante delle condizioni positive di fare qualcosa – il meglio possibile – per non riuscire a far niente, per attendere attivamente la morte. Se è così, non si vede perché ci si debba preoccupare dei problemi dell’agire. Ogni azione è uguale all’altra, non ci sono valori e non ci sono possibilità diverse. La realtà si presenta attingibile solo a condizione di “chiudere gli occhi” e lasciarla perdere. No, anche questo modo di vedere non mi pare accettabile.
Anche per Sartre si pone il problema del rinvio all’esterno di qualcosa che dovrebbe essere, invece, al di qua, nell’ambito della totalità, perché nel caso se ne riscontrasse la mancanza questa totalità risulterebbe definitivamente straziata in due parti. Il problema della frattura è centrale in questo autore e viene risolto con un accurato rifiuto, spesso anche dettagliato in maniera monotona e ripetitiva, del progetto inclusivo della totalità. Da questo suo non sapersi decidere ad affrontare fino in fondo, o le conseguenze della dicotomia (non conflittuale ma istituzionale), o l’aperta ammissione della realtà come fatto totale, gli derivò l’impossibilità assoluta di una costruzione coerentemente rivoluzionaria. Se una parte della situazione di cui l’individuo è costituito sta “fuori”, in un territorio che può solo essere punto di riferimento e desiderio inattingibile, la conclusione possibile sarà quella del sacrificio, dell’attesa, della pulsione mortificata. Lo stesso, per motivi diversi ma paralleli, sarebbe stato nel caso di un’accettazione inclusiva nel senso dell’equilibrio preordinato, elemento derivante da un possibile determinismo di base, effetto di un meccanismo spontaneo della realtà, la quale, comunque, va sempre per il verso giusto. Le forme più becere del materialismo storico sono andate anche in questa direzione, con conseguenze tutt’altro che comiche, perché non si sono certo limitate soltanto alle incongruenze teoriche.
Ancora chiarimenti, questa volta riguardo la metafisica
Pur essendo possibile trascurare la presenza della metafisica, diventa impossibile tacere sulle conseguenze della sua azione sulle idee. Per questo motivo, di volta in volta, cercherò di indicare alcune fra le posizioni note che appaiono come tentativi di portare il discorso dell’azione e della volontà nel campo del fantastico e dell’illusorio.
Innanzi tutto preciso che col termine “metafisica” non intendo “filosofia”. Su questi due concetti ci sarebbe molto da dire. La filosofia per me è uno strumento per capire la realtà, quindi un mezzo per intraprendere il recupero di qualcosa che ci è stato tolto, tolto per motivi oggettivi (se non altro genetici, a partire dallo stesso trauma della nascita), tolto per motivi sociali. La comprensione della realtà non può avvenire che approfondendo i problemi, cioè quelle ipotesi che si presentano come suscettibili di approfondimenti. In fondo tutte le idee sono suscettibili di approfondimento, quindi tutte le idee sono “problemi”, almeno nel senso “aperto” da dare a questo concetto. Per questo motivo, la filosofia tratta di tutti i problemi, cioè di tutte le idee, nessuno e nessuna esclusi. Questo significato del concetto di filosofia dobbiamo averlo come amico, dobbiamo tenerlo insieme a noi, curarlo. L’altro significato, quello di “soluzione” dei problemi (e delle idee), quello di “sussunzione” a livelli superiori (pretesi tali, ovviamente), deve restarci estraneo. È questo secondo significato che corrisponde alla metafisica. Comunque, per quanto distante lo possiamo tenere, questo secondo significato ritorna sempre fra di noi, si impadronisce delle nostre giornate, delle nostre idee, dei nostri stessi desideri e bisogni. Scalzarlo dalla vita di tutti i giorni non è cosa facile.
La critica cosiddetta empirica delle concezioni metafisiche incontra un grosso ostacolo. Non è possibile provare niente facendo vedere le stranezze di alcune affermazioni, anche se queste sono contrarie alla cosiddetta logica del “senso comune”. Infatti, non è raro che su determinate cose il senso comune si sbagli e di grosso. La ricerca scientifica stessa ha finito per dovere ammettere che non sempre l’evidenza – anche strumentale – è un buon punto di partenza per iniziare una critica. Così facendo, si sono sfondate tante porte aperte nei confronti della metafisica ma non si è fatto un solo passo in avanti nella giusta direzione, che è poi quella di ridurre i danni causati all’attività umana da questa distorsione del pensiero. In effetti, i più importanti ostacoli che la metafisica pone all’attività dell’uomo si generano proprio per limitazioni e incomprensioni relative ai pensatori stessi, non raramente per le loro vere e proprie incapacità di ragionamento. Ma, come ci si rende conto di questa “incompetenza”? Il pensiero non è soltanto un’attività esecutiva, nel senso che mette ordine nell’insieme delle esperienze, esso è anche qualcosa di creativo. Quando si tratta di attività che si limitano ad un’applicazione e ad una ricerca, più o meno accurate, ma non dotate di iniziativa, il problema è facile, ma quando si tratta di attività che fanno dei risultati degli altri un punto di partenza per uno sviluppo ulteriore e non una semplice applicazione, la faccenda è più difficile. Ed è proprio qui che risiede la fonte più pericolosa da dove scaturiscono le conseguenze più gravi di una mal riposta competenza. L’errore di un medico, di un ingegnere, per quanto grave, non supera l’immediato e circoscrivibile pericolo, non si rivolge a parecchie persone le quali, per altro, non hanno la possibilità, almeno in tempi brevi, di stabilire se si trovano davanti a una cosa giusta o sbagliata. L’uomo creatore può sbagliare per ignoranza, come qualsiasi altro uomo, ma le sue conseguenze sono di gran lunga più gravi. Il romanziere può sbagliare anche lui, come il metafisico, ma nessuno ci fa caso, in quanto non ci si aspetta che il romanziere, bugiardo per professione, dica la “verità”. Dal metafisico la gente si aspetta invece la verità, e se l’aspetta quasi per definizione.
Il pensatore dovrebbe quindi comprendere accanto alla propria creatività anche l’esperienza concreta delle cose, della vita, delle idee e dei rapporti su cui si basano i fatti sociali, e tutto ciò nella realtà dello scontro di classe e non nel chiuso delle biblioteche. Il pensatore e l’uomo d’azione sono due astrazioni ambedue parziali e limitate. L’uomo completo è anch’esso un’astrazione, ma l’uomo che vive nella realtà, dentro i limiti delle proprie possibilità, continuamente proteso però a oltrepassare questi limiti, solo quest’uomo può unire insieme la genialità del lampo intuitivo su cui il pensiero si basa e la faticosa ascesa della strada della volontà basata sulla ripetizione e sull’ottusità, su cui si fonda la costruzione del futuro. La pacatezza dell’analisi dà corpo e dettaglio al pensiero, la sintesi dell’intuito dà vita a tutto il resto.
Purtroppo le cose non vanno così. Il mestiere di pensare è troppo miseramente pagato. Gli ingegni più brillanti e coraggiosi, quando sono scarsamente capaci di individuare il proprio nemico, si mettono al servizio del migliore offerente. I mediocri, per definizione, non vedono nemmeno l’esistenza di un nemico. La rovinosa crisi della scienza ottocentesca è un fenomeno che va ben al di là dei limiti del campo scientifico, ed è un fenomeno che è stato spesso male analizzato. Non è vero, come è stato affermato, che nella scienza questa caduta riguarda solo l’aspetto teorico. Questa ammissione non confessa il suo presupposto, cioè che possa dirsi ben identificata una separazione tra scienza teorica e scienza applicata, tra scienza nobile e tecnologia. Il crollo di tutto un mondo di esperienze e di lavoro, un mondo che aveva fatto sognare imperi e piccole comodità, grandi conquiste e pacifiche monotonie domestiche, ha coinvolto anche l’impalcatura pratica della scienza, non solo il suo dominio teorico. L’idea di ordine era solo un tabù metafisico, costruito ed impiegato tante volte fino a convincersi della sua ineluttabilità, se non proprio della sua validità. Ma era il concetto scientifico di determinismo che nascondeva bene le contraddizioni di quell’idea, specialmente con una certa aria di profezia che questo concetto riusciva ad innestare nella storia, nella biologia, nella botanica, nella geologia, ecc. Oggi non c’è nessuno che sospetti la presenza di un ordine prestabilito nella realtà. Gli stessi preti ci vanno adagio e si conservano il razionalista Tommaso per le occasioni ufficiali della Chiesa, mentre nella pratica aprono le porte ad una lettura più moderna di alcuni irrazionalisti (da Agostino in poi). Di certo, bisogna intendersi con la parola “ordine”. Sarebbe sbagliato pensare che il pensiero e la scienza in particolare si debbano ridurre ad un insieme di nozioni privo di un filo interpretativo, per cui i risultati di certi sforzi finiscono per andare perduti e non possono servire agli sforzi futuri. L’organizzazione è alla base del pensiero, l’ordine no. Un ordine imposto dall’esterno, voluto ad ogni costo da una mente estranea, da un’autorità, è da considerare un tabù metafisico. Questo tipo di ordine è quello matematico che la scienza del secolo scorso veniva inserendo nella mentalità generale, come significato ultimo del suo credo deterministico. I risultati sperimentali della fisica, la teoria dei quanti, quella della relatività, il principio di indeterminazione, mettendo in crisi il determinismo hanno messo a nudo la macchinosità stentata e spiacevole che reggeva il concetto di ordine matematico. Ma, anziché spingere lo sguardo più lontano, ci si è limitati a fare ricorso ad una nuova diga di “ordine”, un ordine indiretto, quello della logica dell’a poco a poco, l’ordine dell’aggiustamento e della correzione, l’ordine del dottor Pangloss che tranquillamente continua a filosofeggiare mentre il mondo va in rovina, in attesa che le cose si sistemino perché tanto viviamo tutti nel migliore dei mondi possibili.
I rapporti
L’individuo e i suoi rapporti con le cose
Occorre qui specificare meglio come avviene questo rapporto con le cose. Se non c’è dubbio che le cose, in quanto tali, sono già elementi di interazione con l’individuo, è anche certo che questo livello è assolutamente insufficiente a dare un’idea chiara della complessità del rapporto stesso. Le cose, interagendo, si trasformano e nel trasformarsi producono azioni che sono molto più importanti delle cose stesse, allargando il proprio significato sociale.
È in questo senso che dovremo esaminare, d’ora in poi, il mondo delle cose, un senso che ha una sua diversa stabilità sociale, tanto da potersi rapportare a quella della situazione dell’individuo. Tutta una serie di azioni che le cose subiscono e che a loro volta determinano, finisce per presentare elementi di costanza che costruiscono attorno alle cose come un nuovo significato d’essere, un nuovo modo di porsi in azione, una nuova capacità di agire.
Non si può parlare di una “situazione delle cose” perché manca un rapporto diretto interagente con la situazione dell’individuo. Comunque, le cose in rapporto sviluppano caratteristiche che non posseggono quando sono in quiete (rapporti ridotti al minimo e tendenti alla quiete la quale, in assoluto, non esiste) ed è questa peculiarità che fa loro assumere il significato sociale che hanno. È chiaro che la situazione in cui si trova l’individuo dal punto di vista dell’azione lo spinge a sollecitare una selezione abbastanza costante nelle cose in modo da avere, tramite ciò, un avvicinamento al significato sociale delle cose stesse e un contemporaneo allontanamento dal loro originario e limitato significato naturale. Ma ciò non vuol dire collocare, ad un certo punto, le cose in due ambiti diversi. Si tratta solo di due diverse intensità di significato, cioè di rapporto. Ciò avviene, è ovvio, anche sfruttando le interazioni delle cose e delle idee tra di loro.
È in questa prospettiva sociale che le cose assumono una capacità di omogeneizzazione che a livello della singola relazione non è rilevabile. La cosa è necessaria per rendere intelligibile all’individuo il processo di interazione. Nello stesso tempo, questa costanza e questa uniformità, lasciano trasparire una sicurezza di risposta che consente lo sviluppo delle varie azioni in modo più adeguato.
Si vede qui il grosso problema dell’uniformità delle risposte che fa riscontro alla tendenza all’uniformità delle attese nell’individuo. Non bisogna dimenticare che a nessuno piace vivere sempre armato e in lotta. Anche la rivoluzione deve essere sempre intesa come un passaggio. Se diventa la dimensione normale di vita, l’individuo non può sopportarla se non a costo di sacrifici tali che a lungo andare diventano accessibili solo ad una piccola minoranza. I processi repressivi si basano anche su questo fatto.
L’individuo e i suoi rapporti con le idee
Come non si può parlare di una situazione delle cose, così non si può parlare di una situazione delle idee. L’interazione avviene a livello individuale, tra le idee e l’individuo, per quanto le idee siano modificate e poste in rapporto attraverso l’azione della situazione dell’individuo stesso. Non è solo l’elemento culturale della situazione a possedere la chiave di lettura dell’interazione in corso tra individuo e idee, ma l’intera situazione nel suo insieme di realtà interagente.
Nel corso dell’interazione le idee si trasformano (come avveniva con le cose), si distribuiscono e si polarizzano, assumendo l’aspetto di corpi strutturati. La capacità di azione delle idee, in questo loro nuovo aspetto, ha estensioni molto più vaste ed acquisisce quel significato sociale pieno che mancava all’idea in senso relazionale e puntuale. È l’individuo stesso che accelera i processi di selezione delle idee e, a sua volta, subisce un’azione considerevole nella forma della propria situazione.
La conseguenza di questa polarizzazione delle idee in forme più complesse che le qualificano e le ordinano è evidente. Essa permette una più adeguata costanza all’azione individuale che, in un modo o nell’altro, ne risulta condizionata e quindi più uniforme. È questo livello oggettivamente interagente che determina i processi modificativi sul piano sociale della situazione dell’individuo.
Per meglio comprendere la differenza tra i livelli di interazione basta pensare che il rapporto individuo-idee, per quanto difficilmente coglibile a livello molecolare, tende a fare prevalere il momento apprensivo con la caratteristica forma dei rapporti tra componente genetica e componente sociale e relativa permeabilità. In altri termini, a questo livello, l’individuo agisce nella fase prevalentemente apprensiva, cioè pretende qualcosa ma non ha ancora interiorizzato il momento della pretesa. Di fronte alla polarizzazione delle idee o per meglio dire alle idee in rapporto, la sua azione, partendo da una situazione interagente, ha già interiorizzato la fase dell’apprensione, quindi la sua azione diviene indipendente da considerazioni in merito all’azione stessa, viene posta in essere e basta. I processi di interazione tra situazioni dell’individuo e idee sono processi ad alta componente di interazione.
Resta da dire, per evitare un dannoso equivoco, che i rapporti tra le cose e le idee, che si realizzano in interazioni complesse, non possono essere esaminati come sussistenti al di là dell’azione interagente della situazione individuale. Pertanto, risulterebbe fuorviante un loro esame separato, anche in via di ipotesi.
I rapporti sociali
La trattazione dei rapporti sociali è quanto mai confusa in sociologia. L’unico autore che ne parla con chiarezza è Marx, ma le sue stratificazioni sono funzionali esclusivamente al suo sistema e risultano quindi di scarsa utilità per una conoscenza reale del problema. In pratica, egli divide i diversi rapporti sulla base della divisione di fondo tra struttura e sovrastruttura, parlando di rapporti di produzione e di scambio o rapporti sociali “materiali” e rapporti sociali “ideologici”. Vi sono poi i rapporti sessuali, i rapporti biologici, i rapporti di classe, ecc. Proprio questi ultimi rivestono per noi una particolare importanza, anche nell’analisi marxista, proprio per le scarse indicazioni che Marx stesso ha lasciato in merito al problema delle classi. In fondo, per Marx, rapporto di classe e rapporto di produzione sono la stessa cosa.
Oggi si parla di rapporti anche in altro senso e sempre per argomenti che concernono la problematica sociale. Si hanno i rapporti di forza, i rapporti di comunicazione, i rapporti politici, i rapporti di potere, ecc. Tutti questi rapporti hanno poco a che vedere con quanto andiamo dicendo.
I rapporti di cui qui discutiamo sono le interazioni che si realizzano all’interno della forma sociale. Le relazioni sono le caratteristiche costitutive della struttura istituzionale.
Non è senza importanza esaminare alcuni significati del concetto di relazione secondo vari autori. Max Weber scrive: «Per “relazione” sociale si deve intendere un comportamento di più individui instaurato reciprocamente secondo il suo contenuto di senso, e orientato in conformità. La relazione sociale consiste pertanto esclusivamente nella possibilità che si agisca socialmente in un dato modo (dotato di senso), quale che sia la base su cui riposa tale possibilità». (Economia e società, vol. I, Milano 1961, pp. 23-24). Definizione che si avvicina al mio concetto di rapporto, ma limitatamente al “comportamento”, mentre la mia definizione di relazione, con limiti abbastanza simili, risulta diretta verso gli individui invece che verso le strutture istituzionali. Per Leopold von Wiese, le relazioni sociali sono «quegli stati labili a cui conducono i corrispondenti processi sociali. Esse sono i risultati di tali processi». (Sistema di sociologia generale, tr. it., Torino 1968, p. 379). Questi processi e le relative relazioni sono riassunti in tre sezioni: socialità, dipendenza e indipendenza. Pur conservando le relazioni sociali come «le grandi stazioni sulla linea di movimento della vita interumana», (ib., p. 379), questo schematismo sembra piuttosto povero e in pratica si riduce ad un’analisi di sentimenti e non di dati di fatto. Secondo Gabriel Tarde «la società è una reciproca determinazione d’impegni o di consensi, di diritti e di doveri, ben più che una mutua assistenza». (Le leggi dell’imitazione, tr. it., in Scritti sociologici, Torino 1976, p. 104). È uno dei teorici che per primi studiarono il fenomeno della relazione sociale ma, forse anche per questo, ne dà una interpretazione fortemente meccanicistica e riduttiva. Per lui la sociologia non è altro che una “inter-psicologia”, un discorso riguardante gli “eventi interumani”. Discorso abbastanza giusto, ma troppo parziale per dare risultati positivi.
Secondo Ferdinand Tönnies «le volontà umane si trovano tra loro in relazioni molteplici; ed ognuna di tali relazioni costituisce un’azione reciproca che, in quanto compiuta o data da una parte, viene subita o ricevuta dall’altra. Queste azioni sono però di natura tale che tendono alla conservazione o alla distruzione dell’altra volontà o dell’altro corpo – cioè sono affermative o negative». (Comunità e società, tr. it., Milano 1963, p. 45). Anche questa posizione è restrittiva, tiene conto dell’azione della volontà ma non pare sufficientemente chiara la funzione di interazione, in particolare non si vede come i rapporti di affermazione reciproca possano essere studiati se non tenendo conto delle conseguenze appunto della reciprocità. Ben altro discorso andrebbe fatto poi sulla ripartizione binaria tra rapporto considerato come vita reale (comunità) e rapporto considerato come formazione meccanica (società), ma di questo parleremo quando affronteremo il problema della struttura istituzionale e della forma sociale (Stato e società). Più chiaro Talcott Parsons che scrive: «Dal momento che un sistema sociale è un sistema di processi di interazione tra oggetti agenti, la struttura delle relazioni tra i soggetti coinvolti nel processo di interazione costituisce altresì la struttura del sistema sociale. Il sistema sociale è una rete di tali relazioni». (Il sistema sociale, tr. it., Milano 1965, pp. 31-32). Buona disposizione iniziale del discorso ma risultati sempre parziali in quanto non viene operata una sufficiente distinzione tra i diversi soggetti (formali o strutturali). Importante è comunque in questo autore l’analisi dell’interazione, la quale resta tra le migliori che possediamo pur con tutte le sue accentuazioni formalistiche.
La situazione e il suo punto critico
L’interazione tra le situazioni e le cose e le idee è un fatto in corso, un avvenimento in fase di realizzazione. Non può essere quindi considerato come un fatto che si sviluppa per gradi. La formazione delle varie situazioni nel tempo (non dei vari individui nei loro momenti fondamentali dell’azione, che sono a-temporali) è più che altro un fatto di inserimento che seppure modifica l’insieme delle interazioni non può essere considerato il “cominciamento” dello stesso insieme.
Esiste comunque un punto critico per lo sviluppo della situazione dell’individuo, punto che ha conseguenze anche sull’insieme delle interazioni.
Sviluppandosi il vasto corredo di interazioni, la situazione dell’individuo si specifica e si qualifica sempre di più. Egli interiorizza processi in atto di idee e di cose, trasforma stati meramente apprensivi in stati valutativi, dà alle proprie capacità intuitive di decisione un aspetto sempre più uniforme, se si vuole meno creativo, ma certamente più significativo ai fini sociali. In fondo, la creatività primitiva e spontanea viene a modificarsi in un senso che la fa apparire meno brillante e piacevole, ma certamente più evoluta anche se più conformista.
Procedendo oltre, l’individuo si riconosce in categorie più o meno precise che raccolgono altre situazioni individuali produttrici di risultati simili. Da questo momento, le sue azioni subiranno modificazioni non solo in funzione delle altre situazioni e delle cose e delle idee, ma anche in funzione di queste nuove costanti che si vanno delineando. La situazione sviluppa una capacità di apertura immensa. Un gran numero di forme sociali e un certo numero molto più ristretto di strutture istituzionali si sviluppano davanti ad essa.
Il nascere di queste forme e di queste strutture è naturale conseguenza della selezione delle azioni. Qualificandosi in un certo modo a seguito di un insieme di interazioni, la situazione accresce sia la capacità di agire dell’individuo stesso, sia la sua capacità di conoscere quella che è la propria volontà d’azione. Ne consegue una migliore conoscenza di quelle che sono le proprie possibilità, le proprie caratteristiche, la propria personalità, il proprio valore.
Il sentirsi crescere attorno queste forme e queste strutture, aumenta il proprio senso di sicurezza e contribuisce a sentire gli elementi attivi della potenzialità e quelli passivi del potere.
Se il processo di formazione delle situazioni individuali, nel suo insieme, non fosse un flusso (non un progresso, evidentemente, che è un altro problema), e questo livello critico fosse raggiungibile più o meno contemporaneamente da tutti gli individui, si avrebbe che le forme sociali e le strutture istituzionali non sarebbero là a contribuire, in quanto cose e risultati di interazioni tra cose, idee e situazioni, non sarebbero in grado di spingere la situazione verso l’integrazione in queste forme e in queste strutture.
Comunque, a questo punto possiamo astrattamente identificare un livello critico, una linea di non ritorno, al di là del quale la situazione non può più essere autonomamente destrutturata in modo completo e mai in forma indipendente da decisioni valutative dell’individuo. Mentre il viaggio verso l’integrazione avviene via via col semplice interagire, il viaggio inverso (sempre parziale) avviene (a livello individuale) con decisioni valutative che richiedono un notevole livello di conoscenza complessiva dei meccanismi dell’interagibilità.
In concreto, da un punto di vista rivoluzionario, occorrerebbe creare le condizioni adatte per convogliare le situazioni all’interno delle forme sociali, evitando le strutture istituzionali. Ciò consentirebbe un indebolimento del potere delle strutture istituzionali e un rafforzamento della potenzialità delle forme sociali.
Un lavoro in questo senso sarebbe di ben lunga durata e avrebbe risultati sempre modesti, in quanto la situazione individuale nel suo sviluppo si trova già coordinata da una vasta rete di interazioni anche a livello istituzionale, per cui un orientamento selettivo fortemente indirizzato verso le forme sociali è praticamente impossibile. Ecco quindi che si deve concludere per la necessità della rivoluzione sociale, la quale distruggendo le strutture istituzionali stravolge le forme e anche tutta la rete delle interazioni.
Potenzialità e potere
Totalità e movimento
Se consideriamo tutto ciò che esiste semplicemente come una totalità non capiamo il prodursi della realtà. Dobbiamo introdurre nel concetto di totalità quello di movimento. Nel primo caso resteremo legati all’ipotesi di “sostanza” e ad una concezione statica (o meccanica) del materialismo, nel secondo caso possiamo ipotizzare la costruzione di un diverso materialismo che, per comodità d’uso, possiamo definire relazionale.
Il movimento relazionale non è comprensibile senza l’idea di una rete vastissima di relazioni. Questa rete, in movimento, è la realtà. Considerarla un semplice accumulo di fatti farebbe sorgere il problema della relazione tra ogni singolo fatto e l’insieme di tutti gli altri fatti, il classico problema del tutto e della parte. Nella dimensione relazionale in ogni elemento della realtà sono presenti tutti gli altri elementi, allo stesso modo in cui da un singolo punto passano tutte le rette immaginabili. La concretezza ben posta è quindi quella che parte dalla totalità del reale come insieme di relazioni. Le relazioni sono continue e costituiscono il movimento. Quest’ultimo è la realtà, cioè è dato da una serie di relazioni che si modificano continuamente. Diventa così inutile il concetto di identità.
La polarizzazione della relazione, nella sua fase puntuale, identificabile solo per via teorica, avviene attraverso il flusso del significato. Quest’ultimo si concentra ai due lati della relazione. La realtà è costituita da elementi in relazione fra loro i quali vengono percepiti da noi attraverso i significati delle diverse relazioni. Il flusso di questi significati determina il campo. Spesso chiamiamo oggetto questo campo, ma si tratta di definizione insufficiente. La controparte della relazione si allarga nel campo e, da questo, ritorna – nel flusso dei significati – verso la situazione. Ne deriva che quest’ultima può diventare campo se vista da una prospettiva e situazione se vista da un’altra prospettiva.
Di volta in volta, nel corso della discussione dei vari problemi, vedremo i diversi contrasti tra forme sociali e strutture istituzionali. Qui occorre solo accennare alle caratteristiche di fondo che sono: la potenzialità delle forme sociali, cioè la capacità di inserire l’individuo in una serie di interazioni sempre rinnovata senza lasciarsi costringere all’interno della situazione di partenza, il potere delle strutture istituzionali, cioè il mezzo per garantire la continuazione e il rafforzamento di una situazione attuale. Ad esempio, tra l’azione affettiva e la forma sociale dell’affettività, esiste appunto l’acquisizione di una potenzialità nuova per l’individuo. Come, al contrario, tra l’azione affettiva e la struttura istituzionale della famiglia, esiste un rapporto preciso ed è quello del rafforzamento della gabbia istituzionale.
La situazione di classe
La diversa distribuzione delle potenzialità delle forme sociali dà un aspetto dinamicamente costruttivo alle situazioni individuali, mentre la diversa distribuzione del potere delle strutture istituzionali dà ad esse un aspetto vischiosamente normativo.
Le differenti realtà vengono ancora meglio qualificate attraverso il processo di accumulazione dei mezzi che rende, l’intera realtà interagente, una realtà lacerata. Le potenzialità delle forme sociali finiscono per soggiacere ad una stratificazione sempre più massiccia del potere delle strutture istituzionali. Anche se non scompaiono del tutto, queste potenzialità si permeano esse stesse di potere, diventando strumento non ultimo della possibilità di sopravvivenza dello stesso, oppure si piegano in attività di difesa, di isolamento, di autogaranzia. Dettagli della realtà di classe.
Ogni pio tentativo di arrestare il flusso delle interazioni, diretto a far permanere la situazione di lacerazione, alleggerendola e programmando una modificazione nel tempo, è pura illusione riformista.
La situazione di classe è quindi il risultato dell’incontro delle interazioni tra forme sociali nella loro potenzialità e strutture istituzionali nel loro potere, incontro che non è capace di fissare in modo preciso un ambito di possibilità per l’individuo, ma che però è capace di delimitare un flusso, un campo, una sfera di classe. Anche se i contorni sono poco netti, il risultato non è per questo meno chiaro. La situazione di classe dell’individuo è quindi sufficientemente descritta dall’insieme delle interazioni tra forme sociali e strutture istituzionali, tra la potenzialità delle prime e il potere delle seconde, il quale insieme fissa i limiti della sua capacità di agire e, con i limiti, le caratteristiche che definiamo di classe.
La prevalenza della potenzialità assegna alla situazione di classe una caratteristica dinamica non potendo la struttura istituzionale scendere troppo in profondità nel terreno della forma sociale, sia per le caratteristiche relative alla permeabilità del rapporto, sia per una intrinseca refrattarietà dell’azione normativa a venire a patti con le forme creative. La tendenza del potere normativo è quella di restringere all’infinito i limiti di legittimità per fare in modo che l’autonomia possibile resti solo quella della norma, ad esclusione di qualsiasi altra alternativa. Non potendo realizzare questo suo ideale di totalitarismo, il potere è costretto a restare molto al di qua di dove le sue intenzioni vorrebbero portarlo.
Da canto suo, la tendenza della potenzialità creativa e dinamica delle forme sociali è quella di rintracciare nuovi spazi di operatività, nuovi orizzonti sempre più fecondi, di operare in orizzontale, mentre il contrasto con l’invadenza della struttura istituzionale viene sostenuto in funzione della possibilità di conoscere tutti i termini dello scontro. Non essendo possibile ciò, la potenziale capacità dell’individuo di analizzare il rapporto reale tra forme sociali e strutture istituzionali è molto limitata. Pertanto, egli si limita ad agire in base alle proprie sollecitazioni di fondo (la sua situazione), che poi gli sembrano le cose più importanti e necessarie, senza (o quasi) approfondire attraverso quali sollecitazioni esterne è pervenuto a prendere per buone le proprie decisioni, e quindi a coordinare le proprie azioni.
La tendenza della potenzialità delle forme sociali non è, pertanto, una tendenza normativa capovolta, una specie di potere rovesciato, un contropotere. Non può imporre limiti di legittimità alle strutture istituzionali. Ma, nello stesso tempo, non li subisce in modo definitivo. La sua azione sarà così caratterizzata dall’elemento conoscitivo e dall’introiezione dello stesso. La scelta dell’individuo, a questo punto, può essere una scelta di libertà o una scelta di potere.
Partendo dal livello della reale conoscenza della propria situazione di classe, si deve dire subito che la struttura istituzionale s’impone per il suo aspetto ordinato e metodico (apparente), per i suoi tentativi di legittimare l’azione, per l’insieme degli sforzi che dedica ai processi di ideologizzazione, per l’ingenua fiducia che alimenta nelle proprie norme, per la paura della libertà che riesce a diffondere, ecc.
È chiaro che chi ha da difendere processi interattivi di accumulazione finisce facilmente per trovare, in questo enorme laboratorio di mezzi di potere, qualcosa per mettere fine ai disagi della potenzialità dinamica non realizzata. È l’individuo di potere. La sua situazione di classe si identifica sempre più con il modello normativo della struttura istituzionale. Egli non ha più affetti ma una famiglia, non ha affinità ma un partito, non ha stimoli all’azione ma lavora, non ha erotismo ma una codificata sessualità. La conflittualità della coscienza di classe dell’individuo di potere non è eccessiva, questi manipola, sa di manipolare e di essere manipolato, ma la cosa lo turba poco fin quando gli garantisce solidità e sicurezza. Non deve più agire in modo da mettere in causa se stesso, ma limitarsi a ridurre le proprie azioni a fatti stereotipati che si autoriproducono. Non è più amante ma marito, non è più amico ma funzionario o militante, non è più produttore ma operaio o impiegato, non è più innamorato ma maschio o femmina.
Più i processi interattivi di accumulazione si fondano su privilegi, più si acuisce la situazione di potere, più l’individuo di potere sviluppa il suo interagire fondandolo su di un sostegno passivo che gli viene dalla struttura istituzionale, e così diventa egli stesso elemento attivo di questa struttura. Coincidendo in genere questa sua maggiore attività con una più larga padronanza di mezzi culturali a disposizione, egli diventa elaboratore della struttura istituzionale, guardiano, architetto e profeta. In questo caso, l’individuo di potere acquisisce la coscienza della propria classe, la coscienza della classe dominante.
Riducendosi i privilegi su cui si fondano i processi interattivi di accumulazione, può accadere che l’individuo tenda ad adagiarsi in una supina accettazione di quel minimo che gli viene procurato. Le sue stesse catene gli sembrano allora un privilegio, agisce per non farle cadere. Le sue azioni sono standardizzate e abitudinarie. Egli è un individuo di potere in senso passivo, non elabora la struttura istituzionale, la sostiene con la sua passività, schiavo sciocco e utile ingranaggio.
Continuando la riduzione dei privilegi scompare il processo di accumulazione oppure, in alcuni casi, man mano che si fa più acuta la tensione intellettuale di fronte alla lacerazione di classe, l’individuo tende a reagire, cioè a invertire la rotta delle proprie azioni, o comunque a impostare un nuovo processo interattivo. La potenzialità della forma sociale è il suo unico appiglio, l’operatività orizzontale e creativa diventa lo strumento costruttivo di nuove interazioni, la rivoluzione sociale la sua conclusione logica.
I tre aspetti dell’azione
Riprendiamo i tre momenti dell’azione. L’azione-apprensione si basa su di un processo di interazione tra sollecitazione genetica ed esperienza sociale. La caratteristica del processo complessivo è la permeabilità che rende il tutto molto fluido e assolutamente incomprensibile, se non si tenesse conto del contemporaneo effetto delle altre azioni (valutazione e decisione). La specificazione sociale di questa azione è data dalla tassonomia dei bisogni. Occorre però tenere presente che i tre livelli dell’azione intervengono contemporaneamente nell’individuazione dei bisogni in quanto questi, pur essendo in funzione della azione-apprensione, non sarebbero comprensibili in una sfera astratta in cui si venisse a verificare solo l’effetto di quest’azione.
L’azione-valutazione si basa su di un processo di interazione tra sollecitazione culturale ed esperienza sociale. La caratteristica del processo complessivo è la vischiosità che è la caratteristica predominante dei tempi di modificazione dell’universo culturale. La specificazione sociale di questa azione è data dall’accumulazione simbolica, cioè dalle stratificazioni linguistiche che rendono possibile l’interazione con le idee.
L’azione-decisione è processo in corso pur non avendo le caratteristiche delle due precedenti azioni. Partecipa del momento dell’apprensione in quanto fornisce l’elemento intuitivo che consente l’individuazione del bisogno, partecipa pure del momento della valutazione in quanto fornisce anche qui l’elemento intuitivo che seleziona il processo di accumulazione simbolica il quale, in caso contrario, annegherebbe in una nebbia senza fondo. In se stessa si presenta quindi come una apertura verso la situazione e verso i rapporti con le cose e le idee.
Le forme sociali
Con lo sviluppo dei flussi relazionali, le situazioni si perfezionano e si contrappongono, creando indirizzi ben definiti. Certo, l’azione che l’individuo compie nei confronti delle forme sociali è in parte subordinata a quella che queste ultime compiono su di lui. In linea di principio non è facile dire se le forme sociali subiscono direttamente l’azione del singolo. Teoricamente la cosa non può essere esclusa. Evidentemente si tratta di un’azione modesta, almeno se paragonata a quella che si realizza in senso inverso. Perciò parliamo del crescere della forma sociale attorno alla situazione.
In concreto, le forme sociali, allo stato attuale della società, non sono osservabili se non nella loro interazione con le strutture istituzionalizzate. Dobbiamo quindi fare uno sforzo teorico per ipotizzare alcune forme sociali pure, in pratica non esistenti, per poi vedere come interagiscono con le strutture istituzionali.
A livello individuale emergono alcune azioni caratterizzate in un certo modo, ad esempio azioni affettive, azioni di affinità, azioni di attività, azioni di gioia, azioni erotiche, ecc. Queste azioni, interagendo con l’individuo, interagiscono tra di loro. Al livello che qui stiamo considerando, si tratta di azioni che fanno perno sul momento dell’azione-apprensione, hanno una certa angolazione attraverso il momento dell’azione-valutazione e vengono alla luce attraverso l’azione-decisione.
A livello della situazione individuale, queste stesse azioni, che prima avevano forma molecolare, ricevono una forma abbastanza costante e dalla fase puntuale passano a quella del processo di sviluppo. La sfera degli affetti si forma socialmente attraverso la rapida intensificazione dell’interazione con la situazione degli individui più vicini. In situazioni oggettive diverse da quelle attuali, la forma sociale emergente avrebbe notevoli contenuti di libertà, pur non essendo in grado di dire in che misura si possa dare per scontata l’assenza totale di sedimenti di potere. Comunque, allo stato attuale questa forma sociale viene permeata dalla struttura istituzionale. Resta evidente però che la forma degli affetti, per restare al nostro esempio, è prodotta dal processo delle sequenze delle azioni, quindi è pur sempre un fatto relazionale, mentre il livello di interazione con le strutture istituzionali è un livello ulteriore e produce una nuova serie di interazioni anche con la situazione di partenza dell’individuo.
La forma sociale è quindi un prodotto del processo di interazione e, come tale, è movimento, cioè si modifica continuamente (a prescindere dalla interazione con le strutture istituzionali).
Le strutture istituzionali
L’origine di queste strutture è nello stesso processo di interazione. La serie delle interazioni ha determinato in epoca storica l’accumulazione di una differenza nelle possibilità oggettive delle situazioni degli individui, cioè negli sbocchi concreti per questi individui di realizzare se stessi sulla base delle proprie reali peculiarità. L’accaparramento di posizioni di favore da parte di alcuni ha determinato una serie di interazioni dirette a selezionare identiche situazioni di favore per altri con similari forme sociali di affettività, di affinità, di azione, ecc. All’inizio, forse, il problema stesso del possesso – che non poteva essere sufficiente per tutti in sopraggiunte situazioni di scarsità – favorì questa selezione. Poi l’interazione con le cose e con le idee, e alcuni particolari impieghi di queste in vista di quelle, cristallizzarono la disparità. La struttura istituzionale era così completa. Infatti, nella situazione di concorrenza sorge subito il problema, per chi detiene il frutto del processo accumulativo, di evitare disturbi nella polarizzazione stessa del processo che tanto gli fa comodo. Da ciò la necessità di stabilire i limiti di legittimità dell’azione.
La struttura istituzionale interviene nella forma sociale con un processo di permeazione, imponendo limiti di legittimità all’azione dell’individuo interagente nella forma sociale stessa.
Come abbiamo visto, dalle azioni affettive si costituisce la forma sociale dell’affettività, permeata dalla struttura istituzionale famiglia. Dalle azioni di affinità si ha il costituirsi della forma sociale dell’affinità, permeata dalla struttura istituzionale dell’organizzazione. Quest’ultima struttura assume aspetti diversi che possono andare dal partito al sindacato, fino al movimento rivoluzionario specifico.
Dalle azioni di attività si ha il costituirsi della forma sociale dell’azione, cioè del prodotto riflesso di quella componente essenziale dell’individuo che è la sua capacità di agire. In questo caso, la forma sociale dell’azione è, più propriamente parlando, la forma della trasformazione sociale, un mezzo per l’individuo di concretizzare nella propria situazione la capacità di agire (non solo nei confronti della natura, ma anche verso gli altri individui). Questa forma sociale viene permeata dalla struttura istituzionale dell’organizzazione economica.
Dalle azioni di gioia si ha il costituirsi della forma sociale dell’eros, permeata dalla struttura istituzionale della sessualità.
L’azione sociale
La libertà
Le difficoltà incontrate si sono potute superare soltanto in parte. E ciò a causa della non facile accessibilità di alcuni problemi e della difficoltà di natura terminologica e concettuale che ne deriva. Non c’è dubbio che, allo stato attuale della ricerca, il lettore troverà un ostacolo notevole nel capire il funzionamento del meccanismo relazionale. Se non altro perché qui ci interessiamo, senza indugi, di entrare nella dimensione sociale del movimento relazionale, fornendo lo stretto indispensabile dell’apparato metodologico di base, indispensabile alla comprensione. Lo stretto indispensabile, a volte, è troppo poco. Occorre pertanto avere un poco di pazienza.
Il fatto è che nel ragionamento relazionale non è facile fissare i limiti tra il modello umano e il modello naturale dell’interazione. Di più, nel trattare di argomenti sociali questa distinzione, se mai fu possibile, diventa veramente una chimera. Dobbiamo quindi capire che non è ricorrendo ad un umanesimo superficiale ed approssimativo che “capiamo” meglio. Ad esempio, bisogna accuratamente evitare tutti i modelli occasionali che trovano origine dalle cosiddette “relazioni umane”. Questi modelli sarebbero dispersivi e farebbero capire meccanismi che non sono se non una piccola parte, e decisamente secondaria, dei flussi relazionali della realtà. Allo stesso modo, bisogna evitare il modello naturalistico in senso stretto, che impone alla realtà un progetto costruito in laboratorio, facendola piegare alle ipotesi del pensatore. In ambedue i casi perdiamo di vista l’assoluto fondamento di libertà della relazione, l’assoluta anarchia del flusso dei significati.
In una porzione del reale – quale è appunto la dimensione umana – la cosa è visibile con molte difficoltà in quanto l’uomo non è libero ma prigioniero, ostacolato da mille catene che gli vengono chiuse dall’esterno. Per altro, dal punto di vista della libertà, caratteristica della relazione in quanto tale, non c’è modo di cogliere il movimento liberatorio nella sua concretezza. La libertà è possibile come lotta, allo stesso modo in cui la relazione è possibile come flusso, è coglibile come situazione. È quest’ultima che coordina i flussi relazionali, contrapponendosi al campo e facendo emergere l’individualità, la caratteristica specifica, relazionale, ma ben più complessa ed articolata della semplice relazione o della semplice particella elementare che sono pur sempre “realtà”. È nell’individualità che la libertà diventa lotta, possibilità, contrasto, conquista.
L’azione e il significato
L’azione trasmette un significato. Ciò può anche dirsi nel modo seguente, la relazione è determinata dal flusso dei significati. Esiste pertanto un meccanismo del movimento relazionale, ed è quello della polarizzazione dei significati.
La relazione è quindi, di già, anche a livello puntuale, un’azione. Ma non è assolutamente coglibile in quanto tale. È l’oggetto sconosciuto, il funzionamento ignoto di una contrapposizione.
Il viaggio del significato avviene tra due poli, o “lati” della relazione, ma il “lato” è di già un elemento complesso e non può considerarsi punto iniziale di qualcosa. Esso è piuttosto un punto d’incontro di una rete vastissima di relazioni che solo per comodità consideriamo limitata (almeno per intensità di significato).
Da un “lato” della relazione sta quindi una totalità di relazioni possibili che si intersecano (sarebbe più giusto dire “la” totalità delle relazioni), e lo stesso accade dall’altro “lato” della relazione, che ha le stesse caratteristiche del primo “lato”. Il movimento (o, se si preferisce, la polarizzazione) spinge verso queste due estremità due significati i quali hanno diversa intensità.
Siamo davanti al processo di costruzione della situazione. Il continuo mutamento relazionale disegna un territorio di significati grazie alla serie infinita di “viaggi” compiuta dai flussi relazionali. Ovviamente non si tratta di viaggi nello spazio ma di trasformazioni nella realtà o, per meglio dire, nel movimento della realtà. L’accrescimento di significati che questo movimento produce è certamente identificabile (ed anche misurabile) dal punto di vista della singola situazione individuale, ma è praticamente inesistente dal punto di vista della totalità del reale. In questo senso non è possibile una vera e propria “creazione” di significati.
Il “lato” della relazione comprende l’intera realtà delle relazioni possibili. La cosa, in sostanza, è talmente incredibile (tutto ciò che supera la struttura dell’oggetto “scatola” è, per l’uomo, difficilmente immaginabile), che si preferisce dire che da un “lato” della relazione sta un qualcosa, fornito di confini modificabili in continuazione, che viene via via alimentato dai flussi di significato. Questo qualcosa potrebbe essere la situazione di cui parliamo in queste pagine, almeno dal punto di vista oggettivo, cioè per come si va distribuendo il flusso relazionale dei significati. Al contrario, dal punto di vista soggettivo, si potrebbe parlare di campo.
Possiamo quindi fissare qui due fatti relazionati tra loro, la situazione e il campo sono ipotesi ritagliate nella totalità delle relazioni possibili, la prima dal punto di vista oggettivo, il secondo dal punto di vista soggettivo.
L’azione sociale
La vita umana si presenta come contemporanea azione di sapere e di fare, fusione più o meno critica e problematica di consapevolezza e di attuazione pratica. Ciò è vero in quanto la mia vita, quella per cui posso anche permettermi di parlare di una vita umana in generale, non è soltanto una banale contemplazione di immagini metafisiche, ma è essenzialmente azione che rende attiva anche la consapevolezza di me stesso e del mondo.
Non è possibile quindi proporre due momenti separati, quello della teoria e quello dell’azione. Un primo momento in cui si conosce e un secondo momento in cui si agisce. La volontà non determina l’azione che sotto lo stimolo del sapere, ma la conoscenza non può aversi senza la volontà di conoscere.
Coscienza e conoscenza
Il mondo oggetto della conoscenza e dell’agire è, a sua volta, afflitto da una apparente contraddittorietà. Le forze reazionarie hanno sempre avuto interesse a indicare questa contraddittorietà tra leggi teoriche, da un lato, e insieme dei fenomeni, dall’altro lato, come qualcosa di insormontabile, racchiudendo la riflessione all’interno di un relativismo assoluto che finisce per mortificarla. In sostanza, questo mondo è il mondo dell’azione umana, il mondo dell’uomo, il mondo dell’agire umano che ha decodificato la natura e l’ha resa reale. Non si tratta di un mondo di oggetti resi immutabili da una feticizzazione del loro ruolo nei confronti dell’uomo, ma di un mondo in cui le cose, i rapporti e i significati sono elementi venuti fuori dall’agire stesso dell’uomo, un prodotto della sua azione sociale.
Sarebbe un errore proporre un modello di rapporto tra il mondo reale e l’uomo sulla base della coscienza che l’uomo ha del mondo, rinviando l’acquisizione della conoscenza ad un momento successivo e da costruirsi. L’uomo non ha coscienza assoluta del mondo più di quanto non l’abbia di se stesso. La coscienza non può considerarsi come un sapere insufficiente, ma generale, che si contrappone alla conoscenza come sapere sufficiente, ma limitato. Io posso avere coscienza di una situazione di sofferenza in cui si trova il mio corpo e posso facilmente localizzarla nei denti. Posso quindi essere cosciente di avere mal di denti. Ma questo processo può evolversi sul piano della consapevolezza in molti modi, attraverso l’intervento dei processi conoscitivi (la mia bocca è provvista di denti, qual è la forma di questi denti, perché essi sono sensibili al dolore, quali malattie li intaccano, ecc.), senza per altro che si possa dire che questa fase conoscitiva abbia reso adeguato il mio sapere di fronte alla inadeguatezza della coscienza che io avevo di esso. Potrei infatti, malgrado l’allargamento dei piani conoscitivi, intervenuto dopo, potrei non sapere cosa fare per porre rimedio al dolore.
In effetti, la conoscenza contrapposta alla coscienza di una realtà non è un diverso modo di conoscere, ma un modo di conoscere il diverso.
Io posso avere coscienza di una mia situazione di classe, posso verificare reazioni più o meno adeguate a una realtà che mi infastidisce o mi sollecita ad accettarla. E poi conoscere questa mia situazione di classe in un modo che se resta in sostanza identico al modo con cui ne avevo coscienza, mi consente di passare dalla consapevolezza di diversi stati d’animo, alla consapevolezza di diversi stati di cose.
Sulla base di questa differenza puramente estrinseca e sul riconosciuto elemento di fusione tra coscienza e conoscenza, devo ammettere che non c’è una delimitazione precisa tra fare e pensare.
Il problema dell’agire
Sia la teoria che l’azione determinano conseguenze sulla realtà. Non sarebbe giusto dire che le teorie determinano conseguenze sulle teorie e le azioni sulle azioni. Infatti, non è vero che le teorie interagiscono in un loro universo chiuso (poniamo quello delle accademie) ma, come constatiamo tutti i giorni, producono effetti molto concreti nella realtà sociale, ed anche gli effetti che producono sulle altre teorie finiscono per tradursi in effetti su questa realtà. Le azioni allo stesso modo producono effetti non solo nella realtà sociale (insieme di fatti concreti), ma anche nelle riflessioni su quell’insieme di fatti, cioè sulle teorie. In quest’ultimo senso, le azioni costituiscono, nei riguardi delle teorie, insiemi teorici ben delimitati, come le teorie costituiscono, nei riguardi delle azioni, insiemi pratici altrettanto delimitati.
L’elemento che caratterizza in modo profondo questa dimensione teorica e questa dimensione pratica è la conflittualità di classe. L’agire umano, almeno nelle attuali condizioni, è fondato sulla divisione in classi della società, sulla conseguente gerarchia delle posizioni sociali, sulla divisione del lavoro. In quanto partecipe dell’agire umano, la teoria che l’uomo produce è anch’essa fondata sugli stessi elementi, è anch’essa caratterizzata dalla conflittualità di classe.
Il nostro agire è quindi funzione di quello che il mondo esterno è “per noi”, cioè dal punto di vista del campo che ci costruiamo (o, se si preferisce, della situazione che è la nostra, dal punto di vista oggettivo). Tutto ciò con relativi chiaroscuri, contraddizioni, verità e inganni. Di questo mondo esterno (e di noi stessi), abbiamo coscienza immediata, che corrisponde alla nostra reazione più o meno adeguata alle condizioni della conflittualità di classe che caratterizzano il mondo esterno e noi stessi. Ma già il nostro semplice agire modifica questa “coscienza iniziale” portandola ad una più ampia consapevolezza di quanto di distinto e di confuso esiste al suo interno. Questa maggiore consapevolezza costituisce l’avvio del processo di conoscenza o “conoscenza in atto”, cioè conoscenza che agisce e modifica se stessa e l’oggetto della sua attenzione. Questo processo di apertura non è pertanto un modo di capire, ma è un modo di essere la conflittualità di classe. Noi non siamo qualcosa di esterno ad essa che per determinate condizioni favorevoli può capire quello che avviene al suo interno, la conflittualità di classe siamo noi stessi per il semplice motivo che il mondo della realtà siamo noi e le sue conflittualità sono le nostre.
Agendo prendiamo posizione, cioè trasformiamo la realtà, incidiamo su di essa. Ma questo prendere posizione è funzione della coscienza-conoscenza che noi abbiamo della realtà e dei suoi-nostri meccanismi interni. Se il nostro agire è sempre in funzione di parte, se noi intendiamo sempre fare quello che facciamo a favore della nostra parte in conflitto nella realtà, ciò non significa che quello che facciamo raggiunga in pieno il nostro scopo. Esiste una percentuale di scarto che può andare da un massimo di assoluta incoscienza dei propri interessi di classe, ad un massimo di adeguata coscienza di questi interessi.
L’azione del nostro nemico di classe, come la sua teoria, è diretta a rafforzare il suo dominio in quanto da una situazione di divisione e gerarchia esso ricava tutti i vantaggi del dominatore. Da qui la tendenza conservatrice del dominio che cerca di cambiare quanto possibile perché tutto resti come prima. La struttura istituzionale assume pertanto l’aspetto frastagliato e meccanico di uno sviluppo ramificato che contrasta fortemente con l’aspetto sfumato e costante della forma sociale. L’azione di chi subisce lo sfruttamento è diretta a modificare le cose perché si possa avere un miglioramento, una effettiva trasformazione. La forma sociale è quindi in movimento continuo dal basso verso l’alto, la struttura istituzionale è invece statica e si modifica solo lentamente e con processi molto faticosi dall’alto verso il basso.
Quanto abbiamo detto per l’azione del nemico di classe e per l’azione dello sfruttato avviene anche per la teoria della liberazione, cioè per la teoria rivoluzionaria. Contro quest’ultima viene costruita una teoria della conservazione e della reazione. Si tratta di agire-teorizzare in funzione di parte. Ma non tutte le azioni-teorie del dominio solidificano quest’ultimo, come non tutte le azioni-teorie della liberazione lo distruggono. Se nella fase di coscienza immediata esse sono sufficientemente chiare, non lo sono più nella fase di coscienza in atto, cioè quando interagiscono come conoscenza che agisce e teorizza modificando. Ma la scomparsa di quel senso di iniziale chiarezza, per cui si identifica ad occhi chiusi il proprio nemico, lungi dall’essere una debolezza è un acquisto di maggiore forza di penetrazione, la conoscenza perfeziona gli strumenti di lotta e fornisce maggiori indicazioni sulla reale consistenza del nemico.
La polarizzazione di significatività
Un’azione e una teoria ricevono una immediata polarizzazione di significatività, cioè vengono attratte verso zone dello spazio sociale che danno loro un preciso senso, per cui man mano che vengono sviluppate si orientano e orientano verso di loro tutta una serie di interazioni. Si tratta di processi modificativi che non è facile cogliere se non per grandi flussi di significato (orientamento di classe).
Abbiamo così che l’insieme del flusso delle azioni di liberazione, pur comprendendo un tutt’altro che trascurabile quantitativo di azioni che si traducono in un mantenimento del dominio, assume sufficiente omogeneità, in forza del proprio orientamento di classe, da potersi parlare di insieme di azioni che costituiscono una “teoria della liberazione”. Le teorie rivoluzionarie, anche nella ristretta forma della riflessione conoscitiva, orientandosi nel suddetto senso di classe, pur presentando spesso aspetti non trascurabili di manutenzione del dominio (basti pensare alle posizioni autoritarie), assumono sufficiente omogeneità da potersi includere all’interno di quell’“azione rivoluzionaria” che non è scindibile dalla teoria della liberazione.
Spetta alla teoria rivoluzionaria ricomporre i vari gradi di conflittualità tra azione rivoluzionaria e teoria della liberazione che presentano consistenti aspetti contraddittori, inserendo i risultati ottenuti all’interno di una lettura decodificante della teoria e della pratica del dominio, teoria e pratica che hanno al loro interno aspetti non meno contraddittori. Il servizio principale che la teoria rivoluzionaria rende alla rivoluzione sociale è quello di indicare i limiti dell’azione e della teoria che gli sfruttati portano avanti, elevando il livello di quella teoria che esse costituiscono nel loro insieme. Nello stesso tempo, la teoria rivoluzionaria indica quanto di utilizzabile per la rivoluzione sociale ci sia nella pratica che oggi consente la permanenza del dominio, mentre denuncia le componenti reazionarie e mistificatorie della teoria ideologica del dominio di classe.
Da quanto detto risulta evidente che non è possibile parlare separatamente di teoria e di azione, ma che la teoria risulta essere una particolare forma di azione, sebbene non la sola che intervenga a livello della conoscenza in quanto a questo livello intervengono anche tutte le azioni in senso stretto.
I fatti
L’insieme dei fatti
L’insieme dei fatti non è la somma grezza della totalità di quanto accade, cosa che non sarà mai possibile avere se non instaurando un ricorso all’infinito privo di validità immediata, ma è quel complesso dei fatti, quel raggruppamento dei vari aspetti delle cose e delle azioni che è coglibile concretamente attraverso il fatto stesso che si cerca di cogliere. Quindi l’insieme dei fatti è costituito da quel complesso polarizzato che si dispone davanti alla mia azione di apprensione della sua significatività. Sarà questa azione a determinare una certa polarizzazione di significati e a fissare un rapporto che caratterizza la mia azione e l’insieme dei fatti.
La posizione di Wittgenstein è chiaramente idealista quando parla del mondo definendolo come «la totalità dei fatti, non delle cose», (Tractatus logico-philosophicus, tr. it., Torino 1964, p. 5), o quando scrive: «la totalità dei fatti determina ciò che accade», oppure «il mondo si divide in fatti», (ib., p. 5), e ciò perché considera le cose col pregiudizio mistico dell’in sé, oscura eredità della metafisica kantiana. Per lui, comunque, il «mondo è tutto ciò che accade», quindi anche le cose dovrebbero far parte del mondo una volta che non le consideriamo più come misteri ma come realtà che assumono significato a seguito dell’agire dell’uomo. Per noi, infine, tutti i fatti costituiscono il mondo reale non come le patate contenute in un sacco, ma come un insieme relazionato all’interno del quale ogni fatto appare come uno degli aspetti di una serie più o meno complessa di interazioni. Sviluppando una critica del marxismo Friedrich August von Hayek scrive: «L’oggetto dello studio scientifico non è mai la totalità di tutti i fenomeni osservabili in un determinato istante e luogo, bensì sempre soltanto determinati aspetti che vengono da essa astratti». (Scientisme et science sociales, ns. tr., Paris 1953, p. 79). Ciò significa negare il valore che l’insieme dei fatti ha a prescindere dall’attività conoscitiva del singolo che agendo su quei fatti pretende crearli astraendone una parte da un tutto ipotetico e lasciando il resto. Questa è, ancora una volta, un’operazione idealista. Agendo sull’insieme dei fatti non si opera una scelta ma si determina una precisa polarizzazione su quell’insieme di fronte all’atto dell’indagare.
Le due posizioni, quella di Wittgenstein e questa di Hayek, si possono definire “razionaliste”. Esse considerano l’insieme dei fatti come somma di elementi confusi insieme e non ritengono possibile un rapporto conoscitivo con questo insieme se non attraverso una scelta di alcuni elementi che vengono percepiti dal soggetto e che restano sempre piuttosto atomisticamente indipendenti tra loro.
La posizione “organicistica” fa capo a Schelling. Essa afferma la priorità dell’insieme dei fatti e delle cose sul singolo conoscente, per cui la vera e sola conoscenza è quella dell’intuizione. «Questo sapere [intuitivo] – scrive Schelling – deve essere un sapere assolutamente libero, proprio perché ogni altro sapere non è libero, deve quindi essere un sapere al quale non conducano dimostrazioni, ragionamenti, e in genere una mediazione concettuale». (Sämtliche Werke, vol. III, ns. tr., Stuttgart 1856, p. 369). E, più avanti, nello stesso volume: «Tutta la filosofia prende e deve prendere le mosse da un principio che, come principio assoluto, è anche al tempo stesso puramente identico. L’assolutamente semplice, identico, non può essere colto, comunicato mediante la descrizione e, in genere, mediante concetti. Esso può essere soltanto intuito. Tale intuizione è l’organo della filosofia». (Ib., p. 625).
La posizione che si definisce “dialettica” concepisce il reale come un tutto strutturato che si sviluppa rapportandosi ai suoi vari elementi, contraddicendosi e superandosi. Eraclito dice: «Scambio di fuoco sono tutte le cose e fuoco è scambio di tutte le cose come dell’oro la roba e della roba l’oro». (Testi scelti a cura di E. Bodrero in Grande Antologia Filosofica, vol. I, Milano 1966, p. 60). Il concetto del rapporto tra tutte le cose è reso dal seguente famoso frammento: «A coloro che scendono negli stessi fiumi scorrono sopra continuamente nuove acque». (Ib., p. 50). La stessa idea di intima penetrazione tra tutte le cose (e tutti i fatti) svolge Hegel, aprendo la strada al materialismo dialettico: «La logicità diventa natura; e la natura, spirito». (Enciclopedia delle scienze filosofiche, vol. II, tr. it., Bari 1973, p. 528). E, più in dettaglio, nella stessa opera: «L’idea – la quale è per sé considerata secondo questa sua unità con sé, è intuire; e l’idea intuitrice è natura. Ma, come intuizione, l’idea è posta nella determinazione unilaterale dell’immediatezza o negazione, per mezzo della riflessione estrinseca. L’assoluta libertà dell’idea è però, che essa non trapassa solo nella vita, né solo come conoscere finito lascia apparire la vita in sé; ma, nell’assoluta verità di se stessa, si risolve a lasciar uscire liberamente da sé il momento della sua particolarità, o del suo primo determinarsi e del suo esser altro: l’idea immediata, che è il suo riflesso, – come natura». (Ib., vol. I, p. 199). Così Marx: «Il difetto principale d’ogni materialismo fino ad oggi – compreso quello di Feuerbach – è che l’oggetto, la realtà, la sensibilità, vengono concepiti solo sotto la forma dell’obietto o dell’intuizione; ma non come attività sensibile umana, prassi; non soggettivamente. Di conseguenza è accaduto che il lato attivo, in contrapposto al materialismo, fu sviluppato dall’idealismo, ma astrattamente, poiché naturalmente l’idealismo non conosce l’attività reale, sensibile in quanto tale». (Tesi su Feuerbach, in Marx-Engels, Opere complete, vol. V, Roma 1972, p. 625).
La polemica del neopositivismo e dell’esistenzialismo si svolge come negazione di quella totalità del reale, dell’insieme di fatti che ha una sua logica interna che si dispone in un certo modo davanti all’azione di chi la vuole cogliere. Popper scrive: «Il corso della storia umana è fortemente influenzato dal sorgere della conoscenza umana». (Miseria dello storicismo, tr. it., Milano 1975, p. 13). E, più avanti: «La prontezza nel correggere i nostri errori e nell’imparare consapevolmente da essi è la sostanza dell’approccio che ho denominato “razionalismo critico”. Considero l’approccio critico come un dovere». (Ib., p. 10). In questo modo, i fatti ritornano allo stato atomistico e possono essere scelti e vagliati. L’operazione implica una parità di valore sostanziale di tutti i fatti. L’analisi può e deve essere corretta (posizione della socialdemocrazia moderna). L’esistenzialismo conclude per una presenza del mondo reale, ma per una impossibilità radicale della sua conoscenza da parte dell’uomo, oppure (Sartre) per la pari inconsistenza di tutti i tentativi di conoscenza. Heidegger criticando Kant scrive: «Lo scandalo della filosofia non consiste nel fatto che questa prova [circa l’esistenza del mondo reale] non sia stata ancora fornita, ma nel fatto che essa sia sempre nuovamente richiesta e tentata». (Essere e tempo, tr. it., Milano 1953, p. 205). Mentre per Sartre: «Tutte le attività umane sono equivalenti, giacché tutte tendono a sacrificare l’uomo per far sorgere la causa di sé, e tutte sono votate per principio allo scacco. È la stessa cosa, in fondo, ubriacarsi in solitudine o condurre i popoli. Se una di queste attività è superiore all’altra, non è a causa del suo scopo reale ma a causa della coscienza che possiede del suo scopo ideale; e in questo caso il quietismo dell’ubriaco solitario è superiore alla vana agitazione del conduttore di popoli». (L’essere e il nulla, tr. it., Milano 1958, pp. 721-722).
Un problema di confini
Non ci si può immaginare un’azione che si prefigge un intervento nei riguardi della totalità del reale. Ogni azione è, da per se stessa, un flusso di relazioni sufficientemente strutturato. Questo flusso si pone nei confronti delle altre situazioni in modo, per l’appunto, relazionale.
Per quanto si voglia oggettivare l’azione, non è possibile pervenire ad un elemento puntuale, di fondo, ad una struttura elementare. Questo elemento viene considerato come dato all’infinito. Per quanto si voglia scindere nelle sue componenti l’azione, ci ritroviamo sempre davanti al problema dell’oggetto e della sua divisibilità, problema che attiene all’indagine sulla struttura della materia. Esistono materie che hanno una densità molecolare molto maggiore di altre, sebbene alla vista abbiano lo stesso aspetto. Esistono, nella struttura dell’universo, esempi di stelle in cui la densità, e quindi la pressione che viene esercitata sulle molecole della materie, è talmente elevata che una quantità di materia più o meno quanto un pisello dovrebbe pesare circa 100 tonnellate. Questo sta a dimostrare che la composizione delle varie situazioni, all’interno di campi che possiamo definire corpi, oggetti o cose, o anche fatti, o azioni, è modificabile secondo i flussi relazionali, secondo i significati.
Abbiamo pertanto un flusso relazionale modificabile continuamente in funzione della diversa posizione che gli elementi assumono e quindi dei diversi flussi di significato. Ogni singola azione è sempre in situazione, è essa stessa una situazione. Per la situazione valgono gli stessi princìpi dell’azione.
Ora, ogni azione è confinante e confinata. Un problema di delimitazione. Su questo argomento mi sembra molto interessante l’analisi dei problemi delle superfici cosiddette “lisce” nella fisica più recente. Ogni situazione è certamente in relazione con le altre e quindi con i significati che da queste situazioni le provengono. Ma, nello stesso tempo, è in relazione con l’intera realtà, la quale attraversa ogni singola situazione fino ad arrivare ad ogni singolo punto come concetto limite, perché per ogni singolo punto passa l’insieme delle situazioni possibili e per ogni singola situazione passa l’insieme delle relazioni possibili, quindi l’insieme delle situazioni possibili.
Abbiamo così che ogni singolo punto della situazione, il quale è, di volta in volta, centro e periferia, nei confronti degli altri punti della situazione non può essere colto come individualità isolata, ma come elemento della situazione nel suo insieme. Ogni singolo punto riproduce in se stesso la situazione nel suo insieme e la totalità del reale. Ciò permette di cogliere nell’azione non solo una strategia a breve termine, ma uno scopo preciso, le conseguenze di una serie di cause. Tutti discorsi validissimi all’interno della dimensione relazionale, quindi discorsi legati al modello temporale del campo e circoscritti spazialmente nello stesso modello. Ma, al di là di ciò, queste considerazioni ci consentono di vedere il funzionamento della realtà nel suo insieme. L’azione è, nello stesso tempo, nella storia della sua situazione e fuori della storia, perché è nella realtà nel suo insieme, cioè è nella totalità del reale, dove appunto non c’è tempo, non c’è spazio e quindi non c’è storia.
Ne deriva che ogni singola azione è una storia. Spesso la confusione dei tecnici può presentare azioni strutturate in modo particolare dal punto di vista culturale, ad esempio può presentare un libro di storia come se fosse la Storia, ma quel libro è semplicemente un’azione (o, se si preferisce, una situazione), peraltro il fatto che si presenti cristallizzato attraverso lo strumento fortemente limitante del linguaggio, della parola scritta, non modifica di molto le cose in quanto, tutte le volte che il libro di storia viene fruito in quanto tale, trasmette un messaggio che avrà certamente elementi contenutistici, e quindi limitanti (o strutturali perché codificatori), ma, nello stesso tempo, crea sempre situazioni diverse (azioni nuove). Non si può dire quindi che il libro di storia possa rappresentare la Storia, nemmeno la storia di chi l’ha scritto, perché cristallizzandolo in questa prospettiva, come storia di chi l’ha scritto, finisce per scomparire, per diventare un punto di estrema impossibilità di relazione, un “lato” con densità di significato talmente bassa da risultare completamente “fuori della storia”.
Nel momento in cui invece su questo libro di storia premono i discorsi di significatività delle situazioni, i flussi relazionali che vogliono, con le loro intensità di significato, pervenire alla realizzazione di una nuova azione, abbiamo una storia nuova, che è tutte le volte la storia di chi legge quel libro, non la Storia che quel libro pretenderebbe rappresentare, circoscrivere, delimitare. Non possediamo una Storia, possediamo le storie di una o più azioni, ma nel momento in cui queste storie le abbiamo catalogate, e le riduciamo al livello di un meccanismo di riproducibilità, ci accorgiamo che la cosa non è possibile. Possediamo solo orientamenti, quindi il libro di storia si pone come una proposta orientativa, la quale è essa stessa una situazione, con caratteri deliberatamente limitanti, ma pur sempre una situazione, quindi irriproducibile in quanto tale. Questi caratteri limitanti sono caratteristici appunto dello strumento linguaggio, ma sono anche caratteristici di alcuni contenuti. Ad esempio, il libro di storia avrà un taglio ideologico, questo potrà essere riportato all’interno di un modello, di uno schema, cose queste che sono anch’esse situazioni, le quali si presentano ogni volta diverse, se non altro nei dettagli, ma che comunque, in base a valutazioni preventive, possono essere considerate sufficientemente omogenee.
È vero che in questa prospettiva l’omogeneità non significa ripetitività, ma più che altro ripresentazione di costanti nell’azione che si modifica, per cui si ha la possibilità di pervenire all’identificabilità dell’azione stessa. Le costanti possono essere caratterizzate da confini molto più rigidi di quanto non accade con le singole situazioni. Questi confini più rigidi sono costituiti da quegli aspetti connettivi della ripetitività che hanno natura tautologica ma che servono alla comodità di trasmissione del significato.
C’è da precisare che sia l’elemento puntuale della realtà, a livello del quale diventerebbe identificabile la singola relazione, sia la realtà nel suo insieme, la totalità del reale, devono essere considerati elementi non immediatamente relazionali. In un certo senso essi sono elementi che vengono astratti dal processo relazionale per essere considerati necessariamente dati. Qualsiasi realismo ha questo difetto, come qualsiasi strumentalismo.
Non si può considerare atomistica una parte della realtà, come potrebbe essere il caso dell’elemento puntuale di cui parliamo, componente della realtà. Non si può considerarlo però estraneo al processo relazionale. L’elemento puntuale della realtà fa parte del processo relazionale, costituisce il fondamento di questo processo. Il fatto che non possa essere identificato attraverso una intensificazione di significati dipende da una delle caratteristiche dell’azione, tanto è vero che viene considerato, ipoteticamente all’infinito, identificabile. Esso non viene dato necessariamente, in quanto da questo elemento bisogna partire per costruire la realtà, per cui si avrebbe che tutto il resto diventerebbe relazionato, escluso l’elemento puntuale, ma al contrario l’elemento puntuale è esso stesso relazionale, è la base della relazione. Il fatto che non riusciamo ad identificarlo nella nostra particolare costruzione delle situazioni, questa è una limitazione nostra e non una particolare condizione dello statuto dell’elemento puntuale. Lo stesso dicasi per l’insieme del reale, per la totalità del reale, che è l’insieme del movimento (o della realtà). Questa realtà totale non è data a prescindere dalle relazioni che la costituiscono, nel senso che esiste prima e indipendentemente dal processo relazionale, per cui questo sarebbe logico solo nel caso in cui si affermasse che la realtà è in movimento, e che quindi il movimento costituisce una delle caratteristiche della realtà, una parte della realtà, la realtà, poniamo, è necessaria, è costituita da materia, da spazio, dal rapporto spazio-tempo e, come ultima cosa, da movimento. Ora, se il movimento fosse una delle caratteristiche della realtà, questa allora sarebbe a prescindere da tale caratteristica, quindi sarebbe esistente a prescindere dalla relazionalità. Ma la sola caratteristica della realtà è il movimento delle relazioni, perché essa è movimento e non “è in” movimento.
Quindi, affermare che la realtà nel suo insieme costituisce una ipotesi a priori necessaria su cui si basa il ragionamento che si giustifica dal punto di vista relazionale, è un controsenso, perché l’ipotesi della realtà totale è relazionale essa stessa in quanto somma di tutte le relazioni possibili.
L’elemento puntuale della realtà, da un lato, e la totalità del reale, dall’altro lato, costituiscono due estremi che si collocano lungo un processo all’infinito. In quanto estremi costituiscono un’ipotesi limite, un’ipotesi di confine che però è praticamente negata tutte le volte che la si cerca di individuare. In questo senso, l’elemento puntuale e la totalità del reale si identificano, ed è questo che voglio dire quando affermo che da un singolo punto passa la totalità delle relazioni.
I fatti
Operare una “scelta” non significa intervenire con un controllo economico dei fatti, controllo diretto (come pretendono i neopositivisti) ad accertare la consistenza reale del mondo e a eliminare gli errori della percezione, come non si può considerare un gioco fra ipotesi ugualmente inconsistenti, un vano dibattersi (come affermano gli esistenzialisti). Certo, il tentativo di avvicinarsi alla realtà non può tradursi in un’operazione meramente ideologica, per cui l’insieme dei fatti reali, i quali fatti vengono polarizzati dall’avvicinarsi del soggetto conoscente, si dispone nel senso della vuota astrattezza, da cui diventa possibile ogni operazione mistificatoria. Radicando invece il contatto sul terreno della conflittualità di classe l’insieme concreto dei fatti viene mantenuto nella sua concretezza e serve a comprendere meglio le relazioni interne che legano i fatti tra loro e le conseguenze che si sono determinate nell’insieme dei fatti a seguito della stessa operazione di avvicinamento.
L’insieme dei fatti può considerarsi un tutto polarizzato in continuo movimento, un tutto al cui interno ogni fatto interagisce con gli altri.
Dal punto di vista della nostra analisi l’insieme dei fatti si caratterizza:
a) Come insieme “pieno”, in cui i singoli fatti sono interagenti tra loro, presentano una sufficiente chiarezza dei loro singoli momenti e rendono possibile un’analisi intorno alla loro struttura e ai loro rapporti di interazione.
b) Come insieme “concreto”, che non si contrappone ai singoli fatti come una entità superiore, ma che risulta provvisto di una sua storia coerente, genesi, sviluppo, polarizzazione.
c) Come insieme “polarizzato”, che si destruttura per acquisire una nuova polarizzazione in rapporto alla conflittualità di classe.
In poche parole, i fatti sono le azioni da un punto di vista oggettivo e da un’angolazione complessiva dell’insieme sociale. Le azioni sono i fatti da un punto di vista dell’interazione delle situazioni, cioè dei rapporti.
Non tutti i fatti sono azioni e non tutte le azioni sono fatti. Ciò dipende dalla necessaria distinzione tra due modi del fare, “agire” e “fare coatto”. Il primo di questi modi corrisponde all’azione all’interno delle “forme sociali”, il secondo al fare all’interno delle “strutture istituzionali”. Differenti gradi di permeabilità causano nell’agire all’interno delle forme sociali la persistenza di polarizzazioni, le quali sono la base delle forme sociali che più delle altre si avvicinano alle strutture istituzionali.
I nemici dell’azione
Non sempre i veri nemici dell’azione si schierano dietro la bandiera della condanna di ogni possibilità di modificare la realtà da parte dell’uomo. Spesso essi sono, al contrario, apparentemente fautori accaniti dell’azione che però condizionano, in un modo o nell’altro, rendendola così inefficace o dannosa per quanto riguarda la liberazione dallo sfruttamento.
Schopenhauer è uno di quelli che ha più di tutti usurpato la fama di esaltatore della volontà dell’individuo. Su questo fatto c’è da dire che la colpa non è stata tanto di questo autore, quanto di alcuni divulgatori e di alcuni traduttori nelle lingue diverse dal tedesco, in special modo l’italiano e il francese. Quando scrive: «La volontà [...] è l’intimo essere, il nocciolo di ogni singolo, è così pure del Tutto: essa si manifesta in ogni cieca forza naturale: essa si manifesta nel meditato agire dell’uomo; la grande differenza tra questi due campi riguarda soltanto il grado della manifestazione, non l’essenza di ciò che si manifesta». (Il mondo come volontà e rappresentazione, vol. I, tr. it., Bari 1928-1929, p. 21). E in un altro lavoro: «La volontà [...] nella natura priva di conoscenza si mostra come forza naturale; un gradino più in alto come forza vitale; nell’uomo e nell’animale, poi, ottiene il nome di volontà», (Parerga e Paralipomena, vol. II, tr. it., Milano 1983, p. 63), non fa altro che stornare la capacità di penetrazione della volontà come strumento di modificazione della realtà, in quanto anche quest’ultima ha una sua volontà capace di controbilanciare il lavoro della prima.
Unito a lui nella polemica contro Hegel, per quanto apparentemente lontano come tematica, si colloca Kierkegaard. «Se un uomo potesse mantenersi sempre sul culmine dell’attimo della scelta, se potesse cessare di essere uomo [...] non si potrebbe parlare di una scelta. La scelta stessa è decisiva per il contenuto della personalità; colla scelta esso sprofonda nella cosa scelta, e quando non sceglie appassisce in consunzione». (Aut-aut, tr. it., Milano 1964, p. 41). Si noti il parallelo fra la volontà di Schopenhauer, che si identifica con la volontà del Tutto, e la scelta di Kierkegaard, che si identifica con la cosa scelta. È sempre un ipotetico astratto che viene dapprima lanciato sulle ali dell’azione per poi essere subito richiamato dalle preoccupazioni conservatrici che suggeriscono l’identità del soggetto e dell’oggetto.
In Wilhelm Dilthey il rapporto tra volontà e mondo reale non viene risolto che apparentemente in favore dell’azione. La volontà non si organizza in modo da dominare a poco a poco, insieme al pensiero, la realtà, ma si dispone insieme al pensiero in un rapporto interno alla coscienza. «Quando si offrono più possibilità di produrre mutamenti interni o esterni per soddisfare le tendenze contenute nella connessione acquisita dalla mia vita psichica [...] allora sorge la scelta che si compie nei processi della riflessione. Qui si rivela la differenza tra l’atto di valutazione e l’atto di scelta o del preferire. La valutazione non contiene ancora entro di sé la necessità di porsi in un dato momento un determinato scopo». (Critica della ragione storica, tr. it., Torino 1954, p. 128). Gli sforzi di Dilthey sono diretti ad afferrare la realtà, anzi la vita, «I presupposti fondamentali della conoscenza sono dati nella vita e il pensiero non può risalire oltre di essi», (Gesammelte Schriften, vol. V, ns. tr., Leipzig-Berlin 1914, p. 130), ma essi rivelano la loro inconsistente intellettualità proprio quando cercano di fissare il rapporto tra pratica e conoscenza, rapporto che sfuma nell’intuitività coscienziale della realtà. Il soggetto, così facendo, diventa apparentemente più capace di agire, mentre la realtà su cui dovrebbe agire sfuma del tutto.
Il cerchio si chiude con Wilhelm Windelband che assegna al pensiero il compito di fissare una scala di valori al cui interno si possa muovere quanto prodotto dal pensiero stesso, ed anche la volontà e il sentimento. «[Il pensiero] si pone criticamente, cioè in modo da mettere alla prova il materiale del pensiero [stesso], della volontà del sentimento di fronte allo scopo della validità universale e necessaria, e da separare e da rifiutare ciò che non regge dinanzi a questa prova». (Präludien, vol. I, ns. tr., Tübingen 1883, p. 211). Estremizzando questa posizione e sposandola con quella di Dilthey, l’irrazionalismo tedesco apre la strada all’azione gratuita. L’attacco contro la ragione diventa attacco contro ogni possibilità di conoscere la realtà senza riportarla all’interno del proprio io. Spengler dirà l’ultima parola sulla trasformazione della libertà in necessità. «Noi non abbiamo la libertà di raggiungere questo o quello, ma la libertà di fare il necessario, oppure nulla. Ed un compito che la necessità della storia ha posto, verrà risolto con il singolo o contro di esso». (Der Untergang des Abendlandes, vol. II, ns. tr., München 1923, p. 629). La possibilità diventa necessità, la libertà una necessità organica. Il destino si sovrappone all’individuo. L’esaltazione dell’azione nasconde la rassegnazione al fatto organico ed epocale. Non abbiamo scelto noi di vivere qui e ora, non possiamo modificare il corso dei tempi e della storia, non possiamo fare altro che agire secondo come vuole la logica delle cose, essere strumenti di azioni più grandi delle nostre e nelle quali le nostre si inscrivono. O realizziamo quello che è necessario, o realizziamo un bel niente. Una delle conclusioni più estreme sarà quella di Gentile, la quale annullerà l’individuo e la sua capacità di agire all’interno di una dottrina filosofica interamente dedicata all’atto. «Io penso – egli scrive – e pensando realizzo l’individuo che è universale, ed è perciò tutto quel che deve essere assolutamente: oltre al quale, fuori dal quale, non si può cercare altro». (Teoria generale dello spirito come atto puro, Pisa 1916, p. 8). E, altrove: «L’atto, se non deve convertirsi in un fatto, se deve cogliersi nella sua natura attuale, di puro atto, non può essere che pensiero. Il fatto è la negazione del pensiero, onde lo stesso pensiero si crea il suo altro, la natura. Appena dall’atto si scende al fatto, si è fuori del pensiero, nel mondo della natura. Non ci sono fatti spirituali, ma atti: anzi non c’è se non l’atto dello spirito. Il quale non patisce in sé opposizione di sorta. La volontà (emozionalità o attività pratica) di contro al pensiero, non può essere che altro dal pensiero, pensiero essa stessa, non come atto, ma come fatto: il già pensato, è divenuto quindi natura». (La riforma della dialettica hegeliana, Firenze 1975, pp. 192-193). Saranno sempre i filosofi tedeschi a preparare la strada al nazionalsocialismo (come Gentile faceva col fascismo italiano), trasportando queste tesi della necessità dell’essere e della illibertà dell’azione nel dominio dello Stato. Scrive Hans Freyer: «Lo spirito ha bisogno della potenza [dello Stato] per realizzarsi sulla terra e farsi riconoscere dagli uomini. Ma visto dall’interno, la potenza ha ancora più bisogno dello spirito per poter diventare, da una massa di possibilità frammentarie e confuse, qualcosa di reale». (Prometheus, ns. tr., Jena 1923, p. 25).
Anche la filosofia cattolica ha fatto richiamo all’azione, diffondendosi nel tentativo di imbrigliarla e renderla inefficace. La volontà non è più la molla dell’azione ma è, a sua volta, elemento secondario emergente da una precedente azione interna condotta dallo spirito. Sarà infatti soltanto la buona volontà a compiere, secondo il pensiero cattolico, l’azione. Scrive Léon Ollé-Laprune: «La volontà, la buona volontà, ha dappertutto, anche nel puro ordine scientifico, un’influenza che niente può sostituire». (De la certitude morale, ns. tr., Paris 1880, p. 48). In questo modo la volontà diventa fede. I risultati dell’azione sono impliciti nelle premesse dell’azione stessa. Più chiaro, su questo punto, sarà Maurice Blondel: «L’azione volontaria provoca in qualche modo la risposta e gli insegnamenti dell’esterno e questi insegnamenti, che s’impongono alla volontà, sono tuttavia impliciti nella volontà stessa». (L’Action. Essai d’une critique de la vie et d’une science de la pratique, ns. tr., Paris 1893, p. 127). Il mondo si è risolto così interamente nell’io conoscente e agente, il risultato: la conoscenza si incammina nella via prefissata dalla fede.
Un posto a parte occupano due posizioni molto interessanti, quella di Bergson e quella di Sorel. Bergson porta alle estreme conseguenze la vicenda della coscienza che penetra la realtà. Questo punto è visto con chiarezza dal filosofo francese, con in più il fatto che la scienza è indagata come qualcosa di finito e non con la pretesa generica degli irrazionalisti tedeschi di allargarla a tutto l’esistente. Nonostante ciò la conclusione è ugualmente di ostacolo alla realtà dell’azione. Il mondo esterno viene riportato all’identità con la coscienza attraverso il meccanismo dell’evoluzione creatrice. La coscienza da sola in quanto fa non può comprendere la realtà, ma è proprio la realtà, evolvendosi, che rende comprensibile se stessa e la coscienza. Egli scrive: «Più prendiamo coscienza [...] più sentiamo le diverse parti del nostro essere entrare l’una nell’altra e la nostra personalità intera concentrarsi in un punto o meglio in una punta, che si inserisce nell’avvenire intaccandolo senza tregua. In ciò consiste la vita e l’azione libera. Lasciamoci andare, al contrario; sogniamo invece di agire». (L’évolution créatrice, ns. tr., Paris 1907, pp. 219-220). Da notare la grande importanza della concezione bergsoniana di movimento, precisando però che bisognerebbe depurare la teoria dal biologismo che la rende praticamente inservibile. Georges Sorel scrive a questo proposito: «Si potrebbe fare un’applicazione ancora più completa dell’idea di Bergson alla teoria dello sciopero generale. Il movimento è considerato nella filosofia bergsoniana come un tutto indiviso; ciò che ci conduce proprio alla concezione catastrofica del socialismo». (Riflessioni sulla violenza, tr. it., in Scritti Politici, Torino 1963, p. 205).
Molte delle analisi di Sorel sono anche oggi di grande interesse, come quelle sul marxismo (La decomposizione del marxismo, in ibidem) e sul progresso (Le illusioni del progresso, in ibidem). Qui ci interessa sottolineare la sua analisi dell’azione, diffusa più o meno in tutti i suoi lavori. La realtà, per Sorel, è divenire continuo (nel senso di Bergson), quindi è azione e libertà. La libertà si realizza nello scontro tra il passato e il futuro, tra la tradizione e l’avvenire. Ma per aversi una giusta prospettiva per l’azione, necessariamente violenta, che vuole modificare la realtà, ci si deve sostenere con un artifizio, il mito. Così scrive nell’Introduzione alle Riflessioni sulla violenza: «Si può parlare all’infinito di rivolte senza mai provocare un movimento rivoluzionario, fin tanto che non vi sono miti accettati dalle masse: è ciò che dà allo sciopero generale tanto grande importanza e che lo rende così odioso ai socialisti, i quali hanno paura di una rivoluzione; essi adoperano tutti i loro sforzi per scuotere la fiducia che i lavoratori ripongono nella loro preparazione rivoluzionaria; e per giungere a ciò essi cercano di mettere in ridicolo l’idea dello sciopero generale, la quale sola può avere valore propulsore». (p. 105). Egli ha cura di precisare che questi miti non possono essere la creazione intellettuale di qualche teorico, nel qual caso sarebbero utopie, ma sono elementi che «permettono di comprendere l’attività, i sentimenti e le idee delle masse popolari che si preparano ad entrare in una lotta decisiva; non si tratta di descrizioni di cose, ma di espressioni di volontà». (Ib., p. 106). L’elemento esterno all’agire viene da Sorel ricercato nel segno del mito che, a sua volta, è creazione della volontà popolare, chiamata a ricongiungersi con la volontà del singolo, proprio con queste caratteristiche a priori che si riscontravano nei pensatori cattolici sopra indicati, non per nulla Sorel parla in modo elogiativo di Newman, ispiratore e precursore del movimento modernista cattolico. Comunque, sia detto in questa sede tra parentesi, il lavoro di Sorel è di una importanza maggiore di quella che finora è stata sottolineata. Approfondendo questioni di mitologia sociale e mettendo da parte utilizzi strumentali che sono stati fatti, dalla sua opera si possono ricavare fondamentali considerazioni.
Un’altra corrente filosofica, la quale ha dichiarato la propria apertura ai problemi dell’azione, è il pragmatismo. Erede dell’empirismo classico inglese, il pragmatismo americano ritiene che il pensiero possa mettere ordine nel mondo reale, sviluppando analisi che si possono considerare tanto più esatte quanto più corrispondono ai dati forniti dall’esperienza. Fin qui, nulla di male. L’azione conoscitiva è sì distaccata da quello che si considera la trasformazione del mondo reale, ma cerca di adeguarsi ad una selezione di questo mondo (dei fenomeni che ne derivano) fondata sull’esperienza. Vedendo meglio, ci si accorge che una selezione di fenomeni è sempre un’operazione intellettualistica che diventa non più processo conoscitivo, ma regola d’azione, non più modo di polarizzare la realtà in funzione di un intervento modificativo, ma modo di prevedere le possibili reazioni della realtà per meglio adattare l’intervento (azione) allo scopo di evitare ogni disfunzione o disequilibrio. L’analisi in questo modo diventa fondata soltanto quando è utilizzabile in maniera che non contribuisca a turbare la realtà, ma solo ad armonizzarla con i dati dell’esperienza stessa. Questa armonia è ben vista da Charles Sanders Peirce quando parla della credenza o dell’“abito di azione”. Il pensiero non ha altra funzione che quella di produrre abiti di azione. Così scrive: «Per sviluppare il significato di una cosa, dobbiamo semplicemente determinare quali abiti essa produce perché quel che una cosa significa consiste semplicemente negli abiti che essa implica. Ora, l’identità di un abito dipende dal come esso può condurci ad agire. Quello che l’abito è dipende da quando e come esso ci porta ad agire». (Collected Papers, vol. V, ns. tr., Cambridge, Mass. 1931-1935, p. 400). Significativo il titolo del libro fondamentale di James: The Will to Believe. La credenza è l’abito di cui parla Peirce, essa rende possibile la volontà di continuare a produrre e salvaguardare ulteriori credenze. Tutto è diretto a questo scopo: «Il dipartimento volitivo della nostra natura domina sia il dipartimento razionale sia il dipartimento sensibile; o, in linguaggio più chiaro, la percezione e il pensiero esistono solo in vista della condotta». (W. James, La volontà di credere, tr. it., Milano 1912, p. 114). La preoccupazione di James è sempre quella di non turbare l’armonia del mondo così come l’attuale distribuzione della ricchezza ce lo fa vedere. Qualsiasi credenza utile a ciò deve essere considerata positiva, anche se infondata. Essa svilupperà la sua azione nel mondo e lo renderà più comprensibile e più prevedibile. La rinuncia a questa probabilità (tale è infatti considerata da James dal punto di vista metodologico) comporterebbe un rischio troppo grosso. Tra la fede e la non-fede, tra l’adeguamento e l’azione di lotta, James conduce il pragmatismo verso il primo termine, verso la pace sociale. Non mi pare importante seguire lo sviluppo di questa filosofia. Splendida nella forma, l’elaborazione di Miguel De Unamuno ripercorre lo schema di James: «Verità – egli scrive – è ciò che spingendoci, in un modo o in un altro, ad agire, ci fa conseguire il nostro scopo». (Commento al Don Chisciotte, tr. it., Milano 1926, p. 134). Tesi estremamente pericolosa che porta direttamente all’attivismo fascista.
I falsi amici dell’azione
La famosa undicesima tesi su Feuerbach dice testualmente: «I filosofi hanno soltanto diversamente interpretato il mondo; si tratta però di trasformarlo». (K. Marx, Tesi su Feuerbach, tr. it., in Marx-Engels, Opere complete, vol. V, op. cit., p. 627). Su questa breve annotazione si sono versati fiumi d’inchiostro essendo, fra l’altro, una delle poche cose chiare di Marx sul problema del suo materialismo. Mi pare, comunque, che ci sia una cosa da dire. Non è vero che i filosofi hanno interpretato fino ad oggi il mondo, essi lo hanno anche trasformato, in quanto la loro interpretazione è stata pur sempre una trasformazione, sia pure in senso reazionario. Di più, la trasformazione cui fa appello Marx deve essere reale e non fittizia, onde evitare che assuma l’aspetto esteriore della trasformazione e si traduca in sostanza in una ulteriore forma di interpretazione capace solo, ancora una volta, di trasformare il mondo a favore del dominio e dello sfruttamento. Se ne può concludere che la sola trasformazione legittima, cui anche la riflessione è chiamata, è quella che concorre ad abbattere ogni forma di dominio e di sfruttamento nel mondo.
Comunque, a parte questa frase su Feuerbach, Marx, pur non dilungandosi sull’argomento, ha affrontato il problema in modo esauriente nella cosiddetta Introduzione del 1857 (edizione critica a cura di B. Acciarino, Verona 1974). Così egli scrive: «Il concreto è concreto perché è sintesi di molte determinazioni, quindi unità del molteplice. Per questo nel pensiero esso si presenta come processo di sintesi, come risultato e non come punto di partenza, sebbene esso sia il punto di partenza effettivo e perciò anche il punto di partenza dell’intuizione e della rappresentazione». (Ib., p. 100). Criticando Hegel, egli afferma che l’illusione dell’idealismo è stata quella di concepire il reale come risultato del pensiero, come qualcosa che si determina e si muove a seguito dell’azione del pensiero, quando il reale viene captato dal pensiero attraverso l’astrattezza del metodo che consente una sua riproduzione astrattamente concreta. Quindi, il pensiero conoscente, secondo Marx, non è «mai e poi mai il processo di formazione del concreto stesso». (Ibidem). Con cui risulta fondato il materialismo della prassi storica e negato l’idealismo assoluto hegeliano. Ad esempio, continua Marx, prendendo il valore di scambio, si ha che questa categoria del pensiero non ha alcuna realtà senza la popolazione che produce al di dentro di determinati rapporti. Quindi, il valore di scambio esiste come relazione astratta con una totalità vivente e concreta, mentre come categoria filosofica esso «mena una esistenza antidiluviana». (Ib., p. 100). Per la coscienza, il valore di scambio come categoria si presenta come effettivo atto di produzione, il cui risultato è il mondo, e ciò perché la totalità concreta, come totalità di pensiero, come concreto pensiero, è un prodotto del pensare e non del concetto che genera se stesso. «La totalità come essa si presenta nella mente quale totalità del pensiero, è un prodotto della mente che pensa, la quale si appropria il mondo nella sola maniera che le è possibile, maniera che è diversa dalla maniera artistica, religiosa e pratico-spirituale di appropriarsi il mondo. Il soggetto reale rimane, sia prima che dopo, saldo nella sua autonomia fuori della mente; fino a che, almeno, la mente si comporta solo speculativamente, solo teoricamente». (Ib., p. 102).
La dimostrazione di Marx è quindi la seguente: le categorie astratte del pensiero, per quanto possano essere valide, proprio per la loro natura astratta, per tutte le epoche storiche, sono determinate nella loro stessa astrazione dalle condizioni storiche e restano valide solo all’interno di quelle condizioni.
Queste categorie (produzione, lavoro, scambio, ecc.), indispensabili al pensiero, sono quindi, in quanto prodotti storicamente determinati, non il risultato dell’attività del pensiero, ma la premessa. Esse sono la materia prima che il pensiero impiega per produrre conoscenza attraverso l’elaborazione di concetti. Ma tra le materie prime e i concetti elaborati (prodotto finito) si inserisce un altro elemento, cioè si inseriscono i mezzi di produzione. Questi mezzi di produzione sono la teoria scientifica storicamente determinata.
Tra la categoria astratta (materia prima) e il concetto elaborato (prodotto finito) non si ha identità, ma effettiva trasformazione che riesce a inglobare la categoria all’interno di una nuova generalizzazione più specifica. Il passaggio tra questi due elementi è garantito – secondo Marx – dal lavoro della teoria scientifica che realizza, nella conoscenza, lo spostamento dall’astratto al concreto.
Di più, Marx insiste dicendo che «dal punto di vista scientifico» (Ib., p. 112) ogni teoria che consente l’elaborazione dei concetti dalle categorie, sia nella realtà che nella mente del soggetto, costituisce un modo di essere, una determinazione che non inizia dal momento che viene elaborata. La successione delle categorie astratte, dice Marx «è determinata dalla relazione in cui esse si trovano l’una con l’altra nella moderna società borghese, e che è esattamente l’inverso di quella che si presenta come loro relazione naturale o corrisponde alla successione dello sviluppo storico. Non si tratta della posizione che i rapporti economici assumono storicamente nel succedersi delle diverse forme di società». (Ib., p. 114). Quindi, storicizzazione non cronologica, ma funzionale ad una data distribuzione dei rapporti di produzione.
È facile vedere che si tratta di una geniale costruzione. Tra queste tesi e le elaborazioni dei successori di Marx passa più o meno un abisso. Eppure è proprio in queste tesi, così affascinanti intellettualmente e così apparentemente dirette a passare il vallo che separa teoria e azione, che si collocano le basi della negazione dell’azione stessa. I successori non dovranno fare altro che allargare queste basi, scolasticizzando le indicazioni dello stesso fondatore.
Sviluppiamo i punti principali della nostra critica a questa posizione di Marx. Innanzi tutto, Hegel. Tra la categoria astratta (materia prima) e il concetto elaborato (prodotto finito) c’è, come si è detto, un rapporto di trasformazione, non nel senso hegeliano di “autoproduzione” del concetto concreto all’interno della stessa categoria astratta, ma nel senso di trasformazione della categoria in qualcosa di diverso, il concetto appunto. Ma, come appare chiaro, questa trasformazione non sarebbe stata possibile senza una presenza del prodotto finito nella materia prima. Non si possono produrre cose creandole da materie prime che non posseggano, in un modo o nell’altro, gli elementi essenziali di quelle cose stesse, altrimenti il mito della pietra filosofale non avrebbe fatto impazzire generazioni di alchimisti. La scienza moderna che, apparentemente, determina trasformazioni radicali della materia, non fa altro che scendere più in profondità nella sua costituzione, sfruttando capacità intime che preesistevano e che erano semplicemente ignorate. Abbiamo pertanto che se gli elementi essenziali del concetto evolutivo (prodotto finito) sono compresenti alla categoria astratta (materia prima), sono anche parimenti storicizzati, e quindi la loro genealogia (anche quella del concetto che essi costituiscono) non è leggibile che in relazione ad una certa distribuzione dei rapporti di produzione (tal quale l’astratta categoria). L’opera conoscitiva si traduce pertanto in una serie di giudizi analitici, mere tautologie. La stessa teoria scientifica diventa la teoria dell’identità, lo strumento di penetrazione nella realtà elaborato a partire dai dati astratti che questa fornisce esplicitamente nel suo stesso disporsi come realtà divisa in classi, annega nell’insignificanza della ripetitività. Il concetto contiene esattamente quello che la categoria prevedeva, in quanto non può contenere altro da quanto la realtà fornisce alla categoria stessa, né altro può essere fornito dalla teoria generalizzata la quale non prevede che la semplice esposizione del come si sviluppino le tautologie, cioè i passaggi dalla categoria ai concetti.
Le cose vanno diversamente se si considera che la teoria scientifica, o più semplicemente la teoria, è essa stessa azione, non per le conseguenze che ha sull’azione, dirigendosi sul mondo e contribuendo a modificarlo in un senso o nell’altro, ma perché l’azione del mondo, l’intero complesso interagente delle azioni individuali, la struttura continuamente in trasformazione di quanto gli uomini fanno e pensano, è un insieme polarizzato di teorie.
Diventa così funzionale al semplice gioco del potere il terrorismo intellettuale implicito nel termine di teoria scientifica, con cui Marx intendeva svalutare ogni teoria che non possedesse le basi della dialettica storica. Lodevole iniziativa, se fosse stata diretta alla ricerca delle reali condizioni che permettono ad una teoria di intervenire nella trasformazione rivoluzionaria della realtà, ma condannabile visto che venne impostata solo per difendere un nucleo specifico di teoria – più o meno identificabile col marxismo – contrapponendolo ad ogni altra teoria, anche se rivoluzionaria.
Una conoscenza concreta, capace di trasformare la realtà nel senso di costituire uno strumento per abbattere il dominio, è certamente mezzo di produzione del concetto come pure è modo di rendere significativa la categoria astratta che correrebbe il rischio di essere troppo esigua per dire qualcosa di utile ai fini pratici, ma questa conoscenza concreta non è detto che debba nascere dal movimento categoria-concetto, non da un movimento particolare (ad esempio, quello relativo al lavoro e allo scambio) e nemmeno dal movimento in generale fra tutte le categorie e i concetti derivabili dai rapporti sociali di produzione. Essa può nascere (come la categoria) proprio dalla realtà e costituire non il senso coglibile dei rapporti sociali (che sarebbe ancora una riflessione astratta), ma la realtà nel suo stesso svolgersi, nel suo continuo interagire, nella sua innumerevole rete di azioni.
Così ragionando si viene però ad escludere che una ristretta minoranza di iniziati teorici possa impadronirsi della teoria giusta per trasformare la realtà. Di più, si viene ad escludere che questa minoranza possa legittimare l’uso della forza per imporre quella teoria. Così ragionando, non si giunge mai al concetto di “partito”, al concetto di rappresentanza degli sfruttati, al concetto di dittatura del proletariato e simili amenità. Nessun terrorismo intellettuale potrà imporre la validità di una teoria considerata scientifica quando questa teoria viene dalla pratica dell’azione rivoluzionaria del movimento degli sfruttati. Per questa teoria non occorre battesimo di scientificità.
Solo che la pratica teorica del movimento rivoluzionario si presenta come una tendenza verso l’autoliberazione dai residui ideologici, quindi come una tendenza dal riconoscimento della necessità della guida alla scoperta dell’autorganizzazione dell’azione, mentre l’elaborazione analitica, in quanto teoria in senso specifico, si presenta come elaborazione di strumenti che facilitano quel processo e facilitandolo si depurano essi stessi in quanto strumenti.
Subito dopo Marx, la teoria sviluppata nell’Introduzione del 1857 subisce un notevole scadimento. Si tratta del complessivo movimento di riduzione e impoverimento delle tesi metodologiche fondamentali di questo modo di pensare l’azione. Certo, le possibilità di questo impoverimento esistevano, spesso allo stato più che latente, all’interno dello stesso lavoro filosofico di Marx, ed è su queste possibilità che i continuatori, gli applicatori, i mistificatori e gli approfittatori, si sono poi basati. Ma quale pensiero non ha in se stesso le condizioni che lo espongono al rischio di essere “scolasticizzato” e quindi immiserito e stravolto? Non voglio qui “difendere” Marx, non è necessario. Non l’ho mai fatto e non intendo cominciare adesso. Ho avuto da sempre un’avversione per le posizioni teoriche di questo pensatore e ciò mi ha, spesso, portato a perdere molte delle buone cose che si trovano nei suoi libri. Me ne rendo conto. Ma, agli amici elogiatori di un improbabile “Marx libertario” ho sempre chiesto dove si andasse a nascondere questo filone segreto. Non me lo hanno mai indicato. Il giacimento è rimasto sotterraneo. Cose simpatiche ne ho lette anch’io. Marx era prima di ogni cosa un giornalista, e sapeva usare bene lo strumento della comunicazione scritta. Ma non basta scrivere cose simpatiche, e nemmeno profonde. Profondi pensatori (poniamo, Gentile) sono punti di forza della reazione, strumenti teorici del potere pratico. Io penso seriamente che possiamo “usare” – se di questo si parla – molto poco dell’analisi complessiva di Marx, nulla, assolutamente nulla, di quella dei suoi epigoni e strangolatori. Con buona pace dei miei amici marxisti-libertari (di ormai sclerotizzata memoria).
Cominciamo con Engels. Con lui si arriva ad una proposta di “rispecchiamento” della realtà per via dialettica. Il problema di come ciò possa avvenire viene saltato e si dichiara con petizione di principio che avviene e basta, anzi che deve avvenire. «Una rappresentazione esatta della totalità del mondo – scrive Engels – del suo sviluppo e di quello dell’umanità, nonché dell’immagine di questo sviluppo quale si rispecchia nella testa degli uomini, può quindi effettuarsi solo per via dialettica, prendendo costantemente in considerazione le azioni reciproche del nascere e del morire, dei mutamenti progressivi o regressivi». (Antidüring, tr. it., Roma 1956, p. 30). E altrove: «La dialettica del cervello è solo un riflesso delle forme di movimento del mondo reale, della natura così come della storia». (Dialettica della natura, tr. it., Roma 1950, p. 132). Questo riflesso non ci viene spiegato, sembrerebbe una subordinazione del pensiero alla natura attraverso i sensi, ma ciò non eliminerebbe tutte le contraddizioni che gli scettici hanno largamente indagato. E allora? Engels non si dà pensiero: «Nella misura in cui avremo preso cura di educare e di utilizzare correttamente i nostri sensi, e di mantenere la nostra azione nei limiti prescritti da percezioni correttamente ottenute e correttamente utilizzate, troveremo che il successo delle nostre azioni dimostra che le nostre percezioni sono conformi alla natura oggettiva degli oggetti percepiti». (L’evoluzione del socialismo dall’utopia alla scienza, tr. it., Roma 1951, p. 25). Il successo diventa così il metro di valutazione sia dell’azione che dell’analisi teorica, e questo successo deve essere aderente a quanto dalla realtà ci si poteva aspettare, nessun salto qualitativo ma sviluppo ordinato ed equilibrato.
Lenin non si distaccherà molto da questo punto engelsiano: «Il punto di vista della vita, della pratica, dev’essere il punto di vista primo e fondamentale della teoria della conoscenza. Ed esso conduce infallibilmente al materialismo. Certo, non si deve dimenticare che il criterio della pratica, in sostanza, non può confermare o confutare completamente una rappresentazione umana, qualunque essa sia. Anche questo criterio è talmente “indeterminato” da non permettere alle conoscenze dell’uomo di trasformarsi in un “assoluto”, ma nello stesso tempo è abbastanza determinato per permettere una lotta implacabile contro tutte le varietà dell’idealismo e dell’agnosticismo. Se ciò che la nostra pratica conferma è la verità obiettiva, unica, finale, ne deriva l’ammissione che l’unica via che conduce a questa verità è la via della scienza che si mette dal punto di vista del materialismo». (Materialismo e Empiriocriticismo, tr. it., Roma 1953, pp. 130-131). Ancora, la genericità delle formule di Engels con in più il terrorismo intellettuale marxiano.
Non è privo di interesse sottolineare che sarà proprio Stalin a insistere con forza sul fatto che il marxismo non può considerarsi come un dogma ma deve essere modificato e sviluppato. «Il marxismo, come scienza, non può restare immobile, ma si sviluppa e si perfeziona. Nel suo sviluppo il marxismo non può non arricchirsi di nuove esperienze, di nuove conoscenze, e pertanto le singole formule e conclusioni non possono non mutare nel corso del tempo, non possono non essere sostituite da nuove formule e conclusioni, corrispondenti ai nuovi compiti storici». (Il marxismo e la linguistica, tr. it., Roma 1952, p. 68). Ogni rafforzamento del potere ha bisogno di una perfetta manutenzione dell’ideologia, e ciò è realizzabile non solo col terrorismo intellettuale ma anche col terrorismo riformista della bontà della modificazione e del perfezionamento progressivo.
È chiaro da quanto precede che l’efficientismo lasciato intravedere da Engels, sviluppato da Lenin e dogmatizzato da Stalin non può costituire la misura della teoria, come non può costituire un’indicazione attendibile in merito all’avvenuto contatto tra realtà e teoria. Il successo non ha mai indicato altro che il vincitore, cioè colui che la storia ha incaricato di dettare le condizioni del dominio. Di più. Nella tesi di Stalin non c’è altro che un comune buon senso riformista che le cose si possono aggiustare, fermo restando il dominio della minoranza in carica. L’azione conoscitiva viene ridotta a pura contemplazione e non ad un vero e proprio movimento di conquista della cosa che si conosce.
Il fare e l’agire
Usciamo adesso dall’ambiguità in cui ho volutamente lasciato il termine “agire”. Se l’azione è sempre una interazione, cioè un’unità che fa parte di un processo in corso, ogni azione non ha le stesse conseguenze. Abbiamo visto che sulla base della differenziazione di classe alcune di queste concorrono alla trasformazione rivoluzionaria dello stato di cose (rapporti di forza) e altre concorrono al suo mantenimento e alla sua conservazione. Abbiamo anche visto che non sempre questa distinzione è netta e che spesso all’interno di ogni tipo di azione si collocano sfumature ed elementi che appartengono all’altro tipo e viceversa. Comunque, abbiamo individuato nell’autorganizzazione dell’agire la discriminante tra agire liberatorio e fare coatto.
Ora, se l’autorganizzazione caratterizza il vero e proprio agire, l’assenza o una scarsa presenza di autorganizzazione caratterizza un altro modo di agire che, per distinguerlo, chiamo “fare”.
Di già Platone aveva capito che la scienza politica non può avere funzioni di “fare”, ma di “comandare”, cioè di “far fare”. Quindi, dal punto di vista di uno dei massimi teorici del dominio, il fare non è semplicemente agire, ma si riassume nell’obbedire (l’altra faccia del comandare), per cui va distinto e svalutato, mancando di iniziativa e di capacità autonoma di portare a completamento quanto iniziato. È proprio su questa differenza tra “cominciare” e “compiere” che Platone insiste nella sua distinzione tra agire e fare.
È chiaro che il colossale spettacolo della violenza della fabbricazione non può essere considerato un agire ma, sulla base di questa differenza, un semplice fare. In questo senso dobbiamo interpretare la tesi materialista di Vico che gli uomini conoscono le cose perché le fanno e non nel senso che il fare, a sua volta, fa gli uomini, per cui questi, simili alle cose, in loro si identificano. Solo a questa condizione il fare di Vico è agire, cioè azione.
La caratteristica dell’agire è quindi la libertà. Agire significa creare la vita, non perpetuare la morte. Agire significa aprire le strade verso la liberazione, che sono anche le strade verso un ideale di uguaglianza e di fraternità vere. Agire significa distruggere tutti gli ostacoli che il dominio distribuisce lungo il percorso e fare in modo che la creazione della vita non venga arrestata o impantanata.
Agire è anche, più modestamente, miglioramento, progresso, ma a condizione che sia coscientemente riconosciuto come momento di uno sviluppo contraddittorio che impegna nell’azione e non addormenta nell’illusione del fine raggiunto. Quando critichiamo o scherniamo l’ideologia dell’aggiustamento, la “logica dell’a poco a poco”, fiore all’occhiello del riformismo, non lo facciamo perché siamo contro il miglioramento e il progresso. La filosofia del “tanto peggio tanto meglio” non è mai stata la nostra. Critichiamo non solo l’ideale di progresso, ma principalmente la comoda illusione di tanti bottegai travestiti di cullarsi nelle placide onde del loro evoluzionismo, quando tutt’intorno si scatenano i venti e la burrasca. Quello che critichiamo è l’immeschinimento di un ideale a livello di un particolare interesse, di una particolare conventicola.
Progresso, ma non banale vanificazione dell’agire umano in un continuo modificarsi all’infinito. Le cose sono andate sempre così, sempre si è avuto un lento progresso, sempre ci sono stati i dominatori e sempre i dominati, perché lottare per cambiare tutto ciò? Anche l’anarchia non è un arresto del progresso in una imbambolata beatificazione di se stessi. Quando realizzeremo l’anarchia non per questo non ci sarà più nulla da fare nel senso dell’agire. Il mondo potrà sempre essere diverso e in quella direzione, anche dopo la rivoluzione sociale, lavoreremo tutti. Lo sviluppo rivoluzionario delle forme sociali non potrà fare scomparire immediatamente i residui delle strutture istituzionali, queste persisteranno forse molto a lungo, forse anche quando avremo realizzato l’anarchia si troveranno ancora residui archeologici di strutture istituzionali. La lotta dovrà allora continuare, in forme sempre diverse, per la nuova fioritura di forme sociali libere e creative.
Per il momento, occorre avere chiaro che ogni miglioramento ottenuto con l’azione, non concesso per meglio consolidare il dominio, è un risultato dell’agire che non si perde mai, anche nelle alterne vicende dello sviluppo delle opere dell’uomo, ma che viene ora e subito posseduto e goduto, per essere poi rimesso nuovamente in questione e considerato un lontano punto da cui discostarsi per trasformare lottando.
Il fare coatto
Negando al fare coatto il contenuto dell’azione se ne deduce che la caratterizzazione che l’uomo riceve nell’ubbidire ad una pratica che lo avvilisce e lo dissocia, è quella del dominato. In questo modo, i lavoratori di una fabbrica di bombe scioperano per salvaguardare il loro posto di lavoro, lottando per un salario che corrisponde ad una produzione di morte. Nell’ambito della realtà del capitale questo caso è generalizzato. Non occorre la fabbrica di bombe per definire il lavoro coatto una fabbrica di morte. Eppure l’azione della vita germoglia dappertutto, anche nei cimiteri della produzione.
L’agire e la volontà
La riduzione dell’azione all’interno del dominio del fare è compito dell’ideologia. La produttività che caratterizza il capitalismo penetra così all’interno dell’individuo, lo trasforma da animal rationale in homo faber. I rapporti sociali diventano “politica”, cioè modo di giustificare qualsiasi mezzo per raggiungere il fine prefissato. Negli ultimi anni questa dimensione mentale è stata estremamente diffusa. Gli strateghi da caffè hanno infestato il movimento rivoluzionario allo stesso modo in cui i padroni infestano la società.
Nella distinzione tra fare e agire, tra cominciare e compiere, si riflette quella polarizzazione di significato che la divisione di classe assegna al termine azione. Ogni azione non è mai innocua, essa determina sempre conseguenze che sono sostanziali trasformazioni.
Il fare coatto si sviluppa nel mondo con una compattezza esteriore che è stata sempre indicata come l’esempio più evidente dell’utilità dell’ubbidienza e del dominio. La sottomissione consente alla struttura solidificata del politico di mantenere i rapporti di forza sufficientemente stabili nel tempo, dando a questa struttura l’aspetto di qualcosa che sopravanza l’immediato. E questa illusione da bottegai ha anche trovato il suo cantore filosofico in Hegel. Lo Stato che impersonifica la coscienza. La servitù volontaria, caratterizzata dal fare, in favore del dominio crea l’aspetto esteriore del mondo, i suoi grandi e multiformi emblemi del dominio di classe.
L’azione, al contrario, si sviluppa velocemente, anche se contraddittoriamente. Non è infatti escluso che il servitore volontario sia capace, improvvisamente, di salti qualitativi, i quali sopravanzano di molto la sua coscienza di classe. In effetti, non si tratta di incertezza vera e propria, quanto di elasticità che corrisponde ad una effettiva stabilità superiore di molto a quella della struttura istituzionale o politica. Né la mistificazione ideologica né l’oblio spontaneo o sollecitato possono fare scomparire i risultati della trasformazione prodotta da un’azione, da un singolo gesto che abbia le caratteristiche dell’azione. La forza del fare si conclude nel processo produttivo ed estrinseca la sua capacità di “merce” all’interno della struttura del politico. La forza dell’agire si estrinseca nel campo dei rapporti sociali e non si esaurisce mai, anzi può accrescersi e moltiplicarsi in misura tale da destare sbigottimento. Del fare possiamo dire tutto, quando comincia, in che modo estrinseca la sua forza, quando si esaurisce e si solidifica in qualcosa. Dell’agire non possiamo dire molto, abbiamo difficoltà a individuare il momento in cui inizia l’azione (se lo facciamo è solo ai fini pratici e con la dichiarata ammissione d’incertezza), non sappiamo esattamente in che cosa consista la trasformazione che determina, non possiamo cogliere l’ampio spettro delle sue interazioni, ben poco sappiamo sul suo destino, un’azione può avere effetti che durano finché durerà la storia del genere umano.
Questa strana situazione è sfruttata al massimo dal potere. Il fare che trasforma la merce è propagandato come mezzo che realizza l’uomo che, diventando così produttore, si emancipa dal suo rapporto di suddito della natura. Non solo – continua il dominatore – ma questo fare è stabile nel tempo, garantisce uno status rispettato da tutti e dà all’individuo un ruolo da svolgere nel mondo, in base al quale sviluppare determinate attese nei confronti degli altri. Il dominatore ideologico continua dicendo che questo è il vero regno della libertà. Si è liberi di essere quello che si è. L’altra situazione, quella fondata sulla pretesa di agire – insiste il prete – è il falso regno della libertà, getta l’uomo nella disperazione dell’imprevisto e dell’incerto, non sa condurlo verso certezze garantite dalla legge (divina e umana), non sa dargli che sempre nuovi problemi e nuove angosce. L’agire – cantano in coro poliziotti e giudici – non ha un metro stabile, riconosciuto da tutti, accettato da tutti, è troppo legato alle condizioni del momento, quindi getta l’uomo nella più dura necessità e gli impedisce il raggiungimento della libertà.
Queste prediche assumono sempre la veste degli insegnamenti etici e sono dirette tutte a garantire il dominio. Per nascondere questo scopo concreto esse si interessano di salvaguardare l’integrità dell’individuo. L’integrità che questi lupi travestiti vogliono salvaguardare è uno strano imbroglio di sovranità del singolo di fronte ai suoi simili. Dato che l’individuo ha tutti i diritti, solo il mondo ordinato della produzione e del consumo può fornirgli i mezzi necessari per soddisfare i bisogni che avverte (quali essi siano). La mancata soddisfazione di questi bisogni viene indicata come situazione di sofferenza e di incertezza, come mancanza di libertà.
La sovranità dell’individuo non è libertà, è banale egoismo bottegaio. Non è l’egoismo che esalta alla lotta e alla conquista del mondo (sua conoscenza e trasformazione), ma è l’egoismo che spinge a restare nel fondo della propria bottega e criticare tutto e tutti, invocando una catastrofe universale al solo pensiero che possa scendere il prezzo della merce che si nasconde in magazzino. La sovranità dell’individuo non è libertà, perché l’individuo non è solo nel mondo, ma è insieme agli altri individui, alle cose. Se fosse vera l’equazione di sovranità e libertà, allora nessuno potrebbe essere libero salvo che dopo essere riuscito ad uccidere tutti i suoi simili. Questa presenza degli altri, che rende possibile la nostra libertà, in quanto edificabile nella lotta per la libertà di tutti, è la presenza che qualifica in modo incerto e fragile l’azione, legandola ad una rete amplissima di interazioni che praticamente non cessa mai di svilupparsi e di estendersi, essa è l’unica strada verso la libertà.
Riassumendo nel concetto di imprevedibilità questa incertezza e questa fragilità dell’azione, emerge con chiarezza la soluzione. Il futuro dell’azione non può essere previsto in quanto l’azione non è un atto che si trasforma in merce, ma può essere sufficientemente intravisto con la volontà. Il mare in tempesta dell’imprevisto vede sorgere così piccole isole di sicurezza, isole che la volontà indica come impegni futuri, come promesse. L’impegno con noi stessi e con gli altri ci dà un’indicazione, una regola di vita, una struttura della personalità, una coordinazione nell’azione. Non si tratta di un vero e proprio superamento dell’imprevedibilità, ma di un suo temperamento, di una regola pratica che acumina l’azione e la rende in grado di penetrare la realtà. Ma – come appare chiaro – la volontà di mantenere la promessa non avrebbe senso se non ci fossero gli altri a specificare e chiarire l’identità di chi promette e di chi riceve la promessa. La qualità principale è nel soggetto che agisce. Non modifica le condizioni oggettive dell’azione, cioè la situazione dell’individuo e l’insieme dei fatti, ma qualifica in modo soggettivo le condizioni della trasformazione che l’interazione andrà a determinare.
L’azione come astrazione
L’idea di azione viene di regola sviluppata dalle ricerche al servizio del dominio, in base ad alcune astrazioni fondamentali che non hanno ragione di esistere e che vengono alimentate perché tornano utili per distorcere l’efficacia dell’azione stessa. È chiaro che, in questa prospettiva, non c’è distinzione tra fare e agire.
La prima astrazione è quella di considerare l’azione come tale prescindendo da quanto accade nell’individuo a livello inconscio. Viene fatta una distinzione tra studio dell’azione umana (prasseologia) e studio dei fattori psichici che determinano l’uomo all’azione (psicologia).
Una seconda astrazione è data dalla pretesa di separare il comportamento conscio della volontà dal comportamento inconscio degli organi e delle cellule del corpo.
Una terza astrazione è data dall’ipotesi che l’uomo possa – ad un certo momento – trovarsi in una situazione di soddisfazione che non si concretizza in un’azione.
La quarta astrazione è che l’uomo viene considerato spinto all’azione quando vuole passare da uno stato di minore soddisfazione ad uno che gli si prospetta come maggiore. La mente viene vista come qualcosa che immagina lo stato di maggiore soddisfazione e a ciò segue l’azione.
Una quinta astrazione è data dall’impossibilità di valutare all’esterno questa maggiore o minore soddisfazione, per cui quelli che sono validi sono soltanto i giudizi individuali di valore.
Una sesta astrazione sostiene che la scienza che studia l’azione è indifferente agli scopi dell’azione stessa.
Una settima astrazione sostiene che i giudizi concreti di valore che danno significato all’azione umana non sono suscettibili di ulteriori analisi.
Una ottava astrazione insiste sul fatto che l’azione è sempre razionale in quanto il suo fine è sempre la soddisfazione del desiderio dell’agente. L’azione cosiddetta irrazionale non esiste se non come azione che si propone un fine non proprio condiviso dalla maggior parte degli uomini.
Una nona astrazione afferma che l’uomo agisce perché è capace di individuare le relazioni causali che determinano il divenire. Il fondamento dell’azione è pertanto la categoria della causalità.
Una decima astrazione riporta l’esistenza di un fine – come movente dell’azione – alla stessa legge della causalità, per cui il fine diventa una causa indiretta.
Una undicesima astrazione taglia di netto il rapporto tra pensiero ed azione affermando che lo studio dell’azione non deve porsi questo problema.
Una dodicesima ed ultima astrazione conclude dicendo che lo studio dell’azione umana costituisce una scienza teoretica e sistematica che si limita ad esaminare l’azione umana in senso stretto e senza tenere conto di circostanze individuali, accidentali o ambientali. La conoscenza che ne deriva è solo formale. Le regole che vengono enunciate sono a priori come quelle della logica e della matematica.
Questa costruzione metafisica è molto condivisa, in forme e variazioni intercambiabili, ma sostanzialmente concordi. Essa corrisponde alla visione liberale e riformista della realtà, alla “logica dell’a poco a poco”, all’idea che le cose – lasciate a se stesse – si possono disporre nel migliore modo possibile e, comunque, si possono sempre aggiustare. Le migliori riflessioni e le più chiare esperienze di cui disponiamo oggi sono contro queste astrazioni.
Critica dell’azione astratta
Riprendiamo punto per punto le astrazioni di cui al precedente paragrafo. Esse sono prive di fondamento per diversi motivi.
La separazione dell’inconscio dall’azione è funzionale all’isolamento di quest’ultima in una dimensione che può essere ridotta a pura fenomenologia, elencazione di accadimenti, semplice fare. Anche la riduzione a semplice fare però è vista sotto l’aspetto dell’indagine condotta sul fare e non sotto l’aspetto del fare stesso per quanto alienato possa essere. Non per nulla la codificazione fenomenologica che si lascia qui presupporre ha pretesa di oggettività, faccenda che appare più chiara tenendo conto la seconda astrazione che pretende un netto distacco tra volontà e struttura fisica e psichica del corpo. Non può non apparire chiaro qui che sia quello che si definisce inconscio, sia l’insieme delle cellule e degli organi del corpo, costituiscono strutture estremamente complesse che subiscono vasti processi di interazione. Cercare di separare questi flussi di significati interagenti è chiara operazione idealistica che risulta utile solo ad una mutilazione dell’agire.
L’ipotesi di sospensione della pratica serve al ragionamento per fissare un punto esterno come inizio del calcolo della scelta, inizio che non è in alcuna maniera indicabile oggettivamente. Ma questa ipotesi, fondandosi su una pretesa situazione di soddisfazione del singolo, è una chiara indicazione del tentativo di tagliare in due ancora una volta l’unità che consente di capire i processi dell’agire. Funzionale alla successiva distinzione tra i vari gradi di soddisfazione risulta la precedente ipotesi considerando questi gradi come conseguenza dell’astrazione avanzata riguardo la sospensione dell’agire pratico. Il calcolo della scelta appare in questo modo facilmente realizzabile su basi quantitative, una volta che si afferma raggiungibile una gradualità degli stati di soddisfazione.
Per meglio bloccare ogni tentativo di chiarezza sull’agire, la traduzione in valore dei singoli stati di soddisfazione – precedentemente definiti con una pretesa operazione oggettiva – viene ricondotta al giudizio individuale. Si ottiene così il risultato di staccare il valore dal suo ambiente naturale collettivo, o meglio, di classe. Si taglia quindi ogni indagine in merito agli scopi. Questi appaiono tutti uguali, considerati in loro stessi, mentre differiscono (quindi hanno valore diverso) solo all’interno del giudizio individuale. La parità degli scopi per gli uomini in società produce la radicale eliminazione dell’agire e la riduzione di ogni atto al fare. Il cerchio si chiude. Le altre astrazioni sono secondarie.
Un ultimo cenno sul principio di causalità che viene posto a base dell’agire e sul principio di razionalità. L’uomo è capace di cogliere il divenire, in questo modo si impadronisce del flusso causale degli eventi ed agisce in un certo modo perché si aspetta una certa risposta alla sua azione, la risposta fa parte dello stato di futura soddisfazione che l’uomo si prefigge. Quando questo stato è raggiunto significa che l’azione corrispondeva ai requisiti economici dell’obiettivo da cogliere, quindi era razionale. Si tratta di sviluppi astratti di precedenti astrazioni. La causalità viene colta in modo molto diverso dall’esperienza, poniamo, della meccanica tradizionale. Ad un certo evento (l’azione) possono succedere conseguenze che non sono facilmente prevedibili, anzi – come ho detto – se l’azione è veramente tale e non si riduce ad un banale “fare”, le conseguenze sono osservabili e prevedibili in piccolissima parte e in un modo a volte assolutamente insufficiente a determinare l’agire stesso in termini di stretta valutazione economica. Sono proprio gli scompensi qualitativi che muovono il mondo, sono proprio le azioni che non sembrano affatto razionali che determinano quelle conseguenze che il dominio considera tanto pericolose. Fin quando si resta nell’ottica del prevedibile il dominio prevede, al pari di chi agisce, anzi la sua previsione, per molti buoni motivi, è meglio organizzata e arriva anche a condizionare la previsione degli altri e a incanalarla nel verso favorevole alla persistenza del dominio stesso. Spezzando il codice di questa lettura favorevole allo sfruttamento, l’azione appare subito illogica, in quanto la logica corrente è sempre quella dei dominatori, imposta e voluta da loro. Una cosa che esce dalla loro schematica prospettiva di valore viene subito criminalizzata come irrazionale ed espulsa dal contesto causale. Ma si tratta di accorgimenti del dominio che possono essere rintuzzati e progressivamente distrutti. L’esplosione dell’agire nel suo stesso imporsi contro il dominio crea lo spazio della propria leggibilità logica.
La pratica scissa
La sconfitta del vecchio ordine di cose apre, con Bacone e Cartesio, la scienza nuova. La misura sconfigge la vecchia metafisica. I corpi, adesso, non cadono più perché è nella natura dei corpi di cadere, come spiegavano Aristotele e la teologia medievale non spiegando nulla, ma cadono in un certo modo che viene misurato. Dal primato della teoria intesa come “contemplazione” si passa al primato della pratica intesa come attività. Lo svolgimento delle condizioni storiche non consentiva un diverso “disvelamento” dell’attività umana se non come misura e come catalogazione. Dovevano ancora costruirsi le basi che avrebbero permesso una valutazione di questo archivio.
Machiavelli porterà l’indagine sull’uomo all’interno della nuova prospettiva scientifica. Studiando le regole della politica, oggettivandone i segreti, egli dimostra che l’uomo può essere manipolato e che il compito di questa manipolazione spetta al politico.
Manipolazione e misurazione costituiscono i due lati dello stesso problema della nuova scienza. Ma la nozione di pratica che da essa viene fuori è ancora insufficiente. La divisione tra misurazione e cosa misurata, tra manipolatore e manipolato, corrisponde esattamente alla precedente divisione tra teorico e uomo d’azione.
Il superamento di questa divisione sarà opera del materialismo moderno. L’uomo considerato come unità di pensiero e azione non ha più significato al di fuori della sfera del pratico, l’azione non è qualcosa che arriva dopo ad arricchire un’esistenza già completa, essa è la condizione assoluta per cui l’uomo possa dirsi veramente concreto e reale. Nella pratica, l’uomo fa la realtà, quindi la comprende (nel senso di impadronirsene e di capirla).
Ma questa fondamentale indicazione del materialismo mancava in pieno la coscienza del rapporto tra fare e agire, di cui ho parlato prima. Solo lo sviluppo delle moderne differenze di classe riuscì a rendere evidente questa spaccatura e produrre una chiarezza che la realtà storica precedente alla rivoluzione industriale non poteva avere. Proprio perché la pratica è il modo essenziale dell’essere dell’uomo, quando questa pratica apparve finalmente scissa in modo irrimediabile in dominatori e dominati, in capitalisti e lavoratori, divenne chiara l’esistenza delle due sfere che la costituivano.
Azione rivoluzionaria e teoria della liberazione. E viceversa
L’azione che si contrappone al fare coatto crea la vita, cioè la verità, la bellezza, l’utilità pratica. Grazie all’azione si distinguono con sempre maggiore chiarezza i contorni di una teoria della liberazione che la semplice contemplazione della realtà non sarebbe mai stata capace di strappare alle mistificazioni dei dominatori. Grazie all’azione si disputano, centimetro per centimetro, i campi, il mare, i monti, i fiumi, i laghi, alla folle avventura del capitale. Grazie all’azione si riconquistano ad uno ad uno gli uomini che riprendono la strada verso la libertà salvandosi dalle insidie della famiglia, della patria, del partito.
Così, l’agire si contrappone al fare dando vita ad un’azione e ad una teoria che si convertono reciprocamente, l’azione rivoluzionaria e la teoria della liberazione. Specularmente il fare, contrapponendosi all’agire dà vita ad un fare e ad una teoria che si convertono anch’essi reciprocamente, il fare coatto e la teoria del dominio.
La categoria generale dell’azione – e qui dobbiamo fare un passo indietro – comprendendo sia il fare che l’agire, si sviluppa in una serie di pratiche che compartecipano, in modo diverso e in quantità diversa, sia del fare che dell’agire. Elenchiamo queste pratiche:
a) Pratica di produzione. È la pratica più evidente dell’intera dimensione sociale. Nel quadro specifico dei mezzi di produzione essa raccoglie tutti i processi di modificazione della natura in prodotti d’uso attraverso il lavoro.
b) Pratica ideologica. Comprende la pratica politica, quella morale, quella artistica. Anche la pratica ideologica, in quanto pratica, trasforma la realtà. L’oggetto che subisce questa modificazione è la coscienza.
c) Pratica teorica. Modifica in insieme teorico sviluppato la materia fornita dalla pratica ideologica. Gli oggetti della modificazione sono rappresentazioni, concetti, fatti elaborati dai vari settori dell’ideologia.
La compartecipazione del fare e dell’agire all’interno di queste pratiche è problema di grande importanza. Non esiste una pratica privilegiata, nel senso che possa essere immune dalle limitazioni del fare cogliendo tutte le aperture dell’agire. Nella produzione il fare coatto ha una prevalenza sull’agire, ma quest’ultimo non è assente del tutto. Anche attraverso il sentiero tortuoso dell’alienazione la coscienza di classe può sempre trovare la sua strada. Il fare coatto diventa quindi, a poco a poco, azione rivoluzionaria, abbatte gli ostacoli rigidi dell’organizzazione imposti dalla struttura istituzionale e cerca di avviarsi verso l’autorganizzazione, unica garanzia della libertà. È così che la servitù, sbocco naturale del fare coatto, viene negata nel corso stesso del suo approssimarsi e quindi sconfitta. Allo stesso modo, ma per vie diverse e con diverse motivazioni, l’azione rivoluzionaria può smarrire la chiara impostazione autorganizzata, può farsi strumento chiuso, specifico, piccolo elemento di un quadro strettamente militare e partitico. Essa può fallire per paura della libertà, per paura della imprevedibile situazione che la stessa azione crea ogni momento, può fallire perché desiderosa di una fittizia stabilità immediata, per un’illusione quantitativa che le faccia perdere di vista il suo obiettivo eminentemente qualitativo, la libertà.
All’interno della pratica ideologica la compartecipazione del fare e dell’agire si verifica in modo diverso. Il rischio che il fare coatto s’impadronisca in larga misura di questa pratica è gravissimo. La pratica politica, ad esempio, può aprirsi all’azione rivoluzionaria solo a condizione che colga i limiti programmatici dell’ideologia di fondo, non scambiando gli schemi per realtà rivoluzionaria. Non facendo questo, la politica ritrova tutto il suo peso condizionante, lo spauracchio burocratico-organizzativo la soffoca e la nega in quanto pratica di liberazione. Ogni teoria che parte da questo condizionamento è teoria del dominio. Lo stesso discorso vale per l’affermazione di una pratica di comportamento che può essere inserimento dell’azione all’interno della struttura istituzionalizzata, statica, ben stabile, del tutto prevedibile. L’etica è misura dell’uomo continuamente in azione. Quando diventa misura dell’uomo statico, scade in mera ideologia, disfacendo il progetto dell’uomo nuovo nell’uniformità del vecchio mondo riverniciato. La pratica estetica si può lo stesso avviare per due sentieri, la cristallizzazione di valori funzionali ad una precettistica di maniera, di partito, di corrente, di carriera, ecc., oppure una continua verificazione del rapporto artista-mondo reale, un persistente impegno di classe dissociato da quel bieco realismo a tutti i costi che finisce per nascondere un populismo di maniera che ci si illude possa costituire un passaporto per la comprensione.
La pratica teorica è scienza in quanto superamento dell’ideologia, ma è azione solo a condizione che questo superamento venga realizzato in nome dell’agire e non del fare. In questo modo, azione rivoluzionaria e teoria della liberazione si convertono reciprocamente, non nel senso che ognuna di esse perde la propria identità e le proprie caratteristiche, ma nel senso che nel pieno realizzarsi di questa identità e di queste caratteristiche l’azione rivoluzionaria diventa teoria rivoluzionaria e la teoria della liberazione diventa azione liberatoria.
Una rosa gialla
Ma abbiamo finito veramente di interpretare il mondo? Non mi sono accorto che qualcuno stia per trasformarlo. L’avvenimento assolutamente “altro” non si profila all’orizzonte, mentre i meccanismi di mercato si assestano sui vecchi codici e si riproducono, giustificando la miseria e la ricchezza, assurde polarizzazioni del “così va il mondo”.
In Una rosa gialla, Borges ci fa vedere come il poeta Marino, principe del bel dire e padrone seicentesco delle umane lettere italiane, in punto di morte si accorge che non è possibile il dire (o il fare, che poi è lo stesso) come riproduzione e specchio del mondo, come grande quadro interpretativo, e più modestamente conclude per il fare (e quindi anche per il dire) come eccesso, come superflua aggiunta ad una composizione di già completa, anche se per noi sgradita e intollerabile.
Il pensiero, come l’azione, e questa come quello, non sono mai semplicemente progetto, cioè non hanno un senso “soltanto” in funzione di quello che contribuiscono a determinare o di quello che è prevedibile che possano determinare. Essi sono, prima di tutto, una storia anteriore, cioè sono fatti essi stessi, significativi in una loro sorta di autonomia, pieni di senso, quindi portatori del contrassegno che l’operare umano ha loro inferto.
Sono cioè messaggi caratterizzati, pezzi in movimento degli uomini che li hanno pensati e fatti, in quanto pensieri e in quanto azioni. In quanto tali non hanno contropartita netta nello scopo che intendono raggiungere, non si esauriscono cioè negli scopi che apparentemente li hanno determinati. Lo studio di questa “differenza” conduce dritto all’interno dell’accostamento all’assolutamente “altro”.
Se pensiamo e agiamo al solo scopo di adeguarci alla realtà, magari suonando all’impazzata il nostro trombone per farci meglio sentire, e più lontano, non abbiamo tempo per le sfumature, per quell’aggiunta in eccesso di cui sto discutendo qui. Produciamo quanto necessario perché il mondo vada avanti anche col nostro contributo, e le regole del mercato ci impongono i codici di questa produzione, ci dicono (per grandi linee, ma sufficientemente chiare) cosa fare per non risultare mai al di sotto di quanto richiesto perché il progetto si realizzi, ma neanche al di sopra. E quando falliamo nella resa che ci viene imposta, ci sentiamo appunto di avere fallito, siamo dei falliti, e ci guardiamo le mani inefficaci, e piangiamo per lo scoramento.
Forse dovremmo piangere più calde lacrime proprio quando il successo è arrivato puntualmente per la grande capacità di adeguare quello che facciamo agli scopi da raggiungere. Forse proprio in quest’ultimo caso, che l’efficienza sempre più intensa delle moderne tecniche ci suggerisce quotidianamente, abbiamo fornito il nostro piccolo contributo alla grande costruzione del potere. E ciò anche quando il progetto assumeva i dettagli della rivoluzione, del sovvertimento di istituzioni e valori, di costumi e tradizioni.
In questo caso, nel piccolo e nel grande, ci siamo posti come rifornitori del futuro boia, abbiamo concluso i nostri sforzi nella perfezione di quanto avevamo pensato. Un maggior numero di dettagli finali che corrispondono con le ipotesi di partenza viene sempre visto come un più elevato grado di successo. Gli scopi sono stati raggiunti, i traguardi tagliati, le speranze soddisfatte. Adesso i popoli hanno le proprie regole libere, i vecchi tiranni sono morti, nuove libertà si scolpiscono su nuove tavole lustre. Possiamo presentare il conto. Siamo i liberatori, siamo gli autori del progetto e dei suoi dettagli, ne abbiamo covato l’alto significato sociale come si cova un uovo di pavone, adesso assistiamo allo sfolgorio delle penne al sole, dorate.
La forza dello scopo da raggiungere ha ucciso il carattere iniziale dell’azione e del pensiero. E quel carattere era l’aderenza all’opera concreta di chi pensava e agiva, manifestazione di forza che voleva lasciare il proprio segno, che voleva affermarsi nel mondo, che voleva trasformare il mondo, ma non con il segno della subordinazione a qualcosa di esterno, ma con la propria stessa esuberanza, con l’eccesso che il proprio medesimo pensare e fare produce. La preoccupazione di chi agisce e pensa, e del proprio pensiero fa un’unica cosa con l’azione, non è quindi quella di trovare una misura fuori di sé, appunto nell’efficienza con cui è stato realizzato il progetto, nella completezza dei risultati, ma è quella di trovare all’interno del progetto stesso, che era e resta momento del fare e del pensare, tutta la sovrabbondanza dell’assolutamente “altro”.
Che vuol dire?
Vuol dire non aspettarsi che gli scopi diano motivi alle scelte, alle idee e ai mezzi per agire. Non aspettarsi che dall’esterno, dagli altri o da quello che si vuole ottenere, giunga autorizzazione pratica o fondamento morale. Se il progetto non è chiaro in noi, se quindi non siamo disposti a correre i rischi che le nostre idee e le nostre azioni comportano, non possiamo aspettare che il semplice risultato positivo ci fornisca quello che ci manca. Accettando questa ipotesi ci presentiamo come creditori, vogliamo un risultato concreto ma solo per noi, proprio perché di quella mancanza iniziale siamo sempre stati coscienti e di una completezza siamo sempre andati in cerca.
Se invece siamo certi di quello che pensiamo e dei motivi che ci spingono ad agire, siamo completi fin dall’inizio. E se siamo completi possiamo donarci all’altro, possiamo donarci all’obiettivo che vogliamo raggiungere. E questo nostro dono apparirà subito per quello che è: lo scambio di un dono tra noi e l’altro, tra noi e la realtà che ci sta davanti, sconosciuta ma desiderata, che vogliamo trasformare. Il nostro dono non è riparatore, non eguaglia, non fa giustizia, non ricompone torti. Esso distrugge e crea, aggiunge l’eccesso incommensurabile, oltre il quale ogni conteggio diventa impossibile. Ci riempie il cuore, al di là di ogni calcolo economico.
[Per la redazione dei paragrafi I fatti e Il fare e l’agire ho tenuto presente il mio articolo “Teoria e azione”, pubblicato su “Pantagruel” n. 1, gennaio 1981, pp. 5-35. “Una rosa gialla”, pubblicato su “Canenero” n. 30, 9 giugno 1995, p. 4]
Questo sito, oltre a informare i compagni sulle pubblicazioni delle Edizioni Anarchismo, archivia in formato elettronico, quando possibile, i testi delle varie collane.
L’accesso ai testi è totalmente libero e gratuito, le donazioni sono ben accette e servono a finanziare le attività della casa editrice.
