Prima edizione
Dissonanze I: ottobre 1999
Dissonanze II: novembre 1999
Dissonanze III: dicembre 1999
Dissonanze IV: gennaio 2000
Dissonanze V: febbraio 2000
Dissonanze VI: marzo 2000
Seconda edizione in un unico volume: maggio 2015
Alfredo M. Bonanno
Dissonanze
Seconda edizione riveduta, corretta e ampliata
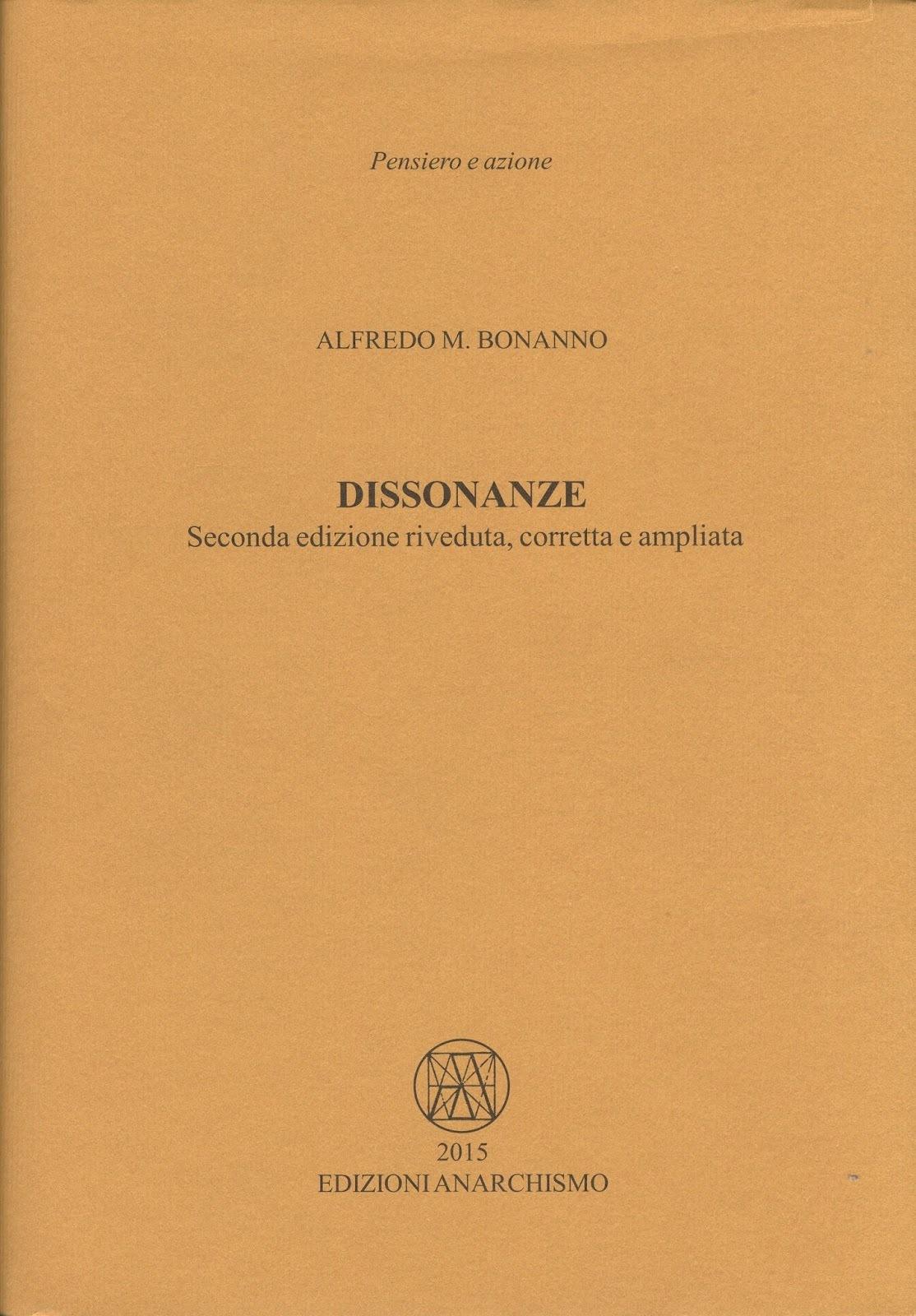
Introduzione alla seconda edizione
Introduzione alla prima edizione in sei volumi
Lusinghiere aspirazioni mortali
La botte piena e la moglie ubriaca
La feroce certezza del proprio dovere
Chi guadagna nella svalutazione?
Fra le righe del bilancio statale
Il massacratore e i massacratori
Varianti repressive: la tortura
Varianti repressive: i pentiti
Varianti repressive: i dissociati
Schema di discussione per un intervento nella scuola
Le tre soluzioni proposte dal capitalismo
Appendice sugli effetti negativi dell’installazione di una linea ferroviaria ad alta velocità
Introduzione alla seconda edizione
Gli scricchioli del mondo che mi circonda li sento sempre più forti, sarà una mia impressione, ma è così. Non voglio indicare la causa di questo rumore persistente, mi sbaglierei di sicuro, forse è connaturata alle vecchie pulegge repressive e partecipative che fanno andare avanti la baracca, fare questo rumore, forse è l’insieme dei lamenti di coloro che soffrono, e se ne dolgono, ma non sanno come porre rimedio ai propri guai se non richiedere, per cortesia, un allungamento della catena.
Altro è il deserto. Il deserto è prova e paura, una minaccia che incombe continua e imprevedibile. Eppure è un’aridità solitaria che educa alla pazienza e all’attesa. È l’immagine più convincente della tensione, dell’intensità che si esalta senza necessariamente apparire irreversibile, senza avere obbligo di apparenza. L’ebete fascino del tumultuoso modo del fare è lontano, pure non essendo scomparso del tutto. I miei nuovi progetti nell’intuizione dell’azione trascolorano e fluiscono nella desolazione, variano dapprima in modo ragionevole, poi sempre più velocemente, all’infinito, rifiutando di ascoltare le mie parole e prestando orecchio alla voce dell’uno che arriva col vento del deserto. Questa voce respira e svanisce a ogni sensazione, canta la vita, la qualità e le intensità che la caratterizzano senza con questo specificarla in modo definitivo fino in fondo, fino a farla conoscere con la forza possessiva della parola. Ogni parte di questa intensità non è distinguibile dall’altra, è tutto continuo nella realtà, inesauribile e lieve movimento, appassionata risposta alla richiesta di amore che viene dal deserto. Amo la fugace presenza di ciò che nella forza era assenza, amo la vita che nel deserto è tanto forte da essere morte nello stesso tempo, da riassumere in sé la morte come ridicolizzazione del tempo. Tutto nella desolazione si dissolve all’ombra di una qualità indefinibile col maglio dell’apparenza, ma ottimamente individuabile nell’intensità. Se la vita e la morte si riconoscono entrambe nella desolazione è perché il tutto e il nulla sono semplici modulazioni dell’intensità, non elementi logicamente antitetici. Nell’azione felicità e disperazione si uniscono insieme, non si distinguono più, gioia e malinconia, condizioni dove, nell’estrema intensificazione puntuale, non posso che essere in loro perché sono stato colto, ma che non posso né capire né dire.
Qui rifletto su un numero considerevole di modulazioni della vita, sofferenze e gioie, attacchi inferti e colpi subiti, tentativi violenti di liberazione e processi repressivi in corso. Mi affascina l’eccesso, l’eccesso senza compromessi, l’essere tutto quello che sono, messo in gioco senza reticenze. Non potrei resistere a lungo senza avvertire presente una tensione estrema, l’ebbrezza di un movimento che cerca quello che non è a portata di mano, che si incanta di fronte alle propaggini di una sconosciuta desolazione, al silenzioso profilarsi di un territorio nuovo, privo di contrassegni e di corrispondenze. La gioia dell’assenza non può essere un semplice aumento di grado della gioia della presenza. Questo passaggio non esiste, la sua impossibilità è data dalla incapacità quantitativa di completarsi. Ciò comporta una sollecitazione al combattimento, anche contro tutto quello che ho costruito, che ho solidificato sotto l’aspetto del possesso, e anche una lotta contro tutti i tentativi di aumentare questo possesso per farlo diventare capace di controllare il mondo. Innalzarmi sugli ostacoli del mondo è una banale esercitazione di muscoli, devo salpare verso nuovi orizzonti, la mattinata è ormai matura e sono sazio del miscuglio di luce e di buio che mi viene servito come verità e non è altro che apparenza. Che la gioia esploda fino a confondermi, che io non sappia più che fare, dove poggiare i piedi, su quale recondita saggezza fare affidamento, che una spinta cresca dentro di me come una pianta tropicale, estranea e incomprensibile, con un ritmo insostenibile e confuso e faccia sfiorire ogni traccia di meschinità e di concezione razionale. La bufera si approssima ed è quella solita che si scatena nel deserto, sabbia e vento.
Arrivederci altrove, ecco il saluto dell’altra volta, quindici anni fa, per me resta sempre lo stesso. Arrivederci altrove.
Trieste, 4 marzo 2014
Alfredo M. Bonanno
Introduzione alla prima edizione in sei volumi
Fra i tanti motivi che fanno amare la musica c’è il ritmo. Tutti pensano di sapere cos’è il ritmo e proprio per questo è bene dire qualcosa in merito, se non altro per far vedere come le cognizioni più sicure nascondono problemi e incertezze.
La parola “ritmo” deriva dal greco “ritmòs” che a sua volta sembrerebbe derivare da “reìn”, che vuol dire scorrere. Ma quest’ultimo termine non si usa mai per indicare lo scorrere di un fiume, a esempio, ma solo per il movimento delle onde, le quali, parlando esattamente, non scorrono ma si muovono più o meno violentemente in una certa direzione, oppure in direzioni contrastanti. Il materialista Democrito usa “ritmòs” per indicare la forma del fuoco, cioè la figura cangiante senza interruzione di sorta che il fuoco prende nel suo ardere. Leucippo, un altro materialista, parla invece del rapporto tra il “ritmòs” e lo “schèma”, cioè la forma del fuoco, ma anche dell’acqua.
Ma questi concetti vanno evolvendosi rapidamente. Di già ai tempi di Platone le cose stanno un poco diversamente. Il ritmo adesso si avvicina alle forme del carattere umano, segna i diversi modi di essere e di manifestarsi, i sentimenti e gli umori di ognuno di noi. I “ritmoi” sono le forme che prendono gli umori. Platone parla chiaramente di una “disposizione proporzionata”, di “ritmòs”.
Ma cos’è la “disposizione” secondo Platone? È una sequenza ordinata di movimenti, alternativamente lenti e rapidi, acuti e gravi. Questo movimento costituisce un metro più o meno identificabile e prende il nome di ritmo.
Poi l’uomo ha scoperto che quanto accade nel cosmo segue una sorta di ritmo. Alternanze del sole e della luna, del vento e della bonaccia, dell’umidità e del calore secco, della pressione atmosferica e delle radiazioni cosmiche. La vita viene vista come ritmo.
Quello che sembra caratterizzare il ritmo è quindi il suo carattere ondulatorio e il ripetersi delle frequenze massime e minime a intervalli più o meno regolari. I ritmi luce-tenebra e veglia-sonno sono sincronizzati per tutti gli organismi. Più l’organismo è sviluppato e più il ritmo della sua vita diventa complesso, con cicli tutti di differente durata. C’è una specie di meccanismo a orologeria intracellulare che funziona col sistema della tensione e della distensione, con fasi equilibrate quasi sempre di durata uguale. Quasi sempre, non è affermazione trascurabile. Forse la sede di questo meccanismo ritmico è nel nucleo della cellula, forse no. Non lo sappiamo, almeno finora. E quando l’avremo saputo, non avremo fatto altro che continuare a chiederci: perché?
La domanda fondamentale, a questo punto, è la seguente: c’è un equilibrio predeterminato nella vita, da cui è possibile dedurre una tendenza all’equilibrio anche nella storia e nella società? La risposta è assolutamente negativa. Tutti coloro che si sono avventurati nella strada impervia del flusso ininterrotto di vitalità, di un equilibrio che sempre si ricompone in nome di un “ordine naturale”, hanno dovuto ammettere, alla fine, che se quest’ordine esistesse esso sarebbe caratterizzato in modo eccellente dal caos.
Pensare, come è stato fatto, alla discontinuità come alla possibilità più che naturale che qualcosa può accadere e può anche non accadere, ha basato le ipotesi del discontinuo: il ritmo come rilevamento e non rilevamento, ora nulla, dopo qualcosa, oppure, ora qualcosa e dopo nulla. Insomma l’alternanza del sì e del no. Ma, osservando bene, questa discontinuità è soltanto apparente, l’evento, che accada in un certo modo o nell’altro, comunque accade, se non accade nel modo previsto dall’equilibrio teorico, accade in altra maniera, che uscendo fuori dallo “schema” denuncia la mancanza di “ritmo” e quindi viene spesso chiamato “nulla”, o mancato accadimento.
Questa riflessione comporta che una serie di eventi, che sembra infinita, è destinata a finire, a interrompersi. Non può uscire sempre il rosso, a un certo momento uscirà il nero, escludendo l’ipotesi dello zero in mano al banco. Ho vissuto situazioni tremende di fatica lavorativa che pensavo non finissero mai, eppure sono finite. Un giorno, in un dato momento, è arrivato l’alt. Ho smesso. Così gli amori e le avventure, i sogni e le tristezze delle ripetizioni. Tutto, prima o poi, s’interrompe. Siamo noi che possiamo immaginarceli totali, infiniti, capaci di durare per sempre, perché li temiamo (la fatica e la paura), oppure perché li desideriamo (l’amore e la gioia). E facendo questo stoniamo, spezziamo il ritmo.
L’armonia, che è alla base del ritmo, è essenzialmente fondata sulla variazione che caccia via la noia (sarebbe meglio dire che cerca di cacciare via la noia). Il massimo della ritmicità onnicomprensiva si raggiunge nel pensiero hegeliano, che passivamente riflette la dialetticità del reale. Sotto l’occhio vigile del filosofo dialettico, i movimenti della realtà si svolgono nelle loro tre fasi, e tutto torna in una condizione di superamento, ritmicamente, raccomodando le eventuali smagliature, i disturbi e le marginalità della storia, che precise organizzazioni di pulizia s’incaricano di far finire nella spazzatura (ricordarsi di Trockij). La Grecia, il Rinascimento e la Prussia di Hegel. Lo Spirito comprende soltanto il ritmo, e lo svolge in una forma assoluta. La natura solo se ricondotta a forza sotto le leggi dello spirito diventa intelligibile, altrimenti ci appare come cosa intraducibile, ricettacolo di ogni abominio e nefandezza. In ogni caso mancanza di ritmo, continuità dissonante, selvaggio desiderio di morte.
Ma questo ritmo, di cui parla Hegel, e con lui tutti i professori di rivoluzione triadica, paralizza qualsiasi movimento di liberazione, ogni volontà di respirare aria migliore, di liberarsi dalla tirannia del fatto. Nel desiderio di rispettare l’armonia del pensiero che crea la natura, il filosofo la riporta sotto le ali del progetto di reggimentazione tassonomica. Ogni cosa al suo posto. Nemmeno una pianticella che riesca a sfuggire al manuale di botanica. Tutto quello che ci è estraneo, che ci disturba, che ci sconvolge con la sua insondabile diversità, viene ricondotto dentro la casa degli accomodamenti. C’è un programma apposta per questi movimenti di recupero. Il mondo è fatto di recuperatori affamati che cercano di mettere qualcosa sotto i denti.
In questo modo il nuovo sfiorisce prima di arrivare a mettere fuori una fogliolina, il molteplice viene semplificato nella formula che toglie via tutte le variabili incomprensibili, la contraddizione superata, il futuro incanalato sotto l’aspetto del comprensibile e del conosciuto. Nulla potrà accadere di pericoloso che non sia facilmente prevedibile dagli organismi della protezione civile. Gli elicotteri sono pronti a decollare e i furgoni dei pompieri a partire. Possiamo andare a letto e spegnere la luce.
Come Dioniso, che arrivava improvviso nella notte, qualcosa resta sempre in sospeso. Nessun calcolo ha una quadratura finita. Non ci sono numeri razionali, se li sono immaginati, la realtà ne produce sempre continuamente, all’infinito. Anzi, il significato di infinito è proprio questa produzione continua. Il discreto che tutti i matematici portano come essenza del mondo, la base su cui contare, e per cui contare, il senso più profondo stesso del contare, è tutto un imbroglio, necessario per non fare scappare le pecore dall’ovile al momento della conta. Anche i detenuti vengono contati, tre volte al giorno. L’alternanza tra Dioniso e Apollo non è presenza dell’uno e mancanza dell’altro, e viceversa, è compresenza. Quando Dioniso arriva Apollo lo riceve, non va via o scompare. Poi Dioniso si allontana, mentre Apollo resta. Non c’è un ritmo in questi movimenti, c’è sempre qualcosa di disarmonico nel cimbalo che ricorda il dio dal piede di toro.
Il ritorno del ripetersi, eterno nella propria circolarità, è anch’esso disarmonia. Quello che apparentemente sembra coronare il massimo dell’identità, presenta una condizione continuamente in via di diventare se stessa, senza che riesca mai a diventarlo fino in fondo. L’eterno ritorno è riempimento impossibile di quello che si è, non equilibro di un divenire altro da sé. In questo riempimento risuonano le disarmonie dell’abisso insondabile, che scuote l’animo di ognuno di noi. La vera compromissione era la delega, il rifiuto di guardare se stessi come misura del mondo, e quindi come possibilità aperta per costruirsi sempre uguali e sempre diversi, quando tutt’intorno la gente urla la propria differenza fittizia, nel restare imprigionata come mosca nella rete delle mode e delle sigle, quelle sì, sempre uguali come divise militari. La specificazione sembra costituire il mondo all’interno della roccaforte del dominio. Tutti gli scienziati sono portatori di pacatezza e autocontrollo, sanno che se il presente è difettoso lo sarà anche il futuro, ma in modo mitigato, qualcosa tende sempre a migliorare nelle possibilità del controllo e del possesso. Il redditiere che arraffa il quattro per cento è contento, anche se sa che quel rischioso investimento di oggi potrà dare al massimo, domani, solo il tre per cento. Ma il suo unico scopo è proprio lì, nel tre per cento, non al di là. Per questo è disposto ad ammazzare i coloni e a torturare gli schiavi. Nulla può fermarlo nel suo buon diritto. Ma lui non ha niente altro da fare che diventare diverso da quello che è, per l’appunto, e semplicemente, più ricco.
Derivandola dalle sensazioni biologiche noi avvertiamo “naturale” la condizione di equilibrio e da qui la trasferiamo nelle costanti valutazioni estetiche che rivolgiamo al mondo che ci circonda. La preminenza del senso della vista e dell’udito sull’olfatto e sul gusto fa il resto. Ci costruiamo così modelli che consideriamo assolutamente fondati e pensiamo che anche la realtà si debba assuefare a questa nostra necessità, diciamo, estetica. Da un altro punto di vista, al primo connesso, riteniamo “funzionali” i presupposti dell’equilibrio, e quindi rassicurativi, ci dormiamo sopra meglio e più a lungo. È l’equilibrio a consegnarci i due sotto-modelli di spazio e di tempo, su cui distribuiamo conformemente tutta la nostra vita. Siamo in questo modo pronti per l’addomesticamento.
I rapporti numerici vengono individuati abbastanza presto dall’uomo, fissando in questo modo le connessioni tra spazio esterno e corpo umano attraverso le capacità di elaborazione della mente. Figure mitiche si sovrappongono a questa costruzione dello spazio e del tempo. Il corpo è il riferimento fondamentale, il ritmo del cuore, forse, quello più importante. Sul corpo si modella la conoscenza dello spazio esterno, a una geografia spazio-temporale ne corrisponde una anatomica e una cosmografica mitica. Tutti questi riferimenti si incrociano al confine tra considerazioni filosofiche e fantasie poetiche. In effetti non ci sono differenze concrete tra queste due attitudini del pensiero umano, se non nella diversa forza che hanno di fissare nella realtà modelli di comportamento opportunamente sacralizzati. La religione finisce per costruirsi come progetto di difesa e di conoscenza a sé stante. Tempus e templum si danno la mano, si ricollegano al greco “témenos”, il solco, della città e del campo, la convivenza e la produzione. Insomma, l’insieme della nuova vita dell’uomo.
Il suono si articola nettamente come produzione esterna, perfettamente coordinata con la mente umana, con i ritmi del corpo. La possibilità di una persistenza nel tempo, raccorda agevolmente spazio e durata, inoltre il suono è più facilmente distinguibile sia in quantità che qualità di quanto accade con gli altri ritmi della natura. Al ritmo dei suoni corrisponde un ritmo del pensiero, una durata che aiuta a equilibrare il funzionamento della mente. I canti che accompagnano il lavoro nei campi hanno questa correlazione ritmica, la cadenza segna le varie fasi gestuali del lavoro, sottolineandole e armonizzandole con il risultato funzionale di favorire una riduzione della fatica.
Ancora oggi siamo prigionieri di questo “cerchio magico”, l’udito resta il senso per eccellenza nella valutazione del tempo, nella successione degli accadimenti e nel ritmo che li accompagna. La parola ha fondamento uditivo, pensata è tutt’altra cosa. Da qui la fondamentale differenza tra la parola scritta e la parola parlata. I Greci raggiunsero molto presto il senso massimo del ritmo, visibile nell’idea che si fecero della danza. La bellezza come perfezione di movimenti nello spazio e nel tempo. La concezione estetica di Aristotele ne è la codificazione più completa nel suo concetto riassuntivo di “simmetria”. La proporzione è fluida ed elastica, tutto il campo (corporeo e spaziale) vi partecipa, la metrica e la strumentalistica entrano a farvi parte come sostegni e controllori esterni, comunque essenziali per garantire la perfezione del ritmo, e in ultima analisi dell’equilibrio.
La lingua della poesia è prigioniera di regole particolari, ferreamente valide anche nella cosiddetta epoca della rottura metrica. All’interno di questo modello ci sono però molti elementi ritmici che lo distribuiscono diversamente, secondo il gusto e la moda: indugi, posizioni toniche e atone, modulazioni e pause, accenti. Per quanto si sia insistito sul fatto che largheggiando nell’uso di questi ultimi si rompa la condizione metrica, anche il tono, la lunghezza, l’accento, la palatalizzazione, la nasalità sono sempre elementi di un equilibrio più vasto che si può ricondurre al metro attraverso l’impiego allargato del concetto di ritmo. Quindi, in ogni caso, la poesia resta sempre espressione musicale.
Resiste quindi il concetto di equilibrio anche contro gli attacchi (formali) delle eccezioni metriche. Molto più chiaro il medesimo processo si svolge nella musica.
Il ritmo nella musica corrisponde alla maniera in cui si struttura il movimento del suono. L’ascoltatore coglie questo movimento solo in base al ritmo dell’intera opera, considerata nel suo insieme, non in base alla singola battuta. Allo stesso modo in cui si comprende l’intera parola e non la singola lettera o sillaba.
Ma cos’è la dissonanza? Eccoci al punto. Di per sé la rottura di un equilibrio può essere considerata un equilibrio di nuovo genere. Restando nel campo musicale, la rottura della tonalità, della consonanza, della melodia, del ritmo e della struttura formale non costituiscono altro che moduli differenti, altrettanto modulari, seppure sotto forma diversa. Certo, la rottura, che ben presto potrà essere codificata, rappresenta un tentativo di sottrarre l’esperienza (in questo caso, musicale) alla tirannia del concreto, del leggibile, della sfera familiare e della di già sanzionata consuetudine. Un passo avanti, ma solo un passo. In fondo, la musica ricomprende la dissonanza all’interno del modulo tonale, considerandola, a volte, costituita da una serie di intervalli o di accordi che producono un effetto di incompiutezza, di sospensione, una malinconica mancanza o insoddisfazione, un’apertura al movimento successivo che però resta inadempiuta.
Poiché qui non parliamo di musica ma affrontiamo il problema in generale della rottura di qualsiasi equilibrio, nelle varie forme in cui l’uomo l’ha pensato possibile, abbandoniamo il paragone in corso.
La serie, piuttosto consistente, di argomenti che vengono presentati in questi sei volumetti consecutivi, documenta, da molte angolazioni, spesso imprevedibili, un metodo dissonante, un’ipotesi di ricerca che cerca di fissare alcuni elementi di rottura, una concezione della vita che si sforza di collocarsi al di là di una linea di accettazione e conservazione. Singolarmente prese, le varie argomentazioni sono tutte insoddisfacenti. In nessuna di esse si arriva a una conclusione che si possa realmente dire “diversa” da quella che, in un modo o nell’altro, dichiaratamente o fraudolentemente, il potere stesso veicola nei suoi mille modi di dire quotidiani. Non c’è un monopolio dell’oltranzismo teorico. La stessa dissonanza, come si è visto, rientra a pieno ritmo nella logica dell’armonia, tutto viene recuperato e tutto ritorna in circolazione, magari sui banchi del supermercato. Respingere il dialogo, irrigidirsi di fronte alla profferta di collaborazione (per carità! assolutamente libera), fare in proprio, gestirsi la cultura come fatto separato e personalizzato, non accettare riconoscimenti e medaglie: tutto questo, anche se lodevole, non basta, non garantisce nulla. Perfino lo stesso rifiuto di una qualsiasi garanzia, fatta una bella capriola, si ripresenta come ulteriore garanzia, proprio fondata sulla mancanza di garanzia. Non basta niente di tutto questo.
La dissonanza sta quindi nei contenuti di questi argomenti, quasi una piccola enciclopedia del “pensare diverso”, ma permanendo nei contenuti, cristallizzandosi in luoghi del dire (e, per quello, anche del fare) viene convertita in possibile condizione del recupero, alimento per il futuro pensiero conservatore, nuove divise (di colore diverso), nuovi “idola” (di formato più gradevole). Non esistono ricette definitive, nemmeno dissonanze capaci di rompere il ritmo che continua ad avvolgerci quotidianamente.
Eppure la dissonanza ha qualcosa d’altro da offrire. Vediamo che cosa.
Nel crocevia dei ritmi tra fatti rievocati, tempo della scrittura e tempo della fruizione, cioè del compito liberamente assunto dal lettore, si colloca qualcosa di significativo, si identifica un contenuto che è esso stesso qualcosa d’altro delle singole argomentazioni di cui si tratta, dei modi del dire e del dire delle modalità. Lasciandosi colpire dalla dissonanza non si riceve nessuna illuminazione, non si cade riversi sulla via di Damasco, ma semplicemente si crea attorno ai propri pensieri un’alea differente, cioè si lascia che l’inavvertenza penetri nell’ambito della codificazione. Lo stesso raggio d’azione argomentativa si apre a connubi imprevedibili, e non voluti dalla fase di scrittura, forse nemmeno presenti nella fase fattuale, nei problemi veri e propri, per come si suole indicare questo momento. La dissonanza agisce quindi come un catalizzatore di aperture casuali, impossibili da controllare. Unica avvertenza: non farsi prendere dal panico del significato.
Se la dissonanza era parte dell’armonia, costituendone l’esito altro, ma sempre prevedibile e perfino augurabile, il suo libero coagularsi in processi di fruizione aleatori produce qualcosa di diverso, una rottura non facilmente sanabile. Che altri rispettino il ciclo conchiuso nell’alveo rassicurante del significato, che portatori d’acqua dissetino le nostre preoccupazioni, ma altrove, per favore, qui si propone una lettura che sia essa stessa un rischio, una chance, un percorso aperto alla possibilità altra.
Il caso è ancora tutto da scoprire, se non altro nelle sue connessioni col caos. Ma anche quest’ultimo è tutto da scoprire, se non altro nelle sue connessioni con l’ordine spontaneo. Arrivederci altrove.
Catania, 29 aprile 1999
Alfredo M. Bonanno
Acquistare il Vaticano
Attraverso Internet è andata in circolo la notizia dell’acquisto in blocco del Vaticano da parte della Microsoft di Bill Gates. Dopo l’abbuffata del codice Hammer, il miliardario americano sembrava avesse deciso la grossa operazione. In effetti questa potrebbe essere l’unica soluzione capace di risolvere il deficit del bilancio della Chiesa cattolica, bilancio gravemente intaccato dalle spese processuali e dalle richieste di risarcimento avanzate da migliaia di giovani violentati da preti cattolici in tutti il mondo. Più di ottocento negli ultimi tre anni soltanto negli Stati Uniti. La notizia non era vera.
[Pubblicato su “Canenero” n. 9, 6 gennaio 1995, p. 2]
Animale-Uomo
L’uomo uccide l’animale, molto di meno, infinitamente di meno, quest’ultimo uccide il primo. Sul piano dello scontro, avendo l’uomo il massimo potere concepibile dalla sua, il rapporto è diseguale.
L’uomo uccide il suo simile, e qui l’uccisione è un po’ di tutti contro tutti, mentre altro potrebbe essere il destino probabile, e perfino realizzabile, di una civile (si fa per dire) convivenza.
La morte è uno dei motivi conduttori della vita, tanto che questa senza di quella non sarebbe pensabile. Solo che l’uomo dabbene, il pacioso e pacifico ragionatore dei problemi via via posti sotto il suo naso, non si pone il problema della morte, se non altro della sua morte, essendo quella degli altri diventata spettacolo quotidiano servito a tutti, indistintamente, al momento dei pasti principali. Donne, vecchi, bambini, adulti nel fiore delle loro forze, vengono massacrati dappertutto, in guerre e piccole guerre, in commerci mortali più o meno dichiarati – dalla droga ai fast food.
Gli animali, come vasta congerie di specie opportunamente catalogate in laboratori finanziati alla bisogna, occupano un posto non secondario in questo massacro generalizzato. Dai cani abbandonati o pettinati come cocotte fino al loro rimbecillimento, dai maiali fatti morire nei camion alle piccole foche uccise a martellate, la terra è coperta dal sangue di questi esseri viventi al cui dolore, ormai industrializzato, siamo stati resi sordi.
Alzare alti lai per fare sapere ai mangiatori di carne (con parsimonia) come me che questo massacro si può arrestare diventando tutti vegetariani, è un modo come un altro per non fare niente e tenere a bada i morsi della propria coscienza, che ci addenta senza misericordia. Lo stesso, se non peggio, inalberare slogan che sembra dicano tutto e invece sono solo stupidaggini del genere: gli animali sono miei amici, io non mangio i miei amici.
Ci sono responsabilità precise, qui e là, queste responsabilità tappezzano il mondo, geograficamente inteso, come una mappa puzzolente. Questa mappa è stata da tempo decodificata, sono stati individuati i luoghi del massacro, gli autori del massacro, i beneficiari capitalisti. Che si aspetta per attaccarli?
So bene che rispondere alla vessata obiezione: a quale scopo? distrutto uno di questi luoghi o messo in grado di non nuocere uno di questi responsabili, gli altri continueranno nella propria attività. Io penso che uno è sempre meglio di nessuno. Viceversa limitarsi ad alzare alta la voce dell’indignazione può anche essere un modo come un altro per mettere a tacere la propria voglia di agire e così voltarsi dall’altro lato la sera, prima di prendere sonno.
Un momento, non è finita. Anche facendo qualcosa in questa direzione, colpendo dove andrebbe colpito, mettendo a tacere l’obiezione perbenista che sostiene la vacuità di un gesto del genere, non si sarebbe che all’inizio. E l’uomo? E quando anche tutti i massacri di animali dovessero cessare, e le torture e le vivisezioni, e tutto il resto dello spaventoso scenario che ognuno di noi conosce, l’altro massacro quotidiano, le guerre, le fabbriche di armi, le torture, le carceri, gli inquinamenti, la produzione di merce dannosa, la pubblicità diretta a incrementare la vendita di merce pericolosa per la salute, e tutto il resto, non cesserebbe.
Qui si delineano due limiti all’azione: non esiste difesa dell’animale che non parta dalla difesa dell’uomo, e non esiste difesa dell’uomo che non intacchi gli interessi capitalisti che distruggono e torturano gli animali. Chi pensa di occuparsi di questa seconda parte del problema, ritenendola staccata dalla prima parte (i danni che si realizzano quotidianamente contro l’uomo) senza saperlo sta dando una mano al massacro in generale. Oggi non è facile non essere complici. E gli intellettuali, uscendo dalle biblioteche, sono i migliori massacratori.
[2007]
Animali
Attaccare gli uomini e le strutture che rendono possibile la tortura e lo sfruttamento degli animali è lotta importante per motivi etici che qui vogliamo sottintendere. Individualmente si può essere più o meno sensibili al problema, ma non c’è dubbio che questo problema esiste e che non è giusto che milioni di esseri sensibili vengano fatti a pezzi per discutibili scopi, spesso neanche ben mascherati in termini di utilità economica o di ricerca scientifica.
Di più. La lotta animalista è importante perché consente una differenziazione qualitativa della propria sfera etica e, nello stesso tempo, può costituire punto d’inizio per altre lotte che comprendano anche la liberazione dell’uomo e non solo quella dell’animale.
A stretto rigore di termini la stessa lotta animalista sarebbe monca e quindi priva di senso etico se si fermasse all’animale, anche fondando questa cesura sul fatto evidente che l’animale non potendo difendersi da se stesso abbisogna di difesa. Ma, sviluppando il concetto etico da cui partono le lotte animaliste si arriva allo scontro rivoluzionario vero e proprio, contro chi ci opprime e ci domina, anche se l’attuale differenziazione della produzione economica spesso non permette di cogliere agevolmente connessioni e rapporti.
La presenza di Brigitte Bardot ai funerali di Jill Phipps, morta in Gran Bretagna, a Coventry schiacciata da un camion, mentre cercava di impedire l’esportazione di vitelli vivi, esportazione che avviene in condizioni terribili per gli animali, segna in modo evidente i limiti di una lotta che spesso per svilupparsi si autolimita. L’attrice è arrivata in aereo privato, ha presenziato al funerali nella cattedrale di Coventry contribuendo alla cerimonia con uno spaventevole bouquet di fiori a forma di vacca, ed è fuggita via in Jaguar con autista. Che dire di sostenitrici del genere? Che di certo non potranno mai essere disponibili per uno sviluppo della lotta animalista stessa nel senso detto prima. L’unico interesse di questa gente potrebbe essere quello della spettacolarizzazione, della riduzione della tensione etica in mera soddisfazione personale e dello scontro vero e proprio in banale occasione di svago.
Ma anche le lotte animaliste che non hanno come scopo lo spettacolo e che quindi vedono impegnati compagni e persone convinti dei motivi etici delle proprie scelte, qualora si autolimitassero all’ambito esclusivamente animalista non avrebbero difficoltà ad accettare coabitazioni con singoli individui che per le loro scelte generali di vita non sono in grado di superare il limite specifico della lotta animalista stessa. Penso sia possibile che un poliziotto si faccia coinvolgere in una lotta del genere, ma non penso che lo stesso poliziotto sia disposto a fare il passo successivo, e nemmeno me lo auguro.
[Pubblicato su “Canenero” n. 16, 24 febbraio 1995, p. 5 col titolo “Non solo animali”]
Anticlericalismo
Nell’attuale [1987] bagarre politica sull’educazione laica o religiosa sarebbe fuor di luogo intervenire con alcune precisazioni nostre. Sono faccende di palazzo, tentativi di ingerenza del potere religioso all’interno del potere statale. Lo Stato reagisce (o, almeno, una parte di esso sembra reagire) perché vede intaccato dal confessionalismo, un settore (quello dell’istruzione) che ritiene di dovere gestire in proprio.
Il problema vero non è però quello di una “presenza” di disturbo della Chiesa all’interno del territorio dell’educazione. L’ora di religione, a parte casi limite di carisma personale dell’insegnante, dai tempi dei tempi, è sempre stata un’ora di inutili attese e di sbadigli spaventosi. Non è quindi un vero e proprio inquinamento che i laici temono. E poi, loro, ormai non credono più alle possibilità di iniettare dall’esterno un sentimento deleterio – come di fatto è quello religioso vissuto attraverso la Chiesa che ne fa elemento di stupro e di dominio – quando sono loro stessi ad avere reso impossibile un’educazione alla libertà e all’autonomia del singolo, subordinando il rapporto tra discente e istituzione agli interessi esclusivi di quest’ultima, intesa essa nel più vasto significato possibile: dalla scuola al mercato del lavoro.
Non è quindi sullo spazio che il prete verrebbe ad avere che ci si sta scannando politicamente in Italia in questi giorni. E non è nemmeno su questioni di “concordato”, cioè di firme su protocolli e di faccende esilaranti come quelle relative alla mancanza di parola o corbellerie del genere.
La lotta al coltello è per motivi di potere, motivi che si riverberano nel complesso della lotta politica italiana e in modo ben più organico del semplice intervento nel settore educativo. Lo scontro è quindi, ancora una volta, una scusa per misurare forze e contare clienti.
Da parte nostra, la riflessione si sviluppa per una tangente diversa. Come anticlericali inveterati, la Chiesa ci mette subito in sospetto, anzi, attira subito la nostra attenzione gelosa e perfino irritata. Il prete, per principio, ci fa schifo, come persona, come simbolo e come elemento di un gioco di potere che poniamo allo stesso livello del poliziotto. Ma oggi, al di là di questo nostro modo di sentire, il quale potrebbe non essere condiviso da molti compagni, si colloca il presente progetto egemonico della Chiesa. E qui siamo davanti a un problema diverso e più grave.
Attraverso la polemica sull’ora di religione si vede con chiarezza di che prospettive controriformiste è impastato il progetto medievaleggiante della nuova Chiesa cattolica. L’egemonia culturale (si fa per dire), che essa vuole imporre, è ricavata da contenuti del passato che fanno ritorno, come tanti allucinati fantasmi, pronti a tradursi in interventi concreti nella nostra realtà di tutti i giorni. Ecco in che modo.
La Chiesa di oggi non si limita a una ripresentazione di argomenti del passato: il peccato, l’inferno, il diavolo, la fede irrazionale, i santi, e non si limita nemmeno più a una lotta contro tutti i tentativi di uscire fuori da una tutela reazionaria in argomenti di natura personale: la famiglia, i figli, il divorzio, l’aborto, ecc. Adesso, si propone di andare più avanti, verso quella conquista della iniziativa politica che era il sogno del grande Gregorio. Per questo si stanno sviluppando, non al suo interno (che proprio qui si collocano le maggiori debolezze), ma al suo esterno, nel corpo stesso della società cosiddetta laica, strutture che agiscono come tentacoli della piovra vaticana. Esempi di notevoli dimensioni sarebbero l’Opus dei e Comunione e Liberazione. La stessa Democrazia cristiana è fortemente ostacolata nel suo puerile tentativo di diventare un partito non confessionale. Queste forze, vivissime oggi, si rifanno apertamente agli ideali reazionari che una volta erano (in tempi recenti) patrimonio dei soli fascisti. Ideali che discendono direttamente dai massacratori “crociati”, dai cavalieri teutonici, dai “soldati di Cristo”, dall’Inquisizione e dai Gesuiti. Lo scopo, non dichiarato, evidentemente, è la riconquista, su scala mondiale (si spiegano così i viaggi del Papa) dell’antico potere temporale. No, non bisogna meravigliarsi per la mancanza di un “territorio” adeguato all’attuale potenza internazionale che la Chiesa costituisce. Il territorio, per un potere in veloce sviluppo come questo, non è essenziale. Quello che conta è l’ascendente psicologico, opportunamente sfruttato, il quale si traduce in sostegno materiale a una politica di sfruttamento a livello mondiale, oltre che in un sostegno a favore di quei processi di ristrutturazione e razionalizzazione di questo stesso sfruttamento che oggi sono in corso dappertutto. Questi sono i veri pericoli della Chiesa. E in una lotta contro di essi dovremmo ritrovarci, tutti insieme, gli anticlericali veri, cioè quelli che non si fermano ingenuamente soltanto davanti ai simboli e ai miti.
[Pubblicato su “Provocazione” n. 8, ottobre 1987, p. 8]
Antifascismo
Il fascismo è una parola di otto lettere che comincia per f. L’uomo, da sempre, si è appassionato fino a morirne per i giochi di parole che, nascondendo la realtà più o meno bene, lo assolvono dalla riflessione personale e dalla decisione. Così il simbolo agisce al nostro posto e ci fornisce un alibi e una bandiera.
Quando al simbolo che non intendiamo sposare, che anzi ci fa schifo profondamente, applichiamo la paroletta “anti”, ci consideriamo da quest’altra parte, al sicuro, e pensiamo di avere assolto con questo a una buona parte dei nostri compiti. Così, poiché alla mente di molti di noi, e chi scrive si annovera fra questi, il fascismo fa schifo, è sufficiente il ricorso a quell’“anti” per sentirsi a posto con la coscienza, racchiusi in un campo ben guardato e ben frequentato.
Nel frattempo la realtà si muove, gli anni passano e i rapporti di forza si modificano. Nuovi padroni si avvicendano a quelli vecchi e la tragica barra del potere passa di mano in mano. I fascisti di ieri hanno messo da parte le bandiere e le svastiche, consegnate a pochi dissennati dalla larga tonsura, e si sono adeguati al gioco democratico. Perché non avrebbero dovuto farlo? Gli uomini di potere sono soltanto uomini di potere, le chiacchiere nascono e muoiono, il realismo politico no. Ma noi, che di politica capiamo poco o nulla, ci chiediamo imbarazzati cos’è successo, visto che ci hanno tolto da sotto il naso l’antico alibi del fascista nerovestito e mazzafornito, contro cui eravamo adusi a lottare a muso duro. Per cui andiamo cercando, come galline senza testa, un nuovo barlume espiatorio contro cui scaricare il nostro fin troppo facile odio, mentre tutto attorno a noi si fa più sottile e più sfumato, mentre il potere ci chiama a discutere:
– Ma prego, si faccia avanti, dica la sua, senza imbarazzo! Non dimentichi, siamo in democrazia, ognuno ha diritto a parlare quanto e come vuole. Gli altri ascoltano, acconsentono o dissentono, e poi il numero fa il gioco finale. La maggioranza vince e alla minoranza resta il diritto di tornare a dissentire. Purché tutto si mantenga nella libera dialettica delle parti.
Se portiamo la questione del fascismo sul piano delle chiacchiere, dobbiamo ammettere per forza che è stato tutto un gioco. Forse un’illusione:
– Il Mussolini, un brav’uomo, di certo un gran politico. Ha fatto i suoi errori. Ma chi non ne fa. Poi s’è fatto prendere la mano. Lo hanno tradito. Siamo stati tutti traditi. La mitologia fascista e anticoromana? Ma lasci perdere! Lei pensa ancora a queste anticaglie? Roba del passato.
“Hitler... – ironizzava Klaus Mann descrivendo benissimo la mentalità di Gerhart Hauptmann, il vecchio teorico del realismo politico – in fin dei conti,... Miei cari amici!... Niente malanimo!... Cerchiamo di essere... No, se non vi rincresce, consentitemi... obiettivi... Posso riempirmi di nuovo il bicchiere? Questo champagne... straordinario, davvero – l’uomo Hitler, voglio dire... Anche lo champagne, quanto a questo... Un’evoluzione assolutamente straordinaria... La gioventù tedesca... Circa sette milioni di voti... Come ho detto spesso ai miei amici ebrei... Quei tedeschi... nazione incalcolabile... misteriosissima davvero... impulsi cosmici... Goethe... La Saga dei Nibelunghi... Hitler, in un certo senso, esprime... Come ho cercato di spiegare ai miei amici ebrei... tendenze dinamiche... elementari, irresistibili...”.
No, sul piano delle chiacchiere no. Davanti a un buon bicchiere di vino le differenze sfumano, e tutto torna opinabile. Perché, è questo il bello: le differenze ci sono, ma non tra fascismo e antifascismo, ma tra chi vuole, e volendolo persegue e gestisce il potere, e chi lo combatte e lo rifiuta. Ma su quale piano potremmo trovare un fondamento concreto a queste differenze?
Forse sul piano di un’analisi più approfondita? Forse facendo ricorso a un’analisi storica?
Non credo. Gli storici costituiscono la più utile categoria d’imbecilli al servizio del potere. Credono di sapere molte cose, ma più si accaniscono sul documento, più non fanno altro che sottolineare la necessità del suo essere tale, un documento che attesta in modo incontrovertibile l’accaduto, la prigionia della volontà del singolo nella razionalità del dato, l’equivalenza vichiana del vero e del fatto. Ogni considerazione su possibili eventualità “altre” resta semplice passatempo letterario. Ogni illazione, assurda piacevolezza. Quando lo storico ha un barlume d’intelligenza, travalica subito altrove, nelle considerazioni filosofiche, e qui cade nelle ambasce comuni a questo genere di riflessioni. Racconti di fate, gnomi, e castelli incantati. E ciò mentre tutt’intorno il mondo si assesta nelle mani dei potenti che hanno fatto propria la cultura dei “bignamini”, che non distinguerebbero un documento da una patata fritta. “Se la volontà di un uomo fosse libera, scrive Tolstoj in Guerra e pace, tutta la storia sarebbe una serie di fatti fortuiti... Se invece esiste una sola legge che governi le azioni degli uomini, non può esistere la libertà dell’arbitrio, poiché la volontà degli uomini dev’essere soggetta a questa legge”.
Il fatto è che gli storici sono utili soprattutto a fornirci elementi di conforto. Alibi e protesi psicologiche. Quanto sono stati bravi i federati della Comune del 1871! Come sono morti da coraggiosi al Père Lachaise! E il lettore s’infiamma e si prepara pure lui a morire, se necessario, sul prossimo muro dei federati. In tale attesa, cioè in attesa che oggettive forze sociali ci mettano in condizione di morire da eroi, barcameniamo la vita di tutti i giorni, per poi arrivare alla soglia della morte senza che quella tanto sospirata occasione ci sia stata porta. I trend storici non sono poi così esatti, decennio più, decennio meno, possiamo saltarne qualcuno e ritrovarci con niente nelle mani.
Volete misurare l’imbecillità d’uno storico, portatelo a ragionare sulla cose in fieri e non sul passato. Ne udirete.
No, le analisi storiche no. Forse quelle politiche, o politico-filosofiche, come siamo stati abituati a leggerne in questi ultimi anni. Il fascismo è questo, e poi quest’altro, e quest’altro ancora. La tecnica di facitura di queste analisi è presto detta. Si prende il meccanismo hegeliano di dire e contraddire nello stesso tempo, qualcosa di simile alla critica delle armi che diventa arma della critica, e si cava fuori da un’affermazione apparentemente chiara tutto quello che passa per la testa in quel momento. Avete presente il senso di disillusione che si ha quando, rincorso inutilmente un autobus, ci si accorge che l’autista pur avendoci visto ha accelerato invece di fermarsi? Bene, in questo caso si può dimostrare, e Adorno mi pare che l’abbia fatto, che è proprio la frustrazione inconscia e remota causata dalla vita che fugge e che non riusciamo ad afferrare che viene a galla, e che ci spinge a desiderare di uccidere l’autista. Misteri della logica hegeliana. Così, quietamente, il fascismo diventa qualcosa di meno spregevole. Siccome dentro di noi, acquattato nell’angolo oscuro dell’istinto bestiale che ci fa aumentare le pulsazioni, sta un fascista incognito a se stesso, siamo portati a giustificare tutti i fascisti in nome del potenziale fascista che è in noi. Certo, gli estremismi no! Questo mai. Quei poveri Ebrei, nei forni! Ma furono poi proprio tanti a morirci dentro? Seriamente, persone degne del massimo rispetto, in nome di un malcompreso senso di giustizia, hanno messo in circolazione le stupidaggini di Faurisson. No, su questa strada è bene non andare avanti.
La volpe è intelligente e quindi ha molte ragioni dalla sua, e tante altre ancora può escogitarne, fino a dare l’impressione che il povero istrice sia senza argomenti, ma non è così.
La parola è un’arma micidiale. Scava dentro il cuore dell’uomo e vi insinua il dubbio. Quando la conoscenza è scarsa, e quelle poche nozioni che possediamo sembrano ballare in un mare in tempesta, cadiamo facilmente in preda agli equivoci generati da coloro che sono più bravi di noi con le parole. Per evitare casi del genere, i marxisti, da buoni programmatori delle coscienze altrui, in modo particolare del proletariato ingreggito, avevano suggerito l’equivalenza tra fascismo e manganello. Anche filosofi di tutto rispetto, come Gentile, dal lato opposto (ma opposto fino a che punto?), avevano suggerito che il manganello, agendo sulla volontà, è anch’esso un mezzo etico, in quanto costruisce la futura simbiosi tra Stato e individuo, in quell’Unità superiore che è lo scopo dell’atto singolo come di quello collettivo. Qui si vede, sia detto tra parentesi, come marxisti e fascisti provengano dal medesimo ceppo idealista, con tutte le conseguenze pratiche del caso: lager compresi. Ma, andiamo avanti. No. Il fascismo non è solo manganello, e non è nemmeno soltanto Pound, Céline, Mishima o Cioran. Non è nulla di tutti questi elementi e di altri ancora singolarmente presi, ma è l’insieme di tutto questo. Non è la ribellione di un individuo isolato, che sceglie la sua personale lotta contro gli altri, tutti gli altri, a volte Stato compreso, e che ci può anche attirare per quella simpatia umana che abbiamo verso tutti i ribelli, anche per quelli scomodi. No, non è lui il fascismo. Non è quindi che difendendo la sua personale rivolta possiamo revocare in dubbio la viscerale nostra avversione verso il fascismo. Anzi spesso, immedesimandoci in queste difese singole, attratti dalla vicenda del coraggio e dell’impegno individuale, confondiamo ancora di più le idee nostre e di coloro che ci ascoltano, determinando inutili tempeste in bicchieri d’acqua.
Le parole ci uccidono, se non facciamo attenzione.
Per il potere, il fascismo nudo e crudo, così come si è concretizzato storicamente in periodi storici e in regimi dittatoriali, non è più un concetto politico praticabile. Nuovi strumenti si affacciano sulla soglia della pratica gestionaria del potere. Lasciamolo quindi ai denti acuminati degli storici, che se lo rosicchino quanto parrà loro. Anche come ingiuria, o accusa politica, il fascismo è fuori moda. Quando una parola viene usata in tono dispregiativo da chi gestisce il potere, non possiamo farne un uso uguale anche noi. E siccome questa parola, e il relativo concetto, ci fanno schifo, sarebbe bene mettere l’una e l’altro nella soffitta degli orrori della storia e non pensarci più.
Non pensarci più alla parola e al concetto, non a quello che quella e questo significano mutando vestito lessicale e composizione logica. È su questo che bisogna continuare a riflettere per prepararsi ad agire. Guardarsi oggi attorno per cercare il fascista, può essere uno sport piacevole, ma potrebbe anche nascondere l’inconscia intenzione di non volere andare al fondo della realtà, dietro la fitta trama di un tessuto di potere che diventa sempre più complicato e difficile da interpretare.
Capisco l’antifascismo. Sono anch’io un antifascista, ma i miei motivi non sono gli stessi di tanti altri che ho sentito in passato e continuo a sentire anche oggi, definirsi antifascisti. Per molti, vent’anni fa, il fascismo lo si doveva combattere dov’era al potere. In Spagna, poniamo, in Portogallo, in Grecia, in Cile, ecc. Quando in quei Paesi al vecchio regime fascista subentrò il nuovo regime democratico, l’antifascismo di tanti ferocissimi oppositori si spense. In quel momento mi accorsi che quei miei vecchi compagni di percorso avevano un antifascismo diverso dal mio. Per me non era cambiato granché. Quello che facevamo in Grecia, in Spagna, nelle colonie portoghesi e in altri Paesi, lo si poteva fare anche dopo, anche quando lo Stato democratico aveva preso il sopravvento, ereditando i passati successi del vecchio fascismo. Ma non tutti erano d’accordo.
Capisco i vecchi antifascisti, la “resistenza”, i ricordi della montagna, e tutto il resto. Bisogna sapere ascoltare i vecchi compagni che ricordano le loro avventure, e le tragedie, e i tanti morti ammazzati dai fascisti e le violenze e tutto il resto. “Ma, diceva ancora Tolstoj, l’individuo che recita una parte negli avvenimenti storici mai comprende il loro significato. Se tenta di capirlo diventa un elemento sterile”. Capisco meno coloro che senza avere vissuto quelle esperienze, e quindi senza trovarsi per forza di cose prigionieri di quelle emozioni anche a distanza di mezzo secolo, mutuano spiegazioni che non hanno ragione di esistere e che costituiscono un semplice paravento per qualificarsi.
– Io sono antifascista! Mi buttano in faccia l’affermazione come una dichiarazione di guerra, e tu?
In questi casi mi viene quasi sempre spontanea la risposta. – No, io non sono antifascista. Non sono antifascista come puoi esserlo tu. Non sono antifascista perché i fascisti sono andato a combatterli sul loro territorio quanto tu eri al calduccio della democratica nazione italiana che però mandava al governo i mafiosi di Scelba, di Andreotti e di Cossiga. Non sono antifascista perché ho continuato a combattere contro la democrazia che aveva sostituito quei fascismi ormai da operetta, impiegando mezzi di repressione più moderni e quindi, se vogliamo, più fascisti del fascismo che li aveva preceduti. Non sono antifascista perché anche oggi cerco di individuare l’attuale detentore del potere e non mi faccio abbagliare da etichette e da simboli, mentre tu continui a dirti antifascista per avere la giustificazione per scendere in piazza a nasconderti dietro lo striscione dove c’è scritto “Abbasso il fascismo!”. Certo, se avessi avuto più dei miei otto anni all’epoca della “resistenza”, forse anch’io mi farei adesso travolgere dai ricordi e dalle antiche passioni giovanili e non sarei tanto lucido. Ma penso di no. Perché, se ben si scrutano i fatti, anche fra la congerie confusa e anonima dell’antifascismo da schieramento politico, c’erano coloro che non si adeguavano, che andavano oltre, che continuavano, che insistevano ben al di là del “cessate il fuoco!”. Perché la lotta, a vita e a morte, non è solo contro il fascista di ieri o di oggi, quello che si mette addosso la camicia nera, ma anche e fondamentalmente contro il potere che ci opprime, con le sue strutture di sostegno che lo rendono possibile, anche quando questo potere si veste degli abiti tolleranti della democrazia.
– Ma allora, potevi dirlo subito! – qualcuno potrebbe rispondermi cogliendomi in fallo, – anche tu sei antifascista. E come poteva essere diversamente? Sei un anarchico, quindi sei antifascista! Non stancarci con le tue distinzioni.
E invece penso sia utile distinguere. A me il fascista non è mai piaciuto, e di conseguenza il fascismo come fatto progettuale, per altri motivi, che poi, una volta approfonditi, risultano gli stessi motivi per cui non è mai piaciuto il democratico, il liberale, il repubblicano, il gollista, il laburista, il marxista, il comunista, il socialista e tutti gli altri. Contro di loro io ho opposto non tanto il mio essere anarchico, ma il mio essere diverso, e quindi anarchico. Prima di tutto la mia diversità individuale, il mio modo personale, mio e di nessun altro, di intendere la vita, di capirla e quindi di viverla, di provare emozioni, di cercare, scrutare, scoprire, sperimentare, amare. All’interno di questo mio mondo permetto l’ingresso soltanto a quelle idee e a quelle persone che mi aggradano, il resto lo tengo lontano, con le buone e con le cattive maniere. Non mi difendo, ma attacco. Non sono un pacifista, e non aspetto che venga superato il livello di guardia, cerco di prendere io l’iniziativa contro tutti quelli che, sia pure potenzialmente, potrebbero costituire un pericolo per il mio modo di vivere la vita. E di questo modo di vivere fa parte anche il bisogno degli altri, il desiderio degli altri. Non degli altri in quanto entità metafisica, ma degli altri ben identificati, di coloro che hanno affinità con quel mio modo di vivere e di essere. E questa affinità non è un fatto statico, sigillato una volta per tutte, ma un fatto dinamico, che si modifica e cresce, si allarga via via sempre di più, richiamando altre idee e altri uomini al suo interno, intessendo un tessuto di relazioni immenso e variegato, dove però la costante resta quella del mio modo di essere e di vivere, con tutte le sue variazioni ed evoluzioni.
Ho attraversato in ogni senso il regno degli uomini, e non ho ancora capito dove potrei posare con soddisfazione la mia ansia di conoscenza, di diversità, di passione sconvolgente, di sogno, di amante innamorato dell’amore. Dappertutto ho visto potenzialità immense lasciarsi schiacciare dall’inettitudine e poche capacità sbocciare al sole della costanza e dell’impegno. Ma fin dove fiorisce l’apertura verso il diverso, verso la disponibilità a essere penetrati e a penetrare, fin dove non c’è paura dell’altro, ma coscienza dei propri limiti e delle proprie capacità, quindi accettazione dei limiti e delle capacità dell’altro, c’è affinità possibile, possibile sogno d’una impresa comune, duratura, eterna, al di là delle umane approssimazioni contingenti.
Muovendomi verso l’esterno, verso territori sempre più distanti da quello che ho descritto, le affinità si affievoliscono e scompaiono. Ed ecco gli estranei, coloro che portano i propri sentimenti come decorazioni, coloro che mostrando i muscoli fanno di tutto per sembrare affascinanti. E, ancora più in là, i segni della potenza, i luoghi e gli uomini del potere, della vitalità coatta, dell’idolatria che assomiglia ma non è, dell’incendio che non scalda, del monologo, della chiacchiera, del chiasso, dell’utile che tutto misura e tutto pesa.
È da ciò che mi mantengo lontano, ed è questo il mio antifascismo.
[Pubblicato su “Anarchismo” n. 74, settembre 1994, pp. 1-6 col titolo “Che ne facciamo dell’antifascismo?”]
Appuntamento con l’apocalisse
Puntualmente l’alluvione è arrivata. Con margini di minore o maggiore pericolosità ed estensione, era stata prevista. Adesso si piangerà per mesi, forse per anni, sui danni e su quello che si sarebbe potuto fare. Come per i danni del Polesine all’inizio degli anni Cinquanta, o per quelli del Vajont, ci saranno processi e chiacchiere a non finire. E da tutto questo si trarrà materia per attendere, con la maggiore tranquillità possibile la prossima alluvione, e così via.
Ma qual è il nostro reale rapporto con la natura? In tutti i modi l’avvertiamo nemica ed estranea, un pericolo incombente, quindi vogliamo difenderci da essa. Ma la concezione di “natura” che possediamo è proprio quella legata all’incertezza, all’evento futuro incerto e sconosciuto, che dobbiamo a tutti i costi prevedere perché diventi conosciuto e quindi controllabile.
L’ideologia della previsione si sposa con quella del controllo. Allo stesso modo in cui vogliamo controllare il comportamento degli strati più turbolenti della popolazione, quasi sempre fonte di preoccupazioni per coloro che non hanno motivo di lamentarsi dell’attuale distribuzione della ricchezza e del benessere, così vogliamo controllare la natura. Nella nostra fantasia, l’incognito movimento del fiume che ribolle sotto i ponti, nell’oscurità della notte, prende sembianze molto vicine ai rumori che ci impediscono di dormire nelle nostre case accerchiate dalla pressione di coloro che dall’esterno guardano con occhio attento alle diseguaglianze sociali e vorrebbero applicare la legge sacrosanta dell’impossessamento a nostro danno.
Ma non riusciamo a controllare tutto per bene. Non controlliamo il passo felpato del ladro nella notte, per cui quando come il dio greco s’introduce dentro di noi ci sentiamo esposti e violentati, sbalorditi che tutto ciò sia potuto accadere, e non controlliamo la furia della cosa che si dispiega nella sua primaria violenza, nella sua livellatrice cecità.
E allora accampiamo diritti di preminenza, statuti di dominio sulla natura, decaloghi di garanzia delle tecniche. I ponti perché non hanno retto? E gli argini, e le difese del terreno? E i boschi che se ne sono andati a causa dell’edilizia selvaggia? E i soldi che hanno preso altre strade? E i controlli tecnici? E i soccorsi?
Passata l’apocalisse pensiamo a ricostruire, come prima, peggio di prima, mentre la vecchia mentalità, dissennata e stupida, proprio nella sua stessa ottusità trova la forza per riconfermarsi come l’unica strada percorribile. Facciamo di tutto per tornare a prevedere, per costruire argini, e ponti, e strutture di contenimento. Tutti insormontabili, naturalmente fino alla prossima apocalisse. Tanto, cosa potremmo fare di più?
[1993]
A pezzi
Per quel che riguarda la vita sul posto di lavoro la percentuale degli infortuni non è affatto diminuita negli ultimi cinquant’anni. Tristemente resta attestata sul morto ogni ora e sul ferito ogni tre minuti. Naturalmente le condizioni nuove del lavoro, caratterizzate dalla flessibilità e dall’approssimazione professionale tendono a fare lievitare queste medie, annullando gli effetti riduttivi dei provvedimenti di salvaguardia e dell’assistenza sociale. La realtà del lavoro resta spaventosa e la schiavitù cui sono sottoposti tutti coloro che subiscono il lavoro è tanto maggiore quanto più elevata è la coscienza di ognuno di loro di vivere in condizioni di morte. I quattro morti di Angri, del 28 gennaio scorso, polverizzati dall’esplosione della fabbrica di fuochi artificiali, erano stati preceduti dai due morti in Lombardia (un ferroviere e un camionista): e non saranno certo gli ultimi. Nel frattempo i gestori del bene pubblico riflettono nelle loro limousine blindate.
[Pubblicato su “Canenero” n. 13, 3 febbraio 1995, p.7]
Antonin Artaud
L’esperienza di Artaud si è inoltrata molto avanti nel territorio della desolazione. Trent’anni fa mi accorsi di come quest’uomo fosse riuscito a porre con estrema semplicità il dito nel punto esatto in cui si trova il limite del non ritorno, e di come non si fosse affatto preoccupato di non andare ancora più avanti nella strada della follia. In molti punti della sua opera, specie in quelle pagine che poi saranno raccolte nei Quaderni, c’è la piena padronanza di questa inquietudine paradossale, enorme, di tale capacità penetrativa da essere riuscita a perforare completamente la coscienza, un’inquietudine che poté fargli capire come della coscienza non fosse rimasto più niente, nemmeno una traccia. Tutto viene così progressivamente travasato nel territorio della diversità, per cui l’immaginazione lavora subito alla trasformazione. Egli dice più volte, e ripetutamente, di non riuscire a localizzare una coscienza interna, mentre testimonia in dettagli esattissimi se stesso, in primo luogo la sua malattia, la sofferenza, il dolore, la piaga fisica al retto. Delle registrazioni dell’assenza assoluta non si può tenere conto, interessando più che altro sensazioni o intuizioni non facilmente comprensibili, ma nei momenti di ricomposizione, corrispondenti a intervalli di minore intensità della malattia, si vede l’immaginazione all’opera che traccia lucidamente la propria condizione delirante, senza tenere conto di che succede all’esterno, in quella zona della coscienza che ormai è totalmente diversità. Negli estesissimi appunti è stata vista l’intenzione di un uomo di capire se stesso, mentre io credo che vi sia il tracciato di un uomo che vuole capire il territorio dove è voluto andare, territorio che scopre sempre più desolato e inospitale, ma da cui non sa più tornare indietro, da cui non vuole più tornare indietro. L’universo della catalogazione non lo riguarda più, i suoi reiterati rifiuti hanno un fondamento retorico. C’è in lui un’evidenza del rifiuto che è più forte e radicata della relativa verbalizzazione. È la realtà che vuole raggiungere, la realtà totale, quell’oggetto totem che cerca disperatamente di fare emergere dal territorio uniforme della desolazione, non capendo che è proprio quella la realtà, l’emersione costante, semplicemente dispiegata, della tensione. In questa testimonianza si può riassumere la condizione spaventosa di un uomo esposto per troppo tempo agli effetti devastanti della forma, un uomo che per sua propria decisione ha voluto trasformare la malattia da appoggio o protesi, per come di solito si vive, in veicolo di penetrazione, forza proiettiva e quindi forza spogliata ormai da qualsiasi capacità difensiva. Negli ultimi anni, i ricordi delle antiche inquietudini controllate dalla vecchia coscienza, quella stessa che lo aveva portato alla teorizzazione del Teatro della crudeltà, vengono recuperati, mentre la coscienza immediata, erede e realizzatrice fallita di quei tentativi di controllo, se non proprio di accumulazione, viene definitivamente smascherata, smontata pezzo per pezzo, distrutta. Ormai definitivamente nel territorio desolato, in una semplice parola, in un riferimento stranamente formulato, nel citare il nome di un amico, o di Dio, o di Satana, egli sviluppa, con quella semplicità impressionante che è propria della tensione, una delle più estese e coerenti forme di immaginazione diversa che io conosca. Lottando contro tutto, ormai, senza nessuno alleato vicino, senza nemmeno se stesso come alleato, senza il proprio corpo, ormai vinto dal male, divorato dall’interno e dall’esterno, ridotto quasi a non mangiare più, trova la forza per lottare contro l’unico nemico che ancora riesce a individuare, la propria vita. È proprio la vita che vuole vomitare, per ridursi, in un’ultima ma reale immaginazione, a semplice qualità.
[1989]
Solo a salve
L’esercito spagnolo ha quasi il sessanta per cento delle proprie riserve di munizioni inutilizzabile. Come tutti sanno (noi non lo sapevamo), le munizioni hanno una scadenza come i medicinali. Per ammazzare qualcuno bisogna quindi prima leggere sulla scatola delle pallottole la data di utilizzo prevista, in caso contrario si corre il rischio di andare in bianco.
Per quel che riguarda le disgrazie dell’esercito spagnolo il fatto è che lo Stato ha ridotto di 900 miliardi le spese di approvvigionamento delle munizioni. I fucili dei soldati e della Guardia Civil, di questo passo, spareranno a salve.
Per i paesi Nato le riserve minime sono 30 giorni di munizioni per tutte le armi disponibili. La Spagna è quindi fuorilegge.
Un buon posto dove passare le vacanze.
[Pubblicato su “Canenero” n. 30, 9 giugno 1995, p. 7]
Lusinghiere aspirazioni mortali
Alcuni anni fa Auschwitz, la fabbrica della morte, venne trasformata in museo, per attirare ondate di turisti. Questa è ormai la sorte comune ad altre strutture simili in altri campi della produzione, per esempio la Fiat del Lingotto e di Mirafiori o le ex fabbriche tessili nell’Inghilterra del Nord.
Questi colossali monumenti al taylorismo e al profitto non devono essere demoliti ma restare in piedi, perché “non dobbiamo dimenticare”. E cosa c’è di meglio del ridondante suono di mezzo secolo per dare l’occasione per una macabra festa, quella riguardante la riesumazione del cadavere del passato alla presenza dei parenti di tutti gli ex-dipendenti, direttori e beneficiari dell’azienda?
Nell’irrefrenabile logica del profitto emerge un nuovo prodotto: al posto del genocidio oggi viene fornita la visione lapidaria del passato, allo scopo di captare l’immaginazione collettiva, la quale coincide con la ristrutturazione del fascismo tradizionale in una forma nuova più adeguata al totalitarismo postindustriale.
Nel frattempo l’industria del genocidio dilaga con l’impiego di mezzi più adeguati ai tempi. Il virus dell’Aids devasta il continente africano, e seleziona altri strati indesiderabili in Occidente. Antichi sentimenti tribali vengono sollecitati e fomentati contro popoli interi. Mezzi altrettanto feroci, ma più flessibili, vengono impiegati, non più in nome di una super-razza prepotente, ma per garantire gli interessi anonimi dei dominatori di oggi.
Il serpente continua a mangiarsi la coda, indisturbato.
[Pubblicato su “Canenero” n. 14, 10 febbraio 1995, p. 3]
Astensionismo
Siamo sempre stati contrari alle elezioni. Di qualsiasi forma e natura. Politiche, amministrative, zonali, sindacali, scolastiche, ecc.
La partecipazione alle elezioni implica la delega, cioè la cessione di se stessi nelle mani di altri. I più si fanno affascinare da programmi ideologici e da parole facili. Gli anarchici non sono mai caduti nell’equivoco.
Chi partecipa al potere è potere esso stesso. Non esiste – del potere – una gestione ottimale. Ne esiste una migliore e una peggiore, ma dal profondo della dittatura alla superficie (apparentemente) dorata della democrazia permissiva, per gli sfruttati, si tratta sempre di ubbidire, fare sacrifici, accettare la divisione di classe, sperare che i dominatori concedano qualcosa.
In qualsiasi prospettiva politica, sotto qualsiasi colore o programma, gli sfruttati sono costretti a piegare il capo, a dire di sì.
Per capovolgere questo stato di cose bisogna cambiare prospettiva. Non si tratta di un’alternativa diversa, ma di una diversa prospettiva. Non occorrono programmi, uomini o partiti diversi, occorre che la gente, gli sfruttati, i lavoratori, i disoccupati, le donne, gli studenti – insomma tutta la grande maggioranza del popolo, – possa prendere in mano le decisioni che riguardano il proprio futuro. Occorre, in una parola, che si neghi la delega e che si applichi l’azione diretta. Certo, queste sono belle parole, che, peraltro, gli anarchici ripetono puntualmente a ogni scadenza elettorale. Non votare non basta. Appunto. Il tradizionale astensionismo, anche quello anarchico, assoluto e costante, non è sufficiente. È uno strumento platonico che solo in determinati momenti storici, quando ci si trova davanti a contraddizioni fortissime del capitale e dello Stato, può significare momento di raccolta delle forze antagoniste. In caso contrario, quando la situazione è più o meno stabile e il potere procede a periodici aggiustamenti politici e amministrativi, l’astensione dal voto produce solo un dissenso ideale.
Occorrerebbe fare un passo avanti. Ne abbiamo parlato più volte, ma si tratta di un discorso che ci accorgiamo sembra decisamente difficile. I compagni sono spesso portati a considerare il problema astensionista come staccato da un processo continuo di recupero del consenso che, in un regime democratico, è regola di ogni giorno. Si pensa a “campagne” d’opinione, al solito manifesto, ai soliti volantini che nascono e muoiono in occasione della scadenza del potere.
A me pare che si possano riassumere alcuni punti di approfondimento per sviluppare un’impostazione astensionista più coerente e, soprattutto, più fattiva. 1) Diversi livelli consultivi: politico, amministrativo, sindacale, scolastico, zonale, sanitario, ecc. 2) Continuità dell’impegno astensionista nel tempo, a prescindere da scadenze nazionali. 3) Concetto di intervento sostitutivo. Cioè un intervento di massa che proponga soluzioni alternative su base locale facendo pressione dall’esterno, sulle singole realtà consultive. 4) Costituzione di strutture astensioniste zonali basate sull’autonomia della lotta, sull’autogestione e sul principio della conflittualità permanente. 5) Caratteristiche di queste strutture (di massa). 6) Rapporti tra strutture astensioniste zonali e movimento anarchico specifico. 7) Elaborazione dell’informazione sui problemi periferici (comunali, provinciali, di quartiere). 8) Globalizzazione dell’intervento in ogni singola realtà (militarizzazione del territorio, carcere, nucleare, ecologia, servizi essenziali, salute, occupazione, scelte produttive, cultura, ecc.).
Chi legge queste righe è pregato di non attribuirci più possibilità di quelle che abbiamo e meno intelligenza di quella che possediamo. La nostra è una proposta di approfondimento. Ci rendiamo pienamente conto che, per il momento, non è possibile andare più in là, ma ci pare sia utile che si possa, almeno, proporre un passo avanti nei confronti della staticità del tradizionale astensionismo.
[Pubblicato su “Anarchismo” n. 46, aprile 1985, p. 2 col titolo “Elezioni: cambiare per restare identici”]
Astio
Sul fronte della lotta nel sociale, sta finendo per prevalere una concezione di attesa, di smorzatura degli interventi, di ricerca di nuovi strumenti di dissenso: pacifici, dichiarativi, soddisfacenti sotto il profilo del minore danno possibile per chi li impiega e per chi li contrasta.
In un clima generalizzato del genere emergono quindi due comportamenti che mi sembra possano ricondursi alla stessa matrice.
Il primo è sollecitato dall’astio. Per coloro che resistono e per coloro che criticano i comportamenti di disimpegno, quando non di pentimento dichiarato o di delazione. L’astio è una brutta bestia e finisce per far dire e far fare cose che non si dovrebbero mai dire o fare. Finisce – questa bestia cornuta – per spingere i compagni di ieri sulla strada del più bieco utilitarismo personale, sulla strada dei modesti bisogni di ogni giorno, delle private rivendicazioni e quindi sulla via della contrattazione singola col potere. Nello stesso tempo, oltre a respingere ogni concezione collettiva di lotta e ogni considerazione riguardo le prospettive del movimento rivoluzionario, porta al proprio annientamento come persona che ha una coscienza rivoluzionaria, una coscienza umana nel pieno significato del termine. Il compagno di ieri, accumulando questo risentimento vive una nuova esperienza deformata del suo proprio essere in carcere o altrove, non fa differenza. E, nella deformazione, smarrisce la propria scala di valori, quelle stesse valutazioni che ieri lo avevano spinto all’azione, per accettare proprio la scala di valori del nemico: l’utilitarismo, il menefreghismo nei riguardi degli sfruttati, il pessimismo nei confronti delle possibilità di lotta rivoluzionaria. L’astio arriva solo a una conclusione: la colpa è di chi non ha fatto quello che doveva fare, non di chi invece si è sacrificato. Se ne deduce che chi accumula un simile risentimento deve necessariamente aver vissuto la propria esperienza come “sacrificio” o come qualcosa che aspettava una “ricompensa”. Non essendo arrivata questa risposta dall’esterno scatta il meccanismo del risentimento. Contro i compagni perché non hanno voluto, o saputo, sacrificarsi anche loro; contro i proletari che non hanno capito la bellezza di simili comportamenti; contro il movimento rivoluzionario nel suo insieme che non ha saputo concretizzare in conquiste precise le sue possibilità; contro chi sviluppa una critica delle scelte di smantellamento e di rifiuto della lotta, proprio perché si limita a una simile critica e non ha creduto opportuno sacrificarsi anche lui.
Ancora una volta sarebbe stata molto più semplice una decisione pacata e chiara di rinuncia alla lotta, senza stare a ricercare di chi è la colpa e senza dare inizio al meccanismo del risentimento che, come tutti sanno, ha un solo sbocco possibile: l’isolamento e la scelta utililarista del cercare di salvare il salvabile della propria vita, cosa che in termini più semplici si traduce sempre in una raccolta di pochi cocci.
A fare da contrappunto a questo atteggiamento sta quello di coloro che riconoscono ormai definitivamente impossibile la lotta rivoluzionaria e si schierano contro chi intende riproporre metodi e strategie che si rifanno allo scontro di classe.
Per questi compagni il problema è molto semplice. Le classi sono diventate una commistione nebulosa di improbabilità. I metodi del passato, in primo luogo l’insurrezione, sono ormai roba da soffitta. Il nemico ha tutte le carte del controllo in mano quindi è inutile tentare di attaccarlo. E poi, cosa vale attaccare qui o là per essere subito repressi e sconfitti sul piano generale?
Da qui si parte per la ricerca di improbabili metodi diversi, creativi, di disturbo ma non di attacco. Metodi che rifiutano la violenza rivoluzionaria e si basano, grosso modo e vista l’estrema superficialità con cui ci sono stati finora descritti, su tecniche che possiamo definire simboliche, pacifiste o di semplice disturbo. Tutto ciò in attesa che – come un seme sotto la neve – sorga infine la coscienza del rifiuto del potere nel maggior numero possibile di persone. Così, semplicemente, come una nuova forma di vita su questo pianeta.
Tra l’astio che non trova conforto e l’amarezza stilizzata di coloro che si confortano da soli rappacificandosi col nemico, non possiamo non vedere una matrice comune: quella della disillusione.
[Pubblicato su “Anarchismo” n. 50-51, marzo 1986, pp. 3-4 col titolo “Aria di disamoramento”]
John Vincent Atanasoff
Quasi senza accorgersene.
È morto a New York John Vincent Atanasoff, scienziato americano di origine bulgara. Professore di fisica per quasi trent’anni in una piccola università dello Iowa, nel 1937, insieme a un suo allievo mette a punto il primo calcolatore elettronico in grado di utilizzare il linguaggio digitale. Alla macchina dà il nome di Abc. Per la prima volta questa macchina utilizza un circuito logico elettronico basato su cifre binarie, ha un banco di memoria separato dal circuito di calcolo e ha un sistema di ingresso e di uscita dei dati. Insomma tutto quello che hanno oggi i computer più sofisticati. Ma Atanasoff non brevetta la sua scoperta perché viene reclutato insieme a migliaia di altri scienziati per lavorare nei laboratori dell’esercito degli Stati Uniti. Solo a metà degli anni Settanta viene riconosciuta la sua paternità nel corso di un processo per i diritti di sfruttamento dell’invenzione tra la Sperry Rand e la Honeywell. Pochi giorni prima muore un altro scienziato responsabile dell’attuale catastrofe telematica: John Presper Eckert.
Con rancore.
[Pubblicato su “Canenero” n. 32, 23 giugno 1995, p. 11]
Banconota fresca di stampa
Escono le nuove 100 mila lire. La stampa ne illustra le caratteristiche anti-falsari, la tecnologia impiegata nella stampa e perfino la bellezza delle sfumature di colore cangiante, ma nessun cenno viene fatto al problema dell’inflazione, come se la nuova emissione non ne fosse una sua causa.
L’attuale circolazione cartacea italiana si calcola a circa 110 mila miliardi di lire. L’inserimento della nuova moneta dovrebbe essere all’incirca, progressivamente in un anno, di circa ulteriori 8 mila miliardi di lire, che considerando l’eventualità sempre più prossima dell’emissione della banconota di 500 mila lire, potrebbero arrivare facilmente a 28 mila miliardi di lire. La quantità media di cartaccia monetaria in circolazione avrebbe quindi un incremento di circa il 20 per cento.
Ragionando alla vecchia maniera dei monetaristi quantitativi, che reazionari erano e tali restavano, ma in fondo confrontandoli con la gentaglia di oggi che occupa a sbafo le cattedre universitarie, erano brave persone, questo 20 per cento si traduce in un proporzionale aumento dei prezzi, aumento che finisce per pesare sui redditi più deboli e più esposti.
Oggi si dice che le maggiori emissioni di Bankitalia producono uno stimolo della produzione e quindi fanno migliore l’economia, alzano gli investimenti, ampliano i posti di lavoro, quindi i salari disponibili alla spesa, rilanciano la domanda, e così gli investimenti risentono di un ulteriore stimolo alla crescita, e tutto va nel migliore dei mondi, per la migliore gloria di chi ci governa. Che sia questa la trovata di Berlusconi per darci i posti di lavoro promessi?
Purtroppo le cose non sono così. Come affermava un economista liberale, se si porta l’acqua al cavallo, quest’ultimo se non ha sete non beve. Quindi, fornire un’economia rissosa e stantia di maggiori strumenti monetari non è certo che produca un aumento della produzione, e se questo non avviene, l’unica cosa che si può verificare è proprio quell’aumento dei prezzi, secco e feroce, che i vecchi monetaristi quantitativi tenevano sempre presente.
Il fatto è che i padroni del vapore più dell’inflazione temono la deflazione, cioè un ristagno dei prezzi, con conseguente rallentamento della produzione, minori posti di lavoro e tutto il resto. Questa eventualità, alimentata anche da una ridotta disponibilità di moneta, potrebbe far scatenare quei perturbamenti sociali che costituiscono l’incubo costante di chi ci governa.
[Pubblicato su “Canenero” n. 8, 16 dicembre 1994, p. 2]
Baffuti e con la gonna
In nome della più ampia libertà di cultura e di religione, il consiglio comunale di Bradford in Inghilterra ha deciso di permettere nel posto di lavoro agli uomini di indossare (se lo desiderano) la gonna, alle donne i pantaloni, agli indiani il turbante e alle arabe il chador. Purché lavorino, è stato detto. Penso che il motivo sia diverso: purché non trovino alimento per una ribellione di altro genere che una volta innescata potrebbe portarsi dietro anche quella riguardante le condizioni di lavoro.
[Pubblicato su “Canenero” n. 13, 3 febbraio 1995, p. 7]
Arturo Benedetti Michelangeli
La stupidità della perfezione.
A Orzinuovi, nei pressi di Brescia, muore a causa di un attacco di cuore Arturo Benedetti Michelangeli. Un grande tecnico della tastiera. Il discorso potrei finirlo qui, ma c’è sempre qualcosa d’altro nell’ottusità di un tecnico, nella maniacale ricerca della perfezione. C’è il grido di paura dell’uomo che guarda all’idea e sa di non poterla raggiungere. Di fronte alle costruzioni solo apparentemente facili di Debussy o di Mozart cosa ci si può attendere dalle corde di un pianoforte? Possono veramente le emozioni trasmutarsi in qualità timbriche dello strumento? Certo, leggendo il testo di Debussy ci si accorge che sta dicendoci qualcosa dietro quegli apparenti arzigogoli da improvvisatore, e questo qualcosa è la struttura solidissima di fondo? oppure è la perdita continua del fraseggio, la rottura della dinamica esecutiva? insomma una sensazione di paura, della paura che l’autore aveva della vita, che la perfezione esecutiva tende soltanto a nascondere? Non parliamo di Mozart dove tutto il discorso si trasferisce a livelli massimi. Michelangeli suona il pianoforte per decenni, e per tutto questo tempo ci tempesta con bizze da divo, maneggi da nuovo ricco, disavventure da tirannello. Faccenda normale per musicisti e cantanti, qualcuno potrebbe rispondere. Sorge il dubbio però che quella maniacale ricerca della madreperla timbrica non sia stata altro che una sua grande illusione, e con lui anche quella di tutta un’epoca.
La musica la stiamo ancora cercando.
[Pubblicato su “Canenero” n. 31, 16 giugno 1995, p. 11]
Benefattore
Muccioli di San Patrignano [oggi fortunatamente defunto] era di certo un cattivo soggetto. Molti suoi denigratori lo tratteggiavano come un padre padrone, un assetato di sangue e di punizioni, allo scopo benefico di redimere povere larve umane in preda agli isterismi dell’astinenza. Ed era anche un predicatore della redenzione attraverso il sacrificio, il duro lavoro, fino ad ammettere, se del caso, la segregazione e la violenza sui recalcitranti.
Poi gli elogiatori. Questi mettono in conto una larvata tendenza per le vie di fatto, ma sempre a fin di bene. Il soggetto era tutt’altro che cattivo, un pezzo di pane, ma sostenitore della linea dura, perché con la fase preliminare dell’astinenza non c’è altro da fare.
Nel panorama della permissività che sembra dilagante, e nell’ambito della più che radicata intenzione di non guardare in faccia il problema della droga e dell’individuo che decide di farne uso, Muccioli aveva una sua posizione che sembrava raggiungere risultati positivi, a qualunque costo. Ed è certo in nome di questa sua coerenza operativa che, nella sua baracca, un morto in più o in meno non poteva preoccuparlo più di tanto. Guai a chi confida negli inflessibili condottieri dell’integralismo di qualsiasi genere, prima o poi finisce per trovarsi a giustificare tutto, anche l’assurda uccisione a bastonate di un povero disgraziato a opera di altri disgraziati.
E cosa avrebbe dovuto fare allora il padre padrone? Chiamare la polizia e denunciare il fatto? Non spetta a noi indicare il comportamento migliore da tenere in questi casi, non essendo con il codice alla mano che si risolvono i problemi, servendo, la denuncia, solo a dare una risciacquata alla propria coscienza.
È invece sul metodo che va puntata l’attenzione. Un metodo di segregazione e di violenza non può che produrre violenza, e fosse quest’ultima stata indirizzata contro gli esecutori materiali del metodo poteva ancora essere letta come ribellione, e quindi capìta e perfino positivamente valutata, come processo di liberazione in corso. Invece, i poveri e i miseri, privati di tutto, finanche della propria dignità, in condizione di violento asservimento, finiscono sempre per azzannarsi fra di loro. Ed è questa l’assurda conclusione cui si è costretti ad arrivare.
Strutture del genere, sia quelle repressive che quelle permissive, servono solo a imbrigliare un processo di liberazione che potrebbe mettersi in atto anche dal profondo degrado dell’assunzione di sostanze stupefacenti intesa come via di fuga di fronte ai problemi che la vita ci mette davanti quotidianamente. Ma per liberarsi realmente occorre ritrovare la propria coscienza di uomini, la dignità perduta, che nessun sistema più o meno segregativo può dare.
Altre le coordinate del problema della droga nella società attuale, altre le possibili proposte, e nessuna di queste passa attraverso le comunità.
[Pubblicato su “Canenero” n. 2, 4 novembre 1994, p. 4 col titolo “La sferza di San Patrignano”]
Ignacio Matte Blanco
Sistematore occulto.
Ignacio Matte Blanco psicoanalista e matematico cileno è morto a Roma. Cattolico e freudiano aveva cercato per tutta la vita di coprire, ricorrendo al manto caritatevole della logica matematica e della topologia, i guai dell’analisi psicoanalitica. Per chi voglia fare del pensiero filosofico, inevitabilmente alla base di ogni pratica psicoanalitica, un punto di appoggio per meglio organizzare il proprio mestiere di “curatore d’anime” a pagamento, non c’è niente di meglio che provvedere alla soluzione di tutte le contraddizioni. Questa strada Matte Blanco l’ha seguita in due modi: primo, nascondendo sotto l’apparente oggettività dell’analisi matematica le antinomie psicologiche, e poi, in una seconda fase, ritirando fuori queste antinomie per spiegarle nella loro supposta separabilità. Da un lato la matematica gli è servita per attutire i pericoli del conflitto razionale/irrazionale, dall’altro questo conflitto gli è servito per non accettare le conclusioni della matematica, troppo presuntose per servire a qualcosa nella pratica psicoanalitica. Farsi pagare per curare, quindi curare per farsi pagare. Tutto qui.
[Pubblicato su “Canenero” n. 11, 20 gennaio 1995, p. 11]
Bombe a parte
Sarajevo è città sotto le bombe. Se non sono le cannonate dei carri armati serbi, collocati nelle grotte delle colline che sovrastano i quartieri residenziali, sono le fucilate dei cecchini. Non si tratta di vita “normale”, simile a quella di tante altre città al mondo.
La guerra trasforma una città e condiziona la quotidiana lotta dei suoi abitanti per sopravvivere. A Sarajevo non è possibile trovare mezzi pubblici per spostarsi da un posto a un altro se non ricorrendo a una specie di elefante blindato, lentissimo e anacronistico. La gente fa prima correndo china in avanti a destra e a manca, secondo i propri affari e le proprie necessità.
Sacrifici e miseria dappertutto. Macerie e distruzione.
In questo quadro che tutti consideriamo, e con ragione, apocalittico, la multinazionale Benetton sta aprendo un negozio per i propri prodotti. Non sono stati risparmiati marmi di pregio e rifiniture. I vetri sono blindati e una considerevole scorta è stata messa da parte per il futuro, quando quelli di già montati cadranno sotto il fuoco dei cecchini.
Il primo ministro bosniaco ha partecipato alla inaugurazione dicendo che il negozio Benetton è il segno, credo abbia detto più modestamente uno dei segni, della rinascita futura della città.
Di certo Benetton non è una ditta che fa investimenti per scopi umanitari, quindi, a parte le idiozie politiche dei responsabili bosniaci, vuol dire che quel negozio, aperto proprio nell’ultimo posto al mondo dove lo si poteva immaginare, ha la possibilità di fornire un reddito, oltre a garantire un’immagine alla casa madre: immagine che potrebbe essere convenientemente sfruttata dal suo fotografo di fiducia.
Il capitale non finirà mai di sorprendere.
[Pubblicato su “Canenero” n. 31, 16 giugno 1995, p. 8]
La botte piena e la moglie ubriaca
Si può avere tutto nella vita? No. Certamente no. E per questo bisogna accontentarsi di lesinare le proprie speranze? Nemmeno questo. Non resta allora che andare alla ricerca di una “via di mezzo”, l’antica ricetta buona per tutti i palati? Ebbene, neanche questo ci soddisfa. In caso contrario non saremmo rivoluzionari.
Alziamo gli occhi al cielo e pensiamo di avere la verità in tasca, semplice come le nuvole che ci sovrastano. Basta non curarsi di niente e lasciar fare al nemico. Prima o poi ci fornisce l’occasione giusta per mettere in risalto le nostre capacità. Come diceva una mente fina che mi ha accompagnato per un certo periodo di tempo in una delle tante peregrinazioni nelle galere, è sufficiente fare il contrario, proprio l’esatto contrario, di quello che pretendono imporci con una decisione non nostra. A esempio, se il potere (lascio libera la fantasia dei miei pochissimi lettori di personificare quest’ultimo come meglio credono) dice di non buttarmi dalla finestra, per essere libero basta soltanto che io scavalchi il davanzale e mi butti nel vuoto.
Ricetta balzana quanto si vuole ma da tanti riverita e considerata come la fonte di una verità profondamente rivoluzionaria. Ecco, per me si tratta di una idiozia. Non perché l’essere bastian contrario non sia, qualche volta, utile e perfino di difficile attuazione, ma solo perché non si può essere sostenitori della negazione in ogni caso e sempre, occorre avere un progetto, accettarne perfino i limiti e programmarne le possibilità di attuazione.
Vedo già molti anarchici drizzare le orecchie. Limiti, progetti, attuazioni, programmi, roba del demonio. Meglio alzare il naso per aria e lasciarsi guidare dall’ispirazione, tanto il sangue che ci circola nelle vene – intendo nelle vene degli anarchici non di qualsiasi individuo – sa dov’è il nemico e avverte un prurito irrefrenabile nelle palme delle mani desiderose di colpire, e poi colpire ancora, e via di questo passo.
Ribelli prima di tutto.
[2012]
Bruno Bozzoli
Un piccolo uomo utile.
Bruno Bozzoli, uno dei maggiori creatori di definizioni per risolvere parole crociate “a schema libero”, è morto a Milano. Tutta la vita ha lavorato alla “Settimana Enigmistica”, giornale che meglio della Caritas o dei telefoni verdi o gialli, ha aiutato la gente a superare momenti di sconforto e ha riempito i vuoti della loro vita. Fra i migliori nel suo campo, teneva per giornate intere avvinti i lettori con la difficoltà delle sue “definizioni”, sollecitando all’impegno in un gioco culturale che nulla ha mai avuto di realmente impegnativo. In un certo senso, e forse senza volerlo, gente come Bozzoli ha anticipato la stupidità e la vuotezza della cultura che si profila all’orizzonte, racchiudendo l’imbroglio dell’universalismo enciclopedico in una sorta di algoritmo verbale che stuzzica senza arricchire, avvince senza persuadere. Come tutti gli idioti saccenti ha fatto scuola fra saccenti e idioti.
Tutto qui.
[Pubblicato su “Canenero” n. 15, 17 febbraio 1995, p. 11]
Calcio
Lasciate per poco spazio che un appassionato di calcio ed ex frequentatore di stadi, oltre che giocatore di modeste proporzioni a tempo perso, dica la sua su di un fenomeno sociale che sta assumendo sempre più le connotazioni di una struttura di sfogo della pressione di classe e di reperimento del consenso.
Dal Milan in giù non c’è quasi da poter trovare un onesto ragazzotto dedito esclusivamente al passatempo di prendere a calci un pallone. Anche l’estrema periferia del calcio, nei campi medesimi dove ho giocato io stesso, a rischio di beccarmi una sassata in testa o un cazzotto sui denti, ragazzini smunti e marcantoni ipernutriti corrono spinti dai sogni di gloria sul modello Maradona.
Il vertice è costituito da uomini di affari in calzoncini corti e scarpette bullonate. Sono: finanzieri, politicanti, affaristi, divi, imbroglioni e mestatori che servono la patria con una remunerazione più alta di quella di altri soggetti della stessa risma.
Poliziotti di nuovo tipo, danno vita a un giocattolo che nelle mani della pubblicità e dell’informazione è diventato un gigantesco affare. Un affare per chi vi investe denaro (Berlusconi, Moratti, ecc.), un affare per lo Stato (che vi investe anch’esso), aspettando, quest’ultimo, dal giocattolo in questione, un recupero puntuale (settimanale o quasi) della carica rabbiosa e distruttiva che gli sfruttati accumulano dentro di loro.
Mi si potrebbe rispondere che anche i padroni vanno allo stadio e si arrabbiano pure; ma non per loro è stato pompato questo gigantesco meccanismo. Il destinatario è proprio lui, lo sfruttato, l’infimo della scala sociale, il giovane senza speranze né prospettive, l’escluso da tutto. È la rabbia di quest’ultimo che viene fatta rifluire in una pantomima che è luogo comune, violenza politica, repressione indiretta, castigo.
E questi bellimbusti ultrapagati sono le piccole ruotine delicate del meccanismo. Si atteggiano a divi ma sono soltanto strumenti prezzolati del potere, numeri di un gioco ben più meschino e stupido del calcio che, se visto liberamente, è una bella combinazione di intelligenza e forza.
E del calcio è rimasto, difatti, ben poco in quella scienza ultramoderna in cui si è trasformato grazie a medici, tecnici e allenatori usciti tutti insieme dalle grandi scuole dove si insegna l’arte del dominio.
Dal Milan in giù, tutti servitori dei padroni, poliziotti meglio pagati, controllori in magliette colorate, uccisori a un tanto a partita di uno dei più bei giochi che siano mai stati pensati.
[Pubblicato su “Provocazione” n. 14, giugno 1988, p. 9 col titolo “Dal Milan in giù”]
Cab Calloway
Una valvola di sfogo.
Cab Calloway, uno degli ultimi re del jazz, è morto a causa di un ictus cerebrale. Dalla Grande Depressione fino a oggi aveva sempre messo la sua arte al servizio del recupero di ogni forma di ribellione, convincendo i neri che stavano affogando nella miseria, che con la musica potevano essere felici, spingendoli poi verso il grande massacro della seconda guerra mondiale, e infine, da uomo ricco e rispettato, ma nero, spiegando che chiunque, a prescindere dal colore della pelle, poteva diventare ricco e rispettato. Per uno come lui, e come tantissimi altri grandi musicisti jazz, i ritmi del dolore e della paura potevano solo servire a intrattenere e a divertire. I rapper di oggi sanno adesso chi era il loro padre spirituale, e noi sappiamo un po’ meglio quali sono gli scopi dei rapper.
Tutto qui.
[Pubblicato su “Canenero” n. 5, 25 novembre 1994, p. 11]
Caporali
A Oria un reclutatore di manodopera in “nero” è stato condannato come responsabile della morte di tre lavoratori avvenuta nel corso di un incidente stradale. Nella stessa zona, un anno fa, diciotto donne caricate su di un piccolo autobus per essere portate sul posto di lavoro erano morte in uno scontro con una gru. Il conducente della gru è stato condannato. I tre morti di prima e i diciotto di dopo guadagnavano circa 23.000 lire al giorno.
[Pubblicato su “Canenero” n. 13, 3 febbraio 1995, p. 7]
Carabiniere
Ma sempre carabiniere è! Tomba scende giù con grande forza e agilità. I suoi muscoli sembrano funzionare alla perfezione, compenetrandosi fino allo spasimo con percorsi innevati che spesso sono disegnati nella maniera più incredibile. Eppure quest’uomo, appesantito dalla vita non proprio regolata e imbambolato dalla pubblicità che fa ruotare attorno a lui miliardi e miliardi, continua a scendere e a vincere.
Corto di cervello, il giovane carabiniere si trova a suo agio nell’euforia delle gare, talmente ottuso da risultare inattaccabile a qualsiasi fiera delle vanità. Per questo scende giù come un ciclone, e vince.
Poi torna alla sua vita di merda, alla vita di un carabiniere che guadagna miliardi all’anno, che può permettersi raid ad alta velocità su macchine di lusso nel traffico cittadino, che gira sempre attorniato da un clan di belle ragazze, anche più sceme di lui, e da ebeti muscolosi, se possibile anche più stupidi.
E ha tutte le carte in regola per impersonare il simbolo della giovane Italia perbenista e vincitrice, che affronta le avversità causate da chi non vuole lavorare e le mene di chi non vuole contribuire ai grandi destini della nazione. Un popolo di frustrati lo guarda come la concretizzazione vivente di tutti i suoi sogni e non si accorge di avere di fronte un imbecille appena appena carezzato dalla fortuna, un giovane carabiniere che ha messo da parte la divisa per attaccarsi gli sci ai piedi e guadagnare così un sacco di soldi senza neanche sapere come. Insomma, uno zombi grande e grosso come un culatello bolognese.
[Pubblicato su “Canenero” n. 10, 13 gennaio 1995, p. 7]
Carogna
Che De Lorenzo, ex ministro della Sanità, insieme al suo degno compare Poggiolini e alla degna signora consorte di quest’ultimo, siano fra le carogne più indegne di tutta la costellazione di sacripanti della politica italiana d’ogni tempo, è fuori discussione. Che sia spontaneo in molti di noi un desiderio di rivincita, che ci faccia intimamente gioire nel vedere questa gentaglia esposta alla gogna e alla sofferenza, è comprensibile. Eppure c’è qualcosa che non funziona.
Non funziona nel sentimento spontaneo di risentimento e di rivalsa, anche in casi limite come questo, casi in cui veramente il soggetto sembra l’ultimo degli individui, il più miserabile e indegno di pietà. Ma qui non si tratta di pietà. Non è che ci faccia pietà De Lorenzo che digiuna [1994] in carcere, che si lamenta delle sue piccole ambasce, obbligato com’è a guardare cupamente l’aria del passeggio in uno dei carceri peggiori che ci siano. Il problema deve essere posto diversamente, e non è problema da poco.
Il moto dell’anima funziona così: De Lorenzo rubava, proprio in un settore fra i più delicati, quindi direttamente sulla pelle dei più bisognosi e miserabili degli oppressi. Ecco, la grande mano della giustizia è arrivata, riparando alle sue malefatte, gettandolo in fondo a una galera. Come si fa a non gioire di tutto questo? Sembra un romanzaccio alla Dickens. I guai di De Lorenzo ci fanno gioire, ed è per questo che molti di noi li hanno desiderati, e una volta arrivati li hanno accolti con soddisfazione. Ma è proprio questa soddisfazione intima che ci degrada moralmente, e che in quanto tale, come irrefrenabile moto dell’anima, ci abbassa fino ad avvicinarci pericolosamente alla canea di miserabili che si gettano con l’accetta in mano su ogni albero caduto.
Qual è la giustizia che si è sostituita al nostro, questo sì!, sacrosanto sdegno? La giustizia dei dominatori, quella della nuova eletta di potere che, nella fretta di subentrare alla precedente, si è soltanto limitata a spazzare via il putridume più fetido, ben guardandosi dal toccare i centri che producono la putrescenza stessa. Come possiamo allora gioire di ciò, senza sentirci noi stessi umiliati dal quel sentimento, che come moto dell’anima quasi quasi non possiamo non provare? Non è affatto vero che godendo delle sfortune attuali di De Lorenzo lo si faccia perché desideriamo il bene al posto del male, cioè operiamo una scelta etica.
La soddisfazione che proviamo è difatti una gioia ipocrita, o almeno lo resta fin quando non la sottoponiamo a una riflessione critica. Per noi quella vicenda è un evento estraneo alla nostra decisione, un segno del cielo, una sorta di castigo di Dio. Le vie imperscrutabili attraverso le quali si è arrivati all’attuale distretta del potentissimo visir della Sanità, ci sono sconosciute, non siamo noi ad avere operato al loro interno. A rettamente pensare, proprio a causa della nostra incapacità, dovremmo desiderare che le presenti condizioni di De Lorenzo migliorino, che venga posto in libertà, che abbia riconoscimenti e allori, se non altro come corrotto da primato.
Ma perché dovremmo pensare ciò? Per il semplice fatto che non siamo stati a noi a causare le disgrazie del personaggio. Non siamo stati noi a presentarci, una volta per tutti di fronte a lui, nel modo in cui gli anarchici sanno e possono fare, modo moralmente ineccepibile, ma abbiamo lasciato che altri lo facessero al nostro posto e a modo loro, con carceri, incriminazioni, processi, condanne e tutto il resto.
Per il momento, la nostra gioia nel vedere una carogna del genere chiusa a Poggioreale, per il momento è soltanto cattiva gioia.
[Pubblicato su “Canenero” n. 8, 16 dicembre 1994, p. 5 col titolo “Una carogna a Poggioreale”].
Il giudizio di Cerbero
Due studenti, un ragazzo e una ragazza, si baciano a scuola. Neanche furtivamente, che non è il caso. Il bacio di due ragazzi è non solo l’apostrofo che tutti ricordano, ma anche un segno d’amicizia, e quand’anche avesse tutti i contenuti della passione travolgente, perché mai nasconderlo?
Un professore dell’Istituto commerciale “Francesco Crispi” di Palermo scopre i colpevoli e li conduce davanti a Cerbero. Qui l’immonda bestia mette in moto la coda e avvinghia i colpevoli. La sentenza è un po’ strana. Vediamola.
I due sono condannati a imparare a memoria alcuni versi della Divina Commedia di un certo Dante Alighieri. Che strana condanna. Forse la coda del cane si è anchilosata, rimanendo ferma alle antiche abitudini di quando ci faceva copiare in bella sui quaderni dalla copertina nera, qualcosa come cinquecento volte la terza declinazione latina per avere sbadigliato in classe? No, il cane sembra sveglio. Il Preside che lo incarna è uomo di lettere e vuole che i ragazzi imparino a memoria alcuni fra i più bei versi di tutta la letteratura italiana. Ma sempre cane è, e qualsiasi cosa tocchi la sua lunga coda puzzolente, l’inquina e la storpia, perfino la bellissima e orgogliosa dichiarazione d’amore di Francesca, perfino il sacrificio di Piccarda Donati.
In più il cane è anche stupido. La sua natura di poliziotto, giudice e letterato (riuniti in un’unica specie come la santissima Trinità) gli fa velo al comprendere un fatto limpidissimo per chiunque. Non si può condannare nessuno a subire qualcosa, neanche la bellezza.
[Pubblicato su “Canenero” n. 23, 14 aprile 1995, p. 3]
Certezze
Un uomo ha bisogno di credere. Senza una fede non riesce a vivere. Non occorre che questa sia una fede ultraterrena, cioè proiettata troppo in avanti, può anche essere una fede legata alle sue aspettative di vita media, una fede terrena.
Il rapporto tra fede e certezza è strano ma spiegabile. Non ci sono elementi di prova che possono garantire la certezza. Ci sono cose più o meno probabili, accadimenti e azioni che presupponiamo si possano verificare in un modo o nell’altro. Ma dobbiamo evitare di approfondirli troppo, in caso contrario diventano inattendibili, non prevedibili. E poiché la nostra vita è un’aspettativa piuttosto grossolana, ci adattiamo a queste incertezze e le sostituiamo con un’attesa fideistica che le trasforma in certezze.
Certo, non possiamo fare questo direttamente. La nostra coscienza etica si rifiuta di accettare un compromesso del genere. Non possiamo cioè dirci, a tu per tu, facciamo come se fosse vero e finiamo per crederci. Siamo troppo rigidi per una cosa così superficiale, noi abbiamo bisogno di pensieri virtuosi e corretti. Una fede, per essere tale, deve fondarsi su dati concreti. Se questi mancano, o sono approssimativi, non occorre preoccuparsi, possiamo sostituirli con un ottimo surrogato della realtà, l’ideale.
Più questa sostituzione è assurda e forzata, più regge e viene mantenuta a lungo. Più diventa grande e articolata, più da semplice ideale, proiettato sullo sfondo come un miraggio, si trasforma in ideologia, un corpo organico che si auto-mantiene e giustifica, fornendo alibi e sostegno a chi ha la prudenza di non fare troppe domande.
Questo bisogno di credere attraversa tutta la storia dell’uomo, sia quella dei suoi fatti come quella dei suoi pensieri, ammettendo possibile una simile distinzione. Al momento del passaggio dei poteri dall’oscurantismo religioso dominante alle prime conquiste del pensiero cosiddetto laico, ci si illuse che si potesse fare a meno di credere. Ogni male della società venne allora rinviato alle colpe della fede in Dio, ma non si tenne sufficientemente conto dell’ammonimento di Stirner che faceva vedere come Dio possa benissimo trasferirsi armi e bagagli dal cielo alla terra. La fede in Dio divenne fede nella Scienza. Alla pratica della preghiera mattutina, l’uomo laicizzato sostituì quella della lettura del giornale, poi, più avanti, quella dell’ascolto religiosamente passivo della radio e, oggi, della televisione. La fonte di produzione delle certezze si trasferisce ma resta sempre nella mano salda del potere.
Non c’è dubbio che anche gli uomini di potere sono uomini di fede. Non appena si rivela l’infondatezza di una certezza, la sostituiscono con un’altra. L’elaborazione del pensiero dominante è una lunga riflessione sui fondamenti della certezza, quindi sull’ideologia del potere, ora dura, ora morbida, ora iraconda e iattante, ora trascurata e triste. Non importano molto queste varianti, quello che conta è fornire a se stessi e agli altri una base alla fede, un soddisfacimento come che sia a questa primaria necessità.
Se ragioniamo dal punto di vista della povera gente, proprio la classe più diseredata, qui la fede assume un valore ancora più importante, se non altro per sopportare il peso della miseria. Ma anche per la classe dominante la funzione della fede è importante, in quanto deve pure darsi una spiegazione del suo compito direttivo e repressivo. La miseria spera di stare meglio, ma la ricchezza non può sperare di stare peggio. E non bisogna credere molto al potere per il potere o alla ricchezza per la ricchezza. Occorre un fine ultimo, ideale, anche per i dominatori. La cosa più strana è che questa fede deve per forza essere più forte nelle classi oppresse, perché è qui che bisogna per forza credere in un cambiamento, vista la situazione di miseria in cui ci si trova. Nelle classi più elevate, e quindi anche più colte, dopo tutto, anche se il cambiamento non ci sarà la situazione presente è sufficientemente accettabile. Per questo motivo, le riflessioni più impietose nei riguardi della fede (e, quindi, anche della possibile certezza di qualcosa o in qualcosa) sono avvenute nei laboratori della classe dominante.
Mentre restava, e per taluni aspetti resta, incrollabile la fede del buon senso comune nell’uomo della strada, un serpente velenoso si è insinuato fra le certezze della classe dominante. Che la scienza meritasse fiducia, fin quando si restò nell’ambito macroscopico delle analisi, era un dogma fuori discussione. E questo durò, diciamo, fino agli albori del presente secolo che sta per chiudersi [1989]. Ma del vecchio Dio che cosa se ne faceva? A parte l’uso meramente strumentale dei professionisti della religione, il vecchio armamentario fideistico passò di sana pianta al servizio di bisogni terreni. Il Dio della certezza intima e quello della certezza oggettiva, si separarono e diedero un contributo notevole alla costruzione di due fedi che, stranamente, presero ambedue il nome di scienza. L’antico razionalismo aristotelico e tomistico passò in pianta stabile nelle premesse non dimostrate della scienza fisica, sopportando eroicamente gli strali pungenti dello scetticismo anglosassone che voleva, in modo lungimirante, costruire subito una società più razionale; mentre l’antico Dio ascoso, quello che è nel soggetto, nel cuore, che ha sue ragioni diverse da quelle analitiche, venne recuperato, a livello di massa, dall’incredibile ed entusiasmante operazione hegeliana. Marx seppe raccogliere questa seconda parte del soggettivismo hegeliano e vi costruì sopra un ragionamento materialista, per un verso, e storicista (quindi idealista), per un altro verso.
Ma il mondo andava per i fatti suoi. Basti pensare alle profonde differenze, di contenuto e a livello di diffusione di massa, che ci sono fra le idee della rivoluzione del 1830 e quelle della rivoluzione del 1848, per capire come il capitale fideistico della religione cambia di padrone e viene messo a ottimo frutto.
Fino al 1871 il lavoro sotterraneo della fede penetra fra le classi subalterne e vi costruisce una nuova speranza, quella della rivoluzione del lavoro, la strada che passa prima attraverso l’organizzazione delle forze produttive, poi attraverso l’espropriazione violenta dei padroni, e infine si conclude nella costruzione della società libera. Questo schema, stranamente immutato fino a oggi, corrisponde come un guanto allo schema triadico hegeliano, come venne rielaborato (sui piedi materiali e non sulla testa ideale) da Marx. Era ed è uno schema fideistico, descrivente l’itinerario dello spirito oggettivo che si libera e trionfa nella Storia.
D’altro canto era sempre meglio della fede nel buon Dio perché trasferiva qui, in questo mondo materiale, quello che il precedente modello prometteva nel mondo dell’aldilà. Anche l’altro aspetto del vecchio pensiero religioso, quello che pretendeva dimostrare l’esistenza di Dio, in cinque prove, prometteva la sua società liberata, in cui il benessere sarebbe stato raggiunto con piccoli aggiustamenti riformisti, dettati dalla ragione e dalla scienza politica e imposti, se del caso, dalla forza repressiva.
E poi c’era la scienza vera e propria, quella che per intenderci si interessa di studiare i fenomeni per come accadono e non le cose per come sono. Questa, ancella e tutrice dello sviluppo industriale, forniva l’unica certezza che poteva fare comodo a quest’ultimo, quella del meccanicismo. Che importa che ai colpi delle insurrezioni nelle strade di Parigi, nel 1830 e nel 1848, corrispondessero le osservazioni “delittuose” in geometria e in matematica? Il buon vecchio Gauss si spaventò talmente delle conseguenze dei suoi studi sulla geometria euclidea e sulle incongruenze a cui arrivava, che tenne gli appunti per più di trent’anni nel cassetto.
Ma le certezze dovevano andare verso il loro destino, non si potevano conservare a lungo nel cassetto. Il proletariato andava verso le sue grandi organizzazioni mentre l’industria scopriva le riserve estreme del colonialismo e si accingeva all’avventura delle guerre globali. Al di sotto, nel chiuso dei laboratori del pensiero dominante, la scienza e la filosofia vivevano le loro stagioni delle foglie morte. Agli inizi del secolo cadevano le certezze in fisica e si scopriva un altro concetto di unità della realtà. Ma la società si illudeva di potere continuare sui vecchi modelli, fin quando la tragedia militarista scosse e confuse le cose. Le organizzazioni dei lavoratori uscirono sconfitte, per non aver saputo resistere sul fronte della negazione, ma la rivoluzione russa ridava fiato a tutto il vecchio armamentario organizzativo, in primo luogo sindacale, proponendo un prolungamento della vecchia fede e un’illusione ideologica che doveva rivelarsi tragica. Nemmeno il facile cambiamento di prospettiva, con altre organizzazioni, sempre di massa, ma volute e imposte dal fascismo dominante, riuscì realmente a mettere in crisi quella certezza. Anzi, proprio la triste esperienza del ventennio fra le due guerre, doveva riportare una nuova speranza e un rinvigorimento della vecchia fede organizzativa, mentre precipitava in malo modo la parentesi rivoluzionaria spagnola.
Diviso il mondo in zone d’influenza, la divaricazione tra la teoria e la pratica diventava più difficile da capire. La crisi della certezza era ormai un fatto fuori discussione nella scienza e nel pensiero dominanti. L’applicazione di queste teorie rendeva più intelligente il potere e consentiva uno sfruttamento più efficace. La versione razionalista, nella forma del pragmatismo americano, svolgeva l’equivalente del ruolo che a Ovest svolgeva il materialismo dialettico. Solo il proletariato continuava a illudersi e a farsi illudere con le sue idee organizzative e con le sue speranze di liberazione definitiva.
In un modo o nell’altro, dovremo fare i conti con tutto ciò, un giorno, fuori dei luoghi comuni e dei tabù imposti dai nostri padri. Anche la storia dell’anarchismo dovrebbe essere studiata in chiave critica e, quel che è più importante, non affidata alle mani degli storici di professione. I compagni dovrebbero mettersi al lavoro personalmente e porsi le domande da soli, proponendo risposte e non accettando soluzioni.
A esempio, non c’è dubbio che nessuno può chiamarsi fuori dal suo tempo. Questo vale per Bakunin, per Kropotkin, per Malatesta e tutti gli altri, come vale per Marx e tutti coloro che continuano l’imbalsamazione. Prendiamo Bakunin. Le sue tesi pratiche sono legate con le sue premesse teoriche e queste ultime non sono sostenibili oggi più di quanto non lo sia il materialismo di Schiff o di Moleschott. Ci fu una volta uno dei massimi storici viventi dell’anarchismo che mi confidò che, secondo lui, bisognava ristampare di nuovo Büchner per contrapporlo ai materialisti dialettici, e me lo disse seriamente. Ora, a parte l’obiettiva ignoranza del personaggio che, non a caso ha fatto carriera all’università, c’è da dire che le limitazioni di Bakunin sono quelle che sono, cioè innegabili, e che la sua validità, cioè la validità delle sue tesi e delle sue azioni, va considerata criticamente, non come una certezza. Tutto si può trarre da Bakunin, tranne una ideologia, se facessimo questo negheremmo la validità del suo contributo e gli faremmo un vero e proprio torto.
Una riflessione uguale si può fare per tutti gli altri anarchici che, in un modo o in un altro, a diversi livelli e con diverse capacità di approfondimento, hanno dato un contributo all’anarchismo, praticamente e teoricamente. Non cambia, a esempio, se parliamo dei cosiddetti anti-organizzatori. La tesi, e le azioni, di un Galleani o, in modo diverso, di un Libertad, non sono valide in assoluto solo perché si adeguano meglio a una concezione critica dell’organizzazione e si sforzano di cogliere i limiti delle forme para-partitiche o sindacali in senso stretto. Anche quelle critiche sono datate e oggi vanno riviste.
[Parte di quanto pubblicato su “Anarchismo” n. 63, luglio 1989, pp. 16-19 col titolo “Malinconie del decisionismo”]
La feroce certezza del proprio dovere
Sicuri e veloci, freddi nella determinazione dei pochi gesti necessari, i facitori di sentenze si accingono a lasciare il palco dell’esecuzione. Il relitto delle loro deduzioni logiche è arrivato in porto, attraccando alla conclusione della tomba: sigillo mortale per alcuni individui chiusi in una gabbia, disposti a guardarli negli occhi, intenzionati a far loro capire quanto grande possa essere la distanza tra la fierezza della vita e l’orrenda bruttura delle alte opere di giustizia.
Ma la forza dell’esecutore è tutta nella propria idiozia, nell’impossibilità di capire cosa sta dietro la sottile paratia di sicurezza dei codici e dei fatti, delle testimonianze e dei verbali. Se solo egli potesse aguzzare la vista, spingersi sulle dita dei piedi e guardare un poco più lontano. Vedrebbe subito quante bramosie di carriera, quante piccolezze da corridoio, quante ignoranze e paure da piccoli, indaffaratissimi mezze-maniche stanno dietro tutto quell’apparato freddamente cosciente di sé. Vedrebbe e si ritrarrebbe inorridito. Vedrebbe infatti l’immagine di se stesso, del proprio fare quotidiano, nelle cose dello specifico giudiziario, ma anche in quelle apparentemente lontane, ma non tanto, di tutti i giorni, cui ognuno attende nella fondatezza della propria dirittura morale: la scuola dove insegna, l’ufficio dove accumula stipendi e delusioni, la fabbrica dove produce pezzi d’un macchinario privo di senso. E vedrebbe anche la miseria della propria morte, come conclusione logica della miseria della propria vita, quella in questa presente e inevitabile, e se ne sentirebbe soffocare.
Molto più facile ritirare la testa fra le spalle, pensare che si è fatto il proprio dovere, che è giusto che “criminali” di quella fatta stiano per tutto il resto dei loro giorni dentro un carcere, visto che non c’è modo, in Italia, di mandarli in una camera a gas.
D’altro canto, cosa si sarebbe potuto fare? Volete mettere qualche piccola contraddizione, apparsa qua e là nel corso del dibattimento d’appello, a paragone delle figure degli accusati: sardi e anarchici, anarchici e sardi. Che gente! Certo, ci sono sardi per bene, tantissimi, ma questi non sembrano tali, quindi non possono esserlo. Tanto vale allora accettare per buone le supposizioni della polizia, e se qualche volta questa ha aiutato la realtà a farsi più convincente, non si è trattato in fondo che di un aiuto alla chiarezza, non certo di un imbroglio. Così si saranno detto i signori giudici, avvolti nella toga e le comparse in abiti civili, così si saranno detto e il loro cuore di coniglio ha tremato un pochino, ma solo un poco, forse nell’incertezza di un attimo. Poi avranno pensato: gli anarchici, che cosa mai vogliono costoro se non l’abolizione del potere, quindi di quello strumento che ci permette di stare seduti sulle sedie che oggi occupiamo? Certo, avranno continuato, ci sono anche anarchici per bene, e tanti, ma questi, andiamo. Siamo coerenti, noi. Che cosa importa se le confessioni dei pentiti sono state estorte, se le dichiarazioni in aula sono state tutte favorevoli agli imputati, se la macchina da scrivere che doveva provare la colpevolezza di uno di essi era stata fabbricata dopo la data della lettera con cui si richiedeva il riscatto. Aspetti marginali, avranno concluso, di fronte alla parlata suadente del presidente della corte, e si saranno rassicurati. E adesso tutti avranno materia per discutere la sera, accanto alla televisione, con gli amici e i parenti che li ascolteranno a bocca aperta, chiedendosi cosa avranno mai provato quando pronunciavano la sentenza che chiudeva per sempre la porta del carcere a esseri umani desiderosi, come tutti, della libertà e della vita.
Poi si addormenteranno soddisfatti di aver compiuto il loro dovere.
[Pubblicato su “Canerero” n. 15, 17 febbraio 1995, pp.6-7]
Che cos’è l’economia?
Che cos’è l’economia? Ponendosi questa domanda i più si aspettano una risposta. In sostanza non è possibile dare questa risposta, eppure è utile porsi lo stesso la domanda.
Prigionieri come siamo al momento della formazione capitalista che ci ospita, tanto vale guardarsi attorno per capire meglio quello che ci imprigiona, anche se per ora non possiamo vedere nemmeno una traccia di quella trasformazione radicale che desideriamo in quanto rivoluzionari e anarchici.
Mettendo da parte la quasi totalità dei problemi tecnici che la scienza economica cerca di approfondire – vedremo in queste paginette che in effetti non li metteremo del tutto da parte – resta pur sempre la condizione di bisogno in cui ci troviamo. Tutti abbiamo bisogno di alcuni beni per la nostra vita. I beni sono oggetti che soddisfano alcuni nostri bisogni. Un paio di scarpe è un bene e qualcuno lo deve produrre. Ragionamento terra terra ma ineccepibile. La disagevolezza del camminare al freddo senza scarpe è un senso di pena profonda che ingenera il bisogno delle scarpe.
Dietro queste affermazioni così ragionevoli si nascondono alcuni aspetti importanti che di regola sfuggono all’attenzione immediata. Non tutti i bisogni che dobbiamo soddisfare sono necessari. La gran parte di essi hanno natura indotta, cioè il meccanismo produttivo non si limita solo a costruire oggetti di consumo ma anche il bisogno di consumare gli oggetti che vuole produrre e dalla cui produzione trae un guadagno. Questa produzione aggiuntiva costituisce oggi la quasi totalità della produzione nel suo complesso, per cui possiamo affermare che produrre l’oggetto stesso è solo una piccola parte dello sforzo produttivo, se la commisuriamo a quanto viene investito nel produrre prima il bisogno da soddisfare con quell’oggetto.
Il bene in se stesso, l’oggetto che indossiamo o che mettiamo sotto i denti, diventa così qualcosa di marginale, qualcosa di così poco importante che alla fine può anche sparire. La produzione di oggetti virtuali rende più agevole e meno costosa la fabbricazione del bisogno relativo che quegli oggetti rende possibili in veste di beni di consumo. L’importanza della virtualizzazione produttiva, solo in questi ultimi anni viene capita meglio, perché solo adesso si colgono i movimenti di interrelazione che si mettono in atto tra meccanismo produttivo del bene virtuale e meccanismo produttivo del bisogno di quello stesso bene. La struttura di queste due produzioni ha caratteristiche sociali che a loro volta sono anch’esse in relazione di reciproco scambio. Il capitalismo moderno investe sempre di più nella costruzione di una società in cui la raffinazione del bisogno si dettaglia in modelli estetici standardizzati ma suddividibili all’infinito, mentre la risposta produttiva a questa domanda variegata (simbolo ma non sostanza di una maggiore libertà) si può facilmente evadere con costi produttivi via via meno impegnativi.
Ma questo indirizzo il capitalismo non sa bene come controllarlo, come non sa controllare fino in fondo qualsiasi cosa a cui mette mano. Questo limite tecnico dovrà essere tenuto presente nella lettura del presente scritto perché ne costituisce uno dei motivi conduttori. La carota del guadagno immediato – le teorie marginaliste non sono mai morte – guida il capitalismo di oggi come quello di cento anni fa. Oggi tutti sappiamo che una potente riduzione del costo del lavoro si ha fabbricando in Thailandia o in Cina i prodotti che prima si fabbricavano poniamo in Europa. Il capitalista persegue questa possibilità di maggiore lucro fino in fondo, cioè fino a quando il valore marginale ottenuto dividendo il costo per la quantità della produzione non tornerà ai livelli di partenza, fino a quando insistere nel produrre in quei paesi significherebbe fabbricare a prezzi uguali a quelli europei.
Molti hanno dedotto da questo ragionamento – in linea con i classici – che qui si nasconde un meccanismo regolativo interno al capitalismo, e che la tendenza produttiva di una economia globale è quella verso l’equilibrio. Vedremo che le cose non stanno così.
Non stanno così per il medesimo motivo per cui non si poteva (e non l’abbiamo mai fatto) accettare l’ipotesi marxista di un procedere verso la contraddizione conclusiva, la grande crisi che avrebbe segnato l’avvento della società comunista. A me pare che non vi sia nulla di deterministico nella realtà e che la società, con tutte le sue cosiddette leggi, quindi anche quelle economiche, si muova attraverso processi in gran parte imprevedibili e inspiegabili, e che tutte le volte che mettiamo mano a previsioni e spiegazioni queste sono sempre fatte sulla base di presupposti assoluti, in altre parole teorie fondate su una credenza o una fede, più che su elementi provvisti di una qualche oggettività.
Il capitale, nervi e sangue del capitalismo, non è una quantità di ricchezza ben determinata, ricchezza che cresce se utilizzata bene o decresce se male impiegata. Il capitale è un flusso, un movimento di reddito. Capire questo concetto è importante per i rivoluzionari. Immaginiamo che uno possieda un milione di euro in banconote o l’equivalente in un bene rifugio come l’oro. Se seppellisce in giardino questi oggetti è come se non li possedesse. Solo utilizzandoli essi hanno un valore, quindi il loro significato economico comincia proprio nel momento in cui essi si muovono, escono dalla loro immobilità che li azzera e entrano in relazione con l’universo produttivo. Ma in questo momento essi devono correre dei rischi, modificarsi, diventare molteplicità di beni e improbabilità di ricavi. È stato detto che tutto il sangue della storia è stato versato per assicurare al capitale un reddito medio del tre per cento, ed è affermazione esatta. Il redditiere non chiede altro, un modesto tre per cento, per assicurare un raddoppio del suo capitale in vent’anni, più o meno il lasso di tempo di una generazione.
Ma i gestori della formazione produttiva, i veri e propri capitalisti, vogliono andare oltre questo tre per cento, e nel fissare un tasso appetibile non hanno limiti. Per fare ciò devono correre maggiori rischi. Forse in loro è rimasto qualcosa del modello corsaro alla Francis Drake, forse non sono tipi che amano troppo le regole, forse sono squali affamati, non lo so, certo è che si buttano su qualsiasi preda possa garantire un tasso di rendimento maggiore. È ovvio che le regole da rispettare non sono soltanto quelle stampate sui vari codici, ci sono anche quelle che riguardano il rispetto dei propri simili, degli animali e della natura. Nella sua aggressività il capitalista non solo calpesta le regole dei codici, anzi alla negazione di queste arriva solo dopo che ha calpestato la dignità umana, la vita degli animali, l’anima della natura. Facendo in poco tempo quattro conti si capisce che non si può dare vita a nessuna attività considerevolmente redditizia senza quella che è stata definita l’accumulazione di partenza. Il risparmio, anche il più occhiuto, non basta. Solo l’attacco agli altri, ai diritti degli altri, alla loro vita, ai beni e infine alle regole della cosiddetta convivenza, possono rendere possibile questa accumulazione. Non c’è un capitalista che non abbia alle sue spalle assassinii, stupri, riduzione in schiavitù, sfruttamento di minori, fino alla banale evasione fiscale.
Ecco perché la meta dell’equilibrio è un sogno illuminista che non può realizzarsi nelle condizione produttive del capitalismo. Se il capitalista – per tornare all’esempio precedente – trova più conveniente produrre in Cina, non vorrà aspettare, prima di interrompere questo processo economico, che si esaurisca l’utilità marginale relativa, cioè che le quantità di prodotto abbiano raggiunto un costo tale da rendere antieconomico continuare a produrre in Cina, egli solleciterà altre strade, cercherà di scarnificare altri paesi, ridurre all’osso altre strutture sociali, snaturare altre culture e altre popolazioni, per raggiungere il massimo livello di interesse per il suo capitale. Con questo sarà sempre legato a un intervento aggressivo, in collaborazione con le strutture militari e specificamente poliziesche che lo sostengono a livello nazionale e internazionale. Con questo creerà sempre di più situazioni di conflitto per dissodare nuovi terreni più proficui allo sfruttamento, e ciò tenendo nel minimo conto le vite umane (non solo degli aggrediti ma anche dei propri servitori), i costi in termini di inquinamento e sfruttamento irrazionale delle risorse del pianeta, ecc.
L’ingordigia del capitalismo non è però dettata dalla passione dei capitalisti, ma da un ragionamento legato al processo produttivo stesso. In altri termini, al contrario del redditiere, il capitalista non può aspettare, vuole realizzare il massimo profitto nel più breve tempo possibile, nella sua logica fin quando c’è da lucrare una differenza è assurdo non farlo. Quello che possiamo identificare come l’utile immediato per il singolo capitalista, entra però in conflitto con l’utile a medio e a lungo termine del capitalismo nel suo insieme. E qui si annida un altro aspetto della contraddizione di cui parlavamo prima.
Ma indirizziamoci diversamente verso il medesimo punto del ragionamento.
Lo sfruttamento è legato al lavoro, ma non perché i lavoratori dovrebbero ricevere l’intero valore dei prodotti. Se mai nella storia c’è stato un momento in cui questa equazione (cioè l’equivalenza tra lavoro e prodotto in termini di valore) è stata fondata non lo è di certo oggi. Il lavoro non è la sola sostanza valorificante. E nemmeno il capitale. La maggior parte del processo di valorificazione, in termini capitalisti, oggi è data dal carico simbolico che il prodotto subisce. Riducendo all’osso la maggior parte dei prodotti si resta al di sotto del loro significato oggettivo, cioè della loro possibilità d’uso. Le fabbriche di automobili non producono mezzi di locomozione ma simboli, segni di appartenenza a congregazioni diverse. Le industrie di abbigliamento fanno lo stesso, contraffazioni comprese. Se una rivoluzione economica desse oggi nelle mani dei lavoratori le loro industrie e le loro macchine essi non saprebbero cosa farsene. Se qualche geniale economista progettasse una riforma sociale in cui il valore prodotto dovrebbe andare al produttore non si potrebbe capire cosa dare a quest’ultimo in quanto non si ha nessuna possibilità di arrivare a una determinazione del valore se non in termini di prezzo di mercato, ma questo prezzo comprende, in massima parte, il valore simbolico che sarebbe inesatto accreditare al lavoratore, se non forse per la parte che lui stesso personalmente contribuisce a tenere in vita.
L’estraniamento del produttore di fronte a se stesso, se si preferisce l’antica alienazione, deriva dal non riconoscersi più nella propria condizione lavorativa. È il mondo del lavoro che è esploso polverizzandosi in un numero infinito di pezzi. Spezzata la coesione di classe, sia pure con tutti i limiti di una volta, il proletario non è più tale, si schiera subito dalla parte della sopravvivenza, cerca di barcamenarsi, di sopravvivere. Vede l’altro proletario come un potenziale nemico non più come un fratello. In questo la riorganizzazione produttiva, basata sulle isole o sulle catene modificabili, gli offusca sempre più le idee. La flessibilità gli rende morbida la schiena, nulla lo lega più al contesto produttivo che non sentendolo proprio non lo avverte più neanche come nemico. Lo stesso capitalista, nella concretezza della vicinanza produttiva, cioè nella veste dei capi e dei capetti, è scomparsa. Oggi il controllo del lavoro è affidato ai lavoratori stessi, agli incentivi di cottimo (chiamati diversamente), al considerare ogni reparto della fabbrica, reciprocamente, come fornitore e cliente di tutti gli altri reparti, ecc.
Per avere un’idea più semplice del problema occorre tenere presente che l’elemento centrale dell’economia è il valore. Tutto si riduce a un calcolo sulle grandezze. Il capitale è dato da un flusso di ricchezza, ma questa si ridurrebbe a nulla se non si potesse quantificare. Va bene che chi possiede un panino e non lo mangia ma lo sotterra è come se non possedesse nulla, ma deve avere pure un’idea di quello che possiede, altrimenti non comprenderebbe in che rapporto sta quel panino con gli altri beni di cui il bisogno o l’occasione gli propongono la presenza. Il capitalismo propone il prezzo come valore del bene. Si tratta oggi del sistema più comune di valorizzazione (non sarebbe sbagliato parlare di valorizzazione universale), ed ha pretese oggettive. È facile capire che queste pretese sono infondate. Senza approfondire molto la questione (abbastanza complessa) una variazione del prezzo può avvenire perché si modifica l’indicazione monetaria oppure cresce o diminuisce la quantità disponibile del bene. Più quantità c’è di quel bene e più il prezzo si abbassa, e viceversa. Ma il prezzo può anche muoversi in relazione a tutto quello che il produttore intraprende per incrementare la domanda del bene in questione. Oggi questo secondo problema, essendo la maggior parte della produzione ormai virtualizzata, è più importante. Aggiungendo la complicazione del rapporto dei prezzi a livello internazionale si capisce come, a causa dei cambi, la formazione dei prezzi non è mai un processo capace di indicare il valore di un bene. Anche in paesi cosiddetti democratici i prezzi non sono mai fissati esclusivamente dalle quotazioni di mercato.
Mille forze intervengono sul prezzo. La cupidigia dello Stato, che impone tasse e imposte percependo una parte considerevole in modo diretto (tasse) su alcuni beni, per esempio (importante) la benzina, o indiretto attraverso le imposte sul reddito. Poi la cupidigia del capitalista che cerca di trasferire sul prezzo (quindi sul consumatore) tutti i suoi costi aggiunti, oltre a ogni variazione anche provvisoria che viene così fatta diventare definitiva. Molti costi di fondo, derivanti da disperati tentativi di frenare il disfacimento delle risorse naturali del pianeta, entrano nel prezzo pur appartenendo a forme produttive parallele e quindi dando vita a interrelazioni di costi che finiscono per raddoppiarsi o triplicarsi. In conclusione non c’è nulla di più incerto della formazione del prezzo. Ciò rende qualsiasi calcolo economico una pura illusione in quanto non c’è modo di fissare in maniera attendibile il valore dei beni.
Poiché il meccanismo del mercato non è attendibile, come per altro qualsiasi altra struttura posta in atto dal capitalismo, si è pensato di prendere come unità di misura il valore d’utilizzo del singolo bene. Ma la considerazione dell’utilità è un fatto individuale, essa varia infatti a seconda della situazione sociale e culturale del singolo. È un po’ la stessa storia del desiderio. Ognuno vuole soddisfare i propri desideri nella massima misura possibile, ma per fare questo deve conoscere i suoi desideri e questa conoscenza è legata alla propria storia personale, alla propria condizione sociale e culturale. L’affermazione che la cosa più importante della vita è fare quello che si desidera potrebbe così ridursi a qualcosa di veramente misero, in contrapposizione (fittizia) col sacrificio in nome di un ideale qualsiasi, sia pure l’internazionalismo proletario.
Trattandosi di un bene che si consuma subito, in un certo momento ognuno di noi sa dire dentro limiti accettabili, quanto è intensa questa sua preferenza nei riguardi di un altro bene, ma quando si tratta di un bene che viene usato a lungo, il problema non è di facile soluzione. Inoltre non si deve dimenticare che partendo dal valore d’utilizzo si ha davanti solo il costo del prodotto ma non le sue singole componenti, cioè in che modo i fattori produttivi hanno contributo alla formazione di quel costo. Oggi più che mai il valore d’utilizzo è impossibile da trovare se si tiene conto che alcuni beni hanno un valore semplicemente simbolico e assolvono alla soddisfazione di bisogni costruiti ad arte. Nella maggior parte dei casi tutti noi fissiamo un valore d’utilizzo quando ci confrontiamo con un valore monetario (o di scambio), ma lo fissiamo come termine di paragone, come elemento che contribuisce alla scelta, senza con questo riuscire a incidere sulla realtà normativa del prezzo. Siamo di fronte a circostanze tanto perverse che nessun prezzo tende alla ipotetica condizione di equilibrio studiata per il mercato dall’economia. Facciamo l’esempio del caso di una disoccupazione elevata. Una diminuzione dei salari potrebbe far pensare a un aumento dell’occupazione mentre invece c’è buona probabilità che essa causi un aumento della disoccupazione o addirittura un collasso dell’economia di mercato proprio a causa della diminuzione della domanda conseguente alla riduzione delle linee salariali.
Da queste riflessioni si trae la deduzione che un mercato razionale, puramente o prevalentemente economico, non esiste. L’incidenza istituzionale sulla formazione dei prezzi è oggi tanto forte da potersi parlare di economia controllata. Se a questo si aggiunge la legislazione sociale, il ruolo sia pure di retroguardia dei sindacati, l’istruzione, la ricerca e tutto il resto, si può parlare di una programmazione indiretta dei prezzi, una forma di miglioramento dell’esperienza triste e deprimente accumulata nei vecchi paesi a socialismo reale. Non si può infine parlare di una netta distinzione tra beni privati e beni pubblici, per cui alcuni pretendono fissare il mercato concorrenziale per i primi e, ovviamente, non per i secondi. Molti dei cosiddetti beni pubblici, come la sicurezza nazionale per fare un esempio, hanno connotazioni private, o ricadono nell’ambito della produzione privata (la polizia deve essere dotata di strumenti come auto, computer, pistole, ecc.), e viceversa. L’incertezza domina sovrana in queste materie. Non c’è concetto più evanescente di quello di mercato, eppure è da esso che dipende la nostra vita quotidiana così come l’hanno impostata i capitalisti.
Il valore di cui abbiamo discusso si materializza, sotto l’aspetto di scambio, nella versione monetaria, cioè si presenta di solito come prezzo in moneta. Tutti sanno cos’è la moneta ma pochi si rendono conto delle sue implicazioni. Oggi la condizione comune della circolazione monetaria è quella simbolica, cioè della moneta segno. Non mette conto ricordare le fasi storiche in cui ci sono stati dei rapporti più o meno di eguaglianza tra moneta cartacea e il suo corrispettivo in oro, oggi tutti prendono con fiducia in pagamento un pezzo di carta monetaria perché sanno di poterlo cedere con pari facilità. Si tratta di un comune consenso garantito dalla forza coercitiva dello Stato. Una garanzia indiretta è data dalla produzione complessiva del paese (o del gruppo di paesi) dove quella moneta circola e di cui essa costituisce il valore (simbolico) di scambio.
L’inflazione si ha proprio quando il quantitativo di moneta in circolazione supera il corrispettivo della quantità di merci in circolazione (che dovrebbe rappresentare) e, viceversa, quando la produzione cresce e la disponibilità di mezzi di pagamento resta ferma (o diminuisce) si ha una strozzatura economica che è quello che il capitalismo teme di più. È ovvio che la ricchezza di un paese non è costituita dalla quantità di moneta in circolazione ma dalla quantità di beni. La moneta è soltanto un segno. Le esportazioni di beni fatta poniamo negli USA dalle ditte italiane e pagate in dollari, fanno entrare in Italia una moneta che rappresenta una vera e propria ricchezza, essa stessa in quanto insieme di pezzi di carta, e ciò perché i beni relativi non esistono più nel paese ma si trovano all’estero. Per evitare confusione gli specialisti chiamano “divisa” questa moneta con cui gli Stati pagano le esportazioni nazionali. Questi ragionamenti semplificati seguono qui la sola teoria monetaria quantitativa che ormai è stata allargata da tante altre considerazioni le quali non le tolgono del tutto il suo significato di fondo.
Ma la moneta è anche una merce (di scambio), cioè una merce particolare che assolve al compito di consentire scambi ad alta velocità in condizioni capitaliste di produzione e consumo. Quindi c’è una richiesta di moneta per fare pagamenti. La maggior parte di questa moneta richiesta viene messa a disposizione dal sistema delle banche che per entrare in possesso di questa moneta pagano un prezzo (interesse). Il rischio che lo Stato ha di dovere continuare a stampare moneta facendo con ciò lievitare i prezzi è limitato da questa raccolta di denaro che è fatta dal sistema bancario, il quale guadagna la differenza tra l’interesse pagato a chi deposita e quello incassato da chi chiede un prestito. Un’accelerazione produttiva della formazione sociale causa uno sviluppo enorme delle banche come è quella che vediamo nell’epoca in cui viviamo.
La formazione di un tasso medio di interesse è un fattore di equilibrio per il sistema produttivo, ma è anche questo un punto di grande incertezza. Vi incidono negativamente l’insieme frastagliato del panorama creditizio, l’impossibilità di distinguere tra breve e media scadenza, il livello generale dei prezzi, il grado di disoccupazione del lavoro, la stessa psicologia della gente (in questo momento con la vicenda euro in corso di svolgimento quest’ultimo elemento è di grande importanza). Oggi si è allargato moltissimo l’intervento finanziario nella formazione del tasso di interesse attraverso la creazione di riserve obbligatorie per le banche, le manovre del tasso ufficiale di sconto, la gestione del debito pubblico. Le borse trattando beni immateriali come le azioni, le obbligazioni, ecc., sono ormai un elemento portante dal sistema produttivo e vengono considerate dalle riflessioni economiche più avanzate come qualsiasi altra parte del mercato.
[2007]
Chi guadagna nella svalutazione?
In questi ultimi giorni [1995] la lira è andata giù su tutti i mercati internazionali. La moneta tedesca e il dollaro si sono invece rafforzati.
La Banca d’Italia è intervenuta sostenendo la lira più che altro in maniera formale, in quanto forti pressioni interne, a livello delle elette economiche dominanti, impediscono un’azione puramente e strettamente monetaria.
Ma non sono soltanto gli speculatori classici ad avere vantaggio dalla svalutazione della lira, cioè non sono i grandi giocatori sulla roulette dei cambi internazionali a realizzare profitti (o perdite gravissime com’è successo all’operatore in Giappone della Barings Bank); in primo luogo sono proprio gli industriali italiani, i quali in questo modo possono aumentare le loro esportazioni, conquistare mercati, firmare contratti plurimiliardari, commesse mai pensate prima e tutto il resto.
Mentre dappertutto sembra che le cose vadano male (e difatti vanno male), per loro, per i grandi industriali e per tutto il settore che va a traino di questi complessi capaci di fronteggiare i colossi dell’economia mondiale, per costoro le cose vanno bene.
Un altro motivo della soddisfazione dei grandi padroni è dato dal fatto che i costi di produzione sono di gran lunga diminuiti a causa degli accordi sindacali, della flessibilità operaia, della adattabilità degli impianti in corso di veloce trasformazione, del basso livello di lotta sociale, ecc. L’insieme di questi elementi gioca a favore del tessuto produttivo industriale e dei servizi, un tessuto che non è mai stato così florido come in questo momento.
Naturalmente, questi interessi impediscono che si agisca subito e in maniera efficiente con la manovra monetaria semplice. Il direttore della Banca d’Italia sembra un burattino nelle mani di un burattinaio non tanto nascosto. Le proteste di Germania e Stati Uniti si fanno di già sentire, e si intensificheranno nei prossimi giorni. Ma fin quando potranno, i padroni dell’Italia tireranno la corda, tanto a pagare le conseguenze ultime di questa situazione non saranno loro, ma i soliti ultimi della società, gli emarginati e i senza-salario, poi anche i salariati che vedranno diminuire consistentemente il potere d’acquisto dei loro pochi soldi.
Quando si tornerà all’allineamento ci saranno fortune cresciute per i pochi e miseria altrettanto cresciuta per i molti.
[1995]
Classe
Torna costante l’equivoco che il concetto di “classe” sia una manipolazione marxista e che quindi gli anarchici debbano disinteressarsene o, se si preferisce, elaborare altre categorie logiche per dar conto della realtà sociale nel suo insieme e delle parti che la compongono.
Sta di fatto che questa realtà non è omogenea, né appare come il benefico paese della cuccagna. Conflitti e dolori di ogni genere dilagano a profusione. Profittatori e biechi tutelatori dell’ordine del profitto controllano una situazione in cui la gran massa di coloro che questo stato di cose sopportano, riesce a vivere a malapena, fra stenti e difficoltà.
Per quanto sia difficile tracciare i “confini” dei raggruppamenti di individui che si trovano in una “stessa” situazione sociale, cioè in un processo in corso che risulta determinato storicamente da certi rapporti economici, politici e culturali, è pur sempre necessario fare uno sforzo in questo senso.
La storia, anche poco recente, del movimento di liberazione umana, diciamo almeno dal diciassettesimo secolo, è stata contrassegnata dagli sforzi di dare fondamento a questo processo di determinazione della classe.
L’uso corrente, in questi ultimi quarant’anni [1987], del termine “classe”, è certo inquinato dagli spropositi marxisti, ma questi non vanno – a nostro avviso – tanto cercati nei tentativi (per altro marginali e contraddittori) di dare corpo alla individuazione di cui sopra, quanto nella pretesa di “assegnare” alla classe che subisce il dominio un ruolo escatologico, cioè un ruolo quasi religioso e certamente misterico, in base al quale questa classe realizzerebbe la liberazione definitiva di se stessa e di tutti gli uomini in un futuro più o meno breve, attraverso la guida del partito che pretende rappresentarla.
Ogni anarchico vede benissimo quante stupidaggini e falsità si nascondono dietro questo uso del concetto di classe, ma dovrebbe anche vedere che esse non sono pertinenti necessariamente al concetto stesso, quanto alla pretesa messianica (e deterministica) che il marxismo affida (o affidava?) alla classe degli sfruttati e, più precisamente, alla classe operaia.
A noi, qui, interessa sottolineare non solo la validità ma anche l’importanza del concetto di classe, come concetto orientativo per penetrare i flussi delle composizioni strutturali della realtà sociale, mentre non interessa approfondire i limiti e le superficialità misteriche di un preteso destino della classe operaia.
Che i meccanismi produttivi, in base ai quali, in un passato abbastanza recente, si determinavano, dentro certi limiti, i confini delle classi, siano in profonda modificazione, è un fatto certo. Ma è anche certo che questa modificazione sta producendo una ulteriore differenziazione la quale non corrisponde più alla precedente come aspetto organico, ma riproduce la stessa conflittuale divisione. Si tratta di vedere qual è la materia da contendere. Di che cosa si sta trattando adesso? In base a quale possesso una parte dell’umanità potrà “ritagliarsi” i propri confini di classe dominante ed estromettere il resto in una zona delimitante una o più classi dominate?
L’importanza di questo problema è tale da fare passare, almeno per il momento, in secondo piano lo studio delle stesse composizioni intermedie, cioè gli strati sociali che si possono ricavare all’interno della singola classe. Allo stesso modo, per il momento, ci pare secondario lo studio di una possibile ripartizione in due o tre o più classi. Quello che costituisce il punto di partenza del nostro discorso è dato proprio dalla progressiva scomparsa della tradizionale divisione in classi e dall’emergere di una nuova divisione.
Non è certo nello spazio di un breve articolo che possiamo esaurire questo argomento, ma di una cosa possiamo trattare con un minimo di chiarezza. La precedente divisione in classi si basava su di un problema di “carenza”. Un bene comune, o, almeno, considerato da tutte le classi come “bene”, veniva ripartito in modo ineguale. La classe dominante si impadroniva della maggior parte di questo bene (quello che comunemente veniva chiamato col termine di ricchezza) e da questo ingiusto profitto ne traeva mezzi per continuare lo sfruttamento e il dominio. Quei mezzi erano, in primo luogo, mezzi culturali, ideologici, sui quali si costruiva tutta una scala di valori che condannava gli espropriati a subire le conseguenze di una situazione in pratica non ribaltabile.
In effetti, l’attacco più acuto e radicale alla precedente situazione di dominio è venuto non tanto dalla lotta esterna (o, almeno, non solo da quella), quanto dalla profonda, lacerante, contraddizione interna al sistema stesso di dominio e di produzione. Quel sistema era legato a certe condizioni strutturali e organiche che ne potevano garantire la perpetuazione solo a condizione di fare partecipare sempre di più le classi spossessate ai benefici del possesso. Su questa strada, la soluzione dei ricorrenti problemi di ordine sociale, era affidata solo alla sempre più vasta accettazione di condizioni migliori da un punto di vista sociale per la classe produttiva, ma peggiori da un punto di vista tecnico per la classe dominante.
La rottura di questo rapporto intollerabile per il capitale e per il dominio è avvenuta dopo un rafforzamento delle strutture del capitale a seguito di una più stretta collaborazione con le forme politiche nazionali e internazionali degli Stati; ma si è perfezionata, in modo decisivo, con le nuove possibilità che la tecnologia più avanzata ha messo a disposizione della ristrutturazione produttiva.
Adesso ci si avvia verso una situazione radicalmente diversa. Diventa sempre più sfumato il problema della “mancanza”, mentre emerge il problema del “possesso”. Cioè la differenza di classe non è più determinata dal fatto che una parte non possiede “quanto” l’altra, ma dal fatto, invero insolito nella storia dell’uomo, che una parte possiede “qualcosa” che l’altra parte non possiede.
Teniamo presente, per chiarirci meglio, che anche nella più nera miseria del passato, la classe degli sfruttati “possedeva” pur sempre qualcosa, sia pure la sua “forza lavoro”, cioè la sua capacità di produrre, di cui era sì costretta a far mercato, ma di cui però l’altra parte aveva pur sempre bisogno. La contrattazione poteva anche ridursi a una presa per il collo dei miserabili venditori delle proprie braccia, ma non poteva negare un “possesso” che la classe lavoratrice aveva e che si collocava nella medesima scala di valori a cui faceva riferimento la classe dominante. In passato, sfruttatori e sfruttati, si contrapponevano (pur nella notevole gamma delle stratificazioni di classe) sulla base di un “possesso” comune ma diseguale. Adesso, si contrappongono sulla base di un qualcosa che una parte possiede e che l’altra non possiede e non possiederà mai.
Questo qualcosa è la tecnologia, la gestione tecnologica del dominio, la costruzione di un “linguaggio” esclusivo di una classe “inclusa”, la quale costruirà attorno a sé un muro ben più insormontabile di quello che in passato era dato dalla ricchezza pura e semplice, dalle porte blindate o dalle guardie del corpo. Questo muro sarà quello di una separazione radicale, tanto netta da risultare “incomprensibile” – in breve tempo – a coloro che non si trovano all’interno del processo di inclusione. Il resto, gli “esclusi”, costituiranno una classe di “fruitori” terminali, capaci solo di utilizzare tecnologie secondarie e perfettamente strumentali al progetto di dominio.
La parte “esclusa” dell’umanità non potrà, almeno in tempi lunghi, rendersi conto di quanto gli viene sottratto, perché sarà un bene che non appartiene più alla medesima scala di valori. La classe degli “inclusi”, nel costruire questa separazione, nuova e, a loro sperare, definitiva, sta costruendo anche una diversa scala di valori, una specie di nuovo codice morale che non intenderà più condividere con gli altri, con coloro che faranno parte del mondo degli esclusi. Il tallone di Achille del passato era proprio questo comune codice morale, che per tanti versi tornava utile per un migliore controllo, ma faceva spesso sentire il fiato dell’inseguitore sul collo dell’inseguito.
Ecco, questa nuova situazione, in corso di perfezionamento, tende a costruire nuove strutture di classe, ma non ad abolire il concetto orientativo di classe. La nostra non è una preoccupazione di natura terminologica, ma operativa. Perdersi dietro disquisizioni nominalistiche ci sembra inutile. Al momento il concetto di classe – e quello correlato di “conflitto di classe” – ci paiono concetti perfettamente adeguati per dare indicazioni sui processi storici di formazione delle strutture sociali e sui loro funzionamenti. Allo stesso modo, il concetto di “coscienza di classe” è ancora utilizzabile proprio nella prospettiva di aumento delle difficoltà, per gli “esclusi”, di rendersi conto a livello individuale e collettivo della propria condizione di esclusione.
Ogni strategia rivoluzionaria che potremo immaginare per intraprendere una lotta di resistenza contro il processo di ristrutturazione in corso dovrà tenere conto delle modificazioni in atto e, dentro certi limiti, anche delle stratificazioni interne alle stesse classi. Forse, in una prima fase, quale è quella che stiamo attraversando [fine anni Ottanta], i confini periferici (o inferiori) della classe degli inclusi (cioè della classe nemica, per intenderci), non saranno molto netti e quindi ci si vedrà costretti a indirizzare i nostri attacchi verso gli obiettivi più visibili, ma sarà soltanto una questione di documentazione e di approfondimento analitico.
Quello che più conta, almeno in questa sede, è cercare di far capire come non è con una vacua disputa terminologica che si affrontano i problemi della caccia al nemico e quelli del suo disvelamento. Al più i patetici tentativi di esorcizzare un pericolo cambiando i nomi delle cose, nascondono soltanto l’incapacità di agire.
[Pubblicato su “Provocazione” n. 4, aprile 1987, p. 5 col titolo “Classe e dintorni”]
Comandanti
Cofferati, il patron della CGIL, si è aumentato lo stipendio e, sia pure di poco, tutti i burocrati sindacali hanno avuto un piccolo aumento, dai segretari confederali ai segretari di categoria, fino ai piccoli “apparati” di periferia. In fondo, vendere la pelle dei disgraziati che lavorano non rende moltissimo: Cofferati guadagna, dicono, ufficialmente 3 milioni e 300 mila lire al mese. Il resto al buon cuore degli affari che si possono trovare per strada.
[Pubblicato su “Canenero” n. 13, 3 febbraio 1995, p. 7]
Comunità
In tutti gli anarchici che non si professano esclusivamente individualisti c’è un’aspirazione al “comunismo”, come progetto di società futura e come indicazione di una nuova scala di valori.
Più volte, nella storia e nell’azione degli anarchici, questo problema è andato verso una sua più approfondita definizione. Si è, in altri termini, cercato di uscire dall’utopia, per avvicinarsi alla pratica.
In questi ultimi anni, rispetto a una pratica anarchica in forte ribasso, con azioni che stentano a ripartire, sia a livello di massa che a livello di gruppi specifici, si assiste a una ripresentazione del problema di come avvicinarsi al “comunismo” o di come costruire situazioni reali che esprimano non solo le nostre idee, i nostri valori etici e culturali, ma anche siano in grado di soddisfare bisogni di libertà fondamentali, esigenze personali e collettive, per potere diventare, in quanto situazioni reali, punti di riferimento per molti compagni, al di là della classica divisione tra personale e politico.
Non si può negare che questa istanza corrisponda a un bisogno diffuso, oggi, nel movimento (e non solo in esso). Proprio di fronte al tramonto delle speranze di profonde modificazioni collettive della struttura sociale, trova più ampio respiro la preoccupazione di non farsi travolgere dalla dilagante ristrutturazione, dal sempre più ampio articolarsi della desistenza a qualsiasi livello. Continuare la lotta, rispettando i propri bisogni essenziali, visto che di cambiamenti macroscopici, almeno al momento, non è il caso di parlare.
Il guaio è che queste istanze finiscono per prendere due strade che, poi, a ben esaminare, riconducono nella stessa piccola piazza del ghetto. La prima, più liscia e diritta è quella della desistenza. Niente da fare. Il nemico è troppo grosso. Tanto vale ripiegare sulla semplice diffusione delle nostre idee (che poi sono le migliori) e non insistere nell’attacco che produce solo aumento della repressione e ulteriore difficoltà per il movimento nella sua attività fondamentale di propaganda e diffusione dell’anarchismo teorico. La seconda, più tortuosa e difficile, è quella che passa attraverso la proposta organizzativa (apparentemente si tratta proprio di una proposta organizzativa) fondata sul concetto di “comunità”.
Qua e là diversi compagni parlano, per la verità mai con cognizione di causa, del concetto di “comunità”, cercando di presentarlo come qualcosa che non sia circoscrivibile in un impianto geografico, e nemmeno sia riconducibile a scelte che soddisfino (o affermino di soddisfare) soltanto alcuni bisogni, sia pure fondamentali. Si deve trattare di un modo diverso di concepire la vita, la cultura, la novità, la diversità. Così, la “comunità” potrebbe sfuggire ai pericoli della sclerosi conservatrice, della ripetizione di sigle vuote di significato, delle chiusure, innestando un processo di rinnovamento culturale continuo.
Questa “comunità”, di cui non si dice molto in termini di forme strutturali o altro che avrebbero potuto dare indicazioni sugli aspetti “operativi”, è considerata in termini di sentimento di partecipazione, di coscienza delle contraddizioni specifiche dell’anarchismo (per la verità, mai chiarite bene), di desiderio di libertà e di uguaglianza senza che la prima si realizzi a scapito della seconda e viceversa.
Perché pensiamo che questa seconda strada corra parallela alla prima, quella della desistenza dichiarata e aperta? È presto detto. Perché la lotta rivoluzionaria è fatto organizzativo, qui e subito, non semplice “rivoluzione culturale” (senza fare riferimento a modelli che non ci appartengono, che di “culturale”, appunto, avevano solo il nome). Perché lo scontro di classe non ammette “ritagli” o incavi da ottenere con operazioni fittizie, elaborate all’interno del filone più inquinato e contraddittorio del pensiero filosofico. Perché il rivoluzionario paga sempre di persona ed è quindi sempre cosciente che deve pur affrontare “sacrifici”, cioè posposizioni di problemi, rinvii di soddisfacimenti. Perché chi decide di attaccare realmente il dominio degli oppressori non può ragionevolmente pensare che questi ultimi lo lascino poi tranquillo all’interno delle sue “ideali” tensioni di libertà e di uguaglianza. Perché, se davvero vuole che questi luoghi del vivere “comunitario”, siano minimamente pensabili in termini pratici (e non solo siano vaga esercitazione filosofica, per giunta contraddittoria e inquinata da ignoranze specifiche) deve dar segno di buona volontà, cioè dichiararsi contro la violenza, contro l’espropriazione – in special modo parziale – di quello che ci è stato tolto, contro la solidarietà attiva e non solo a parole nei riguardi di chi lotta veramente affrontando la morte ogni giorno, sia nei posti di lavoro, sia negli altri luoghi dello scontro tra opposti interessi.
A questo punto il problema, almeno a me, sembra posto in questi termini:
1) Parliamo del concetto di “comunità”. Ci limitiamo soltanto a parlarne. Bene. Allora dovremmo parlarne meglio.
2) Cerchiamo di praticare il concetto di “comunità”. Bene. Si dovrebbe dire qualcosa di più sulle strutture comunitarie, sulle attività, sui limiti e sulle possibilità.
Poiché del secondo punto, allo stato attuale delle cose, si possiede solo una vaga critica dei tentativi autogestionari in situazioni capitaliste (critica che, per altro, non tiene conto di moltissimi problemi che io stesso ho contribuito ad approfondire almeno a partire dagli anni Settanta), ci dobbiamo limitare a discutere del primo punto.
Devo subito dire che di un concetto, quando ci si trova davanti a una situazione di fatto che storicamente propone una miriade di usi, non sempre edificanti, è bene prendere subito le distanze, per quanto importante, utile o simpatico esso possa essere. E, non c’è dubbio, che il concetto di “comunità” è proprio di questo tipo.
Approfondiamo l’argomento. Il concetto di “comunità” non è specifico del pensiero anarchico, anzi, al contrario, è stato sviluppato dal pensiero filosofico (che poi sarebbe la codificazione accademica del pensiero della classe dominante), in contrapposizione al concetto di “società”.
Mettendo da parte gli usi specifici che del concetto di “comunità” hanno fatto Platone, Fichte ed Hegel, c’è da tenere presente l’analisi di Marx ed Engels di una comunità primitiva con la quale ha inizio la storia dell’umanità che poi dovrebbe ricostituirsi in una comunità conclusiva, con cui si concluderebbe la storia del proletariato e della lotta di classe. Questo necessarismo filosofico raggiunge la sua massima forza comica (e tragica) nelle teorie di Stalin sulla “comunità”, le quali fanno bella mostra di sé accanto alle teorie dei nazionalsocialisti che sono stati non soltanto teorici ma “quasi” realizzatori (naturalmente, a forza) di una “comunità di cultura e di genti a carattere sacrale”.
Fin qui siamo chiaramente nell’ambito di un significato sovraindividuale del concetto di “comunità”.
Esiste però un’altra elaborazione di questo concetto, sempre eseguita nelle officine delle accademie padronali, ed è proprio a questa che si avvicina l’ipotesi di lavoro di cui oggi si discute all’interno del movimento anarchico. Si tratta del concetto che considera la “comunità” non come entità sovraindividuale, ma come particolare legame tra individui. In altri termini come “relazione sociale”. Si tratta di un interesse comune che finalizza i rapporti individuali e che finisce per creare una interazione che serve come amalgama della “comunità”.
Questo concetto è stato formulato dalla scuola romantica tedesca e precisamente da un teorico della religione (Schleiermacher), nel 1799, e non c’è dubbio che si può ricollegare alla sua ipotesi del significato delle religioni (basata sul senso etimologico della parola “religio”, che significa “tenere insieme”, “legare insieme”).
Nella formulazione più dettagliata, quella di Tönnies, che è del 1887, la comunità viene presentata come un organismo naturale, all’interno del quale si sviluppa una specie di volontà collettiva diretta a soddisfare prevalenti interessi collettivi. In questo organismo le pulsioni e gli interessi individuali si atrofizzano al massimo, mentre l’orientamento culturale tende a diventare chiuso fino (spesso) a scadere nella dimensione sacrale. La solidarietà nei riguardi di tutti i membri è globale. La proprietà è comune. Il dominio (almeno nei termini in cui lo si concepisce oggi) è assente.
Il modello che Tönnies tenne presente per questa analisi (per molti versi assai interessante), è quello della società rurale europea così come si realizzò nel villaggio contadino. Oggi non esiste (o quasi) più. Da parte sua, Kropotkin, che per altro attingeva a differenti realtà (quella del “mir” russo) e ad altra letteratura antropologica (quella di lingua inglese), teneva presente un modello abbastanza simile.
A mio avviso, l’errore che si è commesso è stato quello di pensare che un certo modo di agire spontaneo davanti al verificarsi di avvenimenti disgregativi dell’ordinamento societario, sia specifico delle situazioni oggettivamente comunitarie, o sia il portato storico di un “sentimento” comunitario addirittura maggiormente presente in alcuni popoli e meno in altri. Si è pensato cioè che alcune “istituzioni” comunitarie siano riuscite a filtrare attraverso la grande distruzione operata dallo Stato moderno, permanendo intatte in alcune forme parziali oggi visibili come, a esempio, la famiglia (o i gruppi familiari di parentela), i gruppi di vicinato, le cooperative, o altro. Ciò è veramente puerile. Meno puerile, ma altrettanto erroneo (e quindi pericoloso) è il punto di vista di coloro che affermano che la comunità è una “unione” soggettivamente sentita dai membri, mentre la società è solo capita attraverso un ordinamento oggettivo.
Tutto ciò non intacca minimamente il sentimento di solidarietà, di uguaglianza, di rifiuto del dominio e della proprietà individuale che gli sfruttati, in una situazione precisa, possono realizzare anche in forme ben definite. Come non intacca il fondamento del concetto di autorganizzazione, di creatività e di progettualità spontanee di chi si contrappone al dominio in quanto ne subisce le conseguenze.
Quello che qui voglio mettere in discussione è la validità e l’utilizzabilità del concetto di “comunità”, se non altro per i seguenti motivi:
a) non possiamo considerare la comunità – per quello che attualmente la storia di questo concetto porta con sé – come una indicazione di valore superiore a quello di “società”;
b) ne deriva che non possiamo considerare la “comunità” come facente parte del patrimonio culturale del progresso contro la reazione;
c) a dimostrazione del punto b) c’è il fatto che anche i movimenti fascisti e reazionari in genere si rifanno – a modo loro – al concetto di comunità;
d) non è semplice liberare la comunità dal pregiudizio sacrale, o dei portatori della verità, la qual cosa comporta un effetto distorto della innegabile solidarietà che si diffonde al suo interno in quanto spesso questa solidarietà si diffonde in modo acritico in base a valutazioni di bandiera o di sigla;
e) non appare facile separare dal concetto di “comunità” il fondamento originario, appunto rurale e contadino, con tutto il suo insieme di elementi ormai lontani nel tempo e certamente in contrasto con una situazione generale di profonde modificazioni tecnologiche.
Mi pare che si possa concludere in modo semplice dicendo che non c’è bisogno di ricorrere a concetti del tipo “comunità”, che presentano inquinamenti non sempre eliminabili, per indicare l’effettiva capacità di autorganizzazione degli sfruttati.
Nel caso in cui si voglia invece, con questo concetto, fare riferimento a possibili forme di organizzazione specifica, nella illusione di superare i limiti e le contraddittorietà, i pericoli e le ferite che l’attività rivoluzionaria anarchica inevitabilmente porta con sé, in una situazione di profonda lacerazione sociale quale è quella in cui viviamo, devo per forza sottolineare il mio più totale disaccordo.
[Pubblicato su “Provocazione” n. 5, maggio 1987, p. 8 col titolo “Mal di comunità”]
Conservazione
Almeno una parte dello scontro sociale in atto nel mondo [1992] richiede chiarimenti in merito al concetto della conservazione. Dai movimenti sotterranei russi, che vogliono riportare al potere restaurate intenzioni staliniste, alle avventurose verniciature napoleoniche della nuova nomenclatura; dagli sconvolgimenti in Medio Oriente e dalle relative ondate repressive, ai continui riequilibri internazionali fondati sul prezzo del petrolio e sul sangue degli insorti; dalle vicende di casa nostra, dal microcosmo molto istruttivo delle tangenti, dalla cosiddetta lotta statale contro la mafia agli spostamenti dell’esercito italiano in Sardegna, in Sicilia e in Calabria, vere e proprie occupazioni militari di territori in fondo stranieri; tutto ciò ha una matrice comune, il desiderio di conservare e garantire una ripartizione dello scontro di classe che permanga favorevole ai padroni, inclusi nell’eterno gioco del dominio.
Il conservatorismo appare oggi finalmente sotto la sua vera veste di garanzia dell’ordine, quale esso sia, non l’antico ordine dell’altare e del trono, ma quello continuamente in corso di modificazione e sempre necessario allo sfruttamento. Quindi, il processo ideologico con cui si cerca di legittimare questo sfruttamento, rendendo moralmente plausibile il dominio che lo fa possibile, è legato alla classe dominante, a prescindere dalla sua composizione storicamente significativa. Non esistono pertanto classi dominanti che siano naturalmente conservatrici, e ciò spiegherebbe i comportamenti di classi dominanti estromesse dal dominio e costrette a reagire contro gli attuali possessori delle leve del potere.
Il fatto che oggi le antiche, e per la verità sparute, componenti del partito comunista russo si muovano verso tentativi di ricostituzione del potere perduto, non significa che costituiscano un movimento rivoluzionario, e ciò con buona pace di tutti coloro che, anche in casa nostra, si ostinano a proporre simboli e bandiere che appartengono ormai agli orrori del passato. Si tratta di movimenti conservatori, attualmente all’opposizione.
Allo stesso modo, gli attuali sostenitori di uno Stato “pulito”, lontano dai brogli delle tangenti e dalle mene di partito, gli ideologi di una “democrazia pura ed efficace”, non sono sognatori d’una realtà futura da costituire, ma conservatori che intendono ripristinare illusioni del passato, altrettanto gravi e dense di minacce della vecchia favola della dittatura del proletariato. Così, il conservatorismo si traveste con mille colori, muta continuamente aspetto, rifiuta di parlare di tradizione e propone distinzioni indistinguibili, spacciandole per veri e propri punti chiave della realtà politica.
Che lo Stato s’opponga significativamente alla mafia è semplicemente ridicolo, in quanto la mafia è una parte essenziale dello Stato, essendo costituita da quella componente di esclusi che è riuscita a inserirsi all’interno del processo di sfruttamento attraverso la porta, sempre aperta, della violenza e della sopraffazione, utilizzando gli elementi istituzionali (leggi, monopoli, privative, proibizioni, e altro) espressamente pensati dallo Stato stesso per reggere alcuni progetti, sempre a piccolo e medio termine, di sfruttamento e di controllo.
Su questo punto si commettono, correntemente, almeno due errori, e qualche volta anche da parte di compagni tutt’altro che desiderosi di confermare le intenzioni statali e padronali. Si dice che lo Stato e la mafia sono la stessa cosa. E ciò è senz’altro vero, ma è anche troppo in superficie, sia come analisi, sia come proposta per l’azione. Bisognerebbe almeno capire cosa succede all’interno della mafia, e se questo termine propone alla nostra attenzione, nostra in quanto rivoluzionari, una entità monolitica e compatta, oppure qualcosa di frastagliato, con strutture e forze tutt’altro che gestibili direttamente dallo Stato. Non mi risulta siano stati tentati percorsi interpretativi in questo senso. Poniamo, la micro-criminalità, risucchiata in molti modi all’interno degli interessi e dell’agire mafioso, con reciproco scambio di professionalità e protezione, sfruttamento e occasioni di lavoro, non può sposare fino in fondo interessi che ben presto appaiono troppo al di sopra della sua testa, viaggiando sui voli internazionali dove non si fa presto a distinguere tra il manager uscito da Yale, l’agente segreto fabbricato a Mirafiori e il killer professionista.
Lo Stato non ha interessi reali ad attaccare la mafia, non tanto per le collusioni interne, ma perché esiste una comunanza ideologica di fondo, un rispetto reciproco in nome del principio neoliberale che gli affari sono affari, in qualsiasi modo si facciano. Per altro le condizioni del mercato sono di certo determinate più dallo Stato stesso, con le sue leggi proibizioniste, che dalla mafia con le sue strutture di sfruttamento di quelle proibizioni. Osservando lo sviluppo della mafia, si scopre uno sconcertante parallelismo con lo sviluppo dello Stato, i presupposti fondamentali del vecchio liberalismo si sono evoluti, parallelamente, nella nuova democrazia e nello Stato burocratico, con un’accentuazione del funzionalismo. E, come non si tarderà a capire, le stragi costituiscono più un segno di debolezza della mafia, che di forza, quando questa forza è rappresentata senza dubbio dall’efficienza manageriale e dalla sapienza gestionaria dei suoi grandi investimenti produttivi.
Un altro errore che potrebbe emergere nel percorso analitico che auspichiamo, consiste nel fatto che gli stimoli conservativi in atto non sono necessariamente reazionari, nel senso classico del termine, cioè contrari a qualcosa di ben definito, che si sta muovendo, invece, nel senso progressista. Qui ci troviamo di fronte a un problema di grande spessore e importanza. Il movimento rivoluzionario nel suo insieme tarda ad accettare le lezioni d’una realtà decisamente non travisabile. Tarda come ha sempre fatto, per pigrizia e per paura. Dovendosi per altro attendere proprio dai rivoluzionari un’idea trasformativa della realtà, non la si può vedere nei pallidi riflessi di vecchie idee che furono in passato trasformative, ma che coinvolte nella gestione del potere hanno di poi, e qualche volta anche sùbito, perduto ogni possibilità attiva finendo nella più banale reattività. Gli attuali discorsi di un’opposizione politica scarsamente significativa non possono considerarsi, con il loro alone verdognolo ed ecologico, se non la ribattitura e la riaffermazione del verbo conservatore, il decisivo elemento di conferma.
Non essendoci più nulla contro cui reagire, il potere in carica non reagisce ma si limita a conservare, e questa conservazione diventa tanto più urgente, quanto più non si arriva a capire da quale lato può arrivare, e in che modo e con quali caratteristiche, l’inevitabile rivolta degli sfruttati, forse tanto più temibile quanto più incomprensibile. Così, è giusta la considerazione dei compagni che vedono nei movimenti dell’esercito italiano, progetti di occupazioni militare di intere regioni considerate, dal punto di vista statale, regioni a rischio d’instabilità sociale. Ma è anche riduttivo considerare gli stessi movimenti come occupazione militare e basta. L’esercito oggi non è “strumento” dello Stato, ma è lo Stato stesso che si muove, che si fa più Stato nel territorio, che perfeziona controllo e consenso, perché sa benissimo quanto fragile e inconsistente può essere l’impiego dello strumento militare tradizionale, non solo inadatto alle mutate condizioni della circolazione delle idee, e dello sviluppo delle coscienze, ma anche inadatto ai progetti specifici del moderno conservatorismo, riassumibili nel credo gestionario e compartecipativo. Proporre paragoni con intenzioni del passato, quindi anche slogan di lotta che prevedono una critica “tradizionale” al ruolo esclusivamente “militare” dell’esercito, è fuorviante, proprio perché lo Stato oggi s’indirizza a conservare in forme sempre differenti, a seconda della situazione storica e delle mutate condizioni politiche e sociali.
Allo stesso modo, pescando in altre acque e con altre esche, si possono fare interessanti riflessioni sui movimenti di destra che si propongono come la punta estrema di una più ampia fascia sociale che non accetta le sempre più massicce ondate d’immigrazione. Anche qui, l’antica paura del “negro” si mescola con l’immagine del “diverso”, confezionata con poca cura dagli organi di disinformazione. La Germania appare oggi come il terreno più adatto per la coltura di questo germe che sarebbe errato ricondurre a modelli del passato. I simboli nazisti non devono distogliere dalla realtà del problema. Non che il passato sia per sempre morto e sepolto, solo che quando si ripresenta, lo fa costantemente in forme del tutto differenti, capaci proprio di camuffare quell’eterno ritorno dello spettacolo umano delle miserie e delle sofferenze.
Lo scontro sarà durissimo, anche questa volta, ma non per la capacità militare di questi gruppi di ragazzacci esagitati, sulla cui inconsistenza in termini di idee e di progetti, fino a questo momento, non possono esserci dubbi, quanto per l’ampiezza e il significato sociale di quella fascia di perbenisti che sta seduta dietro, guardando dalla finestra gli incendi degli asili dove risiedono precariamente gli immigrati, ospiti non proprio desiderati dei paesi in cui l’opulenza rischia di diventare un mito del passato. Sconfiggere i musi duri non sarebbe difficile, vista la vigliaccheria che domina incontrastata dietro le spacconate dei cultori di arti marziali, ma difficile diventa se alle loro spalle si erge compatta quella maggioranza silenziosa che questa volta potrebbe avere un solido punto su cui poggiare le proprie paure: la crescita numericamente significativa di nuovi poveri, aggiunti ai vecchi, costituenti tutti insieme il nuovo, grande, instabile e indubbiamente pericoloso esercito dei possibili futuri ribelli. E il conservatore cerca sempre in tutti modi, anche quando utilizza le mazze del picchiatore fascista, di ricondurre lo strumento ai suoi minimi impieghi, allo scopo di ottenere un ordine sociale e un’evoluzione del processo storico che non siano catastrofici per i propri interessi.
Il benpensante è adesso egli stesso progressista, alla maniera migliore del termine, di quel progressivismo di facciata che sta attento al comportamento dell’altro, quando questo si dichiara volonteroso di restare nei limiti fissati dalle regole del gioco. Così il progressista, conservatore da sempre ma solo in tempi recentissimi così dichiaratosi, applica al proprio schema storico una sorta di effetto ritardante, un vero e proprio freno alle libidini velocistiche della storia. La fede nei destini futuri di libertà, ovviamente qui si tratta della propria libertà di star bene a spese degli altri, non viene a mancare, e illumina un’ideologia di legittimazione che spudoratamente si propone come punto di riferimento per ulteriori sacrifici.
Ancora una volta è l’uomo da salvare, l’uomo di cui sempre si parla avendo cura di non specificare di quale categoria sociale si tratta. Ne viene fuori la tragica necessità di staccare dall’umanità una parte che non merita fino in fondo questa qualificazione, allo scopo di poterla estraniare, ridurre alla condizione di sub-umanità, quindi oggetto di possibili emarginazioni autorizzate, persecuzioni, morte. Su questa china potrebbero rotolare tanti buonissimi pensieri umanitari, tante riflessioni autocritiche di antichi difensori di uccelletti e coccodrilli. In questo modo, e a questo livello con grande esattezza, si potrebbe guardare preoccupati al passato: ancora una volta la classe dominante potrebbe illudersi sull’utilizzo dello strumento fascista.
Ma, per quel che ci riguarda, non possiamo partecipare come pecore, ancora una volta, al coro del dissenso quotidianizzato, sconcertati e sdegnati per le passeggiate a base di svastiche e per gli assalti contro gli ostelli degli immigrati. L’indignazione è merce di lusso che non possiamo permetterci, e poi andrebbe fondata su di una critica diretta a dimostrare errata la tesi del destino sociale di determinati gruppi al posto di altri, tesi che non solo non esiste più, ma che viene usata, abbastanza raramente, solo come banalità propagandistica per accozzare gruppetti di teppisti e spingerli al lancio di qualche pietra. Scomparsa totalmente la cultura che reggeva il mito del destino dei popoli, i residui nostalgici che si trovano in circolazione non vanno al di là di una simbolistica da tifo calcistico, roba assolutamente innocua, per quanto possa puzzare di fogna.
La realtà è diversa. Grossi interessi premono perché si ponga un freno all’ingrossarsi di questo enorme serbatoio di latente ribellione. Le insurrezioni del futuro potrebbero benissimo fare impallidire, nell’efferatezza e nella ferocia, qualsiasi esperienza del passato. Non è lecito per il potere spingere grandi masse alla disperazione, e una delle strade da seguire per evitare spiacevoli conseguenze non è tanto quella di eccitare la xenofobia, quanto quella di racchiudere ogni gruppo etnico all’interno delle proprie strutture, in primo luogo la religione, sollecitando quella tendenza inconscia dell’uomo verso le forme tramandate dalla tradizione, ed evitando così l’inserimento in una società ospite non proprio in grado di largheggiare in ospitalità. La gestione di ghetti, meno appariscenti di quelli del passato, almeno sul piano del controllo, è stata sempre più facile di una situazione sociale frastagliata e variopinta. In questo senso, un effetto indotto del razzismo rinascente un po’ dappertutto, potrebbe essere quello di costruire, con la forza e con la paura, queste comunità chiuse, controllate da una propria polizia, dedite esclusivamente alla sopravvivenza e non disponibili a un discorso di collaborazione in vista di una lotta sociale sia pure rivendicativa e minimale.
La reazione conservativa a questi grandi movimenti che stanno invadendo la vecchia Europa, ma il discorso si potrebbe estendere a movimenti non proprio europei, è certo un processo di resistenza alle possibili modificazioni in atto, sia politiche che sociali, ma è anche un tentativo di mediare tra strutture classiche e possibili modelli di gestione allargata, con una partecipazione in funzione subalterna dei nuovi arrivati. Le varie decisioni politiche di questi ultimi anni, sia pure filtrate da nebbie ideologiche progressiste ormai stantie e qualche volta perfino patetiche, propongono questo progetto, tradizionalista ma fino a un certo punto: utilizzazione ma non integrazione. Che poi sarebbe progetto tutt’altro che indegno, in quanto politicamente corretto, perché l’integrazione assoluta non è soltanto un’utopia e un alibi, ma è precisamente una stupidaggine. In effetti, questi poveri in arrivo si allargano verso le fasce che si stanno definitivamente staccando, un po’ dappertutto, dalla salarizzazione, per andare incontro a un futuro estremamente flessibile e incerto. E questa comunità di interessi futura non potrà impedirsi da parte di nessuna forza conservatrice, mentre le intenzioni difensive del potere potranno soltanto limitarsi a circoscrivere e dividere le diverse componenti, in primo luogo gli immigrati, e ciò allo scopo di rendere più immediato ed efficace il controllo.
E, infine, ma non meno importante, il dilagante stimolo del nazionalismo. Qui il richiamo ideologico alla tradizione si fa più intenso, e spesso infittisce la nebbia che circonda l’ordine eterno della società, immaginato perfetto all’indietro, come se veramente ci fosse in quell’epoca lontana, intravista nel ricordo delle nostalgie, la traccia divina della natura, il soffio primigenio della purezza. Insisto nel notare, cosa che ho fatto altre volte, come queste imbarcate di antica civiltà procedono sempre appaiate con il rigetto di ogni formulazione teorica, di ogni approfondimento analitico. L’avversione dei nazionalisti alle astrazioni del pensiero teoretico non sono un’eccezione, ma una costante. Chi sostiene l’esistenza di una società naturale superiore a qualsiasi possibile società civile del presente, non si rende conto nemmeno delle necessità di una critica negativa dei modi in cui la ragione organizza questa società razionale, in quanto gli basta affidarsi a una visione organicamente superiore, quindi al di là di ogni precisazione teorica.
Quando si dimostra che l’unico modo corretto di avvicinarsi all’ineludibile problema delle rivendicazioni nazionali in termini di liberazione resta quello di calare nel concreto dello scontro sociale queste stesse rivendicazioni, sottraendole con ciò alle loro poco plausibili, ma presenti, matrici storiche e organiche, la conclusione diviene incerta, non sempre si è capaci di arrivare alle conclusioni che non ci sono valori nazionali assoluti, ma solo modi interpretativi di vedere la realtà, che poi non sono altro che problemi di potere. Questa semplice verità non riesce a farsi strada, mentre la grande varietà di polemiche che le ruotano attorno non fa altro che portare acqua al mulino della conservazione che, essa sì, ha tutto l’interesse a fissare la nazione come categoria ontologica e antropologica nello stesso tempo.
Solo alla luce del problema centrale del dominio si può capire la funzione e il contenuto dell’idea nazionalista. A volte veicolo di liberazione, mai totale per altro, a volte strumento di ricostituzione repressiva. I due aspetti non sono scindibili e camminano sempre appaiati. Uno degli scopi del dominio moderno è proprio quello di spezzare il nazionalismo spegnendone le istanze di fondo in un ideologico internazionalismo del capitale e dello sfruttamento planetario. Ma non si tratta di un progetto diametralmente opposto, quindi più ampio di quelli regionalmente periferici che caratterizzano la miriade dei nazionalismi contemporanei. Si tratta più che altro della dissoluzione di un antico progetto, anch’esso di dominio, mai condotto fino alle estreme conseguenze, neanche a opera del Terzo Reich. Oggi sappiamo che la storia del dominio tende a discostarsi dalla storia del nazionalismo, e questo, per ovvia conseguenza, tende a divergere dall’antica funzione di semplice sostrato dei movimenti politici di conquista. Pensare che il nazionalismo sia oggi riconducibile alle tesi che dappertutto lo dimostrano e lo sostengono, è vano se non si sanno cogliere, nello stesso tempo, i movimenti di potere che lo utilizzano e lo allontanano sulla base di progetti politici spesso nemmeno molto camuffati.
L’insieme di questi strumenti costituisce un miscuglio repressivo che manca di una chiara impronta teorica. Il conservatorismo non propone teorie degne di questo nome, incapace com’è di capire l’antinomia tra la struttura della società e la struttura del potere che vuole organizzarla e dominarla. Oggi, almeno così sembra, non vengono più messe in giro le giustificazioni “organiche” che una volta rendevano ammissibili le scelte di dominio, mentre, al contrario, va di moda un pragmatismo a volte perfino troppo spregiudicato, una teoria politica dell’aggiustamento che minaccia di diventare pratica amministrativa del giorno per giorno. Nessuno più si arrischia, dopo il crollo dell’ideologia del comunismo di Stato, a parlare in termini di progetto politico a lunga scadenza. Tutti si danno arie da grandi navigatori, mentre gli scogli, sempre vicini, della dittatura e della reazione, appaiono come pericoli che è nell’interesse di ognuno evitare. Bisogna vedere in che modo questi pericoli potranno essere evitati, in quanto a breve essi appaiono tutt’altro che improbabili.
Il fatto è che i gestori del dominio, una volta privi di una propria dottrina speculativa del potere, di una filosofia sufficientemente articolata, non si preoccupano molto degli aspetti repressivi che di volta in volta prendono gli strumenti impiegati, purché il risultato sia assicurato: controllo e consenso. Essi pensano che non avendo di fronte un corpo organico di opposizione, dottrinariamente organizzato, non ci siano pericoli duraturi, non ci sia la possibilità di una dittatura vera e propria. Per contro, s’illudono di essere sufficientemente forti per controllare e eventualmente reprimere le possibili rivolte disorganizzate, le rivolte anarchiche della disperazione e della vendetta. E qui l’errore potrebbe anche essere in ambedue gli aspetti, sia riguardo l’uso di possibili strumenti repressivi, sia riguardo gli esiti di possibili movimenti insurrezionali di liberazione.
Messa in soffitta l’idea, e quindi anche lo spauracchio, di una guerra totale, si afferma la concreta esperienza quotidiana della guerra parziale, dove il nazionalismo gioca il suo insostituibile ruolo. L’antica politica di potenza si rivernicia delle bellezze insite nella dimensione “piccola”. Nessun concetto, per quanto straordinariamente sovversivo, sfugge alla sua versione recuperatrice, ogni Don Chisciotte lamenta il suo Sancio. La guerra “piccola”, non è affatto una “piccola guerra”, e ammazza uomini, donne e bambini a centinaia di migliaia con procedimenti tecnologici avanzati. Come una cavia nella propria gabbia l’uomo cerca di sfuggire a un meccanismo di cui è prigioniero, ma nessuna porta si può aprire sull’attimo, l’Augenblick niciano non segna nessuna decisione effettiva dell’individuo, non provoca trasformazioni degne di questo nome, appare, almeno a prima vista, come l’inizio di una serie infinita di porte, di soglie da superare, di prove da sostenere, senza fine prevedibile, e poi, all’improvviso, un meccanismo ignoto a tutti, sotterraneo ma non cosciente di sé, né tanto meno dotato di progetto e visione politica della realtà, viene alla luce e sconfigge quelle sostanziali inutilità, producendo la decisione vera e propria, facendo nascere i frutti non dischiusi di antiche decisioni rimaste latenti, come assonnate e distratte. Improvvisamente tutto rifiorisce, quella porta viene varcata, l’Augenblick si rivela lo schioccare delle dita che risveglia dal sonno ipnotico, e le danze riprendono, il sogno diventa realtà.
L’unico insegnamento, diciamo sicuro al di là di ogni possibile dubbio, è dato dalla difficoltà di trovare un punto fermo, un luogo delle certezze ideologiche, un modulo “fondazionale” simile a quelli che ci hanno accompagnato e, forse, perseguitato negli ultimi vent’anni [1992]. Paradossalmente, il riconoscimento delle proprie limitazioni non produce avvenimenti disastrosi, almeno in persone coscienti delle proprie possibilità e dell’importanza delle cose da fare. Venendo a mancare la carota davanti al naso, si diventa più affilati, perfino più cattivi, e non si è più disposti a barattare agevolmente azioni contro illusioni. La presa del palazzo d’inverno si è fortunatamente conclusa, gli ultimi rimasti dentro sono stati costretti a uscire alla chetichella, senza nemmeno l’onore dell’applauso d’addio, che non si lesina all’ultimo guitto. La loro recita è stata troppo atroce per meritare una sola lacrima di commiserazione. E con loro anche noi, da sempre contrari, violentemente e ferocemente contrari, ci siamo liberati di un’illusione, ché le illusioni sono dure a morire. Le nostre aspettative adesso sono più limitate, ma per questo più reali, più adeguate alla realtà, ferocemente penalizzante di ogni ritardo in altri tempi giustificato in tanti modi, tutti prosperosamente addobbati a festa.
È venuto il tempo della mezza luce, quando torna a volare alto l’uccello di Minerva. In un’atmosfera esagitata, dove il metro della velocità tende a trascinarci tutti, questo volo potrebbe passare inosservato. E sarebbe un gran danno.
[Pubblicato su “Anarchismo” n. 70, settembre 1992, pp. 1-6 col titolo “Della conservazione”]
Cercasi buddisti
Un’azienda di Livorno, impegnata nel settore pubblicitario, ha messo un’inserzione su “Il Tirreno” con la quale si cercavano impiegati con un’ottima conoscenza dell’inglese e del francese, ma esclusivamente di religione buddista. I motivi di questa scelta pregiudiziale sono elencati dagli stessi dirigenti dell’azienda. I buddisti hanno alcune importanti qualità: resistenza alla fatica intellettuale, capacità di concentrazione, capacità di intessere buoni rapporti con gli altri, serenità interiore e doti di introspezione.
In effetti la scelta non è stupida. I buddisti, la maggior parte dei quali vengono reclutati fra i delusi dell’ultrasinistra in vena di recupero (per prima cosa di se stessi), garantiscono una perfetta aderenza agli ordini dell’azienda per cui lavorano, uno spirito di adattamento, e, prima di ogni cosa, il rifiuto di ogni pretesa sovversiva o di lotta sociale.
Se l’insegnamento del buddismo, anche nella versione di casa nostra, mutuata dal Giappone, resta il rifiuto del desiderio come causa del dolore, esso può andare perfettamente d’accordo col desiderio dei padroni di comandare e sfruttare, desiderio che (i buddisti ne sono certi) arrecherà in futuro ai padroni stessi grande dolore, per cui al momento questi ultimi sono più da commiserare che da combattere.
E i dirigenti di azienda, cosa potrebbero scegliere di meglio?
[Pubblicato su “Canenero” n. 5, 25 novembre 1994, p. 4]
Controllo sociale
Il dibattito attuale sul problema del “controllo sociale” si è quasi sempre fondato su di un equivoco, spesso alimentato da una scarsa capacità di approfondimento.
Dato per certo che il problema del “controllo” diventa centrale per lo Stato e per il capitale solo come condizione primaria per il reperimento del “consenso”, non si vede perché il controllo debba essere interpretato – come alcuni fanno – solo in termini di capacità tecniche.
Non c’è dubbio che lo Stato possiede apparecchiature che prima nessuno immaginava e che queste apparecchiature possono controllare più agevolmente. Ma non c’è neanche dubbio che lo Stato, da per se stesso, è un’astrazione. Noi lo pensiamo costituito da uomini, i quali, per quante apparecchiature possiedano, sempre uomini sono e sempre difetti e limitazioni avranno.
Se la cosa si vede da questa angolatura non si arriverà alla strana conclusione della “fine dell’epoca del segreto”.
Ma di quale segreto?
Quando mai il movimento anarchico ha scelto, di sua propria volontà, la strada della clandestinità? Ma, per un altro verso, cosa potrebbe mai voler dire che di fronte all’attuale strapotere di controllo dello Stato dobbiamo fare tutto alla luce del sole?
Ci sono cose che sono da farsi alla luce del sole, come a esempio la propaganda, lo sviluppo del movimento nel suo insieme, la controinformazione, le lotte sociali, ecc., ma ci sono cose che necessitano di una cautela, che non possono essere fatte sapere a tutti. Ciò non contraddice affatto ai principi dell’anarchismo. Infatti, anarchia non è stata mai sinonimo di ingenuità o, peggio ancora, di stupidità. Ci sono lotte che il potere non deve conoscere se non a risultato ottenuto. E non vale l’obiezione che, allo stato attuale, il livello di controllo rende impossibili queste lotte, perché questa obiezione può, al massimo, avere il valore di un richiamo a una maggiore prudenza, a un maggiore spirito di autocritica, ecc., al di là di questo livello, nel caso si insistesse troppo, tutto finirebbe per andare a finire in un vuoto e generico invito alla desistenza.
I compagni sono tutti altamente responsabili. Sanno tutti cosa vuol dire una lotta e cosa vuol dire una lotta che ha caratteristiche diverse. Nell’impegnarsi in un senso o nell’altro sanno perfettamente il livello di pericolosità cui vanno incontro e, quindi, scelgono i mezzi che ritengono più opportuni.
Un’analisi che faccia vedere i moderni mezzi di controllo è certamente utile, perché da essa i compagni traggono insegnamenti validi per fare maggiore attenzione nel proprio lavoro. Ma quando questa indagine travalica il campo che le è proprio, cioè quello della documentazione, e minaccia di diventare esortativa, didascalica, pedagogica, allora il risultato non è diverso da quello di un semplice e diretto invito a deporre le armi, a smettere di lottare, a desistere.
[Pubblicato su “Anarchismo” n. 52, maggio 1986, p. 26 col titolo “Ma è vero che il controllo sociale è ormai completo?”]
Coscienza
Due correnti interpretative si contrappongono più o meno nella storia del pensiero per quanto riguarda il significato di coscienza. Il senso di “consapevolezza”, con le caratteristiche di esteriorità e oggettività, si contrappone al senso di “coscienza morale”, con le caratteristiche di interiorità e di soggettività.
È ovvio che lo sviluppo di queste due correnti non è sempre parallelo come non sempre è possibile individuare l’appartenenza di un’interpretazione a una corrente specifica. Spesso le cose si imbrogliano, mentre gli stessi filosofi hanno spesso un interesse preciso (appunto, di classe) a imbrogliarle sempre più. Platone e Aristotele ignorano praticamente una nozione di coscienza, sia in un senso che nell’altro, e con essi tutto il pensiero greco fino allo stoicismo. La filosofia greca non ha mai sviluppato il concetto di coscienza. Solo in alcuni passi di Platone viene preso il problema dell’anima che dialoga con se stessa. «[...] la conoscenza [...] la cercheremo nel processo, qualunque nome esso abbia, quando l’anima si affatica da sé sola essa stessa intorno a ciò che è». (Platone, Teeteto, 187,a). Allo stesso modo per Aristotele non esiste una quale che sia attività contrapposta all’esteriorità delle percezioni sensibili. «[...] il pensare è il pensiero in atto [...] è il pensiero che pensa se stesso [...] pensiero di pensiero. È chiaro che la scienza, la sensazione, l’opinione e il pensiero si riferiscono sempre a qualche cosa diversa da sé, e a se stessi soltanto in via secondaria». (Aristotele, La Metafisica, 1074b, 30-35).
La coscienza come “realtà interiore” appare timidamente alle origini del pensiero neoplatonico e diventa riflessione matura soltanto con Plotino. La differenza tra i due significati (interno ed esterno) è ampiamente trattata da questo filosofo sebbene con la specifica intenzione di fondare la possibilità di conoscere il Bello (e quindi Dio). Il riconoscimento di una sfera interiore nell’uomo avviene contemporaneamente all’idea di una “contraddizione” tra questa sfera e quel mondo esterno su cui si era fermata l’attenzione di tutti i pensatori. Questo riconoscimento si ha con lo stoicismo ma trova completa maturità solo con Plotino. Il concetto che questo pensatore sviluppa al massimo grado è quello di “anima”, ma sostanzialmente nei suoi scritti si trova la prima formulazione coerente e completa del concetto di coscienza. «L’anima è una, e le molte si riconducono a lei in quanto una, che si concede e non si concede alla molteplicità. Poiché è capace di porgersi a tutti e restare una». (Plotino, Enneadi, IV, 9, 5). «Divisibile, poiché è in tutte le parti dell’essere in cui è, ma indivisibile, perché è tutto e tutta in qualsiasi parte di esso [...]. Resta tutta in sé, ma è divisa nei corpi, non potendo i corpi, per la loro propria divisibilità, accoglierla indivisibile». (Ib., IV, 2, 1). «Bisognava che ci fossero molte anime e un’anima sola, e che dall’unica venissero le molte differenti, come da un unico genere la specie [...]». (Ib., IV, 8 3). «Assolutamente nessuna delle parti dell’anima né l’anima intera si deve dire che sia nel corpo come in un luogo. Il luogo è ciò che contiene e comprende il corpo [...]; l’anima non è corpo, né contenuto più che contenente [...]. E neppure vi è come parte nel tutto; perché l’anima non è parte del corpo [...]. Né come forma della materia, quando l’anima è presente nel corpo, vi sia presente come la luce nell’aria?». (Ib., IV, 3, 22). «L’anima dunque, non è nel mondo, ma il mondo in lei, ché non il corpo è luogo dell’anima; ma l’anima è nell’Intelletto, e l’Intelletto in altro». (Ib., V, 5, 9). «E l’anima, avendo in sé le idee degli esseri, ha in sé tutte le cose insieme». (Ib., III, 6, 18). «Pensi bene [...] ogni anima che proprio essa fece i viventi tutti, spirando in loro la vita, e quei viventi che nutre la terra e quelli che nutre il mare e quelli che dimorano nell’aria e nel cielo – astri divini –; che essa ha fatto il sole e l’immenso cielo e lo ha ordinato [...]. Tutto, con tutta se stessa vivifica, ed è presente tutta ovunque [...]. E il cielo, pur essendo molteplice e diverso nelle sue parti, è uno per la potenza di essa, e per essa è dio questo mondo». (Ib., V, 1,2).
Il cristianesimo riprende una parte delle argomentazioni di Plotino e le sviluppa particolarmente con Agostino e Tommaso. Con Agostino l’approfondimento del concetto di coscienza raggiunge notevoli livelli, basta pensare al problema del tempo che viene riportato interamente a fatto soggettivo e ciò per la prima volta nella storia del pensiero. Egli scrive: «Non uscire da te, ritorna in te stesso, nell’interno dell’uomo abita la verità; e se troverai mutevole la tua natura, trascendi anche te stesso». (Agostino, De vera religione, 39). E altrove: «Niente infatti la mente conosce così bene come ciò che le è più accessibile e niente è alla mente così vicino come essa a se stessa». (Agostino, De trinitate, XIV, 7).
Su di un altro livello, senz’altro più modesto di quello di Agostino, per quel che riguarda il nostro problema, si pone Tommaso. La sua interpretazione è legata al tentativo di ricucitura aristotelico. Egli scrive: «La nostra mente conosce se stessa di per se stessa in quanto conosce la sua propria esistenza: infatti, in quanto percepisce la sua propria attività, percepisce la sua propria esistenza». (Tommaso, Summa contra gentiles, III, 46).
Il Rinascimento approfondisce invece il problema di come la coscienza interna sia condizione per comprendere la realtà e quindi elemento essenziale della coscienza esterna. In questo senso Telesio: «Il senso è la percezione delle azioni o delle cose, degli impulsi dell’aria, nonché delle proprie affezioni, delle proprie modificazioni e dei propri movimenti; e soprattutto di questi. Il senso infatti percepisce quelle azioni, solo in quanto percepisce di essere influenzato, modificato e commosso da esse». (De rerum natura, VII, 3).
La sistemazione razionalista moderna comincia con Cartesio per cui la coscienza non diventa un accadimento ma l’insieme della vita spirituale dell’uomo. In diversi punti della sua opera Descartes svolge il problema della coscienza. Nei Principia philosophiae scrive: «Col nome di pensiero intendo tutte quelle cose che avvengono in noi con coscienza, in quanto ne abbiamo coscienza. Così non solo intendere, volere, immaginare, ma anche sentire è qui lo stesso che pensare. Giacché se io dico: io vedo o io cammino perciò sono e intendo parlare della visione o del camminare che si fa col corpo, la conclusione non è assolutamente certa; perché, come spesso avviene nei sogni, posso credere di vedere o di camminare sebbene non apra gli occhi né mi muova dal posto e forse anche senza che abbia alcun corpo. Ma se intendo parlare dello stesso senso, cioè della coscienza di vedere o di camminare, la conclusione è certa perché allora si riferisce alla mente, che solo sente o pensa di vedere o di camminare». (1, 9). Su questa base di razionale evidenza della coscienza a se stessa si fonderà buona parte dello sviluppo del pensiero occidentale.
Kant in un certo senso ribalta la posizione rinascimentale e porta la coscienza esterna alla base della comprensione della coscienza interna. Si prospetta così il primo vero e proprio tentativo di trovare all’esterno un fondamento concreto della coscienza. La sua critica dell’idealismo, come viene sviluppata in una famosa nota alla Prefazione alla seconda edizione della Critica della ragione pura, suona così: «[...] io sono cosciente della mia esistenza nel tempo (e quindi anche della determinabilità di questa esistenza nel tempo) attraverso un’esperienza interna: ciò è qualcosa di più dell’essere semplicemente cosciente della mia rappresentazione, ed è invece la stessa cosa della coscienza empirica del mio esistere, il quale è determinabile soltanto mediante un riferimento a qualcosa, che al di fuori di me è legato con la mia esistenza. Questa coscienza della mia esistenza nel tempo è quindi identicamente legata con la coscienza di una relazione a qualcosa fuori di me, e ciò che connette inscindibilmente l’esterno con il mio senso interno è dunque esperienza e non finzione, senso e non capacità di immaginazione. Il senso esterno, infatti, già in sé è riferimento dell’intuizione a qualcosa di reale fuori di me, e la realtà del senso esterno, a differenza dall’immaginazione, si fonda soltanto sul fatto che esso è inscindibilmente legato con la stessa esperienza interna, in quanto condizione della possibilità di quest’ultima: il che si verifica nel caso in questione». (24, 3).
La posizione di Hegel è più significativa delle altre in questo svolgimento storico del concetto di coscienza, in quanto egli pone al centro della propria filosofia la coscienza stessa, anzi la coscienza come concetto. La sua pretesa non è quella di riflettere “sulla coscienza”, come egli afferma hanno fatto tutti i pensatori, almeno da Kant a Fichte, ma di superare questo livello per trasformare la coscienza in scienza oggettiva e assoluta. In contrapposizione Hegel, riprende il patrimonio plotiniano rivissuto attraverso le riflessioni dei mistici tedeschi della Riforma, stravolgendone però il significato e indirizzandolo a una nuova concezione del potere assoluto. Così egli scrive: «L’esperienza, che la coscienza ha di sé non può, secondo il concetto dell’esperienza stessa, comprendere in sé meno dell’intero sistema della coscienza ossia dell’intero regno dello spirito [...]. Sospingendo la coscienza [...] verso la sua esistenza vera, raggiungerà un punto dove si libera dall’apparenza di essere inficiata da qualcosa di estraneo che sia soltanto per lei come un altro: un punto in cui l’apparenza diviene uguale all’essenza». (La fenomenologia dello spirito, 1, Conclusione dell’Introduzione). In sostanza Hegel non pone le basi per la costruzione di una coscienza oggettiva o di una coscienza esterna, nel senso visto prima, capace di contrapporsi a una coscienza interna. Egli risolve il tutto; ricorrendo al meccanismo dialettico, all’interno della stessa coscienza (intesa come coscienza interna), ponendo in relazione la coscienza con il concetto di coscienza o autocoscienza, e illudendosi che questa relazione sia in grado di spezzare lo sviluppo parallelo dei due significati di coscienza.
Dopo Hegel il problema si divide sostanzialmente in tre strade interpretative. La prima corrisponde all’oggettivismo marxista e propone una valutazione strumentale del progetto hegeliano allo scopo di inserire un elemento psicologico all’interno della valutazione operativa delle possibilità oggettive della classe degli sfruttati.
In quasi nessun punto della sua vasta opera Marx tratta in modo esplicito del concetto di coscienza di classe. Il più delle volte il fatto dell’oggettività del movimento storico, con la massima espressione costituita dal processo di valorizzazione, si coglie tra le righe. Più volte Marx parla di qualcosa che la gente, o le classi, fanno senza volerlo (a esempio i passi dedicati ad Aristotele e a Franklin nel primo capitolo del primo libro del Capitale). In modo più chiaro precisa la sua posizione nei confronti di Hegel nel Poscritto alla seconda edizione del Capitale, dove scrive: «[...] mentre elaboravo il primo volume del Capitale i molesti, presuntuosi e mediocri epigoni che ora dominano nella Germania colta si compiacevano di trattare Hegel come ai tempi di Lessing il bravo Moses Mendelssohn trattava Spinoza: come un “cane morto”. Perciò mi sono professato apertamente scolaro di quel grande pensatore, e ho perfino civettato qua e là, nel capitolo sulla teoria del valore, col modo di esprimersi che gli era peculiare. La mistificazione alla quale soggiace la dialettica nelle mani di Hegel non toglie in nessun modo che egli sia stato il primo a esporre ampiamente e consapevolmente le forme generali del movimento della dialettica stessa. In lui essa è capovolta. Bisogna rovesciarla per scoprire il nocciolo razionale entro il guscio mistico». (Parte finale).
Un esempio ancora più chiaro di questo meccanismo oggettivo Marx lo dà in una breve analisi sul proletariato: «Le condizioni economiche avevano dapprima trasformato la massa della popolazione del paese in lavoratori. La dominazione del capitale ha creato a questa massa una situazione comune, interessi comuni. Così questa massa è già una classe nei confronti del capitale, ma non ancora per se stessa. Nella lotta, della quale abbiamo segnalato solo alcune fasi, questa massa si riunisce, si costituisce in classe per se stessa. Gli interessi che essa difende diventano interessi di classe. Ma la lotta di classe contro classe è una lotta politica». (Miseria della filosofia, tr. it., Roma 1950, p. 139).
La definizione marxista più nota di coscienza di classe è quella di Lukács: «[...] la coscienza di classe è la reazione razionalmente adeguata che viene in questo attribuita di diritto a una determinata situazione tipica nel processo di produzione. Questa coscienza non è quindi né la somma né la media di ciò che pensano, sentono, ecc., i singoli individui che formano la classe. E tuttavia l’agire storicamente significativo della classe come totalità viene determinato, in ultima analisi, da questa coscienza, e non dal pensiero del singolo, ed è conoscibile soltanto a partire da essa». (Storia e coscienza di classe, tr. it., Milano 1971, p. 66). La tesi di Lukács si fonda sull’analisi del concetto di totalità che viene definita come “l’essenza del metodo di Marx”. (Ib., p. 35).
La seconda strada interpretativa corrisponde alla riflessione mistica della coscienza interna e trova il suo massimo rappresentante moderno in Bergson; essa riporta la coscienza al livello della introspezione ma si preoccupa di rilanciarla a una concezione globale (ma non totale) del movimento generale della vita. La concezione “globale” di Bergson tiene conto della compresenza del tutto nella singola realtà, ma, spesso, per la componente vitalistica e biologica, le sue analisi perdono di vista il senso realmente modificativo della totalità e scadono nel senso limitatamente interpretativo della globalità. Questa seconda interpretazione corrisponde a un interessante tentativo di dare fondamento alla coscienza individuale dal punto di vista della globalità dei fenomeni e raggruppa quel sentimento cosmico di cui una parte della borghesia venne a soffrire alla vigilia della prima guerra mondiale. Scrive Bergson: «In tutta l’estensione del regno animale, diciamo, la coscienza appare come proporzionale alla potenza di scelta di cui l’essere vivente dispone. Essa rischiara la zona di vitalità che circonda l’atto. Essa misura la differenza tra ciò che si fa e ciò che si potrebbe fare. Considerandola dall’esterno, la si potrebbe prendere quindi per un semplice accidente dell’azione, per una luce che l’azione stessa accende, scintilla fuggitiva che sgorga dallo scontro tra l’azione reale e le azioni possibili [...]. L’evoluzione della vita, considerata da questo punto di vista, prende un senso più netto, per quanto non la si possa ancora sussumere come una vera e propria idea. Tutto accade come se una larga corrente di coscienza penetri nella materia, carica, come ogni coscienza, di una molteplicità enorme di virtualità che si penetrano reciprocamente [...]. Da questo punto di vista, non solo la coscienza appare come il principio motore dell’evoluzione, ma di più, tra gli esseri coscienti l’uomo viene a occupare un posto privilegiato». (L’évolution créatrice, ns. tr., Paris 1948, pp. 180-183).
La terza strada interpretativa corrisponde sempre a una versione della coscienza interna, e trova alimento nel lavoro di Husserl che sviluppa il concetto di intenzionalità della coscienza come pulsione verso l’esterno, cioè verso qualcosa che non è facente parte della coscienza interna. Scrive Husserl: «Un sentimento non apparisce per adombramenti. Se getto il mio sguardo su di esso ho qualcosa di assoluto, privo di aspetti che potrebbero presentarsi tanto in un modo che in un altro». (Idee per una fenomenologia pura e una filosofia fenomenologica, tr. it., Torino 1965, par. 44). «Per quanto la mia corrente di coscienza non venga afferrata che in ristretta misura, per quanto sia sconosciuta nelle parti già scorse o ancora a venire, tuttavia, gettando lo sguardo sul suo effettivo presente e cogliendo me stesso quale puro oggetto di questa vita, necessariamente affermo: io sono, questo vivere è, io vivo: cogito». (Ib., par. 46). «L’intero mondo spazio-temporale al quale l’uomo e l’io umano appartengono come singole realtà subordinate è, secondo il suo senso, un essere puramente intenzionale, in quanto ha il suo senso meramente secondario e relativo di un essere per una coscienza. È un essere che la coscienza pone nelle sue esperienze, che è visibile e determinabile soltanto in quanto rimane identico nella molteplicità delle apparizioni, ma, all’infuori di questo, è un nulla». (Ib., par. 49). Dal lavoro di Husserl si sviluppano due interpretazioni: l’interpretazione soggettivistica (Jaspers e Sartre) e l’interpretazione oggettivistica (Heidegger).
Jaspers è uno dei teorici più consequenziali di questo ruolo soggettivo della coscienza. «La coscienza è coscienza intenzionale, cioè coscienza che si relaziona agli oggetti, ma non come due cose che entrano in contatto tra loro, perché la coscienza non possiede con le cose alcun rapporto né casuale, né reciproco, come invece accade tra due entità omogenee su un piano. Il modo di relazionarsi della coscienza prevede, piuttosto, che io, in essa, abbia un oggetto davanti a me [...]. La coscienza riflette su se stessa. Essa non si esaurisce nella direzione intenzionale agli oggetti, ma, ripiegandosi, è in grado di riflettere su se stessa; come tale, non è solo coscienza, ma anche autocoscienza. La riflessione della coscienza su se stessa è evidente e sorprendente come l’intenzionalità. Rivolto a me stesso, sono a un tempo unità e dualità. Il mio esserci non è come quello delle cose ma, scindendosi intimamente, diventa per me oggetto, quindi movimento e inquietudine interiore. Non si deve pensare la coscienza come qualcosa di stabile e consistente. Se la considerassi come essere mi sfuggirebbe, perché l’essere della coscienza non è come quello delle cose spaziali e ideali di cui mi occupo e che posso determinare e oggettivare nei termini in cui si presentano. La coscienza, mentre apprende gli oggetti come qualcosa d’altro, apprende se stessa come oggetto, solo in quanto coincide con la sua oggettivazione». (Filosofia, tr. it., Torino 1978, p. 118).
Sartre, invece, con una mossa tipica della dialettica di cui il marxismo ci ha dato ottimi esempi di mistificazione, pretende di fondare l’oggettività attraverso la negazione della stessa oggettività interiore della coscienza, e ciò a seguito della dichiarazione che “essere” e “nulla” si identificano. Così egli scrive: «La scissione intracoscienziale è nulla al di fuori di ciò che essa nega e non può aver l’essere che in quanto non la si vede. Questo negativo, che è il nulla d’essere, è insieme un potere nullificante, è il nulla. In nessun posto potremmo attingerlo in una simile purezza. Dappertutto, altrove, bisogna in un modo o nell’altro conferirgli l’essere in sé in quanto nulla». (L’essere e il nulla, tr. it., Milano 1958, p. 120).
L’analisi di Heidegger si presenta come un attacco radicale alle forme della coscienza interpretate dal pensiero filosofico, alle linee evolutive esaminate nelle note precedenti. Nello sforzo di oggettivare la coscienza partendo dal presupposto dell’intenzionalità della metafisica di Husserl, Heidegger sostanzialmente la porta alle sue estreme conseguenze, mostrandone i limiti e il fallimento in modo più chiaro di quanto non accada al “marxista” Sartre. Egli scrive. «Del discorso fa parte ciò-di-cui il discorso discorre. Il discorso informa su qualcosa e per un determinato riguardo. Da ciò su cui il discorso verte deriva ciò che il discorso dice in quanto è questo discorso: ciò che è detto come tale. Nel discorso, in quanto comunicazione, ciò che è detto è reso accessibile agli Altri e, per lo più, nella forma dell’espressione linguistica. Nella chiamata della coscienza, cos’è ciò di cui si discorre? Cioè, chi è chiamato nel richiamo? Manifestamente l’Esserci stesso [...]. Ma in che consiste ciò-che-vien-detto in questo discorso? Che cosa dice la coscienza nel suo chiamare il richiamato? Esattamente nulla. La chiamata non afferma nulla, non dà alcuna informazione sugli eventi mondani, non ha nulla da dire. Essa non si propone affatto di suscitare nel se-Stesso richiamato un “colloquio con se stesso”; al se-Stesso richiamato non è detto “nulla”; esso è semplicemente ridestato a se-Stesso, cioè al suo proprio poter essere». (Essere e tempo, tr. it., Torino 1978, p. 56).
Questa terza strada, in tutte le sue varianti, rappresenta la crisi vera e propria del pensiero borghese e, quindi, l’espressione più chiara ed evidente della sua falsa coscienza. Questa crisi, che naturalmente trova riscontro in molti altri concetti filosofici e nelle interpretazioni corrispondenti (a esempio il concetto di verità, di conoscenza, di razionalità, di progresso, ecc.), si riflette – allo stato attuale – anche all’interno del movimento rivoluzionario che – com’è inevitabile – mutua e filtra una grandissima quantità di concetti provenienti dai laboratori accademici.
Accade molto spesso che coscienza di classe venga impiegato come concetto con diversi significati, per cui chi lo usa – secondo come più gli conviene – accentua ora l’uno ora l’altro di questi significati, finendo per dare falso fondamento a quello che dice e inattendibilità alle conclusioni cui giunge.
Elenchiamo qui di seguito gli usi più comuni, tutti contraddittori tra di loro, e tutti facenti capo a un diverso impianto ideologico che fornisce una specie di giustificazione a priori.
Significato interno individuale. È quello di un rapporto che il singolo ha con se stesso, in quanto vede riflesse dentro di sé le condizioni della classe cui appartiene. Così egli conosce se stesso e la classe, valuta le distanze che lo separano da una sua corretta collocazione all’interno della classe, e giudica quanto è necessario fare per adeguarsi alla reazione media della classe cui appartiene. Resta legata a questa visione idealista del problema l’interpretazione fornita da Gramsci. La sua preoccupazione di sviluppare un’analisi della coscienza di classe che parta dalla coscienza del singolo ricorda molto le preoccupazioni che oggi [1981] serpeggiano all’interno dei pensatori ufficiali del PCI. Parlando del posto esatto da assegnare alla natura dell’uomo nel conflitto della storia egli scriveva: «Che l’uomo non possa concepirsi altro che vivente in società è luogo comune, tuttavia non se ne traggono tutte le conseguenze necessarie anche individuali: che una determinata società umana presupponga una determinata società delle cose e che la società umana sia possibile solo in quanto esiste una determina società delle cose è anche luogo comune. È vero che finora a questi organismi ultra individuali è stato dato un significato meccanicistico e deterministico [...] quindi la reazione. Bisogna elaborare una dottrina in cui tutti questi rapporti sono attivi e in movimento, fissando ben chiaro che sede di questa attività è la coscienza dell’uomo singolo che conosce, vuole, ammira; crea, in quanto già conosce, vuole, ammira, crea, ecc. e si concepisce non isolato ma ricco di possibilità offertegli dagli altri uomini e dalla società delle cose di cui non può non avere una certa conoscenza». (Il materialismo storico e la filosofia di Benedetto Croce, Roma 1971, p. 34).
Una critica a Gramsci in questo senso viene anche da parte marxista. A esempio Lucien Sève, pur accettando il rapporto gramsciano uomo-storia, critica la sede della coscienza individuale come punto di partenza per una dottrina che riesce a fondare l’uomo. Questo studioso scrive: «La psicologia della personalità [...] [deve] elaborare, a partire dalla teoria delle corrispondenti forme di individualità, la teoria dei rapporti e dei processi nel cui ambito si produce una personalità concreta. Questa tipologia beninteso non può in alcun modo essere concepita come astrattamente generale e storicamente invariabile, se non si vuol ricadere indirettamente nel naturalismo. Ogni formazione sociale implica le proprie forme di individualità le quali a loro volta, nella misura in cui determinano funzionalmente le strutture della personalità, definiscono la tipologia di quest’ultima. Così i rapporti e le forme di individualità del capitalismo implicano una tipologia della personalità in cui, per esempio, l’attività sociale astratta assume un ruolo mediatore determinante tra l’attività psichica concreta e la soddisfazione dei bisogni». (Marxismo e teoria della personalità, tr. it., Torino 1973, p. 302).
Cogliendo involontariamente il rapporto che passa tra illusioni idealistiche del ruolo delle classi e posizione teorica oggettivistica della teoria economica marxista (da cui deriva la tesi della centralità della classe operaia), alcuni autori scrivevano: «Questa concezione gramsciana ha un grosso valore per la psicologia del lavoro, ma è anche, e non casualmente, l’elemento centrale di una visione della storia che prevede la possibilità e la necessità dell’egemonia della classe operaia, relativamente alla soluzione dei problemi della società, ivi compresi (e soprattutto) quelli dei modi di produzione (prima, durante e dopo la presa del potere)». (I. Oddone, A. Re e G. Briante, Esperienza operaia, coscienza di classe e psicologia del lavoro, Torino 1977, pp. 282-283).
Significato esterno oggettivo. È il rapporto che la classe ha con se stessa. Il concetto è dinamico, in quanto può variare, sempre oggettivamente, in intensità e in estensione. Anche la sua adeguatezza può variare, ma ciò soltanto in relazione a un ipotetico punto ottimale definito raggiungibile a priori. Questo significato ha molti punti di contatto con l’analisi marxista e, di fatto, viene spesso confuso con il significato sviluppato da quella analisi. In effetti, come accade qualche volta, per questo significato non ci sarebbe nemmeno il bisogno di impiegare il termine “classe”. Uno dei primi teorici di questa interpretazione è Max Weber: «Noi parleremo di “classe” – egli scrive – quando a una pluralità di uomini è comune una specifica componente causale delle loro possibilità di vita, nella misura in cui questa componente è rappresentata semplicemente da interessi economici di possesso e di guadagno – nelle condizioni del mercato dei beni o del lavoro (“situazione di classe”)». (Economia e società, tr. it., Milano 1961, vol. II, p. 229).
Molto più chiaro appare l’estensore della voce “stratificazione” dell’Enciclopedia Feltrinelli Fischer, Karl-Martin Bolte: «Mentre nella società fondata sui ceti l’idea dominante richiedeva che esistesse un certo parallelismo tra la stratificazione di fatto e la coscienza di strato, l’attuale riconoscimento della necessità delle differenziazioni funzionali non permette evidentemente la diffusione di una idea uniforme degli strati sociali. Indagini recenti hanno mostrato che la coscienza della differenziazione sociale si distingue in diverse categorie (più di dieci). Alcuni concepiscono le differenze sociali come differenze di reddito; secondo altri, si tratta di stratificazioni professionali; altri non pensano in termini di strati sociali globali». (Stratificazione, in Sociologia, vol. V della Enciclopedia Feltrinelli Fischer a cura di R. König e L. Gallino, Milano 1967, p. 350).
Significato contraddittorio parziale. È quello di un bilancio tra la coscienza di classe interna individuale e la coscienza di classe esterna oggettiva, cioè tra i due significati visti prima, da cui emergerebbe una coscienza di classe fluttuante e inadeguata all’oggettività presunta del significato esterno.
Anche questo significato, provvisto di caratteristiche riformiste e razionaliste, è stato trattato sia sul fronte marxista (e revisionista) che sul fronte liberale e neo-liberale. Scriveva Bernstein: «Ma oggigiorno le classi stesse non sono qualcosa di rigidamente chiuso, le loro frontiere sono delimitate in modo tutt’altro che rigoroso. Su un piano puramente esteriore la statistica professionale ci permette di riconoscere tutt’al più per grandi linee il rapporto quantitativo esistente tra le diverse classi, ma nessuna statistica sui redditi, nessuna statistica professionale può determinare con precisione le frontiere dell’effettiva divisione di classe, poiché proprio nelle regioni di frontiera corrono nell’una e nell’altra direzione infiniti fili di collegamento tra i differenti elementi che si trovano da una parte e dall’altra; tali fili di collegamento modificano in un modo o nell’altro il sentire sociale, il quale svolge anch’esso un ruolo in tutto questo. Più ci si avvicina alla frontiera, e più tale sentire si fa indeterminato. Qui troviamo salariati che vivono in condizioni piccolo-borghesi e che hanno un modo di sentire corrispondente a questo loro stato, là abbiamo piccoli borghesi che si sentono appieno proletari, eccetera. Un grande influsso viene inoltre esercitato dalla tendenza generale dell’epoca, per la quale, oltre alla dinamica economica delle classi, ha un peso importante anche la loro dinamica politica, l’influsso che esse esercitano grazie alle istituzioni politiche. Anche residui religiosi e nazionalistici del passato, usanze radicate, sostenute da particolarità climatiche, possono modificare il modo di sentire nell’uno e nell’altro senso». (“Parteien und Klassen”, in “Sozialistische Monatshefte”, 1902, vol. II, p. 853, citato da I. Fetscher, Il marxismo, tr. it., Milano 1970, vol. II, pp. 304-305).
Sulla stessa linea il sociologo polacco Stanislaw Ossowski: «Esistono altre ragioni per cui il concetto ottocentesco di classe sociale, nelle interpretazioni sia liberale che marxiana, ha perso molta della sua applicabilità nel mondo moderno. In situazioni in cui i mutamenti della struttura sociale sono, in maggiore o minor misura, controllati dalle decisioni delle autorità politiche, siamo ben lontani dalla classe sociale com’è stata interpretata da Marx, da Ward, da Veblen o da Weber, dalle classi concepite come gruppi determinati dai loro rapporti con i mezzi di produzione o, come altri direbbero, dai loro rapporti con il mercato. Siamo ben lontani dalle classi concepite come gruppi che nascono dalle organizzazioni di classe spontaneamente create. In situazioni in cui le autorità politiche possono in maniera aperta ed effettiva cambiare la struttura di classe; in cui i privilegi che sono i più essenziali per la definizione dello status sociale, compreso quello di una più alta quota di reddito nazionale, sono conferiti da una decisione delle autorità politiche; in cui una gran parte o anche la maggioranza della popolazione è inclusa in una stratificazione del tipo che si può trovare in una gerarchia burocratica, il concetto ottocentesco di classe diventa più o meno un anacronismo, e i conflitti di classe cedono il posto ad altre forme di antagonismo sociale». (Class Structure in the Social Consciousness, ns. tr., London 1963, p. 184).
Significato contraddittorio totale. È relativo alla contrapposizione tra coscienza di classe interna individuale e totalità nel senso marxista di “formazione economico-sociale”. Gli elementi di partenza di questo significato sono da rintracciarsi nel concetto di totalità e nel concetto di oggettività. La fusione che ne deriva causa una particolare concezione del movimento contraddittorio della coscienza di classe. Molto chiaro su questo punto è Lukács: «Quest’emergenza del materialismo storico dal principio di vita “immediato, naturale” del proletariato, il fatto che dal suo punto di vista di classe possa derivare la conoscenza della realtà come totalità, non significa tuttavia per nulla che questa conoscenza o l’atteggiamento metodologico verso di essa sia già dato immediatamente e naturalmente al proletariato come classe (e ancor meno ai singoli proletari). Al contrario, il proletariato è certamente il soggetto conoscente di questa conoscenza della realtà sociale nella sua interezza. Ma non è un soggetto conoscente nel senso del metodo kantiano, dove il soggetto viene definito come ciò che non può mai essere oggetto. Esso non è uno spettatore disinteressato di questo processo. Il proletariato non è una mera parte attiva di questo intero, ma il crescere e lo svilupparsi della sua conoscenza da un lato e, dall’altro, il suo stesso crescere e svilupparsi nel corso della storia sono soltanto due aspetti del medesimo processo reale. Non solo la classe stessa si “è formata in classe” solo a poco a poco, nella costante lotta sociale, a cominciare dalle azioni spontanee, incoscienti, della difesa immediata e disperata (e la distruzione delle macchine è un esempio particolarmente evidente di questa situazione iniziale). Anche la coscienza della realtà sociale, della propria situazione di classe e della destinazione storica che sorge con essa, il metodo della concezione materialistica della storia sono prodotti dello stesso processo di sviluppo, che il materialismo storico – per la prima volta nella storia – ha riconosciuto adeguatamente e nella sua realtà». (Storia e coscienza di classe, op. cit., pp. 29-30).
In Marx, al contrario, i passi in cui emerge con la stessa chiarezza il problema della classe, non sono molti. Un punto abbastanza chiaro è da segnalarsi in una lettera a Weydemeyer, dove egli scrive: «[...] non a me compete il merito di aver scoperto l’esistenza delle classi nella società moderna e la loro lotta reciproca [...]. Ciò che io ho fatto di nuovo è stato: l. dimostrare che l’esistenza delle classi è legata puramente a determinate fasi storiche di sviluppo della produzione; 2. che la lotta delle classi conduce necessariamente alla dittatura del proletariato; 3. che questa dittatura medesima non costituisce se non il passaggio all’abolizione di tutte le classi e a una società senza classi». (Lettera a Weydemeyer (1852), citata in É. Balibar, Cinque studi di materialismo storico, tr. it., Bari 1976, p. 48).
La concatenazione oggettivistica di questo passo è chiara a tutti. La preoccupazione di Marx è sempre stata quella di staccare il processo oggettivo della storia, di cui – secondo lui – faceva parte lo scontro di classe, dalla contingenza dei fatti quotidiani, proiettandolo in un clima di necessità oggettiva. Con ciò egli in primo luogo, e i suoi seguaci in modo più accentuato, hanno voluto legare le speranze della rivoluzione a un meccanismo deterministico che servisse da supporto alle forme organizzative, alle decisioni collettive e alle stesse volontà singole.
Portando avanti questi concetti Lenin radicalizza il significato della classe: «Si chiamano classi dei grandi gruppi di uomini che si differenziano per la loro posizione nel sistema storicamente determinato della produzione sociale, per i loro rapporti verso i mezzi di produzione, i quali sono imperativamente fissati e regolati con leggi, e secondo la funzione che gli uomini compiono nella organizzazione sociale del lavoro, e quindi anche secondo il modo e la misura del godimento della ricchezza collettiva di cui dispongono. Nella società divisa in classi ci sono gruppi di uomini che possono appropriarsi del lavoro degli altri gruppi e classi in conseguenza della loro diversa posizione nell’ordine sociale stabilito». (La grande iniziativa, tr. it., Milano 1920, p. 16).
Significato totale interagente. È relativo al rapporto tra coscienza di classe e totalità nel senso anarchico, come rapporto di interazione fra individui all’interno del campo sociale.
La posizione anarchica su questo problema è molto complessa ma si può unitariamente ricondurre al senso della totalità del movimento degli sfruttati, di quella forza rivoluzionaria che Bakunin chiamava “movimento anarchico delle popolazioni”. Senza scendere nei particolari del contrasto tra organizzazione specifica e movimento degli sfruttati, citiamo un’affermazione di Anselmo Lorenzo, riguardante la nascita e lo sviluppo dell’Internazionale in Spagna, che ci sembra molto indicativa: «Caduta l’Internazionale, non tanto a causa delle scissioni provocate dagli antagonismi personali, e nemmeno a causa della repressione statale, quanto per il fatto stesso della definizione delle ideologie e la libera espressione degli avvenimenti, il proletariato continua a essere la stessa personalità vivente, con un ideale sempre più definito e con energie che crescono in potenza e decisione [...]». (Il proletariato militante, tr. it., Catania 1978, p. 19). E più oltre: «Quando oggi ci si sofferma ad analizzare la cosa, si deve riconoscere che l’Internazionale fu una specie di espediente opportunistico abbastanza riuscito per causare un’esplosione di entusiasmo prodotto dalla speranza di un miglioramento e fondato nella realtà della miseria allo stesso tempo che nell’indifferenza o nella trascuratezza delle tendenze, ma quell’unione non rafforzata nella fiducia di tutti in una sola idea, s’indebolì da sola di fronte all’urto cogli errori tradizionali, e, di conseguenza, anche di fronte alla paura di persecuzioni». (Ib., p. 21).
Fondamentale, infine, sull’analisi di classe e sul problema della coscienza di classe, una lunga nota di Bakunin allo scritto: “L’Italia e il Consiglio Generale dell’Associazione Internazionale dei lavoratori”, redatta alla fine del 1871, nota nella quale critica il concetto marxiano di classe: «Noi preferiamo dire come masse, diseredate e declassate, questa denominazione di classe applicata al proletariato può dare luogo a un equivoco e, essendo contraria allo spirito stesso dei considerando dei nostri statuti generali, che pongono come scopo principale dell’agitazione e dell’organizzazione internazionale delle masse operaie di tutti i paesi l’abolizione delle classi; cosa che il proletariato non potrebbe fare se avesse coscienza di costituire esso stesso una classe separata, e ogni classe è necessariamente separata dalle altre, allo stesso modo in cui ogni Stato politico suppone necessariamente l’esistenza di molti altri Stati: cioè la lotta per il dominio, per lo sfruttamento, la guerra perpetua per tutti, e per i vinti, la schiavitù. Ciò che si chiamano diritti delle diverse classi non sono diritti umani, ma privilegi politici, consacrati e protetti dallo Stato. Le classi sono possibili solo nello Stato, che non ha mai avuto e mai potrà avere altra missione che quella di legalizzare questi differenti privilegi che furono e sono le conseguenze sociali della vittoria o del successo ottenuto da una classe sull’altra, sempre a detrimento delle masse popolari che hanno pagato la sconfitta degli uni come il trionfo degli altri. Questa parola, classe, applicata al proletariato, è impiegata quasi esclusivamente e con singolare amore dai democratici socialisti, comunisti autoritari e pangermanisti della Germania. Troverete in quasi tutti i numeri dei loro giornali: “Volksstaat” e “Volkswille”, questa frase: “Bisogna risvegliare nel proletariato la coscienza di classe (das klassenbeweßtsein). In fondo questi tedeschi sono molto logici. Essi non vogliono come noi, l’abolizione dello Stato, sperano, al contrario, potersi servire della forza numerica del proletariato tedesco, politicamente organizzato, per fondare il loro grande Stato pangermanico e cosiddetto popolare. Per conseguenza, tendono con tutti gli sforzi a risvegliare, o piuttosto a suscitare artificialmente, presso gli operai della Germania, questa coscienza di classe che non è altro che la coscienza politica dello Stato, quella di un corpo collettivo privilegiato nello Stato. In questo modo, vediamo tutti i programmi usciti dai loro congressi porre come scopo immediato dell’agitazione operaia la conquista dei diritti politici, il suffragio universale, la legislazione diretta del popolo, e in generale tutte le libertà domandate dalla democrazia borghese, la qual cosa ha per inevitabile conseguenza di mettere il movimento popolare a rimorchio e sotto la direzione immediata di questa democrazia. È il caso di dirla chiara? Essi fanno senza saperlo e senza volerlo gli interessi di Bismarck. È evidente che con questo mezzo di agitazione esclusivamente politico, che hanno imposto al proletariato della Germania, non conquisteranno mai le libertà politiche per il popolo; ma è evidente anche che con questo stesso mezzo essi aiutano meravigliosamente il grande ministro pangermanista nella sua opera eminentemente patriottica di concentrazione interna e di estensione esterna dell’Impero. Essi sono i pionieri, i preparatori pacifici delle sue future conquiste. Quanto a noi, per queste stesse ragioni, poiché non vogliamo né Stato, né dominio, né sfruttamento, respingiamo assolutamente questa parola: classe che i democratici socialisti della Germania hanno trovato nel dizionario politico della borghesia e che in nessun modo può e deve essere applicata al proletariato. Il proletariato, dal punto di vista dello Stato, forma oggi una massa infima, disorganizzata, declassata e discreditata: un immenso gregge di montoni che le classi dello Stato, sotto la protezione dello Stato e conformemente a regole e leggi stabilite dallo Stato, tosano e divorano ciascuna in proporzione dei suoi privilegi o piuttosto della sua potenza reale nello Stato. Dal punto di vista economico e sociale, il proletariato porta già in se stesso tutti i germi della sua organizzazione futura nell’organizzazione naturale dei mestieri e delle diverse associazioni operaie che, prima o poi, dovranno necessariamente abbracciare tutti i lavori umani, sia manuali che intellettuali, per cui ogni uomo diventerà, secondo giustizia, un lavoratore dello spirito e delle braccia nello stesso tempo; adattandosi ognuno liberamente e nel modo più specifico al genere di lavoro che prima gli converrà [...]». (M. Bakunin, Opere complete, vol. IV, Catania 1976, pp. 166-167).
Significati di adeguamento. Sono tutti relativi alla coscienza di “classe per sé”. Il solo caso in cui si prospetta un adeguamento dal punto di vista del singolo è il caso di un calcolo medio dei suoi comportamenti che in genere si perde negli schemi strumentalistici di una certa sociologia americana. Il riformismo si differenzia, a sua volta, in due correnti: la corrente strumentalista e pragmatista americana, che dà vita alla sociologia accademica empirista; e la corrente riformista vera e propria che sviluppa il pensiero marxista in senso favorevole all’adeguamento alle condizioni date dal conflitto di classe. Così scrivono Rumney e Maier a proposito del problema dell’identificazione oggettiva delle classi: «L’esistenza di classi sociali è forse la realtà fondamentale – fatta eccezione per il nazionalismo – della nostra società. È possibile, sulla base di precisi criteri obiettivi – quali l’ammontare e la fonte del reddito, il grado raggiunto nella occupazione e, in misura minore, il grado di indipendenza personale e di sicurezza nel lavoro e la possibilità di esercitare un comando – delineare i confini di ciascuna classe». (Sociologia, la scienza della società, tr. it., Bologna 1962, pp. 145-146).
Sviluppando una critica di Marx da posizioni neo-liberali Theodor Geiger scrive: «Se la coscienza di classe non è un dato psicologico reale bensì una costruzione razionale a cui dovrebbero pensare i membri della classe (ma in realtà non ci pensano affatto) così questa coscienza di classe non può avere il ruolo che Marx gli aveva attribuito nel processo sociale. Essa deve agire come forza motrice della lotta di classe, fare agire i membri della classe, agire in modo solidaristico e infine portare alla rivoluzione e quindi alla ricostruzione della nuova società. Come potrebbe, quindi, una coscienza di classe che non è affatto posseduta dai membri della classe muoverli a qualcosa, anzi a una lotta dotata di scopo? Marx può in realtà servirsi soltanto di una coscienza di classe puramente psicologica che almeno è data in notevole parte dai membri della classe e si muove con determinati orientamenti». (Saggi sulla società industriale, tr. it., Torino 1970, pp. 145-146). Con questa tesi il pensiero riformista si ricollega con le ristrettezze del neo-liberalismo bottegaio, con le conseguenze che vedremo meglio più avanti.
Significati di smarrimento. Sono prevalentemente relativi alla coscienza di classe del singolo in rapporto alla coscienza di classe della “classe per sé”. Il solo caso in cui si può parlare di significato di smarrimento per la classe nel suo complesso è quando si ha una classe alla deriva, cioè quando la sua significatività storica si è completamente sciolta nelle altre classi e ne sopravvive soltanto il simbolo (a esempio come accade oggi con la nobiltà). I più noti fra i significati di smarrimento sono spesso indicati col termine di “falsa coscienza”.
La “letteratura della deriva” è amplissima e molto interessante, per quanto divaghi continuamente su presunti valori astratti. Simmel fu uno dei pochi a concretizzare lo “smarrimento” in forme analitiche di grande portata. «Per l’uomo più profondo – egli scrive – vi è solo una possibilità di sopportare la vita: una certa misura di superficialità. Poiché se pensasse e sentisse, tanto profondamente quanto la sua natura richiede, contrastanti e inconciliabili impulsi, doveri, aspirazioni, desideri, dovrebbe inevitabilmente distruggersi, impazzire, morire. Al di là di un certo limite di profondità le linee dell’essere, del volere e del dovere si oppongono in modo così radicale e con tale forza da determinare necessariamente la nostra dilacerazione. Solo impedendo che oltrepassino questo limite si riesce a mantenerle in un rapporto tale che la vita è possibile». (Probleme der Geschichtsphilosophie, ns. tr., München-Leipzig 1922, p. 55).
Ai significati di cui sopra corrispondono determinati modelli di coscienza di classe che hanno, chi più chi meno, valore operativo e che si convogliano – come vedremo – in diverse posizioni ideologiche.
Coscienza di classe ideale, parte dal significato interno individuale di coscienza di classe ma sopravvaluta le possibilità del singolo di conoscere, valutare e giudicare la propria situazione.
Coscienza di classe reale, parte dal significato esterno oggettivo di coscienza di classe ma, pur tenendo conto delle variazioni di intensità e di estensione del concetto, e quindi della sua dinamicità, sopravvaluta la possibilità che un’entità collettiva come la classe possa avere consapevolezza esterna di se stessa.
Coscienza di classe empirica, parte dal significato contraddittorio parziale di coscienza di classe e pretende di fondare empiricamente una certezza operativa su di una specie di calcolo delle probabilità tra due inadeguatezze: il momento interno individuale e il momento esterno oggettivo.
Coscienza di classe ideologica, parte dal significato contraddittorio totale e giustifica il proprio meccanismo interno col metodo dialettico.
Coscienza sociale di classe, parte dal significato totale interagente e tiene conto dei rapporti di interazione fra individui all’interno del campo sociale. In tendenza costituisce la coscienza anarchica di classe.
Coscienza di classe adeguata, utilizza il rapporto con l’economia, con la storia, con le idee dominanti, con gli interessi di classe e con le possibilità di affermazione politica della classe in modo corretto (sempre come tendenza) ma dal punto di vista della parziale modificazione dello stato di cose presenti. Corrisponde alla coscienza riformista.
Coscienza di classe smarrita (o falsa coscienza), utilizza il rapporto con l’economia, con la storia, con le idee dominanti, con gli interessi di classe e con le possibilità di affermazione politica della classe in modo negativo, riconfermando la negazione del mutamento e il valore della tradizione. Corrisponde alla coscienza reazionaria.
Vedremo adesso per quali motivi i suddetti modelli di coscienza di classe si possono ricondurre a determinate posizioni ideologiche.
Queste sono:
L’idealismo liberale, che coinvolge la coscienza di classe ideale e ogni operazione ideologica diretta a ricondurre la realtà all’interno della coscienza astrattamente considerata.
Empirismo post-keynesiano, che coinvolge la coscienza di classe reale con tutte le pretese di individuare empiricamente le dimensioni della classe e le sue possibilità operative. In genere l’analisi serve per costruire freni e rallentamenti a possibili sbocchi di disturbo.
Pragmatismo tecnocratico, che coinvolge la coscienza di classe empirica e si poggia sulla mentalità tipica dello strumentalismo informatico americano ed europeo.
Tradizionalismo reazionario, che coinvolge il concetto di smarrimento nei suoi vari aspetti e significati per come visto prima.
Socialdemocrazia riformista, che coinvolge il concetto di adeguamento nei suoi vari aspetti e significati.
Materialismo marxista, che coinvolge la coscienza di classe ideologica e si fonda sul tentativo di superare le contraddizioni dell’intero sistema sociale con il meccanismo, appunto, ideologico della dialettica.
Materialismo anarchico, che coinvolge la coscienza sociale di classe e cerca di cogliere la realtà dei rapporti individuali all’interno della rete di interazioni che si stende sul campo sociale.
Morto e sepolto il classico liberalismo del “lasciar fare, lasciar passare”, il suo cadavere continua a puzzare attraverso una trasposizione della mentalità tipica dell’imprenditore del passato nel bottegaio del presente. Pur nelle mutate condizioni operative in cui si trova il bottegaio, questi ha ereditato le caratteristiche che una volta contrassegnavano l’imprenditore: la sacralità del lavoro, la religiosità del guadagno, l’oculatezza dei tentativi, l’abilità nella correzione degli errori, la visione idealistica del mondo (il mondo come fatto su misura in rapporto alle dimensioni della propria bottega), ecc.
A livello di circolazione delle idee o di trasmissione dei princìpi etici da una classe all’altra, il passaggio dell’interpretazione di coscienza (e quindi anche indirettamente di coscienza di classe) dall’imprenditoriato del passato al ceto medio del presente è un fenomeno di grande interesse. In sostanza il ceto medio bottegaio costituisce il filtro con il quale l’ideologia del lavoro e del sacrificio, della scalata sociale e della famiglia, dell’ubbidienza e della gratificazione sociale, ecc., perviene fino alla classe degli sfruttati nell’organizzazione dei suoi diversi livelli. È proprio il ceto medio – tra l’altro – a cancellare dall’ideologia tipica imprenditoriale quella coraggiosa e intraprendente visione della vita che caratterizzava il pirata inglese del ’500 e il mercante veneziano del ’300. Il ceto medio, nell’oscura alchimia delle sue botteghe, cancella e scolora tutte le qualità “umane” e “volontarie” dell’individualismo imprenditoriale. Nella trasformazione le vive come violenza reazionaria, come desiderio di distruggere tutti gli ostacoli che si oppongono a un aumento delle vendite e a una diminuzione dei prezzi d’acquisto delle merci che tiene in magazzino. Il bottegaio è violento e manderebbe tutto a ferro e fuoco pur di vedersi garantito un aumento delle vendite proporzionale nel tempo a quello che egli considera il suo “giusto” guadagno.
In questa prospettiva egli è un “liberale” perché si batte contro le leggi e contro lo Stato finanziario, perché vuole meno controlli riguardo la sua azione di rapina e di sfruttamento dei ceti inferiori, perché ha paura anche del più piccolo intervento riformista diretto a intaccare i margini della sua vergognosa libertà. In ciò è, se possibile, ancora più pericoloso dell’imprenditore del passato, mentre è incommensurabilmente più miserabile e pidocchioso.
Dall’oscurità della propria bottega intravede con una certa chiarezza quali sono i suoi interessi di classe, ma non fa nulla perché questi vengano trasferiti su di un piano oggettivo. Li vive a livello interno, a livello soggettivo, trasferendoli in un appagamento astratto e generalizzante, un appagamento che si basa su sogni di distruzione e di apocalisse, su sogni che prevedono l’instaurazione del regno assoluto del bottegaio fondato sulla legge dell’aumento senza limiti delle vendite e dei guadagni.
La molecolarità della sua esistenza condiziona l’interpretazione che egli possiede di coscienza in generale e di coscienza di classe. Il presente è l’unico modo in cui riesce a vivere il tempo. Il passato e il futuro per lui non esistono. Il futuro, in particolare, o viene visto come timore per possibili guai relativi al livello delle vendite, oppure come desiderio di distruzione totale e senza limiti dei propri nemici, senza che gli sia chiaro il fatto, tra gli altri, che in questa apocalittica eventualità non si vede a chi vadano fatte le vendite a lui tanto care.
La componente bottegaia e artigianale della classe media ha quindi una coscienza di classe confusa e contraddittoria che la spinge verso l’estremismo reazionario, verso i travestimenti progressisti del tradizionalismo. Una minore accentuazione dello smarrimento tipico delle classi dominanti che vedono venire meno progressivamente il proprio potere, porta questa componente a una maggiore aggressività e a una più coerente visione dei propri interessi, tutto ciò, ovviamente, fino a un certo punto, cioè fino al punto in cui la contraddittorietà di fondo non impedisce l’uscita dalla bottega e il passaggio a una vera e propria coscienza di classe sociale. La componente burocratica della classe media costituisce, come vedremo, l’altra anima di questa classe, l’anima che si avvicina di più alle strutture dell’attuale classe dominante.
Anche la coscienza di classe del capitalista moderno è confusa e contraddittoria, come per altro sono tutte le altre coscienze delle classi, o dei ceti, che realizzano o concorrono alla realizzazione del dominio. Si può affermare che una classe in lotta per la propria sopravvivenza, tallonata dalla repressione e dallo sfruttamento, arriva, mediamente, a una coscienza di sé molto più evidente e palmare di quanto non possa fare una classe che è solo preoccupata di trarre profitto dalla propria situazione. Non è lo stimolo alla conquista del potere e all’avvicendamento delle classi che fornisce l’occasione oggettiva per una maggiore coesione e una maggiore evidenza, ma piuttosto lo stimolo della difesa, della conservazione, della situazione di sfruttamento e di sofferenza in cui si vive. Di conseguenza abbiamo, il più delle volte, che i momenti di maggiore coesione di classe sono quelli che si raggiungono a livello sindacale e riformistico e non quelli a livello rivoluzionario. Cioè, contrariamente a quanto comunemente viene affermato, riteniamo che la coscienza di classe emerga più chiaramente proprio a livello rivendicativo, in cui gli strumenti stessi dell’organizzazione sindacale e partitica forniscono l’occasione per il più chiaro riconoscimento dell’obiettivo di classe. Al contrario, a livello rivoluzionario, la classe sfruttata insorge e attacca non solo le strutture del potere e le classi che la opprimono, ma anche tutte quelle forme strutturali e ideologiche che normalmente essa stessa considera facenti parte della propria classe. Nella situazione rivoluzionaria la stessa distribuzione delle classi viene travolta e cade in uno con i concetti che la rendevano intelligibile in momenti caratterizzati dalla lotta riformista. Se si vuole, nella situazione rivoluzionaria la classe degli sfruttati perde la chiarezza (riformista) della propria coscienza di classe per acquisire una realtà confusa e contraddittoria, ma capace di fare emergere gli elementi creativi della nuova società, realtà che è caratterizzata dalla coscienza sociale di classe.
Abbiamo quindi che la coscienza di una classe è sempre confusa e contraddittoria quando questa classe esercita il dominio e quando scatena la lotta sociale decisiva per la propria liberazione; nel caso di una lotta economica e politica riformista la coscienza di una classe è sempre più omogenea e coerente.
L’omogeneizzazione della coscienza di classe capitalista avviene con un processo di avvicinamento a quello che potremmo definire un movimento di riforma del capitale, messo in atto dal capitale stesso e realizzato da un intervento sempre più massiccio del livello produttivo di pace sociale, cioè il livello d’intervento dello Stato. Nell’esercizio puro del dominio del capitale, almeno nella sua fase formale, si aveva una grossa contraddittorietà di fondo, sia nello svolgimento stesso del processo di valorizzazione (produzione a livello economico e produzione di pace sociale), sia nella dimensione individuale imprenditoriale, caratterizzata dalla irrazionalità della concorrenza. Lo spostamento verso una riforma del capitale, oltre a sfruttare la maggiore omogeneizzazione del livello produttivo di pace sociale, ha determinato una maggiore chiarezza e coerenza nella stessa coscienza di classe capitalista, conseguente a una maggiore sensibilizzazione nei confronti delle contraddizioni di fondo dello stesso capitale.
Per molti versi l’azione post-keynesiana all’interno del capitalismo moderno si può paragonare all’azione sindacalista all’interno della classe degli sfruttati: ambedue hanno creato una coscienza riformista rispettivamente nel capitale e nel lavoro, contribuendo con ciò a produrre una maggiore omogeneizzazione delle rispettive coscienze di classe.
La componente tecno-burocratica della classe media assume via via una maggiore consistenza e importanza nel corso del processo di riforma del capitalismo, cioè nel corso della sua omogeneizzazione conseguente all’accrescersi del ruolo svolto dal livello di produzione di pace sociale.
La coscienza di classe di questa componente, ha quindi tutte le caratteristiche della sistematicità formale che prevale nel corso dello spostamento dalla contraddittorietà della concorrenza alla razionalità della pianificazione. Da notare che questa tendenza non riesce mai del tutto a eliminare l’approssimazione e la confusione di fondo, come del resto accade anche nella dimensione riformista del sindacalismo. La maggiore coesione della coscienza della classe sfruttata non elimina la contraddittorietà delle sue componenti.
Contrariamente alla classe bottegaia, l’altra anima della classe media, il ceto tecno-burocratico, si avvicina di più alla classe capitalista e manifesta una maggiore capillarità sociale, cioè una maggiore capacità di penetrare all’interno delle strutture della classe superiore. Questa penetrazione è corrispettiva alle più pressanti necessità di questa classe di avere una sempre più veloce omogeneizzazione dei propri processi organizzativi e produttivi, cosa che corrisponde, come abbiamo detto, a un vero e proprio movimento riformista del capitale. In queste condizioni il ceto tecno-burocratico manifesta una più ampia autonomia non solo del corrispettivo ceto bottegaio, immerso nei suoi sogni sanguinosi di distruzione e di morte, ma anche della classe che gli sta immediatamente sopra. Questa maggiore autonomia corrisponde a una più chiara visione di classe, cosa che lo porta a premere sempre di più sulla classe capitalista per avere maggiori riconoscimenti oggettivi per l’opera prestata. La concessione di questi riconoscimenti costituisce da un lato una delle condizioni di partecipazione del ceto tecno-burocratico alla gestione capitalista del potere, ma costituisce anche una delle forme in cui si realizza la stessa omogeneizzazione del processo di valorizzazione. Basta pensare in che modo questo ceto contribuisce al reperimento del consenso per capire quali sono le condizioni in cui si realizzano gli scambi di classe tra capitalisti e ceto tecno-burocratico.
Man mano che si operano i grandi sconvolgimenti di classe e che la struttura del dominio si modifica, alcuni strati sociali all’interno della classe dominante risultano meno capaci di altri di capire il senso storico del cambiamento, per cui restano indietro e si attardano a difendere una tradizione di potere che risulta sempre più anacronistica e superata. La propria coscienza di classe non è più soltanto confusa e contraddittoria, diventa smarrita, cioè perde, come abbiamo visto, la corretta posizione di fronte ai propri interessi di classe, di fronte all’agire storico della classe, di fronte alle idee in circolazione e di fronte alle concrete possibilità della classe.
Questi strati smarriti costituiscono un elemento di ritardo nel processo di omogeneizzazione visto prima perché insistono nella difesa di quelle forme tradizionali di realizzazione del valore che, per motivi molteplici, risultano ormai anacronistiche. Al contrario, quando insistono invece per un intervento del livello produttivo di pace sociale, non lo vedono correttamente come semplice accentuazione di una parte di un processo globale di già in corso, ma lo vedono come ritorno a strutture statali del passato che, sia pure per motivi diversi, risultano altrettanto anacronistiche. Sia nell’ipotesi del tradizionalismo reazionario, legato a una visione paleo-capitalista, sia nella visione autoritaria e fascista dello Stato chiuso, si tratta di una spinta irrazionale – per altro oggi abbastanza marginale nell’economia delle forze del potere – che non comprende il reale corso storico degli interessi della classe dominante.
La socialdemocrazia è il massimo livello nella chiarificazione della coscienza di classe adeguata. Il piano oggettivo del lavoro e degli interessi a esso connessi colloca la classe degli sfruttati, nelle sue componenti più vicine al processo di valorizzazione/salarizzazione, a una coscienza unionista che risulta facilmente percepibile proprio perché corporativa, settorializzata, trasferibile su dati precisi e quantificabili (salario, giornata di lavoro, miglioramenti ambientali, qualità del lavoro, professionalità, ecc.).
In una fase in cui il capitale era attanagliato dalle sue contraddizioni di fondo (struttura della concorrenza) e quindi in cui realizzava soltanto la parte formale del suo dominio, l’organizzazione degli sfruttati a livello unionistico contrastava in un certo qual modo con le condizioni oggettive del processo di valorizzazione, condizioni che in momenti critici potevano consentire che il sindacalismo prendesse la forma di un vero e proprio movimento rivoluzionario. In una fase in cui invece il capitale si avvia verso la realizzazione del dominio reale l’organizzazione sindacale risulta funzionale a incrementare l’omogeneità di cui ha bisogno. Lo Stato, il ceto tecno-burocratico della classe media e le componenti organizzate in modo unionistico della classe degli sfruttati, risultano tutti funzionali, in modi e gradi diversi, all’omogeneizzazione del processo produttivo nel suo complesso e all’accentuazione del livello di produzione di pace sociale di fronte al livello di produzione economica.
Bisogna intendersi sul problema del maggiore grado di chiarificazione della coscienza di classe riformista o adeguata. Quella parte della classe degli sfruttati che viene organizzata in forma unionistica, e che quindi si trova nella situazione oggettiva che rende possibile questa organizzazione, viene a costituire una componente sufficientemente differenziata dalle altre che compongono la classe degli sfruttati nel suo insieme. Questa componente in un certo senso privilegiata ha una visione più chiara di quelli che sono gli interessi di se stessa in quanto componente privilegiata e non dell’intera classe degli sfruttati, di cui essa pur sempre fa parte. Non per nulla si deve procedere a operare delle differenziazioni all’interno delle singole classi e ciò in funzione anche dell’andamento stesso del processo di valorizzazione nel suo complesso.
La maggiore chiarezza di questa componente unionizzata ideologicamente, e corporativizzata praticamente, non ha nulla a che vedere con la persistente confusione e contraddittorietà delle componenti staccate dal processo di salarizzazione e quindi criminalizzate. La lotta rivoluzionaria si sviluppa di preferenza in queste componenti, dovendosi considerare la collaborazione fornita da elementi della componente organizzata in forma unionistica alla stessa stregua della collaborazione di singoli elementi della classe media o anche della classe dominante, cioè come un vero e proprio tradimento di classe.
La coscienza di classe ideologica si presenta in sostanza come una forma modificata della coscienza di classe riformista o adeguata. La modifica consiste nel fatto che la conquista del potere politico ed economico può realizzarsi anche attraverso un sommovimento parziale che non ha nulla a che vedere con la rivoluzione sociale ma che di regola viene definito (impropriamente) come rivoluzione.
In linea teorica la conquista del potere politico ed economico da parte della componente unionizzata delle classi sfruttate, conquista realizzata più o meno sotto la guida di una minoranza partitica professionale, o comunque realizzata in forma spontanea ma poi strumentalizzata da questa minoranza, dovrebbe essere il primo passo verso un’abolizione progressiva di queste due forme di potere (corrispondenti grosso modo allo Stato socialista) per arrivare alla società libera comunista o anarchica.
Tutto ciò è semplice fumo ideologico. In realtà le cose stanno ben diversamente. La conquista del potere politico ed economico si cristallizza in una razionalizzazione del dominio su base ideologica. Il partito guida diventa il primo nucleo della nuova classe dominante, attorno a cui cresce la classe dominante vera e propria in tutte le sue componenti. Il processo di omogeneizzazione si realizza in modo più accelerato perché alla forma tipica di produzione di pace sociale, che per quanto riguarda l’attività produttiva statale non ha differenze notevoli con quella delle forme di dominio capitalista in senso tradizionale, si aggiunge la presenza omogeneizzante dell’ideologia.
È proprio questa presenza a caratterizzare, come tessuto connettivo, la coscienza della classe degli sfruttati, classe quest’ultima che si considera detentrice del potere, illudendosi di esercitarlo tramite la propria avanguardia burocratizzata. In realtà quello che questa classe fa è realizzare un processo di unionizzazione accelerato al massimo ed esteso a quasi tutte le sue componenti. Ciò produce immediatamente una maggiore e più chiara coscienza di classe, a sua volta omogeneizzata e resa più coerente dalla presenza dell’ideologia.
Se da un punto di vista del risultato finale dell’azione condotta dal marxismo a livello organizzativo e sociale non ci sono differenze con quella condotta dalla socialdemocrazia riformista, in quanto ambedue portano a una costituzione di dominio da parte di una classe sulle altre; dal punto di vista delle possibilità stesse di organizzare la lotta rivoluzionaria, le differenze sono notevoli. Infatti, mentre per i riformisti socialdemocratici non ci sono dubbi sul fatto che essi sono componente istituzionale del dominio del capitale; sono ancora molti coloro che si illudono che i marxisti cosiddetti rivoluzionari (non stiamo qui parlando del PCI, a esempio) possono essere compagni di strada. È su questa chiarificazione importante e necessaria che i contributi non sono mai sprecati.
I marxisti insistono tanto sulla centralità della classe operaia perché la considerano oggettivamente radicata all’interno del processo di valorizzazione e radicata in modo contraddittorio agli interessi del capitale. Ma questa falsa visione dell’oggettività operaia non corrisponde al ruolo concreto che questa componente della classe degli sfruttati svolge nel processo di valorizzazione. In sostanza quello che anche i marxisti hanno davanti (e che costituisce la realtà oggettiva della classe operaia) è l’unionizzazione di questa componente, cioè la corporatizzazione di una parte della classe degli sfruttati e la sua separazione dal resto della classe stessa. La più chiara coscienza di classe posseduta da questa componente unionizzata (coscienza sindacale) viene scambiata (in malafede) dai marxisti per maggiore capacità oggettiva della classe operaia di porsi al centro della contraddizione operaia. Allo stesso modo dei riformisti socialdemocratici, i marxisti non fanno altro che esaltare l’anima unionista della componente privilegiata della classe degli sfruttati.
La coscienza sociale di classe intende l’assenza di una prospettiva unionistica, la coscienza sia pure confusa e contraddittoria che l’unica prospettiva da unire sarebbe quella della miseria e della criminalizzazione, la sensazione sia pure epidermica che il potere, comunque e in ogni caso, costituisce un nemico da combattere; tutto ciò insieme agli elementi oggettivi determinati dalla lontananza dal processo di valorizzazione e dall’invito coatto all’interno del processo di reperimento del consenso, contribuiscono a determinare non una coscienza di classe anarchica, che sarebbe un assurdo in quanto l’anarchia si basa sull’abolizione delle classi e sulla uguaglianza reale, ma a determinare una coscienza di classe che parta dal punto di vista della totalità sociale.
Ciò è possibile, sia pure in forma embrionale, anche nella società del capitale, nella società divisa in classi, in quanto le componenti diseredate della classe degli sfruttati non hanno la pur minima possibilità di equivocare in merito alla sostanziale struttura controrivoluzionaria dell’unionismo sindacale. Un tentativo come quello realizzato da alcune componenti veteromarxiste di organizzare in forma pseudo-sindacale i disoccupati ha avuto i risultati che erano prevedibili: la subitanea crescita di uno strato cuscinetto con tendenze sostanzialmente riformiste, disposto a partecipare a lotte rivendicative, e il progressivo assorbimento di questo strato o all’interno della componente privilegiata o all’interno delle componenti criminalizzate, secondo le condizioni obiettive offerte dal potere.
L’impossibilità dell’equivoco riformista a questo livello causa una chiusura dei processi di omogeneizzazione, chiusura tanto più rigida quanto più ci si avvicina verso le fasce più lontane da soluzioni intermedie e provvisorie che sono all’ordine del giorno nelle componenti non salarizzate della classe sfruttata (lavoro nero, espedienti, attività illegali, ecc.).
La coscienza di classe che queste componenti sviluppano è sostanzialmente una coscienza sociale, cioè una coscienza sociale di classe. Questa tiene conto del rapporto contraddittorio con le altre classi (sia pure in modo confuso), ma non si fa illusioni né di potere né di organizzazione sindacale. La sola possibilità che ha davanti è la lotta per la propria sopravvivenza, e questa sopravvivenza è possibile solo distruggendo in modo definitivo tutte le divisioni di classe e ogni forma di dominio che le rende possibili. All’interno di queste componenti sta la coscienza della società nel suo insieme, non della società della miseria e del sopruso, ma della società libera, della società anarchica.
Certo, questa coscienza sociale di classe non corrisponde con l’anarchismo teorico, come non corrisponde con le idee che l’anarchismo ha sviluppato nel corso delle sue lotte sociali. Le minoranze agenti anarchiche hanno una composizione sociale che non necessariamente deve corrispondere alle strutture di classe specifiche delle componenti lontane dal processo di valorizzazione. Anzi la stessa caratteristica di fondo dell’anarchismo, il suo volontarismo, il suo entusiasmo, la sua passione per la rivoluzione, il suo amore per gli uomini, la sua fede nella libertà e in una società migliore che è possibile costruire tutti insieme dopo la distruzione radicale e definitiva della presente, costituisce un punto di riferimento per sempre possibili rifiuti di uno specifico inquadramento di classe. Elementi della classe operaia, del ceto medio, della stessa classe dominante possono, qualora rinuncino ai loro privilegi oggettivi e alla loro personale “chiesa delle idee”, entrare a far parte della minoranza agente anarchica e diventare ottimi compagni rivoluzionari. Ma ciò non nega che a livello di classe e quindi a livello globale solo le componenti della classe sfruttata che si trovano staccate dal processo di valorizzazione hanno una coscienza sociale di classe e sono quindi disponibili per una lotta rivoluzionaria diretta alla distruzione del potere.
[Pubblicato su “Pantagruel” n. 3, ottobre 1981, pp. 79-101 col titolo “Per un’analisi della coscienza di classe”]
Cultura
In tempi come i nostri tiriamo un po’ tutti a campare. I profondi sconvolgimenti negli assetti organizzativi della società, quel fenomeno che chiamiamo flessibilità, e altre cose più o meno amene, sono diventati tanto comuni da costringerci a diventare anche noi flessibili e, in fondo, un po’ gigioni.
Tutti si adattano. Perché non dovrebbero farlo anche gli appartenenti alle classi di potere, coloro che da sempre hanno utilizzato la cultura per mantenerlo questo potere, per verniciarlo, renderlo smagliante e perfino accettabile? Della generale ignoranza ci sarebbe da rallegrarsi, per noi amanti della distruzione di questa società, se non ci rendessimo conto che l’assenza o la carenza di cultura costituisce un fatto negativo per le nostre speranze di liberazione. Queste, purtroppo, volendo o non volendo, si basano anche sulla possibilità di espropriare se non tutta, almeno una parte di questa cultura.
Quando la sostanza manca, vi sopperisce l’aspetto esteriore. Mi ricordo che il mio primo maestro di latino e greco fu un vecchio prete, segretario dell’allora vescovo di Catania, nella cui stanza piena di libri, tre volte la settimana, di sera, mio padre mi accompagnava con religiosa (per lui e anche per me) sollecitudine. Di quella stanza dal profondo odore di muffa e rinchiuso, dalle pareti tappezzate di libri e dai due tavoli sgangherati pieni di pergamene, conservo un ricordo indelebile e amoroso. Non appresi l’alfabeto greco da un qualsiasi libro di grammatica, ma decifrandolo da una pergamena dell’officina catanese del 1072, relativa al trasferimento dei resti delle ossa di sant’Agata. Il lavoro fu subito duro per un ragazzo di dieci anni, ma grande la pazienza di questo vecchio prete dal difficile eloquio e di mio padre che sacrificava così una larga parte delle sue serate. Forse, in quelle occasioni che durarono fino a tredici anni, quando decisi di esternare la mia definitiva (per me) prova della non esistenza di Dio al vecchio prete (a rischio di fargli prendere un infarto), imparai poco greco e un po’ più di latino, ma molto di più imparai la disciplina dello studio, la lotta lunga e rigorosa per strappare al nemico i suoi strumenti. Insomma, per dirla semplice, imparai che la cultura o, se si preferisce, il sapere, si conquista con la lotta, ed è uno strumento di libertà solo quando capisci che nessuno ti sta regalando nulla, perché tutte le condizioni esterne sono contro di te.
Non c’è quindi una parte della cultura, anche quella che sembra possa essere lasciata agli specialisti che può essere tralasciata, snobbata. Non esiste un nocciolo duro, un riassunto, facile facile, per spiriti deboli e fisici acciaccati.
Certo, uno può benissimo essere un’ottima persona senza sapere di greco e di latino, o senza conoscere il tedesco, o la filosofia, o la matematica, e può anche essere un ottimo rivoluzionario, ma gli potrà capitare di sentire degli stimoli che resteranno senza spiegazione, oppure respingerà inorridito delle intuizioni per non sapere come spiegarsele. La sua azione risulterà irrimediabilmente circoscritta e, ancora peggio, irrimediabilmente destinata alla delega.
Molti compagni si rendono nebulosamente conto di questo e cercano, qualche volta, di darla a bere. Da un lato ammettono subito di non essersi potuti fare una cultura, di non essere stati in condizioni economiche tali da frequentare università e cose del genere. Ma poi, se dicono qualcosa o, peggio ancora, la scrivono, cercano di fare sfoggio esteriore dei luoghi comuni più triti di questa cultura.
Secondo me il problema c’è, ed è serio. Il povero Andreotti [1989] ha avuto anche lui il desiderio di fare apparire l’appannato latino affermando per incidens qualcosa, che ovviamente non poteva affermare. Ma cos’è mai un errore del genere davanti alla strenua battaglia condotta da Berlusconi contro i congiuntivi, questi testardi ponti dell’asino della nostra lingua? Io stesso, un paio d’anni fa, in un intervento televisivo di un’attempata donzella ministro della pubblica istruzione ho contato non meno di dieci errori di grammatica. E dire che su quella poltrona si sedettero in passato uomini come De Sanctis, che di lingua se ne intendeva, e Gentile, che se non di altro almeno di filosofia se ne intendeva (per la verità scriveva da cane, ma non faceva errori).
Il vero problema non è nemmeno qua. Sta un po’ più avanti. Ancora uno sforzo, miei pochi lettori e spero che sarete ricompensati. La cultura è un patrimonio dell’uomo e riguarda gli eterni problemi dell’uomo: la vita, la giustizia, la libertà, l’uguaglianza, la coerenza, tutti problemi morali. La scienza è certo anch’essa cultura, ma non deve essere troppo specialistica, in caso contrario obbliga i suoi studiosi a dedicarsi troppo a un solo settore e poi a dire stupidaggini senza fine in merito ai problemi fondamentali dell’uomo, come recentemente è accaduto alla Montalcini e a Rubbia (ma è davvero bene non guardare mai in bocca al caval donato? come ebbe a chiedersi Emilio Cecchi dopo il Nobel dato a Quasimodo?).
La cultura può aiutarci a dare risposte a questi eterni problemi dell’uomo. Ma deve essere un patrimonio reale, conquistato, strappato con le unghie e con i denti, con il sacrificio e l’impegno, non una edulcorazione che serve a coprire la nudità dei mattoni sottostanti, una semplice superfetazione. L’attuale struttura del capitale ha ridotto le occasioni gratuite di reperimento della cultura. I brandelli che vengono seminati attraverso i mezzi della grande informazione sono studiati apposta per ottenere uomini con minori capacità culturali, in grado solo di adattarsi velocemente e risolvere piccoli problemi. I mezzi per affrontare i problemi veri dell’uomo si fanno sempre più ridotti.
Voglio fare alcuni esempi lontani, apparentemente lontani, da tutto quello che ci mettono sotto il naso tutti i giorni. Ho letto sui giornali di Manzoni a proposito degli esami di Stato e delle tragedie manzoniane. Conoscendone a memoria i cori me li sono ripetuti, tanto per passare il tempo, qui dentro [nel carcere di Bergamo] e, nel primo di essi, nei versi ormai fuori moda e fuori stile ho sentito improvvisamente un insegnamento per me, uomo del Duemila, rivoluzionario, carcerato, un insegnamento e una sollecitazione al rifiuto della delega e alla rivolta. Non un concetto vago, ma un discorso approfondito, collettivo, di un popolo che si illude e spera, che si ferma, che poi finalmente capisce che la sola speranza è quella della ribellione popolare, senza aiuti e senza appoggi. E mi sono sentito più forte non per un concetto che certamente sapevo bene, ma per quelle parole, per quel coro, per quel ritmo e per quello stato d’animo preciso, che soltanto quei versi di Manzoni sanno dare in modo insostituibile.
Un altro solo esempio. Allo stesso modo e per lo stesso motivo, per passare il tempo e per l’influsso del luogo, mi sono ripetuto a memoria i versi tradotti da Pindemonte, i versi in cui il vecchio Odisseo torna alla sua isola, alla sua donna, al suo cane, e vi trova l’ignobile scempio approntato dai conquistatori, l’attesa della propria donna, l’incertezza del figlio, la fedeltà immutabile del cane, e vi trova anche la necessità della vendetta, l’ineluttabilità della vendetta. E il vecchio lottatore prende in mano le armi e inizia il suo doloroso compito e non ha paura del sangue e delle giovani vite stroncate, a una a una, come bestie al macello, e man mano che va avanti nella terribile necessità il suo cuore vacilla, sente la difficoltà di capire il perché di tanto nuovo dolore, il perché di quelle nuove morti, ma ecco che la sua mano torna improvvisamente sicura e forte, l’uccello di Atena è volato là vicino, si è posato su di una trave, simbolo della coscienza armata, che continua dura e inflessibile, anche quando il cuore e il sentimento dell’uomo sembrano vacillare.
E nel chiuso di questa cella, insieme ai miei versi, mi sono sentito più forte e anche più sicuro.
[Pubblicato su “Provocazione” n. 22, novembre 1989, p. 5 col titolo “La cultura e la vita”]
Cyberpunk
La caratteristica principale del Cyberpunk è quella di sottrarsi a ogni definizione. Ciò deriva da una poliedricità di scelte visibile all’interno delle tesi dei suoi sostenitori, ma anche da un effetto diretto, e riscontrabile, delle possibilità tecniche offerte dalla nuove direttrici metodologiche dell’informatica. Nulla, in questo campo, è quindi nettamente separabile. Lo stile del racconto, in molti tratti narrativo, risente del mezzo che lo traduce in oggetto trasmissibile e questo stesso racconto ha poi, a sua volta, conseguenze sull’elaborazione di nuove soluzioni informatiche.
Non c’è dubbio che la pratica del meccanismo permette una sorta di autonomizzazione della coscienza individuale, da cui una sofisticazione nelle capacità decisionali, se non altro per quel che riguarda i tempi. Non è possibile prevedere quanto viene speso in termini di effettiva capacità intellettiva, sopportando l’elemento razionale tutto il peso dell’incasellamento rigido della procedura. Qui, ogni tono elogiativo appare quasi un esorcismo contro un’incertezza che sembra difficile non cogliere.
L’individuo che accetta questo rapporto con la macchina informatica s’indirizzerebbe presto verso un rifiuto dell’autorità centralizzata in genere, sentiero nella foresta capace di condurlo verso conclusioni molto importanti da un punto di vista libertario, se non trovasse subito lo stesso strumento in quanto ostacolo. L’interazione attore-strumento non ha sbocchi reali se non quelli di costituire attorno al campo operativo, di regola piuttosto sfumato, un ambiente di tolleranza se non proprio di disinteresse verso tutti gli aspetti che comunque sono minacciati lo stesso da un dilagamento ordinativo dei risultati del mezzo informatico di cui si fronteggia l’utilizzo.
C’è da dire che l’insieme delle manifestazioni cyberpunk finisce quasi inconsapevolmente per produrre una visione edonistica della vita, un’accettazione dello scetticismo in quanto relativismo oggettivo dei valori, modo di pensare intelligente verso cui sono spinti gli specialisti d’ogni livello, e il computer finisce per costituire una specializzazione, con un suo linguaggio e una sua mentalità. La simbiosi tra chi dialoga con la macchina e la macchina è pertanto inevitabile, ma occulta, tanto occulta da essere sistematicamente negata, trovando nella propria negazione elemento ulteriore di nascondimento. E la mentalità dello specialista s’incontra sempre un passo prima. Più avanza nel territorio dell’oggettività maneggevole, più qui si culla nel senso di sicurezza che deriva dal sentirsi a proprio agio nell’ambito di procedure che si conoscono, che interagiscono fra loro, e che delimitano in maniera sempre più netta e rigida il confine del mondo privo di procedure che aspetta soltanto di essere regolamentato e quindi ricondotto nell’ambito del misurabile. Lo specialista è distinguibile proprio da questa sua spavalda certezza dei valori, dei suoi valori, che tendono a debordare verso l’esterno, proprio in quelle direzioni di conoscenza delle quali egli, in quanto specialista, ignora tutto o quasi tutto. Ma questa ignoranza non gli appare più come un elemento negativo, cui porre rimedio, ma soltanto un remoto luogo della desolazione da colonizzare, un selvaggio caos dove portare ordine e comprensione.
Tutto ciò non deve far pensare a una visione rigida della realtà. Non misuratori e tecnocrati. Ciò sarebbe stato inevitabile in altre epoche, ormai lontanissime dall’era informatica attuale. L’elaborazione di nuove procedure qui manifesta un considerevole livello creativo, permettendo ironiche riflessioni sugli aspetti organizzativi della società. Il paradossale e il contraddittorio ha quindi accesso nelle tecniche di ragionamento. Ciò permette di fare esplodere molte pratiche in senso visionario e forse surrealista, se ci si potesse mettere d’accordo su questo termine. Ma la cosa non ha importanza. Ha importanza invece il parallelo meccanismo di accettazione di tutte quelle tecniche oggettive che rendono possibile la rottura visionaria della realtà. In un certo senso, il viaggio viene realizzato a spese della meccanizzazione del sogno, proprio dei livelli neurologici che non siamo in grado di controllare, salvaguardandoli da implicazioni ordinative inconsce.
Viene così fuori un realismo implicito che costruisce se stesso indipendentemente dalle decisioni, e dai desideri, dei partecipanti all’esperienza cyberpunk. I processi di organizzazione elettronica dei dati costruiscono questa realtà, all’interno della quale ogni esperienza, anche violentemente visionaria, finisce per diventare codice e cifra della medesima comunicazione digitale. L’avventura virtuale, almeno per il momento centro della cultura cyberpunk, può correre il rischio di disseminare le intenzioni proprio in quel territorio della codificazione dove ogni gioco potrebbe essere letto in chiave confermativa proprio dal potere. L’implicita ideologia della tolleranza reciproca anche nei riguardi di qualsiasi hackeraggio, per quanto estremista questo sia, nasce e si alimenta nell’ipotesi, per il momento non dichiarata ma sotterranea, che il potere sia in grado di recuperare qualsiasi atteggiamento gestionario nel settore dell’informatica. Nei prossimi anni, le condizioni oggettive di questo rapporto potrebbero modificarsi, sia per l’attuazione (nel settore si avanza a grandissima velocità) delle speranze dei cyberpunk, come pure dell’acutizzarsi delle preoccupazioni del controllo sociale.
Che ci siano intenzioni demistificanti questo è anche vero, e le attività di recupero e di sottrazione servono indirettamente a studiare i comportamenti del potere nella gestione e nel controllo dei dati. Ma ciò torna ben presto sotto la copertura, a mio avviso maligna, del fatto tecnologico stesso, che interferisce con l’intenzione spostandola in modo irrefrenabile al di là del proprio stesso progetto. L’ideazione di nuove procedure è certo un’astrazione che utilizza il mezzo cablato come occasione, ma finisce per diventare essa stessa occasione d’un momento intermedio del mezzo stesso, e ciò a partire dalla soglia dell’incontrollato sistema complessivo d’interazione tecnologica. Da notare che tutto ciò avviene a due livelli: nel livello specifico, in quanto nessuna creazione può sottrarsi alla propria interattività nel sistema; nel livello tecnologico in generale, in quanto una interazione più ampia finisce per giocare sullo sviluppo di tutti i settori tecnologici, e ciò in modo del tutto fuori controllo. Non esiste niente al mondo, né il cyberpunk né la struttura di potere, che può controllare questo secondo livello di interdizione tecnologica.
Molti sottolineano gli aspetti negativi di una collaborazione di alcuni partecipanti al movimento con il governo tedesco, oppure fanno dell’ironia riguardo la restituzione dei soldi rubati tramite il computer allo scopo di dimostrare le debolezze della controparte. Non credo che questi siano argomenti seri nell’ambito di una critica sostanziale all’attività del processo dell’interagire informatico. Prima di tutto perché si tratta di decisioni personali e poi perché il terreno dell’eventuale critica deve essere quello dell’utilizzo possibile della tecnologia in generale, e di quella informatica in particolare, in maniera diversa da quella controllata e gestita dal potere. In altri termini, la sola domanda da farsi è se diventa possibile un utilizzo realmente individuale del mezzo informatico.
La fine della comunicazione, visibile nei brandelli della parola scritta, sembra contrassegnare l’inizio del terzo millennio. Può lo spazio virtuale che ci si apre davanti costituire spazio effettivo di comunicazione, oppure diventa un modo di sigillare la bara dell’individuo? La gestione massificata della comunicazione procede in modo verticale, mentre si riducono gli spazi di rapportazione fra individui. Quando questi spazi sopravvivono, essi vengono inglobati nel codice unificato del settore, appaiono cioè, come trasmettitori di uniformità di notizie che diventano significative proprio perché preventivamente omologate nell’identico contenitore. Tutto sta nel vedere se il modello virtuale che viene proposto riesce veramente a muoversi in orizzontale, oppure se questo movimento non è altro che un passaggio dall’intenzione all’omologazione, e ciò nell’attesa che l’altro, proprio in quanto interlocutore, venga definitivamente sostituito dalla macchina stessa e dalle sue potenzialità virtuali.
Ma tutto ciò, almeno da parte cyberpunk, ha una premessa condizionale, cioè quella tutta da provare che la macchina possa essere posta realmente al servizio dell’uomo, e che il potere non possa, parallelamente, immagazzinare tutte le informazioni sufficienti a gestire la tecnologia informatica e, allo stato attuale delle cose, la totalità del processo di produzione e controllo. Lo scopo dell’hackeraggio sarebbe quindi solo quello di dimostrare quante e dove sono le crepe nella struttura di controllo dell’informatica dominante. Se questo scopo fosse praticabile dovrebbe essere certo anche il pensiero opposto, cioè che la struttura dominante non avrebbe mezzi per correre ai ripari in maniera radicale. Ora, per quel che può essere l’esperienza negli altri campi e nelle altre modalità di attacco, la capacità di correre ai ripari c’è sempre, e questa capacità resta diciamo così dialogica solo nel caso in cui l’attacco si mantiene nell’ambito del procedimento simbolico. Entrando nell’ambito della distruzione vera e propria, la struttura di potere modifica il proprio atteggiamento e ai ripari aggiunge contromosse non solo repressive, ma anche organizzative.
Quello che voglio dire è che un disturbo dimostrativo può semplicemente convincere la controparte a includerlo nelle variabili della gestione, come percentuale d’incertezza. Un disturbo più radicale, porta a provvedimenti che sul piano tecnologico non possono essere studiati e valutati da chi semplicemente interloquisce con la struttura di potere, proprio perché la sua azione non li provoca e quindi non li costringe a venire fuori. Permanendo un simile approccio, che sembra generalizzato a sufficienza, le affermazioni pro e contro rimangono semplici petizioni di principio.
Supporre che i risultati ottenibili attraverso l’impiego della tecnologia elettronica non s’indirizzano direttamente verso una crescita della coscienza umana solo perché essi si trovano a essere gestiti da una minoranza, essa stessa priva di coscienza sociale, o è una tautologia senza speranza o è un’illusione innestata nella funzione sociale della tecnologia in generale e informatica in particolare. Possono gli esclusi raggiungere un differente utilizzo? Può questo ipotetico differente utilizzo diventare obiettivo di tutti coloro i quali si prefiggono l’attacco contro la gestione del potere? Il problema è quello classico della lotta contro chi gestisce il dominio, solo che adesso, in aggiunta agli aspetti tradizionali di questo problema, si devono tenere presenti anche le componenti specifiche, e le interazioni del mezzo elettronico.
Ciò non vuol dire che ci si debba disinteressare demonizzando qualsiasi aspetto della tecnologia elettronica o limitandosi ad attaccare le sue espressioni oggettive più a portata di mano. Questo chiuderebbe la conoscenza diretta dei possibili effetti psicologici di questa tecnologia e quindi ogni sviluppo degli attacchi diretti a porvi rimedio contrastandone le relative implicazioni sociali e politiche. Solo che mi sembra ingenuo affidarsi all’equazione che pone in termini di processo lineare l’interessarsi di questi problemi con un certo sforzo teorico e il ricavarne la possibilità di capire e decidersi per porre rimedio agli aspetti negativi nella contemporanea conservazione degli aspetti positivi.
A scanso di equivoci, e quindi di inutili polemiche sull’uso del computer o sul preferibile ritorno alla penna d’oca, si deve precisare che non c’è nulla di sacrale nel sospetto contro la razionalità in generale e contro l’addentrarsi, muniti di piani a lungo termine, all’interno delle strategie (per altro velocemente sostituite e costantemente sul punto di essere superate) dell’informatica. Su questo problema, due punti da notare: primo, non mi pare indispensabile una conoscenza altamente sofisticata per rendersi conto, al livello di coscienza rivoluzionaria, dei pericoli di questa tecnologia; secondo, non bisogna dimenticare l’effetto specialistico sul singolo individuo del lavoro stesso di penetrazione nel mondo informatizzato. Qualcuno potrebbe rispondere che limitare questo approfondimento conoscitivo, in un mondo che di per sé viaggia globalmente verso l’informatizzazione, equivale a stare su di un treno e disinteressarsi della sua destinazione, obiezione giusta, senza che con questo ci si senta obbligati a diventare piloti del treno per capire se la destinazione è quella giusta o quella sbagliata.
Molti sono i modi per divertirsi, e la realtà virtuale ne prospetta di nuovi e affascinanti. Non si può allegramente sostenere però che questo equivale all’azione che potremmo svolgere (ma che spesso non svolgiamo) nella realtà concreta. Tra una fruizione passiva dei mezzi telematici, in primo luogo la televisione, e quella attiva, a partire dal semplice videogioco, passa una considerevole differenza, ma stranamente questa differenza corrisponde in modo sospetto a quello che il potere si aspetta da noi, cioè una risposta falsamente attiva alle sue sollecitazioni, un concorso alla realizzazione di quelli che sono i ritmi d’iniziativa codificati e omologati dal consenso globale. La figura dell’attuale spettatore che si beve la birra davanti alla televisione guardando l’incontro di calcio preferito, potrebbe sostituirsi in un futuro non lontano con lo spettatore (sempre lui) che si gioca una sua partita alla televisione, o ad altro mezzo telematico, e ciò mentre altrove gli inclusi decidono delle sue sorti di soggetto passivo improvvisamente illusosi di possedere una fantastica forza capace di sconvolgere il mondo.
Ma il mondo è altro, e quest’“altro” potrebbe così restare per sempre lontano dalla nostra portata.
[Pubblicato su “Anarchismo” n. 68, aprile 1992, pp. 27-30 col titolo “Cyberpunk e tecnologia”]
Guy Debord
Girotondo nello spettacolo.
Guy Debord, forse il situazionista più conosciuto, è morto suicida. Tutto il suo pensiero ruota attorno a un libro, e questo libro attorno al concetto di spettacolo. Concetto importante e saccheggiato su cui un po’ tutti abbiamo vissuto a credito, chi più e chi meno. Ma il credito maggiore l’ha avuto proprio lui, che si è avvolto in questo concetto, come in un sudario, evitando di esporsi agli spifferi delle vicende umane. Tutte le volte che qualcosa accadeva fuori della sua cella di monaco, egli si affacciava alla finestra e, direttamente, o indirettamente per bocca dei suoi correligionari, la incasellava all’interno della teoria dello spettacolo concentrato, diffuso e, infine, integrato. Qui tutto tornava a riappacificarsi, proprio nella pretesa apocalittica di poter tutto distruggere. Lo spettacolo assorbiva la realtà, quindi anche se stesso, in quanto rappresentazione, e il suo profeta. In questo è consistito il suo inobliabile contributo alla produzione di pace sociale. Adesso osserviamo indifferenti il triste spettacolo dei suoi discepoli in lacrime, intenti a strapparsi i pochi capelli residui. Tutto qui.
[Pubblicato su “Canenero” n. 7, 9 dicembre 1994, p. 11]
Decisionismo
Qui si annida un equivoco che voglio cercare di dipanare. L’accademia ci ha fornito analisi – a uso e consumo del capitale – che hanno fatto vedere, specialmente in questi ultimi venti anni [1989], come il vecchio pensiero decisionista sia ormai superato e che al suo posto vada collocato un nuovo pensiero, il quale per distinguerlo dal primo, discutibilmente “forte”, si è definito debole. Con un equivoco che ricorda, rovesciato, quello a suo tempo diffuso sul pensiero di Schopenhauer, molti compagni si sono ribellati contro una tesi del genere, considerando un pensiero debole come qualcosa di oltraggioso. Come se spettasse all’accademia stabilire che cosa sia il pensiero, per cui una volta emessa la sentenza di debolezza non ci resta che cospargerci il capo di cenere. Cosa vogliamo fare? Dimostrare che il pensiero è forte? Con tutti i guai che abbiamo non ci mancherebbe che questo.
Ora, per la verità, il pensiero, non è né forte, né debole. La teoria sì, una teoria in particolare può essere forte e può, anche, essere debole. Teorie scientifiche forti sono quelle deterministe, conclusesi con la fine dell’Ottocento. Sono teorie deboli quelle più moderne, a sfondo indeterminista, che ammettono i limiti della conoscibilità umana. Filosofie forti sono i grandi sistemi che spiegano il mondo, gli idealismi di destra e di sinistra. Filosofie deboli sono i pragmatismi e gli irrazionalismi più o meno riformisti o estremisti. Come si vede non c’è che l’imbarazzo della scelta. Una società con una forte ideologia di progresso, come accadeva più o meno una ventina d’anni or sono, utilizza un pensiero debole di tipo pragmatista; se ha un’ideologia centralista, burocratizzata, ne utilizza uno forte, per forza di cose a sfondo idealista. Una società come quella in cui viviamo ha bisogno di un pensiero debole, che dia spazio a una scienza debole, in una società che fa della debolezza la propria possibilità di sopravvivenza, anzi che ha impostato la gestione del dominio in modo morbido.
Le vecchie concezioni rivoluzionarie erano tutte basate su di una teoria forte, mutuata dallo storicismo (versione liberista) o dal marxismo. Molte delle stupidaggini che l’anarchismo continua a friggerci in tutte le salse, sono derivate da un pensiero forte storicista e, in piccola parte, hanno degli inconfessati debiti col pensiero forte marxista.
Visto che ci siamo, ripuliamo il terreno di un altro equivoco. I fascismi non hanno mai veramente utilizzato una teoria debole, al contrario si sono tutti basati su teorie forti come l’idealismo. Gli orpelli delle chiacchiere sulla razza, sul biologismo, sulla genetica, sullo spazio vitale, sul destino dei popoli, a ben vedere si ritrovano tutti nelle superfetazioni delle teorie idealiste. Non bisogna accettare come un dogma la tesi stalinista dell’irrazionalismo uguale fascismo, così come è stata esposta, in modo splendido, a dire il vero, nel libro di Lukács: La distruzione della ragione. Dall’ultimo Schelling a Hitler, il tragitto non è assolutamente lineare. Purtroppo la sudditanza verso l’egemonia culturale marxista ha impedito una riscrittura seria di questa storia.
Le recenti chiacchiere che molti anarchici americani hanno fatto, chiacchiere scimmiottate anche da qualche nostro compagno italiano, sulla fine della rivoluzione e sull’avvento della pratica di rifiuto pacifista e di massa dell’autorità dello Stato, sono un esempio di accettazione (non il solo possibile) del pensiero debole di origine pragmatista. Non è un caso che fra questi compagni si trovano filosofi allievi di Popper, ed estimatori di quella corrente di pensiero che si richiama al circolo di Vienna e all’empirismo logico. Non sanno, e i peggiori di loro, quelli legati al carro delle università, fingono di non sapere, che quel pensiero è alla base del peggiore dei riformismi, quello paternalista.
Esiste un rapporto tra teoria e azione? Io penso di sì. E penso che la teoria non si inventa, nemmeno si può considerare – come erroneamente faceva Malatesta – una cosa che va al di là e non ha molta importanza di fronte alla pratica. Non possiamo nemmeno considerare la teoria in modo riduttivo, come semplice analisi delle condizioni oggettive per provvedere, al più presto, al perfezionamento di una strategia di lotta. Il pensiero è qualcosa di più organico e si intreccia in modo molto complesso con la realtà sociale. Per questo motivo non possiamo tralasciare la ricerca e, ovviamente, nemmeno l’azione.
Oggi, il crollo delle certezze è generalizzato. Se ciò può farci piacere per quanto riguarda la fine della fede in Dio o della fede nel partito, non dobbiamo fermarci ad accettare questo fatto come uno dei tanti fatti che ci passano sotto il naso. Dobbiamo chiederci perché. Sarebbe grave se dovessimo essere noi soltanto quelli che non capiscono che i tempi cambiano e le realtà si modificano.
Dobbiamo avere il coraggio di interrogarci sul nostro patrimonio culturale e di farlo criticamente e non limitarci ad affermare che comunque e in ogni caso “Viva l’Anarchia!”. Quindi dobbiamo darci gli strumenti di questo approfondimento.
La fine del decisionismo si riflette in tutti i campi, anche in quello altamente specializzato del pensiero. Non esistono più punti di riferimento autorevoli, luoghi deputati alla scelta di decisioni a cui fare riferimento. Né esistono uomini in grado di ricoprire questo ruolo. Se la Storia non ha più burattini, questo, in quanto animale antistorico, non posso saperlo e non mi interessa. Ma, se non ci sono “grandi” uomini, e quindi non ci sono nemmeno “grandi” pensatori, non per questo sono scomparse le loro ombre. E queste continuano a tormentare i presenti.
Le tragiche conclusioni della scienza e della filosofia, che non c’è più verità scientifica, né tanto meno filosofia da realizzare, non possono riassumersi in una corrente di pensiero. Niente nichilismo, quindi, inteso come pietra da mettere sopra il problema e non pensarci più. Mancanza di certezza, questo sì. Ma è un’altra cosa. Vediamo perché.
Il filosofo, e le sue trasformazioni più recenti (psicologo, economista, sociologo, ecc.) è stato sempre un aiutante del principe, un uomo di corte. Il fatto che il principe si sia trasformato non poteva non causare, a sua volta, una trasformazione nel ruolo del pensatore e quindi anche nel pensatore come uomo. La realtà è che non esiste più un’etica forte. La chiave dell’analisi sta qui. I nostri ideali di solidarietà, di libertà, di uguaglianza, non possiamo fondarli come in passato, ma dobbiamo metterli in discussione, dobbiamo rischiarli. In passato Kropotkin, a esempio, e si tratta di un nostro esempio, aveva fondato la sua etica sulla natura; giusta o sbagliata, provata o non provata, quella sua scelta, oggi, negli stessi termini è improponibile. Noi cogliamo, nel lavoro di Kropotkin, un contenuto diverso, quasi sotterraneo al suo stesso tentativo scientifico di ricerca, un contenuto legato all’indagine sui processi di autorganizzazione e di movimento, ma questo è un andare oltre, e spesso anche contro, una interpretazione non adeguata dell’insieme del suo lavoro. La verità è che quel lavoro è irrimediabilmente datato, che le conseguenze a cui quelle scelte condussero, sempre ripresentabili (a esempio, l’accettazione della guerra come male minore), oggi, in mutate condizioni, vanno scoperte e denunciate sotto altre spoglie e con altri mezzi d’indagine.
Il rischio che dobbiamo correre è quello di non partire da una catalogazione a priori della morale. Non sappiamo più, e forse non l’abbiamo mai saputo, dove sta il bene e dove sta il male. L’imperativo categorico era un’invenzione, un gioco di parole, non una realtà. Lo stesso la bontà insita nell’uomo e nell’animale, fuori o dentro la specie. In fondo, non sappiamo se l’uomo è buono, e nemmeno l’animale. Non sappiamo neanche se è cattivo. Se non vogliamo ridurre tutto questo discorso in banale relativismo, dobbiamo dichiarare questa debolezza di partenza. Nessuno può sapere, con certezza, se un determinato comportamento è buono o cattivo, se non si impegna direttamente e personalmente in quel comportamento, se non è coinvolto nell’azione. Ma questo è difficile. Ci vuole coraggio. Più tranquillizzante è l’indicazione oggettiva. Mettiamo il seme qui, anche se c’è la neve, verrà il sole, non può mancare di venire, e quel seme fiorirà. Ebbene, oggi sappiamo che senza di noi quel seme non fiorirà di certo. Forse non fiorirà nemmeno con noi. Ma non abbiamo altra scelta. La vita, tutta la nostra vita, è in quella partecipazione, in quell’impegno totale. In caso contrario, non solo perdiamo la capacità di individuare il bene, ma anche perdiamo la nostra vita.
Non erano solo i dominatori di una volta a sognarsi la mascella quadrata. Vecchi e nuovi, si riscoprono sempre uguali a se stessi. Hanno bisogno di progetti sicuri che, se non marciano con loro, marciano anche senza di loro. Hanno bisogno delle masse, e queste di loro.
Ma, anche nel piccolo della nostra vita, chi non desidererebbe avere la capacità di decidere sempre e bene, prima degli altri, meglio degli altri? Chi non vorrebbe avere la vista più lunga e la mano più svelta? Chi non vorrebbe essere sempre il primo, il più elegante e, perché no, il più bello?
Eppure qui c’è sotto un imbroglio. Un piccolo, invisibile, miserabile imbroglio. Ci costruiscono addosso una scala di valori, utilitaristica, frutto della nostra classe e del nostro tempo, e ce la spacciano come fosse il fondamento oggettivo della morale. Noi facciamo di tutto per venirne a capo, ma difficilmente mettiamo le mani sulle nostre piccole cose sicure. E quando ci coinvolgiamo in qualcosa chiediamo sempre una garanzia. Se scommettiamo una cifra, non ci giochiamo mai tutto il capitale. Sottoponiamo a critica un campo di rapporti, ma vietiamo a tutti l’ingresso in un altro campo. Abbiamo sempre, alle nostre spalle, uno spazio riservato di terreno dove collochiamo il nostro personale santuario, dove trasferiamo i nostri lari non appena sentiamo odore di bruciato. Ci impegniamo, certo, ma con parsimonia. In questa logica del risparmio, sappiamo anche essere decisi. Dal grande uomo politico che la mascella quadrata ce l’ha davvero, il quale si gioca ogni giorno qualcosa ma ha il conto in Svizzera; al piccolo uomo della strada, perso nei problemi della famiglia, del lavoro e dell’avvenire dei figli. Fino ad arrivare al rivoluzionario, che può anche mettere a repentaglio tutto ma deve avere un ideale, altrimenti preferisce tornare alla vita ordinata di tutti gli altri.
Viviamo in un mondo dai colori tenui. È finita l’epoca dei grandi contrasti. Le insurrezioni di domani non saranno sullo schema di quelle di ieri. Per stimolarle, per cercare di farle sviluppare, per renderle quanto più pericolose possibile, occorre prima di tutto capirle.
I grandi motivi che spingevano all’azione ieri, motivi così evidenti da fare ammutolire la Storia, non esistono più. Oggi lo spettacolo quotidiano del massacro ci ha abituati a quanto di peggio possa esistere. Peraltro, la miseria, da per se stessa, non fa spettacolo, quindi stiamo quasi dimenticandola. Chi la subisce, il più delle volte, è talmente marginalizzato da non avere nemmeno la forza di reagire. L’asse della ribellione si sposta lentamente dalle antiche motivazioni, ancora presenti e largamente diffuse ma non più operanti, a nuove motivazioni, più sfumate, più difficili da capire.
Finita anche l’epoca del dominio forte, del capitalismo duro, avventuroso e di rapina. Le prospettive sono quelle del reperimento sempre più soffice del consenso, sono chiari gli indizi di un coinvolgimento sempre più gigantesco, di una separazione tra una minoranza di gestori e una maggioranza di gestiti. Nelle sottili sfumature dei colori svaniscono anche le possibilità di vedere chiaro il nemico. Il vecchio decisionismo è sostituito da una radicale sostituzione dei valori comuni, quelli in nome dei quali ognuno, dal proprio lato della barricata, combatteva e moriva.
Un’analisi che cerchi di spiegare questo profondo cambiamento, non può più utilizzare i grandi miti del passato. Il marxismo è stato una delle ultime vittime illustri. Ma a piombare giù non è tanto questo o quel progetto filosofico, ma proprio l’intera pretesa di una spiegazione ideologica del mondo. I grandi affreschi del passato, che spiegavano il mondo in mille pagine, sono letture ancora valide come qualsiasi altro romanzo. Possono anche essere occasione per riflettere sul destino dell’uomo, ma non sono spiegazioni della realtà, quindi non possono essere strumenti di trasformazione.
Questa polverizzazione della teoria sistematica, si è ripercossa nel campo delle scienze specifiche, in primo luogo l’economia e la sociologia, poi – ma qui il discorso è di interdipendenza reciproca – in fisica, e così via. Il quadro generale, dove siamo obbligati ad attingere i dati, è molto cambiato. Si può dire che non esistono più concezioni che si affidano all’oggettivo funzionamento di un processo, quale esso sia, spirituale o materiale. Il crollo delle illusioni, da questo lato, è stato pressoché totale.
In un mondo con maggiori dettagli visibili, si impone una modestia di fondo, se non si vuole fare cattiva figura. Una volta, sembrava possibile sorvolare su molte cose, tanto, bene o male, quello che occorreva era soltanto la fede nell’Anarchia. Oggi, sappiamo che non si possono ignorare le condizioni specifiche della realtà che ci circonda.
Più di quanto accadeva in passato, oggi, se vogliamo agire, dobbiamo conoscere.
Per motivi diversi queste posizioni, diverse fra loro ma tutte fondate su di un unico modello logico, sono ormai superate. Uno scontro frontale, di forze rivoluzionarie contro gli arroccamenti reazionari, è ormai impossibile. Non per i motivi che certi timorosi di Dio si sognano, quali, a esempio, quelli di un controllo ormai generalizzato o di un’azione opportunamente tenuta segreta ormai impraticabile. È il nemico stesso che ha cambiato sostanza, si è diffuso nel territorio internazionale, spostando non solo i centri produttivi, ma dematerializzando i centri decisionali. Questo lo ha reso più debole? Non sono convinto. Lo ha reso, e lo sta rendendo, più adeguato a condizioni di produzione che dovevano cambiare. La nuova capacità di rafforzamento deriva tutta dall’avere sempre meno bisogno di utilizzare la forza lavoro, insomma, chiamatela come volete, di utilizzare la classe dei lavoratori, l’antica classe operaia. Lo sbriciolamento di quella vecchia, a sua volta mitica, compattezza è ormai un fatto innegabile.
Non c’è più il cuore in uno Stato che non è più un Moloch immane e poco flessibile. Le strutture statali stanno cambiando velocemente. Con le moderne fibre ottiche si riescono a mandare via telefono bilioni di informazioni al secondo per ogni fibra. Ne deriva che lo spostamento a livello planetario delle informazioni è ormai un dato certo. Su questa base, essenziale per ogni possibile sviluppo, il decentramento decisionale deve per forza seguire a quello, di molto più avanzato, che è l’accentramento produttivo. Dobbiamo smetterla di pensare alla presa del palazzo d’inverno, o rischiamo di diventare ridicoli.
Per ultimo, tutto ciò fa scadere d’importanza l’aggregazione tradizionale, il peso della mobilitazione dei grandi numeri. Le strutture di lotta di domani devono anch’esse essere flessibili, ed è proprio quello che andiamo dicendo da anni.
Un sindacato no. Nemmeno rivoluzionario. Pensate al ridicolo di un sindacato bancario, con coloriture libertarie, di cui ho avuto notizia. Ormai fuori del tempo, queste forme organizzative sono penalizzate per la loro ipotesi di fondo e per il referente, oltre che per la limitatezza del metodo e degli obiettivi. Il discorso diventa più difficile se ci si riferisce a forme sindacali alternative: nuclei di base, e altro. In questo caso, soltanto se il metodo ha la meglio sulla richiesta, cioè se la conflittualità finisce per diventare permanente e quindi travalicare l’immediatezza e la limitatezza degli obiettivi economici e contrattuali, si può cominciare a discutere in termini positivi.
La struttura di massa nuova, come abbiamo più volte ricordato dovrebbe essere un punto di riferimento, abbastanza visibile in termini fisici e programmatici, ma non da diventare necessariamente un polo di aggregazione. Può crescere, anche quantitativamente, nel corso delle lotte, per poi tornare a essere punto di riferimento e basta. I compagni capiscono – o dovrebbero capire – subito la funzione di queste strutture. In sostanza, nessuna lotta può essere intrapresa, con un minimo di progettualità a breve termine, se non si costruiscono queste strutture, specifiche, con obiettivi sia pure minimi, ma chiari, con metodi non semplicemente rivendicativi ma anche di lotta e di azione diretta. Parallelamente alla struttura devono però crescere anche gli interventi di attacco diretto, distruttivo, contro l’obiettivo della lotta. Questi attacchi possono aspettare che la struttura cresca, non possono aspettare un’adesione di massa. Anzi, per la verità, dovrebbero iniziare prima della nascita della struttura, prima che questa svolga le sue iniziali lotte di carattere intermedio.
Fra le tante critiche fatte a questo schema logico di lavoro rivoluzionario, quelle più attente, hanno sottolineato due elementi: primo, che la separazione tra strutture di massa (sia pure nei termini sopra descritti) e attacco distruttivo parallelo non è né possibile, né auspicabile; secondo, che proprio queste azioni distruttive impedirebbero la crescita della struttura di massa.
La risposta è semplice. Per cominciare bisognerebbe togliersi dalla testa quello che invece ostinatamente si ha tutto l’interesse a lasciarvi dentro. Questi attacchi sono diffusi nel territorio e non presuppongono affatto il modello clandestinizzato che abbiamo visto all’opera in un recente passato. Non stiamo suggerendo di dare vita a complesse operazioni del genere “cuore dello Stato”. Ora, chi non vuole capire, continua a fare di no colla testa, ma in fondo sa di non volere capire. Basta che si limiti a fare attenzione ai pochi concetti che andiamo precisando. Potrà condividerli o no, ma almeno avremo la soddisfazione di un fondato non essere d’accordo. Quindi, nessuna separazione di principio tra struttura di massa e tentativi paralleli di realizzare attacchi distruttivi. Soltanto una separazione oggettiva, di tempi, di luoghi, di sigle, di persone e ciò per evitare quel minimo di computisteria che ogni poliziotto conosce. Anche il secondo elemento critico, quello che azioni del genere finirebbero per coinvolgere la struttura di massa, cade se si pensa bene al fatto che non stiamo, ancora una volta, parlando di grandi organizzazioni clandestine armate, ma di gruppi di pochi compagni che realizzano azioni, semplici, diffuse nel territorio.
I due livelli di intervento sono necessari per tutta una serie di considerazioni.
Le strutture di massa, flessibili e impiantate su di una conflittualità permanente, risultano più adeguate alle realtà in corso di modificazione. Luoghi della produzione con contraddizioni profonde tra vecchio e nuovo, ma anche realtà periferiche, dove il vecchio predomina e si scontra con le propaggini del nuovo che intende impiantarsi e riduce all’osso i livelli di sopravvivenza. E poi le realtà metropolitane, i grandi ghetti dove la violenza si traveste di mille atteggiamenti ma in fondo è sempre quella della miseria che non trova sbocchi. Le recite periodiche, davanti alle cattedrali dove si condensava la rappresentazione del mito statale, andranno sempre di più a scomparire, man mano che la ristrutturazione si realizzerà nel pieno della sua efficienza. Anche i luoghi di alta concentrazione militarizzata tenderanno a scomparire, almeno nei paesi capaci realmente di decentrare i comandi e gli obiettivi produttivi. Tramontano in questo modo, anche le malinconiche pose decisioniste di coloro che amavano portare davanti a questi obiettivi migliaia di persone che col loro peso corporeo, e null’altro, avrebbero dovuto capovolgere l’ago della bilancia.
Un’altra considerazione, fondamentale, è quella che si ricava dalla semplice osservazione di quanto sta accadendo nel mondo produttivo, proprio a livello tecnico, non solo a livello di ristrutturazione dei costi. La nuova base, assolutamente essenziale, è data dalle possibilità di comunicazione telematica. Ora, anche un profano, come in fondo siamo noi, capisce che questa comunicazione si diffonde sul territorio, come una rete. Colpire questa rete, in molti punti, con piccole azioni distruttive, facili da eseguire, senza grandi pretese militari, senza grossi rischi, può avere conseguenze di disturbo notevoli. Si potrà obiettare, come è stato fatto, che sarebbe l’equivalente di sgonfiare il palloncino del figlio del maresciallo. Obiezione idiota, secondo noi, non solo perché non coglie la realtà pratica di quello che proponiamo, i possibili sviluppi di questa realtà, l’importanza del coinvolgimento dei compagni in azioni di attacco e non in semplici chiacchiere; ma, principalmente, perché lascia intendere che chi la solleva è ancora legato alla mentalità tradizionale che solo le grandi azioni di attacco armato sono significative. Che poi sarebbe lo stesso che elogiare la tecnica delle B.R. ma non condividerne gli obiettivi politici. Quando, ed è la sostanziale realtà della storia di questi ultimi quindici anni, poche azioni di grande rilievo militare e di notevole complessità realizzativa, volute e quasi imposte dalle centrali operative dei partiti armati, hanno finito per snaturare un tessuto di decine di migliaia di piccole azioni che hanno di certo disturbato il potere e che sarebbero state molto più difficilmente recuperabili dallo Stato e dal suo apparato repressivo, specialmente se si fossero sviluppate come era nella speranza di tutti noi.
La maschera del decisionista nasconde il feticcio. Sognare la certezza perduta è umano, agire come se fosse ancora lì, davanti a tutti, è riprovevole. La miseria dell’infinitamente modesto rende la decisione, e l’atteggiamento quadrato, ancora più miserabile. Anche quando si pensa di essere nel giusto, la fede e la mancanza di critica conducono irrimediabilmente all’errore.
Il crollo delle grandi fantasie oniriche sull’andamento della Storia, sulla vittoria finale e sull’instaurazione del regno della libertà e dell’uguaglianza, è evidente dappertutto, solo gli anarchici continuano a pensare possibile una cosa del genere e a immaginarsi l’anarchia come suggeriva Hegel, come la società che diventa filosofia, liberatasi definitivamente delle sue contraddizioni di classe. In questa prospettiva, considerata non molto lontana, se si pensa di potere guardare a questa realtà sociale e produttiva come a qualcosa di utilizzabile dopo l’evento rivoluzionario, il decisionismo s’impone, e quando esso non appare si tratta solo o di inadeguatezza di mezzi o di timidezza personale. In fondo, ormai dovremmo sapere perfettamente bene che non possiamo conservare nulla di una realtà produttiva che ha una logica inutilizzabile, nulla di una società che deve per forza di cose essere sconvolta dalle sue fondamenta se si vuole evitare che si riproduca con tutti i suoi mali intatti. Niente di quanto ci sta alle spalle può ripresentarsi inalterato, né la tecnologia né la storia. Fra poco non saremo neanche più in grado di pensare a un possibile utilizzo della prima, mentre della seconda, forse, soltanto al nemico resterà la chiave di lettura. Forse, prima di quanto pensiamo, saremo costretti a combattere nel terreno della pura barbarie, nel medesimo campo dove ci rinchiuderanno, con l’illusione (questa volta esclusivamente loro) di averci sottratto il desiderio di essere liberi dandoci la certezza di una vita senza grossi fastidi.
Ecco perché, fin d’adesso, vogliamo attaccare, per essere pronti ad attaccare anche dopo, e poi ancora, ancora.
[Parte di quanto pubblicato su “Anarchismo” n. 63, luglio 1989, pp. 22-27 col titolo “Malinconie del decisionismo”]
Di tutto, di più
L’imbalsamato Filippo sembra che a suo tempo, molto tempo fa, abbia avuto alcune relazioni extraconiugali. La povera Elisabetta, regina dell’immarcescibile impero britannico, anche lei è stata quindi tradita dal consorte. Insomma questa famiglia reale inglese è uno schifo, come tutte le famiglie. Anzi, peggio delle altre famiglie perché qui si tratta di un’accozzaglia di semi-ebeti e di totalmente imbecilli, di gozzuti e svaniti che solo il peso della tradizione tiene in piedi a spese degli altri.
Il costo della monarchia inglese non è difatti trascurabile. Ma si tratta di un’istituzione. Dove andrebbero a pranzo gli ospiti di pari livello sociale, presidenti e regnanti di tutto il mondo, se non a Buckingham Palace?
Per i tabloid del Regno Unito è diventato una lucrosa attività dire male della famiglia reale, fotografando i suoi componenti dappertutto, perfino in mutande. Ma l’istituzione si difende. Dietro l’istituzione, ogni istituzione c’è sempre una sorta di supporto metallico che le regge, che assorbe le critiche e perfino i pettegolezzi e le maldicenze, riuscendo a trasformarli in nuova linfa vitale.
[Pubblicato su “Canenero” n. 19, 17 marzo 1995, p.7]
Distruggiamo la scuola
Come ogni anno anche questa volta, puntualmente, all’apertura della scuola si sentono dappertutto le voci di coloro che vi incitano allo studio e all’impegno. Sono le stesse voci di chi gestisce il potere e quindi di chi affama, uccide, sfrutta, violenta, sempre in nome di ideali sacrosanti, con la benedizione di cristi e bandiere.
Vi è stato detto, in modi diversi, che dovete fare di tutto per possedere un titolo di studio perché la società richiede lavoratori sempre più qualificati. Ciò è una triste menzogna. La vostra qualificazione non esiste. In pratica, dalle scuole uscirete automi o apprendisti automi, capaci di manipolare quei quattro soldi di istruzione che un potere arcigno ha creduto opportuno donarvi. Sarete chiamati a diventare sfruttati, disoccupati, emigrati, addetti a una macchina produttiva cieca e ottusa che non sarete mai in grado di comprendere. Ma non vi si chiede di capire. Vi si insegna a ubbidire, a fare come dice il professore e il preside oggi, il capetto e il padrone domani.
Lo squallore e la monotonia della scuola sono lo specchio degli orrori di domani, quando vi troverete ad affrontare la vita nella società del capitale, quando vi daranno ruoli produttivi e responsabilità, quando attorno vi si stringerà il cerchio soffocante della famiglia, del lavoro, dei debiti.
I privilegiati fra di voi, gli appartenenti alle classi più elevate, e anche i più preparati e intelligenti, avranno la possibilità di diventare essi stessi sfruttatori, ladri a fianco di ladri, assassini a fianco di assassini. Il resto, la grande parte di coloro che oggi possono solo attingere ai livelli di istruzione che il potere concede liberamente, costituiranno la massa di manovra dequalificata che il capitale destinerà ai più bassi lavori ormai quasi robotizzati senza stare a vedere se i singoli individui vanteranno diplomi e lauree, ormai svuotati di contenuto.
Ribellarsi è la sola possibilità di vita che vi resta. Accettare l’ordine di cose che la scuola vi impone significa dichiararsi sconfitti, adeguarsi, uniformarsi, vendersi alla volontà di professori che non sono altro che stupidi negrieri al soldo di loschi interessi.
Non basta ribellarsi rivolgendosi soltanto alla musica, al vestito, alla moto (per chi può permettersi queste scelte). Questo tipo di “ribellione” è già previsto e quasi voluto da chi gestisce le grandi centrali produttive musicali, della moda e della produzione in serie.
Il ribelle è l’anarchico che getta in faccia allo stupido sgherro che gli sta davanti (nelle vesti del professore, del preside o dello sbirro) l’urlo di quanto gli cresce dentro. La propria rabbia, la propria voglia di vivere, la propria gioia di sentirsi libero, la propria capacità di ribaltare i rapporti di forza imposti dal potere. Il ribelle è l’anarchico che getta in faccia al gregge muto e paziente degli altri giovani, quelli che non vogliono far niente e che aspettano soltanto di essere promossi per diventare automi di produttività, il proprio grido di rivolta. Ambedue: il lupo che azzanna e la pecora che si offre docile, sono strumenti insostituibili per la costruzione della società della morte. E noi vogliamo invece costruire la società della vita.
Basta anche con le analisi politiche, con le lunghe e balorde cicalate sulle funzioni della scuola nella società del capitale. Occorre fare tacere anche tutti coloro che nelle assemblee vi riempiono la testa con le frasi fatte di sempre, con le citazioni, con le grandi concezioni strategiche. Per il momento vi basta sentire fisicamente l’oppressione che le stesse mura della scuola vi provocano, la semplice visione delle classi, dei banchi, delle aule, delle facce impietrite dei professori. Gli anarchici non sono disponibili ad approfondimenti politici con chi non è d’accordo a distruggere, ora e subito, questa realtà che ci sta uccidendo tutti, a poco a poco, trasformandoci in robot.
Che cosa preferite? continuare a passare gli anni più belli della vostra vita sonnecchiando e annoiandovi sui banchi di scuola, sognando improbabili avventure, dandovi da fare per indossare un vestito nuovo o pilotare una nuova moto; oppure passare all’azione e decisamente capovolgere un rapporto di forza che vi sta soffocando? Cosa preferite? farvi uccidere dalla scuola o bruciarla e mandarla per aria?
Solo dopo essere venuti a capo di questa alternativa sarà possibile approfondire il reale problema della scuola, della società, della rivoluzione, della libertà, dell’uguaglianza e dell’anarchia. Per il momento, se non ci si dichiara per la vita, per la gioia, per la bellezza e contro la morte non si può fare nessun passo avanti. Occorre prima battersi, attaccare, poi fermarsi e ragionare. Se cominciamo dapprima a riflettere non faremo altro per tutta la vita, e sulla nostra ponderatezza gli altri costruiranno i loro imperi.
[Pubblicato su “Anarchismo” nn. 53-54, settembre 1986, p. 6 col titolo “Agli studenti”]
Droga
Ci sono almeno due modi di fare letteratura. Quello negativo e quello positivo. Si può stridere fin che si vuole sulle corde del proprio violino, senza con ciò riuscire a fare passare per musica quello che ne viene fuori. Ma anche un ottimo rifinitore manuale degli spartiti dei grandi maestri potrebbe non essere un vero e proprio musicista, e di regola è proprio così. Ne deriva che non bisogna tanto fare attenzione a come le cose si dicono, quanto a quello che si dice.
Sulla droga si sviolina come su tante altre cose. Ognuno a suo modo, anche se con scopi diversi. C’è chi parla con aria di sufficienza, anche se in fondo ne sa solo per sentito dire. Questa scienza gli proviene dall’esperienza degli altri, una vicenda “esterna”, ha guardato vicende che non possono essere le proprie, ha raccolto “testimonianze” che sono segnali e non realtà. Che poi si ponga nei riguardi di questi fatti con atteggiamento permissivo e tollerante, o suggerisca apocalittici provvedimenti, a mio avviso, la cosa cambia solo di poco.
C’è poi chi parla sollecitato da progetti di egemonia politica – nel grande come nel piccolo, anche qui la differenza è poca –, e costui non può essere definito che sulla base di quello che è, un farabutto.
Ci sono poi i disarmanti in buona fede, quelli che sono in buona fede per professione e di questo loro stato di grazia se ne fanno quasi un usbergo dietro cui avanzano timidamente proposte di “fare qualcosa”, che poi sono sostanziali rimodernature del più vecchio assistenzialismo.
Ci sono poi gli sviolinatori della mafia che abbinano la loro prolissa attività anche alla droga – evidentemente i due settori sono interdipendenti – e le imbecillità paradossali che dicono sulla “mafia”, si fanno un punto di onore di ripeterle pari pari parlando della “droga”.
Ci sono poi i “rivoluzionari” più avanzati i quali hanno, grosso modo, due posizioni, ambedue comiche, ma per motivi diversi. La prima è permissiva ma fino a un certo punto. Condividono l’uso delle “droghe leggere”, non quello delle “droghe pesanti”, questi spingono tanto avanti la loro lungimiranza fino al punto di farsi, qualche volta, consumatori in proprio, naturalmente con rivoluzionaria parsimonia, di piccoli quantitativi di “droghe leggere”, avendo cura di tenerne poco a portata di mano per non incorrere nei rigori della legge, ché non si tratta di cose “adatte” a un rivoluzionario. La seconda posizione è quella della condanna assoluta “leggere o pesanti, che differenza c’è?”, ambedue rincoglioniscono. La posizione dei “rivoluzionari” di cui parlo qui è certo parziale. La differenza tra “leggere” e “pesanti” mi è sempre sembrata spuria, anche perché è una differenza che viene dai laboratori giuridici del sistema, e la cosa non mi piace. Poi c’è il fatto che mi sembra troppo sbrigativo stabilire, una volta per tutte, l’equazione che tutti i drogati sono degli imbecilli senza midollo spinale, incapaci di autogestire la propria vita e quindi pezzetti di legno in balia del fiume vorticoso del potere.
Gli imbecilli e i superficiali, i deboli e gli incerti, i desiderosi di uniformità a qualunque costo, militano sotto tutte le bandiere, anche sotto quelle rivoluzionarie. Qui, accanto a me, sotto la mia stessa bandiera, li ho sentiti anelare spesso davanti a situazioni troppo dure per il loro palato debole di umanitaristi camuffati da leoni, o li ho visti camuffare le proprie debolezze sotto atteggiamenti da giudici spaccamontagne. Di qualche protesi abbiamo bisogno quasi tutti, non dico che anch’io non ne abbia bisogno. Se non altro, quando non posso dormire prendo una pillola, o mangio troppo quando sono nervoso, o cose del genere. Non stiamo trattando delle debolezze di ognuno, ma degli atteggiamenti davanti a quelle che pensiamo siano le debolezze degli altri.
Per questi motivi, considerando bene la mia posizione, la trovo “inattuale”. Non mi sento di sottoscrivere nessuna delle tesi di cui ho dato un breve elenco sopra. Nemmeno quella della superiorità con cui si considerano i cosiddetti “drogati” (ma “tossico” fa più “in”). La penso diversamente.
Ancora una volta dovremmo partire da una cosa ovvia: la libertà. Certo, mi si potrebbe subito rispondere che il ragazzo con poche capacità di scelta, di conoscenza, di prospettiva, ecc., non ha molte possibilità di partire dalla libertà. E allora? Cosa dovrei fare? Sarebbe come dire che mi dolgo moltissimo del fatto che gli sfruttati hanno poche possibilità di ribellarsi perché il potere è stato tanto bravo da metterli nel sacco. In effetti non mi dolgo per niente di una cosa del genere. Se lo sono voluto loro, con i loro miserabili e piccoli bisogni da soddisfare, e noi dietro di loro con i nostri altrettanto miserabili e piccoli suggerimenti in merito alle cose da fare per obbligare lo Stato a soddisfare quei bisogni. E così, ogni volta, i bisogni venivano più o meno soddisfatti o rimandati, e la cosa si prolungava un poco più avanti, permettendo risistemazioni del controllo e ristrutturazioni della struttura economica. Fin quando, se non oggi ma domani, gli spazi della rivolta saranno sempre più ridotti, quasi inesistenti.
Se l’individuo vuole stabilire un rapporto del genere con le droghe è libero di farlo, ma non mi si dica che è il solo rapporto possibile. Per anni, almeno per gli ultimi quindici anni [1988], ho pensato che la situazione che si aveva negli anni Cinquanta era diversa. Allora eravamo “cercatori di fuoco”, oggi possiamo cercare a lungo ma troviamo solo zombi piagnucolanti una “dose”. Ma io non mi bevo questo tipo di piagnisteo. È lo stesso che potremmo ascoltare davanti a qualsiasi porta proletaria o a qualsiasi tugurio della miseria più disgustosa e infamante – infamante principalmente a livello di dignità personale –, senza nessuno che alzi un dito mentre passa davanti ai vetri blindati di una banca dentro la quale le casseforti con la bocca spalancata non fanno altro che aspettare. Certo, c’è un problema “sociale” della miseria e dello sfruttamento, come c’è un problema sociale della droga, ma c’è anche un problema sociale della sottomissione, del perbenismo, del pietismo, dell’accettazione, del sacrifico. Se lo sfruttato è veramente un ribelle comincerà non certo col risolvere il problema sociale di “tutti” gli sfruttati, ma almeno risolverà il suo, senza stare troppo a menarla sulle cattiverie del capitalismo. Nel caso non ne fosse fisicamente capace, deve pur sempre valutare lui, personalmente, cosa deve fare, anche della propria vita, prima di arrivare all’abiezione della semplice denuncia della propria miseria.
Con questo non dico che ho in odio gli sfruttati o i poveracci che si drogano e barcollano in preda ai loro fantasmi, più psichici che fisici. Mi fanno pena, questo sì, dopo tutto sono anch’io un essere umano, ma non sono disponibile a fare qualcosa per loro. Cosa dovrei fare, condurli ancora una volta alla lotta per ottenere le case, l’acqua, la luce o la pensione, per poi passare alle nuove leve della miseria e dello scoramento? E per queste larve in trance cosa dovrei fare, fornirli di metadone? o costruire per loro un libertario e umanitarissimo ospizio? Ma non parlatemene neanche!
So per certo che il proletario sfruttato si può ribellare, se non lo fa anch’egli è responsabile, almeno allo stesso titolo di chi lo sfrutta. So per certo che anche il drogato si può ribellare, se non lo fa anche lui è responsabile, allo stesso titolo di chi si arricchisce sulle sue miserie. Non è vero che gli stenti, il lavoro, le miserie, le droghe, tolgono la volontà. Anzi, la possono acutizzare. Non è vero, come tanta gente senza esperienza diretta va affermando, che l’eroina, tanto per andare sul “pesante”, tolga la volontà o renda incapaci di agire con un progetto determinato e con una coscienza della realtà di classe, cioè del funzionamento dei meccanismi che producono, fra l’altro, anche il mercato della droga. Chi dice il contrario, o è un incompetente, o è un mistificatore. Nel drogato, anche nei cosiddetti elementi all’ultimo stadio (ma quale è poi questo ultimo stadio?), c’è sempre la coscienza di sé e la progettualità del sé. Se l’individuo è un debole, un povero fuscello, dal carattere di già segnato da una vita di stenti o di agi (a questo punto la cosa non ha poi tanta importanza), egli reagirà in modo debole, ma avrebbe fatto la stessa cosa in qualsiasi altra situazione si sarebbe venuto a trovare. Mi si potrebbe rispondere che la droga come protesi è certo più ricercata proprio dai soggetti deboli. Devo ammettere che questa obiezione è vera, ma non toglie validità al ragionamento (“inattuale”) che ho fatto prima, quello che sottolinea la responsabilità del debole nei riguardi della propria debolezza.
Mi pare sia giunta l’ora di cominciare a dirsi le cose fuori dei denti.
[Pubblicato su “Provocazione” n. 18, dicembre 1988, p. 11 col titolo “Inattualità sulla droga”]
Dubbio
È penoso constatare, come ricordava spesso Bakunin, che l’umanità non ha ancora trovato una strada migliore della Rivoluzione per affrancarsi della propria condizione di servitù. E la Rivoluzione non è purtroppo un fatto piacevole. Spesso resto sorpreso del fatto che molti compagni sognano l’evento rivoluzionario come una bella giornata, con tanta luce e il sole che sorge sullo sfondo, naturalmente il sole nascente, quello dell’avvenire. Ma, fuori da questa iconografia vieta, e scendendo nella cruda realtà dei fatti, penso che l’evento rivoluzionario, da quello mitico e glorioso, che in prospettiva tutti sogniamo, colorandolo ognuno come meglio crede, c’è la realtà rivoluzionaria, che è ben differente, concreta, pratica, violenta, spesso dolorosa, qualche volta sanguinosa.
Nessun compagno può arrogarsi il potere, massima espressione di tutte le autorità possibili, di giocare con la vita degli altri, solo il terrore bianco e fascista lo ha fatto e continua a farlo, solo i massacratori al servizio dello Stato lo fanno, tutti i giorni, come loro fatica quotidiana e, forse, ma non sono certo, anche loro non ci prendono gusto. Pensate un compagno, un uomo che ha la piena coscienza dei limiti e delle prospettive della propria azione, un compagno che conosce fin dove può arrivare e fin dove quello che sta facendo mantiene un senso e una fondatezza, una ragionevolezza critica e uno slancio umanitario, pensate come un individuo del genere, estremamente sensibile, possa decidere un’azione pericolosa a cuor leggero. Ma il fatto è che non c’è mai la certezza che non emerga il piccolo inconveniente, l’ostacolo imprevisto, l’attimo di ritardo, la presenza del bambino, del povero vecchio, del passante incolpevole.
A questo punto, la soluzione ha due aspetti: o si decide di sospendere tutto, in linea di principio, e per sempre, in quanto non ci sarà mai la certezza di colpire l’obiettivo giusto, o si decide di continuare lo stesso, ovviamente facendo “attenzione”, anzi la massima “attenzione possibile”.
Ma, nell’eventualità di un disastro, la coscienza del rivoluzionario potrà dirsi in pace con se stessa, solo perché certa di aver “fatto attenzione”?
Sono sicuro di no.
Ed è molto doloroso sapere che a questa conclusione non c’è alternativa.
[Pubblicato su “Anarchismo” n. 67, maggio 1991, p. 8 col titolo “Non c’è mai la certezza”]
Doris Durante
Al servizio del Regime.
Doris Durante, forse la più celebre attrice italiana del ventennio fascista, è morta a Santo Domingo. Non c’è anticamera o letto di gerarca fascista di un qualche rango che non ospiti la bellissima Doris. Per anni rappresenta la superficialità, e anche il provincialismo, di una piccola società italiana che si lascia dominare senza reagire. È ai Parioli il suo regno rosa e bianco. Si può dire che l’attuale fama del quartiere romano risale proprio a lei e alle frequentazioni che si alternano negli attici soleggiati dove trascorre l’annoiata vita delle amanti di Regime. Ma non ha lo stile della Petacci. In fondo è una povera guitta continuamente in cerca di protezione. Quando trova Pavolini, il suo destino sta per concludersi. Alla fine, a Verona, riesce a farla franca, e mentre il tragico segretario del Partito fascista viene fucilato, lei fugge in Svizzera con parte dei soldi della Repubblica di Salò. In lei mancano del tutto le qualità di simpatia e spregiudicatezza che in genere accompagnano molte arrampicatrici sociali e donne in carriera.
Una vita da poco, la sua.
[Pubblicato su “Canenero” n. 19, 17 marzo 1995, p. 11]
Ecologia sociale
Le riflessioni sull’ecologia, anche quelle che più precisamente si finalizzano come sociali, hanno una caratteristica che si potrebbe dire generale: vanno dall’ovvio alla parzialità.
Non che ci sia superflua l’ovvietà, anzi, al contrario, riflettere sui problemi sociali, che poi sono spesso gli stessi, non è mai una cosa superflua, fornisce strumenti a chi voglia veramente muoversi, fare qualcosa, contrapporsi a una condizione di sfruttamento e di miseria, non solo della natura, ma anche dell’uomo. E giustamente l’ecologia sociale sa tutto questo benissimo e lo svolge fino in fondo.
Affermare – come fa qualcuno – che l’ecologia sociale sia una “corrente libertaria che lavora per l’abbattimento di tutte le barriere” significa dire una cosa errata in quanto se esiste una corrente del genere, e noi non la conosciamo, non vediamo perché debba porsi come obiettivo la “riflessione e la sollevazione contro gli inquinatori eccellenti”, dove qui l’accento si deve per forza porre sul termine inquinatori. Insomma, una corrente libertaria è implicitamente una parte del movimento libertario nel suo insieme, sovranazionale e internazionalista, e, in quanto parte, giustamente, può scegliersi il nemico che vuole, quindi anche gli “inquinatori” che sono parte dello schieramento oppressivo e non costituiscono la totalità delle forme del nemico. Ora le cose ci appaiono contraddittorie: se col termine “inquinatori” ci si riferisce non solo agli inquinatori veri e propri, ma anche agli “insabbiamenti della partitocrazia” e alle “menzogne dell’informazione protetta”, tanto voleva allargare al massimo il ventaglio e aggiungere qualsiasi nemico, dal padrone delle ferriere al boia di Stato, tanto il peso sarebbe stato lo stesso. Però, così facendo, come mai tutto questo bel lavoro potrebbe caricarselo sulle spalle soltanto una corrente libertaria e non tutto il movimento anarchico nel suo insieme?
Questa situazione colpisce in modo atroce tutta la teoria ecologica sociale la quale risulta stiracchiata da un lato verso un anarchismo rivoluzionario che sarebbe la sua logica conclusione generalizzata e, dall’altro, verso un riformismo settorialista che si prospetta all’orizzonte come un migliorismo specifico e parziale. Da questo dilemma non si esce se non con chiare indicazioni di metodo e di lotta.
Parlare di una “battaglia di idee” è una bella cosa in quanto è delle idee che la gente ha bisogno ed è con le idee, degli altri, precisamente degli sfruttatori, che la si racchiude nel ghetto dell’imbroglio e dello sfruttamento. Quindi, ben venga questa battaglia di idee e ben si appoggi sui “bisogni quotidiani”, antica e legittima tesi sostenuta per tanti decenni dai correttori delle storture di regime, ma che penso dai nostri autori venga sostenuta in modo diverso. E la diversità è insita nel verbo “disobbedire”. Ma cosa vuol dire questo verbo? Disobbedire è forse “cooperare”? I due termini non mi sembrano sinonimi. È forse “solidarizzare” a livello internazionale? Anche qui la cosa mi pare dubbia. E poi cosa vorrebbe dire solidarizzare? Questo problema che è stato sollevato parlando del Fondo Monetario e di quello che si potrebbe fare per “aiutare” i popoli in lotta, ora, in questo momento, e se questo fare si debba per forza arrestare alla manifestazione (locale o internazionale) di “alto sdegno”, o possa anche arrivare all’attacco diretto contro individui responsabili e cose, senza con questo incorrere non solo nelle più che prevedibili ire degli organi repressivi, ma anche nelle delazione di alcuni cosiddetti compagni.
Disubbidire è un bel verbo, ma può portare lontano ed è facile fermarsi nelle vicinanze giocando con le parole a nasconderello ed evitando di prendere una posizione precisa.
Il lavoro del disvelamento è una bella cosa, ma risente troppo dell’antica iconografia marxista (la talpa, ecc.), per potere oggi reggere da solo. Siamo pieni di informazioni e di analisi, di controinformazione e di ermeneutica, abbiamo anche bisogno di qualcosa di più terra-terra, foss’anche un missile di questo tipo non sarebbe di certo una pessima acquisizione. Ma, a parte gli scherzi, che è bene evitare perché poi la polizia non li capisce, occorre che queste analisi scendano un po’ dal piedistallo dell’astratto e si avvicinino alla realtà concreta.
Che il muoversi fuori delle “armature ideologiche” riguardo il problema dell’ambiente “significa innescare movimenti, iniziative, devianze” è verissimo, e giusto, ma tutto ciò si deve per forza fermare allo scopo di “allargare la conoscenza, l’informazione, la cultura intorno alla situazione ambientale del pianeta”, o può andare anche oltre, può anche andare fino a procurarsi i mezzi per l’attacco di un nemico così ben identificato, illustrato, chiarito e posto sotto i riflettori?
Perché mai tutto deve ridursi “a un nuovo modo di pensare” e non comprendere un antico modo di agire? Tacere su questa alternativa può avere diverse spiegazioni: o non la si ritiene praticabile, e allora bisognerebbe dimostrare il perché; o non la si ritiene produttiva in termini immediati e anche in questo caso bisognerebbe dire il perché; o non la si ritiene nemmeno pensabile, e allora ognuno è libero di trarre le conclusioni che vuole.
L’elenco dei danni prodotti dal capitale è ben nutrito e abbastanza ben dettagliato, tale da potere essere condiviso a prescindere da qualsiasi etichetta ecologica o meno, a noi sembra quest’ultima una clausola assolutamente superflua, utile solo per attirare l’attenzione della gente e utilizzabile fin quando ci si limita a denunciare semplicemente i danni prodotti dal capitale e non si fa il passo successivo, necessario e ineluttabile, quello di prospettare una strategia di lotta. Facendo questo passo tutto quello che si era guadagnato in termini di possibilismo ecologico, e quindi in termini quantitativi di coinvolgimento di strati della popolazione a cui piange il cuore al solo pensare a quanti bambini muoiono di fame (ma solo a pensarlo), si perde in termini di concreta capacità di attacco.
Ora, non voglio affermare che non sia importante convincere larghi strati della popolazione dei crimini commessi dai responsabili del capitale (uomini e organizzazioni), mi limito soltanto a constatare che questa informazione è una parte, senza dubbio rilevante, dell’attività rivoluzionaria anarchica, ma non ne costituisce la totalità. Il fatto di chiamarla “ecologia sociale” non la sottrae per nulla alla responsabilità di dare concrete indicazioni di lotta e di attacco contro i suddetti responsabili, allo stesso modo in cui fanno gli anarchici, da sempre, e non solo gli ecologisti sociali.
Se è vero, com’è vero, che “ovunque esplodono momenti insurrezionali”, non è vero che questi, da per sé soli, “rappresentano punti di mutamento all’interno dei sistemi di pressione e di rapina”. L’insurrezione è l’inizio di un mutamento, non il mutamento stesso, tutti i movimenti insurrezionali che abbiamo sotto gli occhi nel mondo sono fenomeni in corso che hanno bisogno di aiuto, chiamano al soccorso. E la solidarietà internazionale cosa fa? Lascia che sia la lotta degli altri che prima o poi finirà per affrancarsi “contro lo sterminio per fame”, o che raggiungerà “la pace nel mondo, il disarmo unilaterale, la difesa diretta dell’ambiente, l’autogoverno dei cittadini?”. Ma andiamo, anche mettendo da parte il ridicolo di un’affermazione come “disarmo unilaterale”, che non mette conto criticare, resta il fatto ineluttabile che noi rifiutiamo di ridurre il nostro ruolo privilegiato alla semplice denuncia, al semplice sottolineare e cogliere “secoli di stupidità dissimulata come ragione”. Tutto ciò sarebbe troppo parziale.
Noi chiediamo con tutta la chiarezza che ci è possibile, a tutti i sostenitori dell’ecologia sociale, cosa vogliono dire in concreto affermazioni come: “lavorare contro gli specialisti della paura”, “chiedere l’impossibile”, “liquidazione di tutte le predazioni sui bisogni e sui diritti quotidiani di tutti”. Chiediamo cosa vogliono dire frasi come: “un’umanità non realizzata non è umanità”, “smascherare la miseria mercantile dell’apologia occidentale?”. Cosa mai vogliono dire queste strane battute se non che bisogna fare qualcosa per impedire la distruzione che il capitale a livello mondiale sta perpetrando. In caso contrario sarebbero affermazioni prive di senso, se non gesuitiche denunce di un pusillanime burattinaio da quattro soldi.
Ma le cose non stanno così, perché i nostri autori affermano chiaro e limpido che “ecologia della libertà significa che nessuno può più permettersi di essere spettatore. O si è complici o si è disertori di una società spietata”. Il che lascia intendere che bisogna fare qualcosa. Tacere non è possibile, in caso contrario si diventa complici: giusto! Parlare, denunciare, è possibile, ma col fare ciò non si è ancora disertato, ci si trova ancora dentro la società del genocidio. Forse ci si trova male, in quanto si lotta contro di essa e si è presa coscienza, ma sempre dentro ci si trova. Alla classica domanda se è possibile chiamarsi fuori, è stato risposto da sempre che nessuno può trarsi fuori dal mondo dove vive, nessuno può veramente disertare. O sta di qua, o sta di là. O sostiene il genocidio, o lo combatte. Quindi, escludendo la possibilità pratica di “disertare”, perché sarebbe veramente troppo comodo, e non mi si venga a dire che disertare lo si può attraverso l’obiezione fiscale o attraverso una scelta oculata nell’acquisto di prodotti, se quindi praticamente non si può disertare, resta solo le denuncia. Ecco, non sono d’accordo.
Oltre alla denuncia resta l’attacco contro gli uomini e le strutture responsabili di questi genocidi. Non il grande attacco spettacolare, organizzato da strutture consistenti di natura militare, ma l’attacco polverizzato nel territorio, i mille obiettivi possibili che la stessa composizione e distribuzione del capitale espongono sotto gli occhi di tutti coloro che hanno sensibilità e cuore per quest’ultima soluzione.
Se l’ecologia sociale è veramente “un appello alla disobbedienza”, non vediamo perché nel concetto, fortunatamente molto ampio, di “disobbedienza” non ci debba stare anche l’attacco diretto, l’azione rivoluzionaria diretta, ora e subito, anche minoritaria, diretta proprio contro quegli obiettivi che così egregiamente la stessa ecologia sociale ha sottolineato e posto all’attenzione di milioni di persone.
O ovvietà, o parzialità. Dal dilemma non si esce.
[Pubblicato su “Anarchismo” n. 65, giugno 1990, pp.22-25 col titolo “Ovvietà o parzialità?”]
Entrismo
Permettetemi di tornare un momento sull’enormità che è stata detta poco fa, che è quella di entrare nelle istituzioni per renderle democratiche. Sebbene non metterebbe conto parlarne, visto che il problema è stato sollevato, affrontiamolo.
Che cosa si vorrebbe fare? Entrare anche nella polizia, per fare diventare la polizia più democratica? o anche nell’esercito, che cosa si vorrebbe? un altro generale anarchico anche oggi? Ma non diciamo stronzate. Lasciamo stare queste estremizzazioni che forse sono soltanto humour. Ammesso e non concesso che non si avesse in mente di dire questo, ma prendiamo le altre strutture, a esempio la scuola. È giusto che gli anarchici entrino nella scuola così trasformando dall’interno la struttura scolastica la possono portare verso gli ideali di una pedagogia libertaria, ecc.? Mettiamo che fosse questa l’ipotesi fatta, lasciamo perdere l’esercito o la polizia. È il classico concetto di entrismo, diffusosi da Trockj in poi. Infatti, il padre di questo concetto è proprio Trockj. Questa ipotesi non tiene conto del fatto essenziale che non è l’uomo che decide soltanto di sé, ma anche la situazione in cui si viene a trovare. Non è che noi siamo capaci di trasformare il mondo in assoluto, dobbiamo stare attenti perché anche il mondo ci può trasformare. Diventa inutile che io dica: ora entro nella polizia perché così entro in questo corpo, mi avvicino di più, anche fisicamente, al ministro degli Interni e gli posso sparare un colpo sul centro del cervello. Ecco questo progetto, apparentemente, può sembrare bello, ma nella pratica non lo è, perché dal momento che io entro nella polizia, lascia oggi e lascia domani, sono costretto a vivere situazioni, rapporti, concetti e fatti, perché l’entrismo è proprio tutto questo, per cui alla fine è la struttura che mi mangia non io che mangio la struttura. Questa è una regola fondamentale, che non ha eccezioni. Quindi è bene che noi ci teniamo lontani da queste strutture se le dobbiamo lottare, se invece le dobbiamo accettare è un altro paio di maniche.
[Parte del dibattito seguito alla Conferenza dal titolo “Anarchismo e democrazia” da me tenuta a Bologna il 16 marzo 1995 presso la Facoltà di lettere e filosofia. Trascrizione della registrazione su nastro]
Esercito della salvezza
Le sottoscrizioni e la raccolta di fondi per “solidarietà” con situazioni di lotta sono, ovviamente, uno strumento minimo che può – qualche volta – tornare utilissimo ai compagni che si trovano in situazioni conflittuali. Questo è un fatto certo.
Resta da considerare la situazione specifica degli scioperi dei minatori inglesi [1986]. Abbiamo espresso in merito il nostro pensiero con chiarezza. Sollevando, come è ormai consuetudine, ironie e superficialità (a dire il vero non solo in Italia), ma senza riuscire a fare riflettere, tanti compagni che si erano subito imbarcati a testa in giù in campagne di solidarietà che, a nostro avviso, risentivano di una scarsa comprensione del problema reale inglese e di una preclusione a priori nei riguardi della ricerca di possibili interventi diversi.
La “raccolta di fondi” è la prima cosa a cui si pensa. Lo stesso è accaduto per gli scioperi inglesi.
Ma, in effetti, come si è potuto constatare, i lavoratori inglesi non avevano tanto bisogno di fondi, quanto di una analisi chiara e di un sostegno esterno “reale”.
Perché non avevano bisogno di fondi? Perché lo sciopero era stato indetto dai sindacati su posizioni di retroguardia e di difesa dello status quo, perché una lotta come quella – per quanto assumesse nei dettagli aspetti radicali – era destinata a morire e a spegnersi senza benefici diretti per i partecipanti. Perché essa risultava al contrario benefica per i piani di ristrutturazione del capitale inglese che, con i ritardi produttivi ottenuti a causa dello sciopero, ha avuto modo di dislocare in un arco di tempo più lungo i licenziamenti in programma e la chiusura della maggior parte delle miniere (quasi tutte superate, pericolose e non certo gestibili da parte di un proletariato vincente). Perché quel genere di lotta – destinata a sconfitta sicura – sarebbe stato meglio durasse il meno possibile (salvo a poterla spingere verso obiettivi diversi). Perché i finanziamenti (paralleli a quelli delle diverse raccolte realizzate dai compagni un po’ dovunque) erano fatti non solo dal sindacato dei minatori ma anche dallo stesso governo che, come a un certo punto apparve chiaro, non poteva permettersi di “radicalizzare” la situazione.
In queste condizioni, un sostegno esclusivamente finanziario era da reputarsi negativo. Ed è questo che abbiamo detto.
L’alternativa era, o radicalizzare lo scontro (o, almeno, contribuire alla sua radicalizzazione), senza nessuna fuga in avanti, o dichiararlo perdente e quindi non contribuire al suo prolungamento.
Questo lato della faccenda non è cosa che i compagni possono comprendere subito, in quanto spesso si fanno affascinare dagli aspetti esteriori della lotta (scontri con la polizia, picchettaggi, violenza contro le cose, ecc.). Ma è necessario che si approfondiscano problemi di questo genere.
Perché si aveva bisogno di una analisi chiara? Per il motivo semplice che non si distinguono i retroscena della politica di ristrutturazione del capitale inglese, politica che si lega con un ritorno a breve termine dei laburisti al governo e con una interruzione dei processi di privatizzazione in corso. I minatori sono stati – da sempre – l’elemento di punta, la forza d’urto, impiegati dai politici cosiddetti di “sinistra” per spezzare la predominanza conservatrice quando questa ha ormai fatto tutti i danni possibili al governo (e anche tutti i benefici, almeno dal loro punto di vista). La strategia impiegata dal sindacato inglese, anche questa volta era visibile a occhio nudo, ma non è stata sottolineata, anzi si è quasi sempre preferito indirizzarsi verso una esaltazione banale e superficiale degli scontri, non tenendo conto né delle premesse (chi aveva dichiarato lo sciopero), né degli scopi (dove andava a finire la lotta, quali interessi garantiva, quali prospettive politiche di ricambio rendeva possibili).
Perché si aveva bisogno di un sostegno esterno “reale”? Perché qualsiasi lotta proletaria, anche quella partita su basi sbagliate (come è stata appunto quella degli scioperi dei minatori inglesi), può modificare la propria prospettiva nel corso dello svolgimento. Per aversi una modificazione si deve verificare qualcosa che in modo non previsto intervenga a turbare i progetti di chi dirige la lotta sulla pelle dei lavoratori. E questo qualcosa di nuovo poteva essere la vera solidarietà rivoluzionaria di cui si è sentito il bisogno. Il movimento rivoluzionario mondiale può intervenire nella lotta e fornire un “sostegno reale”, capace di modificare l’indirizzo della lotta stessa. Certo, tutto ciò non può essere fatto da un “movimento d’opinione” che, al massimo, può realizzare qualche colletta o qualche dibattito pubblico diretto più a tacitare la propria coscienza che a dare reale appoggio alla lotta in corso.
Chiedersi se qualcuno di noi ha fatto qualcosa di diverso della semplice raccolta di fondi o dell’altrettanto semplice critica dell’iniziativa in questione, ci pare domanda fuori luogo, malgrado la stessa ci venga rivolta con garanzia del più assoluto riserbo. Prendiamo la cosa come una battuta umoristica e finiamola lì.
Restando invece nel generico riteniamo che un attacco agli interessi inglesi in Italia, e in particolar modo agli interessi inglesi legati all’estrazione, alla lavorazione e all’esportazione del carbone, poteva essere una solidarietà molto più significativa di una semplice raccolta di fondi.
Questo lo riteniamo noi, ma non è detto che la cosa sia necessariamente condivisibile da tutti. Ognuno ha le sue idee. Ognuno si regola per conformare le proprie azioni alle proprie idee. Su questo non c’è dubbio.
[Pubblicato su “Anarchismo” n. 50-51, marzo 1986, pp. 15-17 col titolo “Per una critica della mentalità da ‘Esercito della salvezza’”]
Famiglia
A Firenze, una ragazzina di tredici anni denuncia a uno dei moltissimi telefoni della pubblica morbosità, la violenza sessuale cui il padre da diverso tempo la sottoponeva.
Notizia come tante che non stimola neanche più la curiosità lardosa di tanti benpensanti che nel chiuso della propria casa, battendosi subito dopo il petto, sbirciano le forme segrete delle proprie figlie sognando per un attimo chissà quali chiotti e improbabili amplessi.
Prova indiretta, fra le più evidenti forse perché una delle più estreme, di come sia impossibile l’amore nell’ambito della carcerazione. Se la famiglia è un carcere, e in qualsiasi modo si veda la faccenda a questa affermazione si sfugge con difficoltà, in carcere l’amore tra carcerieri e carcerati è impossibile, salvo a non prendere le vesti della violenza e dello stupro. Resta da vedere se le cure che spesso i genitori hanno per i figli, l’affetto quotidiano, le preoccupazioni a cui sembrano in preda giornalmente, siano riconducibili all’amore, oppure a una forma fra le più contorte del desiderio di preservare se stessi contro le paure del futuro.
L’amore non c’entra e, se c’entra, cerca subito di fare a meno della famiglia.
[Pubblicato su “Canenero” n. 20, 24 marzo 1995, p. 7 col titolo “L’imbroglio familiare”]
Forza
Dietro il mito della certezza c’è sempre stato quello della forza. Il raggiungimento di uno scopo, considerato non solo possibile ma anche certo, ha spinto gli uomini, per altro ragionevolmente, a darsi gli strumenti idonei allo scopo stesso. Una minoranza di utopisti e sognatori, letterati e affini, è stata recuperata rimacinando le loro idee nel più pratico dei modi, rendendole funzionali al potere in carica. Pensate alla linea che unisce Fourier, Freud e le équipe che lavorano oggi nelle carceri e nei manicomi.
I dominatori si sono accorti subito della necessità della forza (l’astuzia, è da considerarsi, in questo caso, una variante raffinata della forza), fin da quando le loro azioni di preda e rapina, proprie dell’accumulazione primitiva, si trasformarono dalla semplice grassazione alla conquista di contrade e città. Dapprima con la promessa del saccheggio, poi col soldo, poi ancora col saccheggio, poi con l’ideologia della rivoluzione proletaria in tutto il mondo, poi con quella della libertà e della democrazia, la registrazione dei meccanismi del potere è avvenuta sempre attraverso la mobilitazione della forza e con la sua organizzazione.
I dominati si sono accorti un poco in ritardo che per ottenere risultati concreti dovevano far ricorso anche loro alla forza. Il modello che avevano davanti era quello dei dominatori, le loro idee, le loro strutture. Per la verità, fin quando gli scossoni si mantennero nella forma di insurrezioni spontanee e semplicemente distruttive, quello che si vide fu una forza incosciente, semplicemente oggettiva, che esplodeva sotto la forma di una giustizia livellatrice, assolutamente incapace di darsi programmi e quindi, intimamente debole e destinata alla sconfitta. Poi, modellandosi sempre di più sull’immagine del nemico, nacquero le prime organizzazioni di resistenza, i primi partiti degli oppressi, le prime ideologie dell’organizzazione, frammiste a illusioni di redenzione e speranze di immediati miglioramenti. Vedendo quanto e come i dominatori fossero organizzati, e scoprendo come ottenessero in modo facile e sbrigativo i migliori successi, ci si illuse che la soluzione del problema fosse esclusivamente nell’organizzazione, nella forza dell’organizzazione.
La simbiosi continua. Oggi, in una fase molto avanzata delle raffinatezze repressive, il potere ha capito che l’impiego della forza deve essere indirizzato alla collaborazione, al consenso collettivo, all’imbroglio della democrazia. Dall’altro lato, la critica cosiddetta rivoluzionaria ha accettato questa tesi dei laboratori culturali del capitale, e ha decretato che bisogna allargare il dissenso, convincere la gente a un movimento che sia delegittimante, cioè capace di sottrarre la base di sostegno alla forza che col proprio consenso legittima il potere. Ancora una volta, in un modo platealmente evidente, i due poli camminano insieme e collaborano allo stabilirsi e al perpetuarsi delle cose così come stanno, fatto questo che corrisponde agli interessi del primo e ai danni del secondo.
Ma dove trovano, questi opposti schieramenti, le idee che mettono in pratica? Come funziona e come ha funzionato in passato il laboratorio culturale del capitale? Non è privo di interesse vederne il processo di sviluppo.
Cogliamolo nell’approssimarsi dell’Ottocento. Le idee aggregative e le corrispondenti survalenze produttive determinate dall’organizzazione, sono ormai dominio comune. La grande industria è un fatto generalizzato ma ha subito i primi contraccolpi di sottoconsumo. A salvarla sono intervenute le avventure coloniali e le guerre interne di liberazione. Ma la scienza avanza i primi dubbi sulle certezze meccaniche che avevano fondato sia la grande industria che le utopie e le ideologie di liberazione e di mantenimento del dominio. La disgregazione della certezza del reale o, almeno, della sua conoscibilità, conduce verso due strade: da una parte, verso la pretesa di potere operare una sospensione e quindi continuare come prima indisturbati; dall’altra, verso il cedimento immediato di ogni concetto lineare di sviluppo e l’impiego della forza a uso personale o, al più, a uso di una nuova stirpe di uomini diversi, capaci di dominare su se stessi e non più sugli altri e sulle cose.
Un capitolo a parte meriterebbero gli equivoci, involontari o ad arte, che si scatenano nel periodo fra le due guerre. I temi della forza vengono ripresi da più parti, con una tale capacità d’incomprensione da sbalordire. Basti pensare alla fortuna di Schopenhauer nel movimento anarchico di quel periodo, per chiedersi in che modo era stato letto questo autore che non esalta affatto la volontà ma, anzi, la indica come l’essenza della cosa, la condanna eterna dell’uomo. Lo stesso si può dire per Stirner, le cui orrende traduzioni costringono ai più ridicoli errori il movimento di lingua italiana, e lo stesso per Nietzsche di cui, alla fine, si accetta la condanna voluta dallo stalinista Lukács. Ciò dimostra che non basta l’elaborazione del laboratorio dei padroni, occorre anche una autonoma capacità di lettura da parte dei rivoluzionari, lettura che può avvenire soltanto parallelamente allo svolgimento delle lotte. E queste si indirizzavano, in quel periodo, ma anche nel dopoguerra, verso una ulteriore esaltazione delle forze organizzate. Il mito del palazzo d’inverno non fu facile da sradicare, anche perché corrispondeva al mito del sindacalismo rivoluzionario americano ed europeo.
Ormai, il crollo delle certezze è molto avanzato. Non c’è più uno scarto tra teoria e prassi nel campo del dominio. Il capitale aveva saputo mantenersi in bilico tra la certezza della forza e la certezza delle crisi ricorrenti che, comunque, un compito di portata storica, poteva sempre superare. Già con la crisi degli anni Venti, cominciò dovunque a rendersi conto che una separazione netta, capace di durare per un millennio almeno, non poteva esserci fin quando si restava obbligati a cooptare i miserabili. La soluzione fascista, nella sua radicalizzazione nazista, fu senz’altro più conseguente, proponendo di escludere una parte consistente dell’umanità – considerata inferiore – per garantire una stabilità, appunto millenaria, alla razza considerata superiore. Fallito il tentativo, le forze vincitrici usarono, e stanno usando, fino in fondo, gli effetti positivi di quel disastro, materiali e psicologici, per mantenere un dominio che sta ormai disintegrandosi. Adesso ci si avvia verso l’epoca del crollo reale dei miti e delle certezze.
Occorre fare in fretta. Tutti dobbiamo fare in fretta. I miti e le illusioni traballano e c’è necessità di costruirne di nuovi, oppure andare avanti allo sbaraglio, con le proprie risorse e le proprie debolezze.
Tutti sentiamo questa situazione come la cruda realtà. Ci sono i rigurgiti religiosi, ma non arrivano fino al misticismo, non propongono una vera e propria ideologia sostitutiva, sono possibilisti (vedi, a esempio, il Vaticano secondo). Quando sono integralisti in senso stretto è la situazione oggettiva di arretratezza che rende possibili i millenarismi di riscatto che, nelle zone più avanzate economicamente, subiscono pesanti penalizzazioni (vedi, a esempio, l’islamismo estremista). Ci sono le lotte nazionali, ma non hanno davanti a loro il mito della nazione, quando questa trama esiste è appena accennata, quel tanto che basta per mobilitare un certo ceto sociale, ma nessuno basa su di questo mito, totalmente, la propria lotta. Gli obiettivi sono più concreti, anche se, spesso, altrettanto anacronistici.
L’ideologia marxista leninista è andata in soffitta e nessuno sembra rimpiangerla. Anche le nostre stesse polemiche di qualche decennio fa, ora, sembrano roba d’antiquariato. Lo stesso si può dire per il liberalismo tradizionale, per l’industrialismo opulento dei poli d’attrazione e, per un altro aspetto, per il terzomondismo d’esportazione guardato da sempre a bocca aperta nelle grandi metropoli del benessere diffuso e del malessere endemico.
Il capitale ha impostato un programma che, per la prima volta, si regge sulla negazione stessa dell’ideologia. Un programma di tono basso, riduzionista, che tende non a imporre ma a spiazzare. A questo è arrivato non per caso ma attraverso un processo durato vent’anni più o meno, durante il quale si sono esauriti gli effetti sia dei grandi disastri precedenti, sia delle illusioni ideologiche, sia della gestione imperialista del mondo. La scienza è venuta incontro alle necessità del capitale illustrando le cose per come stanno: impossibilità sostanziale di continuare col vecchio progetto industrialista, esaurimento delle vecchie tecniche di sfruttamento diretto o indiretto, limite dell’indebitamento mondiale, riduzione progressiva delle risorse naturali. Una realtà difficile che ha soltanto l’apertura verso una gestione diversa del potere, basata sulla rigida divisione in due categorie della popolazione mondiale: una minoranza di eletti e una di reietti, o, se si preferisce, una di inclusi e una di esclusi.
La realtà di oggi non consente molte illusioni, è troppo cruda per essere spacciata in tinte rosa. Il capitale sta pertanto facendo appello al realismo e alla scientificità delle forze politiche e sociali, per mettere al posto delle vecchie ideologie una nuova concezione del mondo. Ed è di questo progetto globale che forse non ci rendiamo conto, se dobbiamo basarci sui nostri ritardi, nostri in quanto rivoluzionari.
Una nuova concezione unitaria è quella del nuovo capitale. Intende basarsi su di una compattezza maggiore delle due grandi ripartizioni dell’umanità. Tale compattezza deve presentarsi come ineluttabile, qualcosa contro cui non solo non è possibile lottare, ma contro cui non ha senso lottare. E questo sarà possibile solo se l’unità degli inclusi sarà completa, costituita cioè da elementi oggettivi (economici) e da elementi soggettivi (etici). L’autonomia assoluta degli inclusi è possibile solo a condizione che gli esclusi vengano usati senza saperlo, senza cioè avere notizia esatta degli scopi di quello che fanno e dei benefici che arrecano a un altro universo, totalmente tagliato fuori non solo dalla loro possibilità di comunicazione ma anche dai loro desideri.
La concezione unitaria del dominio del nuovo capitale si basa quindi su di un mondo sempre diviso in due, ma basato su due universi assolutamente incomunicabili tra loro, per cui ognuno di questi due mondi, ma specialmente quello degli inclusi, risulterà fortemente unitario e autosufficiente. Non stiamo parlando di sogni e di utopie, ma di progetti concreti, alcuni di già coscienti nella logica del capitale, altri quasi latenti ma non per questo meno operativi.
Per chiudersi in un mondo autosufficiente, gli inclusi hanno bisogno di alcune cose essenziali. Una autonomia energetica non a livello di produzione ma a livello di impostazione dei programmi produttivi, comunque basata su fonti energetiche non inquinanti e non pericolose dal punto di vista della contaminazione nucleare. I recenti studi [1989] sulla conservazione e il trasporto dell’energia elettrica, fanno pensare molto vicino il momento per una simile soluzione. La larga accettazione del discorso ecologico spiega l’interesse del nuovo capitale verso tecnologie che non mettano a repentaglio la propria autonomia (un incidente nucleare colpisce tutti). Una disponibilità di mano d’opera (una parte considerevole ma non il totale degli esclusi) capace di svolgere lavori ripetitivi, flessibili ma settorializzati, principalmente basati sull’utilizzo di macchine altamente sofisticate i cui programmi sono elaborati soltanto dagli inclusi e comprendono la capacità di auto-ripararsi. L’esistenza di un linguaggio diverso tra inclusi ed esclusi, basato su di una riduzione progressiva ma inesorabile dei contenuti linguistici dell’attuale linguaggio comune, riduzione che sarà però praticamente operativa solo per gli esclusi. L’elaborazione di una diversa morale del desiderio con speranze, ideali, obiettivi, sacrifici, giochi e così via, a uso degli esclusi.
Se si studia attentamente la società di oggi che, nelle sue enormi contraddizioni, è ancora ben lontana dalla realizzazione di un progetto come quello illustrato sopra, si possono però ricavare le coordinate di un orientamento. L’autonomia energetica, la flessibilità lavorativa, il taglio del linguaggio, la morale dell’imitazione, e altro, sono in fase di svolgimento, anche se non hanno ancora raggiunto livelli tali di sviluppo da consentire un discorso approfondito e definitivo.
La forza va bene. Ci mancherebbe. Chi ha portato sempre ben chiusi i pugni in tasca, pronto a scattare, sa perfettamente cosa vuol dire. Davanti alla prepotenza e al sopruso, ancora e sempre la violenza liberatrice può dare il suo apporto, spesso importante, mai, purtroppo, decisivo, se resta da sola, circoscritta, sospettata e condannata. Il mito della forza no. Non la forza come aspettativa messianica di una potenza che cresce col tempo, col numero, con la quantità, in vista di raggiungere gli obiettivi finali della liberazione, dell’anarchia. No. Questo mito è vecchio. Come quello del partito. Hanno fatto entrambi il loro tempo.
[Parte di quanto pubblicato su “Anarchismo” n. 63, luglio 1989, pp. 19-22 col titolo “Malinconie del decisionismo”]
Franco Fortini
L’uomo che non è mai esistito.
Franco Fortini, dopo lunga malattia, è morto a Milano. Non si era mai liberato dalle radici marxiste, né dal bisogno, radicato e profondo, di un partito. Eppure, qualcosa in lui lottava contro le chiusure del partito e le sconclusionatezze filosofiche (e politiche) del marxismo. In tutto quello che Fortini ebbe a scrivere c’è la traccia di questa contraddizione mai sanata, la quale ha sistematicamente annullato il significato profondo del suo dire, e quindi anche del suo fare. Gli atteggiamenti da guascone del pensiero, o da cercatore di pulci, si smorzavano quindi su questa barriera insuperabile da intellettuale organico con velleità di autonomia. Ogni accadimento della realtà veniva nei suoi scritti a perdere la connotazione essenziale, quella irrimediabile rottura tra la dimensione del potere e quella degli esclusi, dei diseredati di ogni genere. Fortini non ha mai trovato la forza di allontanarsi dall’area di potere, anche se spesso quest’area si palesava più come un’anticamera che una vera stanza dei bottoni. Non saranno i suoi scritti a lasciare il segno sulla nostra epoca. Tutto qui.
[Pubblicato su “Canenero” n. 6, 2 dicembre 1994, p. 7]
Fra le righe del bilancio statale
Incredibili idiozie e penosissimi dettagli di spese e di entrate, corredano il fascicolo della “Gazzetta Ufficiale” dedicato alla pubblicazione del bilancio di previsione dello Stato per il 1995. Un’analisi in dettaglio di alcune spese farebbe emergere luminosamente la pazzia burocratica nella quale siamo immersi. Per il momento ci pare interessante sottolineare la voce concernente i proventi derivanti dalla vendita di manufatti e prodotti industriali degli stabilimenti penali, delle case di rieducazione e dei riformatori giudiziari: quasi sette miliardi. Invece circa 380 milioni sono previsti come entrata proveniente dalla lavorazione di prodotti e altre attività svolte nelle carceri giudiziarie.
[Pubblicato su “Canenero” n. 11, 20 gennaio 1995 p. 7]
André Frossard
I peggiori sono i migliori. André Frossard, scrittore cattolico francese è morto di cancro a ottant’anni. Ateo, si converte al cattolicesimo dopo una sorta d’illuminazione avuta in una piccola chiesetta della rue d’Ulm, dove vede la fiammella d’un cero divampare in una grande luce blu. Fervente cattolico indipendente, alieno da qualsiasi dogma e sostenitore del ritorno alle origini, contribuisce come pochi al rafforzamento della Chiesa di oggi in termini di unità del potere papale. Insieme a Jean Guitton, è la voce “laica” più ascoltata dal papa che lo interpellava pochi giorni fa riguardo l’espulsione del vescovo francese favorevole agli omosessuali. Durante la guerra fa parte del Maquis e viene arrestato e torturato dagli uomini di Klaus Barbie. Gollista della prima ora, è autore per decenni di quotidiani appuntamenti con i lettori de “Le Figaro” che preparano in maniera sottile e profonda, la coscienza della nuova classe di potere, oggi al governo in Francia. Uno di quegli uomini dabbene su cui si reggono le fortune di tutti i dominatori.
Tutto qui.
[Pubblicato su “Canenero” n. 14, 10 febbraio 1995, p. 11]
Fuga in avanti
È un vecchio problema. Gli amanti della dialettica, e dei meccanismi di sussunzione e di ripresentazione, hanno spesso parlato di un loro modo di risolverlo. Noi siamo stati sempre scettici non solo sull’uso, ma sulla validità di giochi di parole che pretendono rappresentare la realtà, e anche di modificarla.
Il fronte della lotta, certe volte ben individuabile a priori, capace di dotarsi di strumenti di intervento, più o meno adeguati allo scontro, di colpo si spezza: un’azione va fuori tempo, rompe l’“armonia” prestabilita del concerto delle iniziative, accelera il passo, alza il tiro, supera livelli di rapportazione e strategie politiche. Colpisce più in alto.
Sulla validità di colpire più in alto non ci possono essere dubbi. Non stiamo parlando di “più in alto” nel senso della gerarchia sociale, ma nel senso di un obiettivo, anche periferico e polverizzato, che però costituisca, nell’insieme delle azioni che il movimento nel suo complesso riesce a realizzare, qualitativamente, un qualcosa di diverso e di più “impegnativo”. E, come è accaduto in Germania [ottobre 1987], decidersi di sparare sui poliziotti è cosa che va sottoposta a profonda riflessione.
Non sappiamo se chi ha realizzato l’azione abbia portato fino in fondo questa riflessione, e, allo stato attuale delle cose, non sappiamo cosa sia accaduto realmente fra le nebbie dell’aeroporto di Francoforte. Possiamo fare alcune ipotesi. Di già la documentazione, riportata da tutti i giornali, di un avviso dato alla polizia di allontanarsi e di non insistere nel pestaggio e nella ricerca dei singoli compagni in una zona di campagna (azione che, chi l’ha vissuta personalmente, sa quanto possa essere spiacevole), dà l’indicazione che ci troviamo davanti a qualcosa su cui si è riflettuto, un’azione che ha avuto lo scopo di mettere un freno, immediato e brutale, se si vuole, ma sempre un freno al dilagare delle pretese repressive della polizia. C’è da dire che non sappiamo se i realizzatori di questa azione – che, sia detto in tutto tondo, comprendiamo perfettamente – si siano fermati a riflettere sulle conseguenze repressive che essa andrà a scatenare su tutto il movimento. Ed è questo l’argomento della fuga in avanti.
Fermiamoci un attimo a riflettere. Non stiamo dicendo – come il coro unanime dei piagnucolosi recriminatori di cui la sinistra europea sembra dotata in numero inesauribile – che si tratta di un’azione sbagliata perché farà aumentare la repressione e contribuirà alla rottura del movimento. Stiamo dicendo ben altro. Questo genere di azioni serve per scuotere il movimento, per gettare via dal suo interno quel ciarpame numerico che a volte copre, lasciando nascoste, le piaghe di una mancanza di decisione di volere cambiare le cose. Si va avanti in questo modo, con manifestazioni senza significato e con azioni senza sugo, finché un bel giorno si scopre che tutto quel gran lavoro (fittizio) non ha avuto altro esito se non quello di portare acqua al mulino del potere. Se, guardandosi attorno, si vede che la cosa funziona perché siamo in tanti, questo non può mai esimerci da un esame critico del fatto che ci ha portato a essere insieme e del perché si è così tanti insieme. Se questo esame porta alla conclusione che si è insieme grazie al fatto che siamo talmente non incisivi e prevedibili da raccogliere la grande maggioranza di coloro che dissentono (platonicamente) dal modo in cui il potere gestisce le sue cose, allora dobbiamo fare in modo che la situazione cambi, anche se la nostra azione finirà per sconvolgere l’assetto pacifico di quel gran numero di persone che, pacificamente e senza sforzo, sta davanti a qualcosa, dimostrando e preparandosi a subire le prossime legnate della polizia.
Quindi, in primissima analisi, siamo d’accordo con l’azione che alza il tiro, che sospinge in avanti la situazione di conflitto, che colpisce obiettivi “via via” più significativi, anche al di là di quello che la gran massa delle persone, in un dato momento, riesce da sola a trovare come livello dell’intervento possibile.
Ciò non toglie, però, che non siamo d’accordo (nel senso di sottoscrivere o realizzare noi) con un’azione che si presenti del tutto scollegata da una determinata situazione in atto, cioè che pretenda di imporre, nella generale mediocrità di un contesto di lotta, un modello che, da per se stesso, può anche essere condivisibile, ma che deve tenere conto della realtà in cui si va a inserire. E ciò non tanto perché le conseguenze dell’impiego di quel modello saranno certamente quelle di un aumento della repressione, la quale colpirà il movimento (e abbiamo visto i motivi per cui questo aspetto della questione ci interessa meno), quanto perché non intendiamo lasciare dietro di noi nessuno, non vogliamo realizzare nessuna “fuga in avanti”, non vogliamo portare a compimento nessuna azione che sia soltanto soddisfazione per i nostri sentimenti feriti o per le nostre membra doloranti.
In fondo, andare avanti è, spesso, molto più facile di restare nel gruppo. Non nel centro del gruppo, aspettando di farsi tirare a dritta e a manca da qualcun altro, ma nel gruppo in modo vigile, stimolando all’azione, realizzando quel genere di lotte e di azioni che sono “adeguate” alla situazione in cui ci si trova e anche un qualcosa in più. Ma questo qualcosa non può mai essere considerato una “fuga in avanti”, bensì una indicazione precisa, un progetto dettagliato, un approfondimento di metodo, una chiarificazione di obiettivo.
Al di là, la vigliaccheria di chi si riscopre animato da sentimenti di retroguardia che portano tutti nelle braccia della delazione, o la titubanza di chi non sa cosa fare e finisce per restare abbagliato dalla “giustezza” di un’azione che però non solo considera come qualcosa di mitico ma che, in fondo, intimamente, non condivide.
[Pubblicato su “Provocazione” n. 9, novembre 1987, p. 4 col titolo “La fuga in avanti”]
Il gioco e la morte
La Ada (Advanced Development Attraction) è una ditta che ha rilevato le condizioni fallimentari della Alenia dell’Aquila. Quest’ultima fabbricava apparecchi meccanici di precisione, sistemi informatici ma, principalmente, sensori e sistemi di puntamento e di guida per missili terra-terra, cioè missili in grado di bloccare e distruggere qualsiasi carro armato.
La trasformazione aziendale ha determinato anche una modificazione produttiva: dal settore militare l’Ada è passata a quello dei giochi. Un contratto con l’Ultrapolis (azienda che lavora in Estremo Oriente e che sta realizzando un enorme parco giochi a Singapore), ha reso possibile la collocazione dei nuovi prodotti. Anche la Ultrapolis ha bisogno di sensori e di sistemi guida (quelli ordinati si chiamano Kimerix e 54 di essi costano 96 miliardi di lire), da impiegare nei sofisticatissimi giocattoli che produce e nei grandi impianti dei parchi giochi. Altre attrazioni elettroniche sono previste dentro il corrente anno. Il mercato mondiale del settore è vastissimo.
[Pubblicato su “Canenero” n. 30, 9 giugno 1995, p. 7]
I guai della vecchia signora
La Banca di Francia ha avuto un guaio. La “vecchia signora”, come viene chiamata da quelle parti aveva di già fatto stampare dalle proprie rotative 17 milioni di banconote per un valore di tre miliardi e mezzo di franchi. Il biglietto: quello da 200 franchi, il più tartassato dalle imitazioni.
L’infortunio è dipeso dal fatto che mentre i torchi della Zecca gemevano qualcuno ha fatto notare che i fratelli Auguste e Louis Lumière, effigiati sulla banconota (rispettato il centenario della nascita del cinema), a suo tempo avevano avuto un flirt con il governo fascista di Vichy, quindi erano fascisti e non solo fascisti ma anche collaborazionisti col tedesco invasore, insomma non potevano essere considerati quella gloria nazionale che merita di finire nella mani di tutti i cittadini.
Gustave Eiffel, prontamente suggerito come sostituto da qualcuno non è andato neanche lui bene. Ai suoi tempi aveva avuto un ruolo non secondario nel fallimento degli investimenti francesi nell’apertura del canale di Panama, con grande disdoro di tutti i seguaci di Saint-Simon in Francia che sono molti (anche oggi) e che si possono considerare una specie di massoneria ad altissimo livello.
Un’altra proposta porta avanti la candidatura di Edith Piaf, ma chissà se la sua canzone: “Je ne regrette rien”, non nascondeva qualcosa oltre al rifiuto di non pentirsi di nulla?
In fondo, a pensarci bene, anche l’utilizzo dell’effigie dei coniugi Curie, immortalati definitivamente nel nuovo corrente biglietto da 500 franchi, aveva subito critiche: dopo tutto per un oggetto così, diciamo, intimamente francese, come il franco, metterci su una polacca, non era sembrata una cosa da farsi. Ma poi tutto era stato accettato.
[Pubblicato su “Canenero” n. 32, 23 giugno 1995, p. 3]
Ludwig von Hackwitz
Nel vuoto.
Ludwig von Hackwitz, direttore generale della Fondiaria Assicurazioni, si è ucciso gettandosi dal ventunesimo piano della Torre Velasca nel centro di Milano. La società per cui lavorava è uno dei colossi delle Assicurazioni in Italia, ma si trova in difficoltà. La Consob l’ha di fatto posta sotto controllo sospendendone il titolo in Borsa, in attesa di decisioni che potranno coinvolgere anche la Latina Assicurazioni e altre società del gruppo. La Fondiaria è stata uno dei fiori all’occhiello di Enrico Cuccia, quindi della Mediobanca, che detiene il 15 per cento delle azioni. In passato alla Fondiaria aveva tentato la scalata Gardini, poi ridimensionato dai denti di Cuccia. Proprio quest’ultimo aveva nominato un dirigente delle Assicurazioni Generali, Luigi Amato Molinari, a riorganizzare la Fondiaria, e questo dirigente aveva chiamato a Ludwig von Hackwitz a dirigere l’azienda, quindi a provvedere a circa 400 licenziamenti e a risanare in questo modo i bilanci. Il nuovo dirigente proveniva dalla Gerling Konzern di Colonia e dalla Allianz di Monaco e aveva anche a lungo lavorato come dirigente della Allianz Ras Tutela Giudiziaria, il particolare settore che copre gli infortuni giudiziari dei giudici.
Nessuno lo rimpiange.
[Pubblicato su “Canenero” n. 26, 12 maggio 1995, p. 11]
Hacker
Il tradimento dell’hacker. Mark Abene è un ragazzo di 21 anni di New York che aveva messo qualche tempo fa in difficoltà i sistemi di sicurezza dei computer delle grandi banche e della stessa società dei telefoni americana.
Soprannominato “Phiber Optick”, il nostro amico era riuscito a inserirsi nella rete della Southwest Bell e a collegare il codice di chiamata con il codice delle cabine pubbliche per cui qualsiasi telefonata riceveva come risposta: “prego depositate 25 centesimi” e poi la comunicazione veniva interrotta. Sembra che per venire a capo del problema la società telefonica abbia speso mezzo miliardo di dollari.
Mark era stato arrestato, un anno fa, per avere venduto ad alcuni quotidiani gli estratti conto di alcuni attori di Hollywood come Richard Gere e Tony Randall, o di un personaggio della Tv come Geraldo Rivera. Incidentalmente ricordiamo che questo tipo di sabotaggio veniva di già praticato nella Francia della fine del secolo scorso e aveva il nome di “sabotaggio a bocca aperta”. Anche in Italia i compagni, una ventina d’anni fa, hanno realizzato qualche azione del genere distribuendo davanti agli sportelli di diverse grandi banche le cifre dei depositi bancari più significativi, cifre che si era riusciti ad avere grazie alla collaborazione di alcuni compagni. In dettaglio questo tipo di azioni, e altre consimili, è stato illustrato nel libro di Pouget, Sabotaggio, delle edizioni La Fiaccola. Naturalmente il caso di Mark Abene ha di differente che collegandosi direttamente via cavo con il computer delle banche, e penetrato il codice di salvaguardia, il sabotaggio può effettuarsi in maniera più rapida e non abbisogna di una base interna alla banca stessa.
Comunque, dopo questi successi, che gli sono valsi in America la simpatia di milioni di persone e l’odio di pochi responsabili dell’ordine pubblico e dei grandi interessi finanziari della nazione, il nostro Mark ha pensato di voltare gabbana e di mettersi al servizio proprio di quelle grandi imprese che prima aveva danneggiato con la propria capacità tecnica di lavorare col computer e col modem.
Per quel che è possibile capire dalle sue dichiarazioni rilasciate ai giornali, a indurlo al tradimento non è stata la paura di nuove condanne o il rischio della prigione, quanto il fatto di aver trascorso dodici mesi in carcere senza l’amato modem. Qui, infatti, egli aveva a disposizioni un computer ma, evidentemente, non poteva usufruire di un modem. L’astinenza lo ha fregato.
[Pubblicato su “Canenero” n. 11, 20 gennaio 1995 p. 9]
Hooligan
Cancellando la stupida iconografia che tutti i giornali, settimana per settimana, cesellano attorno alla cosiddetta violenza negli stadi, resta la realtà nuda e cruda: in questi luoghi ormai fuori da qualsiasi logica fondata sulla competizione sportiva, c’è gente che con puntualità settimanale, e spesso infrasettimanale, si picchia di santa ragione, e picchiando i rappresentanti dei colori avversari, picchia anche la polizia.
Come sopraggiunta spettacolare a quell’ormai misero spettacolo che si recita effettivamente sul campo di gioco, non c’è male. Non sono mai stato fra gli esaltatori della violenza cieca, non sono mai stato fra le beghine che inorridiscono di fronte a un randello. Anzi, a dire il vero, quando ho avuto occasione di menare le mani, se non altro per non prenderle supinamente, ho cercato di fare del mio meglio.
Come avvenimento di monotona ricorrenza, quanto accaduto a Brescia domenica scorsa, col suo bravo corollario di alcuni poliziotti gravemente feriti, non avrebbe sollecitato il mio interesse e neanche queste poche righe, se non ci fosse stato un pensiero sotterraneo parallelo, forse neanche tanto sotterraneo. Vediamo di esporlo.
Per lunga pratica, essendomi trovato non poche volte al centro di risse e bastonature collettive, riconosco la presenza di una struttura di supporto, cioè di un punto di riferimento organizzato che regge le sorti dello scontro fisico, ne fissa gli obiettivi, e, dentro certi limiti, decide a priori quali risultati raggiungere e quale è il momento in cui desistere dallo scontro. Ora, non ero a Brescia, ma per quel che ho potuto vedere negli stadi in questi ultimi anni, come pure per quello che viene puntualmente registrato dalla televisione o dai giornali, e anche per qualche approfondimento diretto con persone più addentro di me in questi problemi, questa struttura esiste e non è neanche difficile da individuare.
Ora, per principio, quando ci sono strutture del genere, ci sono anche tutte le condizioni per la strumentalizzazione degli scontri. Giovani che spontaneamente scelgono la rissa come momento di sfogo o di passatempo, come attività fisica sollecitata da un organismo quotidianamente sottoposto alle peggiori torture del lavoro o del tedio (la cosa non fa differenze e sarebbe faccenda di lana caprina stabilire cos’è peggiore, il lavoro o la noia) o come qualcosa da fare, qualunque cosa pur di concludere in modo diverso una settimana che di diverso non presenta mai nulla: ecco questi giovani, a un certo punto, vengono attirati all’interno di una trappola. I dirigenti delle tifoserie parlano, decidono e agiscono al loro posto. Prendono accordi con il presidente della squadra di cui sono sostenitori, o, come accade nei grandi club, con un funzionario della dirigenza, di regola un consigliere della società, espressamente designato per mantenere i rapporti con i capi dei vari gruppi di tifosi. La forza contrattuale di questi individui che fanno del tifo sportivo una professione, e che dirigono i gruppi di supporter con la mano di ferro di un dirigente politico educato all’alta scuola del partito nazista, non è trascurabile. Può bloccare una campagna abbonamenti, può trasformare una partita di calcio in un bordello di fischi e in una bolgia di improperi, oppure in un cimitero di silenzi, all’interno del quale i pochi urletti dei quattro tifosi perbenisti finirebbero per sembrare il vagito di un neonato.
Ecco perché quegli scontri non mi piacciono, perché dietro quei ragazzi che litigano con la polizia (in questo unanimemente affratellati con i “nemici” della squadra avversaria), ci stanno pochi individui, quasi sempre fotografati col braccio alzato nel saluto romano, individui che non aspettano altro che di mettere in vendita il loro lavoro di organizzatori di tafferugli, dai quali, essi stessi, si tengono ai margini, limitandosi a decidere quando cominciare, contro chi dirigersi, e quando smettere le risse. E dietro questi squallidi individui ci stanno gli interessi miliardari dei presidenti dei club, quelli ancora più consistenti del Totocalcio e del Coni, fino agli stessi interessi dello Stato e della politica.
* * *
Chi paga i treni speciali? Chi li organizza? Chi paga il biglietto d’ingresso allo stadio quando si va in trasferta? Chi riduce fino a cifre irrisorie gli abbonamenti per gli iscritti ai gruppi organizzati della tifoseria? Gli stessi proprietari delle squadre di calcio, che in questo modo si palleggiano vicendevolmente un fenomeno che non ha sbocchi e che minaccia di travolgere questo ignobile circo in un crollo senza futuro.
Darsele di santa ragione è faccenda che può anche essere piacevole, purché non ci sia mai qualcuno che organizzi il mio personale modo di darle, stabilisca a chi io debba darle e mi dica di smetterla quando i suoi interessi sono stati raggiunti.
Qua e là, fra interviste e sproloqui pubblicati dai giornali, emerge la conferma di quanto sopra: un piccolo gruppo di professionisti decide come, quando e fino a che punto scatenare gli scontri negli stadi.
Le figure emerse sono lapidarie: tutti fascisti. Disoccupati e garzoni di bottega, ma anche poliziotti e consiglieri sportivi di gran nome, come il riciclato Bettega, che difende questa gente (fascisti in primo luogo), non sappiamo se per paura di perdere il posto (a causa di un non improbabile sciopero bianco della tifoseria) o per coerenza con le proprie idee di destra.
Quindi, diciamolo chiaro, anche se l’affermazione potrà disturbare: non è che (per fare un esempio) i tifosi della Roma sono di sinistra e quelli della Lazio di destra, esiste una spaccatura trasversale, in base a cui della Roma ci sono anche settori di tifosi che si richiamano a iconografie e pratiche fasciste, come della Lazio ci sono settori (forse meno numerosi) che si avvicinano alle idee di sinistra.
La confusione cresce ogni giorno e la faccenda potrebbe interessare poco, ma una domanda si impone legittima: come possono, persone che si ritengono di sinistra (quindi si sentono compagni, con tutte le sfumature che volete) passare i pomeriggi delle partite, affrontare i viaggi in treno e perfino partecipare alle scazzottate, accanto a stupidi bestioni con la croce uncinata? Come possono sopportare il lezzo del loro modo di fare in nome d’un comune colore sportivo? Quale gusto può esserci in una bastonatura reciproca e generalizzata, quando si hanno a fianco pecore imbufalite che solo nel gregge e nei simboli della peste trovano il proprio coraggio?
In che misera condizione si sono ridotte le idee.
[Primo pezzo pubblicato su “Canenero” n. 5, 25 novembre 1994, p. 2 col titolo “Datevele di santa ragione”; secondo pezzo pubblicato su “Canenero” n. 7, 9 dicembre 1994, p. 9 col titolo “La dirigenza del bastone”].
Idea
Sicuramente ci sono molti anarchici che sanno, o pensano di sapere, che cos’è l’anarchismo, e tutti quanti sappiamo, o pensiamo di sapere, che cos’è la democrazia. Quindi molti si possono anche chiedere perché mai discutere di queste cose di cui siamo a conoscenza. Per esempio, l’anarchismo che cos’è?: rifiuto dell’autorità, negazione dell’autorità. Quindi, detto questo, uno ci può anche mettere una pietra sopra e dire: io sono contro l’autorità il resto si vedrà, qualsiasi cosa io stia per fare, purché sia contro l’autorità. Molti si sono acquietati pensandosi in questa maniera. Qua cercheremo di dire qualcosa in più: non basta essere contro l’autorità; potrebbe anche il definirsi, il considerarsi, o il sentirsi contro l’autorità, un alibi per non fare nulla, abbastanza consistente e difficile da smontare.
E poi la democrazia, il governo o la forza del popolo, ma di quale popolo, che cos’è il popolo e che cos’è la forza del demos, della gente? È veramente la forza della gente che ci sta governando e che continua a governare la stragrande maggioranza delle condizioni politiche in cui si suddivide il globo oggi? È vero quello che dicono: la democrazia è questo valore che può salvare il mondo in nome del quale bisognerebbe sacrificarsi, e tutto il resto? Ecco le domande che ci porremo.
Partendo da un particolare punto di vista, io sono anarchico, quindi dal punto di vista degli anarchici. L’angolazione degli anarchici ha molte caratteristiche, una delle quali, penso la più interessante, è quella di considerare il mondo come se fosse possibile una non distinzione fra la pratica e la teoria; ognuno di noi ha bisogno di una sua propria teoria, non quella dei libri, o non solo quella dei libri o quella che viene macinata, prodotta e distribuita in aule come queste, ma una sua propria teoria, una sua propria concezione del mondo. Se pensate per un attimo all’assenza di questa concezione del mondo, nessuno si alzerebbe dal letto la mattina, non ci sarebbero motivi.
La vita, nel momento che la concepiamo e la viviamo, è una concezione essa stessa della vita, cioè a dire è una teoria. Gli anarchici ritengono che fra la teoria, quindi fra la concezione del mondo, e il modo pratico in cui la vita viene vissuta non c’è una differenza, nel senso che, non è che venga prima la teoria e dopo la pratica, quindi la vita nella sua realizzazione pratica sarebbe una applicazione della teoria, ma è essa stessa teoria. C’è un travaso continuo tra il modo di vedere la vita e il modo di viverla, fra la teoria, la capacità di conoscere che abbiamo e di vivere, e la capacità di trasformare il mondo, la capacità di agire.
Quindi, nel momento in cui agiamo, dicono gli anarchici (questa tesi è fondamentale per l’anarchismo), noi trasformiamo il mondo perché trasformiamo noi stessi e la nostra stessa teoria, e nel momento che riflettiamo agiamo, perché la stessa riflessione, la stessa analisi, lo stesso approfondimento teorico, è azione essa stessa. Per l’anarchico non è possibile distinguere in modo netto fra teoria e azione, l’una passa nell’altra e viceversa. Questo è importante, questa concezione, perché apre tutta una serie di considerazioni diverse: non esistono gli specialisti che possono essere autorizzati a trasmettere il loro pensiero, ma a fermarsi davanti all’ostacolo dell’azione. Il teorico che vi suggerisce possibile la distruzione del mondo, ma che si ferma sulla soglia di questa distruzione, assomiglia molto al bottegaio che è un rivoluzionario terribile e sanguinoso, purché si fermi davanti alla soglia del suo negozio e purché possa alla fine della rivoluzione, che dovrebbe distruggere e trasformare il mondo, ritornare a fare l’inventario delle merci che aveva negli scaffali.
Quindi il teorico che chiacchiera sulla rivoluzione, sulla trasformazione del mondo, sulla trasformazione dei valori, sul superamento delle condizioni di sfruttamento in cui ci troviamo a vivere, questo teorico è un lestofante, è un imbroglione, se non è esso stesso in prima persona capace di approfondire il discorso che fa, realizzandolo nella concretezza delle azioni, in quanto è da quella azione, da quella realizzazione pratica, che gli viene il completamento, la logica conclusiva, la capacità di approfondimento, in fondo, la giustificazione e la legittimità della sua teoria.
Se noi, invece, abbandoniamo sia pure per un attimo questa fondamentale condizione dell’analisi anarchica, della teoria e del modo di concepire e di vivere la vita degli anarchici, se noi la mettiamo, per un attimo, da parte: cosa troviamo? troviamo quello che passa il convento, cioè a dire come vengono prodotte nel mondo in cui viviamo le opinioni, cioè quello che viene inteso, prodotto, macinato e distribuito.
Noi oggi viviamo in un mondo che produce opinioni, attraverso canali che qua non è il caso di analizzare, e che conosciamo tutti: giornali, mezzi di informazione, televisione, aule universitarie, scuole, palazzi di giustizia, producono opinioni, cioè a dire macinano delle idee talmente sbriciolate e assolutamente nullificate che diventano opinioni.
Ora, queste opinioni vengono impiegate nei ragionamenti quotidiani, sono i classici discorsi che si fanno sugli autobus, nel caffè la mattina, quando incontriamo qualcuno per strada. Provate a prendere qualunque discussione, in genere si comincia col fatto che si sono fregati i soldi, che sono un pugno di ladri quelli che stanno al governo, e che, comunque, in ogni caso ci vuole la pena di morte. Questa è la discussione, non può andare al di là di ciò, perché l’uomo medio, come dicono gli inglesi, il viaggiatore dell’autobus di Clapham, cioè l’uomo medio, vestito mediamente, con le opinioni medie, il benpensante, che è il prototipo che si riproduce a milioni e milioni, ha concezioni di questo tipo, queste non sono idee vere e proprie, sono opinioni. Il potere oggi non si basa sulla coercizione assoluta di una volta, non è una dittatura, non è un assolutismo di idee, non è un potere che ha una carica ideologica fortissima, ma ha una carica ideologica debole, e il sostegno lo trova proprio su questo modo di produrre le opinioni e di gestirle e al limite di sostituirle, ricambiandole continuamente in funzione delle necessità del proprio svolgimento, della propria applicazione. Quindi la produzione delle opinioni è essenziale nel mondo moderno, costituisce l’asse portante del potere.
Combattere le opinioni, nel senso diretto della parola, è impossibile, perché sarebbe come pestare l’acqua in un mortaio. A esempio, una illusione considerevole è quella di potere utilizzare i grandi mezzi di informazione, si tratta di un’illusione che ha attraversato gli ultimi trent’anni del movimento rivoluzionario. Facciamo in modo, si diceva in un certo momento, se voi ve lo ricordate, che i grandi mezzi di informazione parlino di noi, se non altro quando facciamo qualcosa trasmettiamo questo qualcosa con un bel comunicato, stilato in perfetto linguaggio politichese, in modo che il grande mezzo di informazione si faccia carico di trasmettere, e così grandi numeri, milioni di persone, comprenderanno la natura, la ragione, la fondatezza, gli scopi, gli obiettivi, quello che vogliamo raggiungere con la nostra azione. Errato, errato tragicamente. Pensate all’errore tragico che ha portato il movimento rivoluzionario degli ultimi vent’anni a scegliere le grandi azioni eclatanti invece delle piccole azioni diffuse sul territorio, perché delle grandi azioni parlavano i grandi mezzi di informazione e delle piccole no.
L’utilizzo, quindi, dei mezzi che producono e macinano opinioni, per dare, per produrre una nostra opinione sostitutiva è impossibile. Perché è impossibile? Perché noi non possiamo perseguire la strada di una contrapposizione diretta in termini sostitutivi.
Accanto a questa grande illusione degli ultimi vent’anni, relativa all’utilizzo dei mezzi di informazione notevoli, dei grandi mezzi di informazione, c’è stata l’altra illusione che ci ha accompagnati fino a ieri l’altro: l’illusione dell’informazione. Di fronte a una informazione di regime, a una informazione di governo, sostituiamo la nostra informazione, la quale essendo nostra ed essendo noi l’antitesi del regime dominante, deve essere una “controinformazione”. Anche questo è stato un tragico errore, perché ci ha portato dietro tutta una serie di sforzi documentativi, di approfondimenti, che sostanzialmente non potevano sostituire l’informazione di regime, ma che molte volte la corroboravano, la puntellavano, la giustificavano. Pensate, a esempio, alle vecchie tesi sulla dietrologia, sui complotti, sulle ipotesi di golpe, tutte queste cose che hanno attraversato questi dieci, quindici anni [1995], che in alcuni casi erano vere, in altri casi non erano vere, queste ipotesi, ma che sostanzialmente producevano enormi sforzi con un piccolissimo risultato.
Non c’è dubbio che, nell’attuale situazione, se noi continuassimo a produrre, per i grandi mezzi, azioni o pensieri e opere, come volete, per i grandi mezzi di informazione, saremmo funzionali al potere. Se noi continuassimo a produrre un grande quantitativo di informazione, una controinformazione, saremmo ancora una volta funzionali al potere.
Allora mi si potrebbe giustamente dire: ma cosa dobbiamo produrre? cosa dobbiamo fare? Ecco, alla ricerca di questo qualcosa dobbiamo cercare di andare. Perché se l’opinione è quell’idea vuota di contenuti, priva di significati, quel guscio vuoto, senza nulla dentro che viene macinato e prodotto, se noi facciamo un passo indietro, da cosa nasce quell’idea e risaliamo all’idea concreta che c’era, che c’è alla base dell’opinione, che viene masticata e continuamente messa in circolazione, possiamo trovare un diverso modo di accostarci alla realtà.
Certo questa affermazione merita un grosso approfondimento. Se noi lottiamo contro il potere, in quanto, appunto, siamo anarchici e quindi siamo contro l’autorità, non possiamo soltanto limitarci a dire: noi siamo antiautoritari, questo ci sta bene, possiamo dormire tranquilli. Dobbiamo sviluppare anche dentro di noi, dentro ognuno di noi, dentro ogni singolo individuo, una concezione della vita diversa. Quindi l’idea deve cominciare a farsi strada dentro di noi, come una piccola luce, come una piccola fiammella, che a un certo punto illumina certi modi di concepire le cose. Non possiamo, quest’idea, caricarla immediatamente di troppi compiti, di troppi scopi, dobbiamo averne cura, come una pianticella, non dobbiamo pensare che è un albero robusto, è una piccola pianta. Questa idea può crescere, come tutte le idee, soltanto attraverso una luce critica, attraverso una luce di approfondimento, non attraverso l’abbacinante chiarore delle ideologie. Se noi facessimo piovere su questa piccola idea, che ora vedremo qual è dentro di noi, quest’idea che è capace di tornare alla radice delle cose, smontare il concetto di produzione di opinione, se noi facessimo piovere su quest’idea la luce abbagliante dell’ideologia, guardate, la uccideremmo, quale che sia l’ideologia. Perché l’ideologia non è altro che l’opinione in divisa, l’opinione messa in campo, militarmente costruita e schierata, per poter attaccare e raggiungere uno scopo. Fosse pure l’ideologia anarchica, anche questa sarebbe una opinione in divisa.
Per il momento permettetemi di lasciare così queste affermazioni, che verranno chiarite subito dopo.
Facciamo un altro esempio, torniamo sul concreto. Su tutti i giornali, da molti anni a questa parte, ci tempestano con la questione di Di Pietro, la questione “mani pulite” [1995], ecc. Pensate a quanto di incredibile riesce a fare l’opinione prodotta dai grandi mezzi di informazione. Attorno a un pubblico ministero, cioè all’ultimo degli individui, a un boia al servizio dello Stato, viene fatto un tifo da stadio, siamo all’assurdo. Com’è mai concepibile che un giovane possa tifare per il boia, cioè chi assume il ruolo di rifornire le prigioni dello Stato, di sostenere direttamente il potere? Chi gioca questo ruolo, in genere, ha fatto schifo, sempre. Invece no! sono riusciti a costruire intorno a questa figura un’immagine da rotocalco, un affare da milioni e milioni di tirature, qualunque cosa faccia un individuo del genere.
Quello che tradizionalmente ha fatto schifo a tutti, sempre, viene ora fatto diventare allettante, diventa ben vestito e con ciò il concetto di giustizia diventa opinione di giustizia. Attorno alla figura di un qualsiasi Di Pietro si accumula, prende corpo, lo sviluppo di un progetto di potere strisciante, diverso, forse per la prima volta visibile nelle sue nuove vesti.
Ora, se noi riflettiamo un attimo, noi un’idea di giustizia l’abbiamo, perché si capisce: gentaglia come Craxi, come Andreotti, non possono non starci sullo stomaco. Tutti pensiamo che deve pur esserci il modo per fare qualcosa contro di questi. Ma certamente non può essere questo modo delegato allo Stato stesso, il quale attraverso questo procedimento mi fa capire di essere in grado di autocorreggersi e di produrre uno Stato migliore, uno Stato virtuista, capace di imporre a tutti la giustizia legalizzata, sulla base dell’uguaglianza, sulla base della pace sociale e dei destini futuri della nazione.
Affermazioni del genere non possono essere ideali di giustizia. Ma dentro di noi, se noi guardiamo bene, non può non esserci un concetto di giustizia, cioè a dire la nostra dignità personale, individuale, si sente offesa dal comportamento di gente come il re, il dittatore della sanità, come Andreotti, come De Lorenzo, come qualunque altro personaggio del genere. Quindi che cosa c’è di diverso in questo sentimento? C’è una enorme differenza fra questa idea di giustizia, che ognuno porta dentro di sé e che può a un certo punto mettere a tacere, perché la commercializza, la svende, in nome di una contropartita, in nome di mettere a tacere la propria coscienza, come comunemente viene detto. Se questo accade allora perdiamo di vista completamente quella possibilità di poter alimentare dentro di noi quella pianticella, quella piccola luce, se non accade invece possiamo capire meglio il concetto di giustizia.
Su cosa si basa questo concetto di giustizia? Si basa sull’ipotesi di fondo dell’uguaglianza. E su che cosa si basa il concetto di uguaglianza? Attraverso tutta una serie di approfondimenti, esso si basa non sul concetto dell’identità (tutti uguali), ma si basa sul concetto di difesa della differenza, di uomini e donne diversi uno dall’altro in cui l’esaltazione della differenza è la condizione di uguaglianza, cui nessuno deve essere costretto a sacrificare la propria radicale, insostituibile e unica differenza, in nome di un concetto esterno di sacrificio, o per ottenere benefici futuri, oppure un tozzo di pane o un pezzo di salario. Questo concetto lo dobbiamo alimentare dentro di noi, lo dobbiamo conservare, custodire.
Facciamo un altro esempio. Tra le opinioni che vengono macinate e messe in circolazione c’è il concetto principe di democrazia, cioè il concetto della tolleranza. Ci hanno inquinato il cervello con questa storia della tolleranza, perché è chiaro che la democrazia si deve basare sulla tolleranza, perché si contrappone, se non altro teoricamente, ai vecchi regimi del passato assolutisti e dispotici, che teorizzavano la volontà del più forte. La democrazia ha altri strumenti per realizzare la volontà del più forte, ha lo strumento della delega rappresentativa, lo strumento della selezione, della decisione di una minoranza, ha lo strumento della dittatura di una minoranza sulla maggioranza, legalmente riconosciuta e legalmente costituita.
La democrazia era stata per la dittatura, è la realizzazione indolore della dittatura, una minoranza sulla maggioranza. Ma ha bisogno di una diffusa area, un diffuso clima di tolleranza, perché dall’apice estremo, mai raggiunto neanche dai regimi più totalitari e dispotici, nemmeno da Hitler e Gengis Khan, da questo apice estremo che è assoluta mancanza di spazi di libertà, che non è mai stato raggiunto nemmeno in quelle condizioni, perché anche quella gente aveva bisogno di dare dei margini di libertà, all’attuale conclamata disponibilità di spazi di libertà, c’è un processo, un processo che si basa esclusivamente su ordini di tolleranza, cioè di consentire alcune libertà per impedire la realizzazione della libertà.
Se noi siamo qui, questa sera, in quest’aula universitaria di Bologna, a discutere, abbiamo la libertà di parola, non veniamo assaliti da una banda di assassini in divisa, loro non lo fanno perché esiste la libertà di parola, io sono venuto qui, non mi hanno minacciato sul treno che qui mi portava, quindi c’è una libertà di locomozione, ecc.
Queste sono le libertà, sono le miserie della libertà, le briciole di quello che è rimasto in fondo alla pentola della libertà. Se dovessimo lottare per queste libertà io non sono disponibile, perché queste libertà sono le libertà che segnano il perimetro del carcere. Sono i movimenti che vengono consentiti ai detenuti che hanno il diritto di andare a passeggio per due ore al giorno e così via, che hanno il diritto di parlare, ma a certe condizioni, che possono esprimere un’opinione, ma a certe scadenze, che possono delegare, ma a certe persone, che non possono agire mai in prima persona, ma che devono accettare certe opinioni non altre. Ora in questo contesto di delega e di subordinazione, se queste sono le libertà, allora io non sono per la libertà. Per questo i patrioti spagnoli, che venivano fucilati dall’esercito rivoluzionario, tra virgolette, di Napoleone, che venivano con le bandiere tricolore della grande rivoluzione francese, morivano gridando “abbasso la libertà”. E allora anche noi dobbiamo dire abbasso la libertà, perché queste libertà non ci stanno bene.
Ma queste sono le libertà fondate sulla tolleranza, prodotte dalla democrazia, sono le libertà delle opinioni, l’opinione della libertà. Su tutti i giornali c’è questa produzione di libertà, questa produzione continua di concetti sulla libertà.
Cos’è, invece, dentro di noi, che potrebbe ancora avere uno spazio piccolo, nell’ambito di quel concetto che dicevamo prima, quella piccola luce, una piccola finestra? In ognuno di noi c’è un’idea di libertà, la libertà senza limiti, senza frontiere, senza confini. La libertà che ha confini che libertà è? Ma dire la libertà senza confini significa l’assoluto scatenamento degli istinti più pazzeschi e bestiali di ognuno di noi. Certo è anche quello, c’è anche il pericolo che sia quello. Però la libertà è questa, è questa cosa pericolosa, non è quell’altra questione, non è quel vestito a fiori della festa che ci vogliono far credere e che viene sbandierato su tutti i giornali, non è quella la libertà, quelle sono le libertà da qualcosa, libertà da questo, libertà da quello, poter far questo, poter fare quello. Ma le condizioni della libertà sono l’assoluta mancanza di limiti. È questo che abbiamo dentro di noi, non c’è dubbio che ognuno di noi c’è l’ha, ed è questo che fa paura. È questo che nei nostri sogni, per alcuni, o nei propri incubi per altri, immaginiamo, “e se succedesse lo scatenamento della libertà?”.
Facciamo un altro esempio. Sempre l’idea di ordine: sui giornali continuamente viene costruita, articolata in mille sfumature, l’idea di un ordine istituzionale. Lo Stato è la massima espressione di ordine istituzionale, una struttura gerarchizzata, un organigramma in base al quale funziona la baracca, in base al quale c’è un ordine. Ora l’ordine è un concetto in funzione del quale possiamo prevedere cosa accade in futuro. Quindi se noi aspettiamo l’autobus e c’è un orario degli autobus, l’autobus si presenta all’orario che c’è scritto sulla tabella, vuol dire che le cose sono in ordine, questo è il concetto di ordine istituzionalizzato: una possibilità di prevedere il futuro. E siccome la paura ancestrale, più radicata e più forte, che ognuno di noi conserva anche dentro di sé, è la paura del futuro: cioè cosa accade fra un po’, fra un ora? cosa accade, non lo sappiamo, cosa accadrà domani, fra un mese, fra un anno? non lo sappiamo. L’uomo ha sempre avuto un terrore per il futuro, la scienza lo ha saputo consolare a lungo. Fra le sue grandi glorie dell’Ottocento c’era l’ipotesi di Laplace: “Se fosse possibile conoscere tutte le forze, si potrebbe prevedere il futuro nella sua totalità”. Il motto della scienza dell’Ottocento, della fisica e della meccanica, era vedere per prevedere; in fondo, praticamente, l’uomo ha sempre paura del futuro, allora deve esorcizzare questa paura e lo fa ricorrendo a delle protesi. Una delle protesi può essere la scienza, che è la massima espressione militarizzata, concreta, organizzata dell’ordine.
Però esiste anche un altro concetto di ordine, che è l’ordine spontaneo, che si sviluppa accanto, o al di sotto, o al di sopra, non lo so, comunque certamente in modo assolutamente indipendente dall’ordine istituzionalizzato. C’è un ordine spontaneo. Di quest’ordine spontaneo gli anarchici hanno parlato sempre, la loro utopia, immaginata come società libera, come società anarchica, si basa assolutamente e del tutto sull’ordine spontaneo, non sull’ordine istituzionalizzato. Anche le sfumature organizzative che gli anarchici hanno immaginato, riguardando l’amministrazione della società futura, e non il governo della società futura, si basano su una capacità riconosciuta ai singoli individui di autorganizzarsi, cioè di auto-ordinarsi. I concetti di autogestione non avrebbero senso se non ci fosse l’ipotesi di un ordine spontaneo. Noi, in effetti, non conosciamo quasi nulla dell’ordine spontaneo, però se prestate attenzione ad alcuni aspetti del funzionamento della società, vedrete che nella stessa società dove viviamo, ci sono degli elementi che lasciano intravedere l’esistenza di un ordine spontaneo. Anche nella stessa struttura del capitale ci sono degli ordini spontanei, che il capitale utilizza, spesso inconsciamente, ma li utilizza.
Per esempio i progetti di gestione del capitale, le ristrutturazioni del capitale, non vanno mai al di là della breve e media scadenza, non sono capaci di fare progetti a lunga scadenza, tutte le volte che ci hanno provato, hanno fatto clamorosi fallimenti bestiali. Però, in un modo o in un altro, la baracca funziona, funziona perché si basa su un processo di ordine sotterraneo spontaneo; a esempio se voi riflettete su come funziona il mercato, come funziona la formazione del prezzo in un mercato, vi accorgerete che si basa su un ordine spontaneo. La formazione del prezzo non è determinata dalla volontà di un singolo produttore, o di un gruppo di produttori, questo singolo produttore o gruppo di produttori, possono intervenire sul mercato acquistando, vendendo, levando merce, e così via, ma il movimento dei prezzi, la determinazione dei prezzi è un processo indiretto. Nel mercato capitalista esiste, quindi, un ordine spontaneo, ed è un esempio di ordine spontaneo. Cioè all’interno della storia degli uomini ci sono degli elementi di ordine spontaneo.
Questo concetto di ordine spontaneo possiamo tenerlo presente nel problema di che cosa fare nel momento rivoluzionario, nel momento della trasformazione del processo rivoluzionario. A volte la produzione delle opinioni ci chiede: perché mai la distruzione della società attuale dovrebbe produrre un effetto creativo? Noi non sappiamo cosa rispondere. Quando affermiamo la necessità di distruggere il contesto che ci ospita, che ci è nemico, spesso ci viene obiettato: ma come mai attraverso la distruzione verrà fuori una società migliore? Ne siete così sicuri? Siete sicuri che verrà fuori un processo creativo, ecc.? Spesso non sappiamo come rispondere. Potremmo rispondere, a esempio, perché i processi creativi dovrebbero essere indirizzati a sbarazzare l’ordine istituzionalizzato, lasciando l’ordine spontaneo della realtà. A esempio, nel caso del mercato, la formazione dei prezzi senza il capitale non potrebbe più avvenire, e quello stesso meccanismo, che oggi serve per la formazione dei prezzi, nella comunicazione reciproca fra le persone, potrebbe produrre un accordo diverso, la formazione degli accordi. Capisco che sono concetti a cui non si è abituati, però è interessante vedere come nel processo rivoluzionario non c’è nulla da inventare. Perché se noi affermassimo: va bene, basta distruggere poi si vedrà. Sarebbe veramente grave, perché potremmo anche affidare le nostre speranze a un processo di cui sconosciamo completamente il meccanismo e il funzionamento.
Non c’è dubbio che tenere presente un ordine intrinseco alla realtà, che non sia soltanto l’ordine istituzionale, anzi, che viene ucciso dall’ordine istituzionale, o nella migliore delle ipotesi viene utilizzato e strumentalizzato, è importante. Ora, questo concetto di ordine naturale, ordine spontaneo, l’abbiamo dentro di noi, noi tendiamo singolarmente, come organismi, come complesse organizzazioni, il nostro stesso corpo tende a un’organizzazione, a un ordine del genere, difatti, le perturbazioni di quest’ordine le chiamiamo malattie, stati di scompenso, di disequilibrio, come volete. Quindi noi dobbiamo tenere presente anche questo concetto, che come vedete non ha niente a che vedere con quelli che vengono fabbricati nell’ambito delle opinioni.
Un ultimo esempio vorrei fare. Il discorso che viene fatto a livello dell’opinione sulla necessità di mettersi insieme, perché il mettersi insieme costituisce un segno di forza, l’aggregazione costituisce un segno di forza. A parte che la parola aggregazione viene da gregge e a me ha sempre fatto un po’ schifo come parola. Però, a parte questo, appellano all’aggregazione tutti quanti, un uomo disaggregato, secondo l’opinione diffusa, non è nemmeno un uomo. Viene suggerito, continuamente, di appartenere a qualcosa, di consegnarsi a una qualche parte, partito, organizzazione, di impegnarsi in qualche attività, l’individuo da solo viene considerato con sospetto.
Però dentro di noi sappiamo che attraverso questo processo di deformazione, quindi attraverso l’opinione che produce la necessità apparente di aggregazione, ci sta un fondamento di verità, cioè a dire, noi, in effetti, come singoli ci sentiamo molto limitati, cerchiamo qualcosa, qualcosa che sia fuori di noi, ci muoviamo nello spazio, ci rivolgiamo verso l’altro, ma questo altro per noi non è un assoluto, un assolto, posto fuori dal processo di giudizio. Per noi non può essere qualunque altro, deve essere un altro che ha certe caratteristiche, certe caratteristiche che sono affini alle nostre caratteristiche, qualcuno che non sia identico a noi, che non esiste, perché sarebbe mortale per noi, una duplicazione, una clonazione di noi stessi. Ma qualcuno che abbia delle affinità. E la conoscenza di queste affinità significa approfondimento dell’altro, muoversi verso l’altro, amare l’altro, approfondirlo nei suoi difetti, nelle sue capacità, nelle sue speranze, nel suo modo di vedere la vita, e così altro comincia a diventare per noi il punto di riferimento di una diversa concezione dell’essere insieme.
Come vedete, queste idee, l’idea di giustizia, l’idea di trasformazione del mondo, l’idea di ordine, e, principalmente, l’idea di affinità, di identificazione e sintonia comune con l’altro, sono completamente differenti delle opinioni che ci somigliano e che vengono messe in circolazione.
Io mi sono sempre chiesto, se l’attuale situazione in cui ci troviamo, e quindi la produzione e il consumo delle opinioni, poteva essere possibile, nella stessa maniera di come accade oggi, venti o quaranta o cinquanta anni fa? io penso di no. Non è che c’è soltanto una produzione di una merce chiamata opinione. Come per tutte le merci, il consumo precede la produzione – si dice in economia politica –, cioè la necessità di quella merce determina la produzione. Ora il mercato, per essere in grado di ricevere l’opinione, è stato in un certo senso precostituito. Siccome si tratta di idee, e le idee si esprimono attraversi i concetti, e i concetti si costruiscono con le parole, c’è un problema di linguaggio. Cioè determinate opinioni non potrebbero avere la circolazione che hanno se non ci fosse in questo momento un processo di impoverimento del linguaggio. Riguardo questo processo sarebbe troppo lungo cercare di capire se è venuto prima o dopo, se l’opinione determina un impoverimento del linguaggio, o l’impoverimento del linguaggio determina l’utilizzo e quindi la richiesta e la produzione dell’opinione, per quanto sia importante questo discorso, non lo si può risolvere in modo adeguato. Però un impoverimento del linguaggio c’è, ed è visibile.
I motivi per cui questo processo si è sviluppato corrispondono esattamente, combaciano perfettamente, con quelle che sono le trasformazione della struttura produttiva, quindi condizioni diverse a livello di produzione del capitalismo, hanno richiesto diverse condizioni produttive. Per fare un’ipotesi, un abbassamento della qualificazione, una dequalificazione del lavoro. Ora, la scuola in generale, in tutti i suoi ordini, produttrice della futura forza lavoro, della merce lavoro, è stata per tempo dequalificata. Si è abbassata la qualificazione perché la richiesta del mercato della forza lavoro era di persone, lavoratori, non altamente qualificati. Mentre prima c’era una considerevole richiesta di lavoratori altamente qualificati e una piccola richiesta di persone non qualificate, oggi c’è una altissima richiesta di persone mediamente qualificate. Dalle università non escono specialisti, esce la manodopera mediamente qualificata, gli specialisti se li creano altrove, nei master post-universitari, ecc., che il potere ha sempre bisogno di utilizzare.
L’abbassamento del linguaggio ha determinato l’incapacità, sotto certi aspetti, di contrastare determinati progetti. Perché noi, forse non ci riflettiamo molto bene, abbiamo un unico elemento comune con il potere, ed è il linguaggio, abbiamo tutte le cose in contrapposizione, ma il linguaggio l’abbiamo in comune. Ora, il linguaggio, essendo la materia, l’elemento, lo strumento attraverso cui si può desiderare, perché il desiderio non riesce a esprimersi se manchiamo delle parole, non riusciamo a capire cosa desideriamo, abbiamo una nebulosa idea del desiderio, ma per individuare l’obiettivo, quello che vogliamo, e che ci manca, per attaccare il nemico che questo obiettivo possiede, a cui noi vogliamo sottrarre la cosa che ci manca, dobbiamo poterla esprimere in parole, se no non possiamo capirla. Noi non solo parliamo parole ma pensiamo parole. Se queste parole si impoveriscono, non siamo in grado di parlare, ma non siamo nemmeno in grado di pensare, e se non siamo in grado di pensare non siamo in grado di desiderare. Immaginate cosa succederebbe se si dovesse verificare un approfondimento radicale di questa condizione di impoverimento. Se questi dovessero costruire un muro, un muro fra gli inclusi e gli esclusi, un muro in cui il linguaggio che circola all’interno degli inclusi, dei privilegiati, risultasse a poco a poco incomprensibile agli esclusi. Cosa mai gli esclusi dovrebbero desiderare che appartiene agli inclusi? Tutta la storia della lotta di classe fino a oggi si è basata su un elemento essenziale: tutte le cose desiderate da chi non le aveva erano cose possedute da chi le aveva, ma erano cose che chi non le aveva le comprendeva, le capiva, e capendole le desiderava, riusciva a esprimerle. Se viceversa si costruisse un muro, basato su due linguaggi completamente differenti, un linguaggio estremamente impoverito, quelle dieci o quindici parole (forse sono eccessivi questi numeri, però ci sono degli studi precisi, che indicano nei college americani un uso di non più di ottanta parole: voi pensate, una lingua ricchissima come l’inglese, ridotta soltanto a ottanta parole, una cosa spaventosa) gli esclusi non riuscirebbero più a capire le cose che appartengono agli inclusi, quindi non le desidererebbero, non lotterebbero per avere una cosa che non capiscono.
Le trasformazioni del progetto capitalista, sicuramente, vanno in questa direzione, e anche le trasformazioni della democrazia vanno in questa direzione. Dobbiamo tenere presente che c’è un rapporto fra democrazia e capitale. La democrazia non è quell’ipotesi astratta, quella sorta di valore che ci contrabbandano nei giornali: “bisogna difendere la democrazia” o cose del genere; la democrazia è una forma di organizzazione, un metodo di organizzazione politica, e probabilmente questo metodo di organizzazione politica ha fatto anche il suo tempo. Poniamo la democrazia rappresentativa inizia ad apparire difficile, specie se pensate alla possibilità di ingresso nell’ambito delle strutture organizzative politiche di tipo democratico di grandi nazioni come la Cina o la Russia, ecc.
È chiaro che in questo ambito diventerebbe più difficile la gestione classica della democrazia rappresentativa, ecco perché ci sono sforzi verso altri tipi di democrazia, verso la democrazia diretta, verso la partecipazione diretta, non soltanto attraverso la delega; non sto riferendomi soltanto alle ipotesi puntuali dei referendum, ecc., ma praticamente anche a una forma organizzata costante di democrazia diretta. Adesso esistono le capacità tecnologiche per le possibilità, le potenzialità per poter realizzare un continuo rapporto fra chi gestisce il potere e i sudditi, su qualsiasi argomento, quindi per realizzare il mito classico di Rousseau della democrazia diretta. Perché Rousseau parlava della democrazia diretta, però poneva due ostacoli alla sua realizzazione in grande, primo che c’erano troppe leggi, quindi occorrevano poche leggi, secondo, l’ostacolo delle grandi città, ma poteva essere realizzata in piccoli agglomerati urbani, questa era la tesi di Rousseau. Adesso non c’è più questo ostacolo, adesso si può realizzare anche in grandi città o in grandi nazioni questo concetto di democrazia diretta. Ecco perché attraverso l’opinione, e quindi attraverso il processo dei grandi mezzi d’informazione che abbiamo visto prima, ecc., ecc., viene polverizzato il concetto di partecipazione.
Pensate a quante storie e chiacchiere vengono fatte sul volontariato e sull’importanza sempre maggiore che questa forma di organizzazione dal basso, finanziata e sponsorizzata dallo Stato, assume e sta assumendo nelle grandi democrazie capitaliste. Con questo volontariato si educa la gente a partecipare, la si politicizza in modo concreto, la si sottrae a certe discussioni astratte del passato, le quali in un clima di ideologia debole o debilitata non hanno più significato. Il concetto di volontariato, e quindi di partecipazione, è da collegarsi col concetto di democrazia diretta, e il concetto di democrazia diretta è in funzione di una sua possibile sostituzione del concetto della democrazia rappresentativa.
Gli anarchici, purtroppo, alcuni degli anarchici, sono spesso caduti in questo equivoco, cioè del possibile utilizzo libertario della democrazia diretta. Non è affatto vero che sia una caratteristica di quei compagni anarchici che oggi si riferiscono al municipalismo, ecc., ma io mi ricordo, a esempio, che negli anni Cinquanta c’è stata una grossa polemica all’interno della Federazione Anarchica Italiana perché alcuni compagni, fra cui anche alcuni compagni siciliani che conoscevo personalmente, sostenevano la possibilità, anzi la necessità, di partecipare ai Consigli comunali; un caso clamoroso a Castelvetrano: gli anarchici entrarono nel Consiglio comunale. D’altro canto, se voi riflettete un attimo, a esempio esperienze, in Italia, in cui i compagni anarchici si sono impegnati nelle lotte sindacali, in piccoli centri, a un certo momento la gente stessa chiede: ma cosa si può fare? perché vi fermate, perché siete arrivati a un certo punto del vostro ragionamento e poi vi fermate? se siete stati con noi nelle lotte rivendicative a un certo momento perché vi fermate e non andate al Consiglio comunale? La risposta che viene data a questa obiezione, assume un carattere di natura ideologica: gli anarchici sono contro le elezioni per principio e quindi sono contrari alla partecipazione alle elezioni municipali. Non è sufficiente come obiezione, o si fa un discorso che risale alle origini, o si rifiuta tutta la partecipazione, oppure, a un certo punto, si è inconcludenti. Pensate al grande e tragico errore della Spagna del ’36, quando si entrò nell’esercito, quando gli anarchici vestivano le divise. Io ho conosciuto personalmente, ormai vecchio, un generale di divisione, Cipriano Mera, che ha pubblicato un libro che si trova anche in italiano, che era generale di divisione sull’Ebro. Ma sarebbe errato rimproverare agli anarchici: “come, gli anarchici sono antimilitaristi e poi entrano nell’esercito e vestono la divisa dell’esercito?”, sarebbe stato errato rimproverare “solo” questo, bisognava rimproverare loro di essere entrati nel governo, e sarebbe stato errato limitarsi a rimproverarli di essere entrati nel governo, perché bisognava risalire indietro e rimproverarli di essere entrati nei sindacati, perché è chiaro che quando diventi il gestore del più forte sindacato, poi non puoi lasciarti sfuggire il potere dalle mani, e per forza a un certo punto entri nel governo, entri nell’esercito.
Qui l’errore sta sempre all’origine della decisione: o noi tagliamo di netto questo processo, o noi ci contrapponiamo, fin dal primo momento, contro tutta la sequenza, fin dall’inizio, che ci fa compartecipe sia pure esterni del potere, oppure a un certo punto diventiamo inconseguenti, non bastoano più le ragioni ideologiche.
Consentitemi, prima di finire, di tornare a quel momento intimo dell’individuo, parlavamo di quella piccola luce, dell’idea che c’è dentro di noi, in ognuno di noi, di queste idee fondamentali con cui a un certo punto possiamo fare piazza pulita dell’opinione, non contrapponendo un’opinione giusta, o contrapponendo un’idea diversa. Però se noi restassimo chiusi, singolarmente, dentro di noi, cosa varrebbe tutto ciò? Anzi potrebbe spingerci a crederci superiori agli altri, mentre non siamo superiori agli altri, anzi siamo più deboli degli altri, perché ponendoci più problemi abbiamo più difficoltà a vivere; ogni piccola cosa diventa un problema; mentre la gente, ogni mattina, esce di casa e sa che cosa fare, noi, molte volte, usciamo e non sappiamo che cosa fare, ci poniamo problemi per tutto. Come fare diventare questa debolezza una forza? È chiaro, possiamo metterla a frutto questa debolezza, trasformarla in una forza, innanzi tutto attraverso la strada dell’affinità, trovare i nostri compagni, con cui parlare, non milioni di persone, ma uno, tre, cinque persone, quei compagni che hanno quelle caratteristiche che ci stanno a cuore. E queste caratteristiche non le portano scritte in fronte, non fanno parte della loro maggiore bellezza o della loro maggiore bruttezza, e nemmeno fanno parte del fatto che ci stanno più simpatici, non è la simpatia l’affinità, è quello che hanno dentro, le loro idee che riescono a trasferirmi, e io per saperle queste idee devo conoscerle, devo approfondire questo discorso, non devo avere paura, e nemmeno devo farmi affascinare dall’impatto iniziale. E questo è un grossissimo lavoro di approfondimento, non c’entra niente con l’aspetto politico, non c’entra niente con quello che si deve fare, c’entra con la vita, con la vita di tutti i giorni, se non vogliamo che questa vita si trasformi in una tragica farsa. E quindi individuati questi compagni devo muovermi, devo muovermi fuori di me, nello spazio che sta fuori di me, perché guardate il concetto di spazio non è neutro, ma è fortemente caratterizzato dalla presenza del potere, senza lo spazio il potere non esisterebbe.
Non c’è la giustizia, ma ci sono i tribunali; non c’è il militarismo, ma ci sono le caserme; senza le caserme non ci sarebbe il militarismo, senza i tribunali i giudici avrebbero molta difficoltà a esercitare il loro mestiere sotto l’albero del villaggio. Non c’è la segregazione o la pena, ci sono le carceri. Devo muovermi, quindi, in un tessuto territoriale in cui il potere è costituito da fatti concreti, da palazzi, da persone, da rapporti visibili, non da idee. Quelle opinioni, idee svuotate di senso, di cui parlavamo prima, sono, come dire, il mare in cui tutta questa questione viene immersa, è l’atmosfera che fa vivere questi strumenti di coercizione, di potere e di morte, che ce li fa apparire come indispensabili. E quindi se io mi muovo, mi muovo contro queste realizzazioni.
Capite adesso il rapporto, di cui parlavamo prima, che appariva astratto, tra azione e teoria? Io non posso muovermi contro queste strutture se non ho approfondito teoricamente il loro rapporto, ma a che vale approfondire teoricamente se poi non mi muovo, e nel muovermi non contribuisco ad approfondire teoricamente la consistenza, l’identificazione, la diffusione nel territorio di queste strutture? Cosa varrebbe, a esempio, trovare alcuni compagni con i quali sto bene, per poi rinchiudermi in cima al mondo, in un piccolo locale circoscritto, restare in casa, difendendomi? Perché il concetto di restare presso di sé implica il concetto di paura del mondo. Io devo uscire, e uscendo devo scontrarmi con questo contesto diffuso nel territorio.
Pensate adesso questa diffusione nel territorio quanto è essenziale per il potere. Il potere così come si sta costruendo, come si sta sviluppando, il capitalismo, è essenzialmente fondato su una diffusione sul territorio, nello spazio. Pensate l’inserimento della telematica nella tecnologia moderna, come è coessenziale all’idea stessa di funzionamento la diffusione nel territorio. Pensate, a esempio, per fare un solo e unico esempio, l’importanza del nuovo tipo di cavo basato sulle fibre ottiche per fare delle trasmissioni, delle comunicazioni, nello spazio. Quindi non ci sono solo chiese o cattedrali isolate, ma ci sono locali nello spazio in comunicazione fra di loro: sostanzialmente il globo è attraversato da una rete di comunicazione. È qua che si scontrerà la lotta rivoluzionaria di domani.
Ora consentitemi di chiarire cosa sono i gruppi di affinità, la cosa è importante. L’ultima trovata della polizia e della magistratura è stata quella di accusarci di costituire dei gruppi di affinità e di costituire gruppi di affinità con l’idea di dare vita a una struttura organizzata, una associazione diretta a sovvertire gli ordinamenti democratici, ecc. Ora i gruppi di affinità non hanno nulla di questa caratteristica, che invece i vari pubblici ministeri, della stessa categoria del sullodato Di Pietro, cercano di metterci, non c’entrano nulla perché sono due concetti completamente diversi. In fondo, lo Stato che cosa vede fuori di sé, che cosa può vedere fuori di sé, se non una riproduzione di se stesso? A se stesso nemico. A esempio lo Stato, vent’anni fa, vedeva nelle Brigate Rosse una struttura che voleva sostituirlo nella gestione del potere, però vedeva una struttura organizzata da capi, sottocapi, organigrammi, cellule, soldati, generali e così via. Cosa che non ha nulla a che vedere non soltanto con noi, ma non ha nulla a che vedere con l’anarchismo, con la libera e spontanea decisione dell’individuo, non ha nulla a che vedere con la difficile, incerta, problematica e tormentata ricerca dell’affinità, della conoscenza dell’altro, con la costruzione di un tessuto di rapporti essenzialmente umani, ma anche di lotte rivoluzionarie.
Vi ringrazio dell’attenzione.
[Conferenza dal titolo: “Anarchismo e democrazia” tenuta a Bologna il 16 marzo 1995 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia. Trascrizione della registrazione su nastro]
Immaginario
Fra i concetti di nuova emergenza accade di imbattersi, sempre più spesso, su quello di “immaginario sociale” o “collettivo”. Esso viene, quasi sempre, buttato lì, come cosa da tutti risaputa, e dal fatto stesso che viene posto in mezzo ne derivano conseguenze nel ragionamento e deduzioni che non appaiono abbastanza fondate.
Da ciò la necessità di chiarire alcuni aspetti di questo “concetto”, aspetti che poi determinano non poche difficoltà nelle analisi.
Per quello che si può capire – e non crediamo sia molto – quando viene impiegato il concetto di “immaginario” (sociale o collettivo, poco importa), ci si vuole (più o meno consapevolmente) riferire ai sentimenti che un fatto o una situazione socialmente significanti, determinano sulla società intesa come insieme di persone. Nello stesso tempo, ci si vuole riferire ai mezzi moderni di comunicazione che realizzano il passaggio di questi fatti “sociali” significativi, dal semplice accadimento circoscritto nel tempo e nello spazio, alla diffusione di massa, la quale diffusione consente una persistenza nel tempo e una dilagazione senza paragoni nello spazio.
In altre parole, si tratterebbe di un meccanismo inconscio (e quindi irrazionale) attraverso cui i membri della società rappresentano a se stessi i fatti sociali più significativi, proprio nei modi realizzati dalle strutture di comunicazione di massa e nelle forme volute dalla struttura politico-culturale dominante.
Che questa realtà esista, viene dato per scontato. Non c’è dubbio, infatti, che la gran massa delle persone sia in balìa dell’informazione di potere, della cultura e, quindi, delle idee elaborate dal potere. Non c’è nemmeno dubbio, a quanto sembra, che la gran parte della gente reagisca in modo sufficientemente uniforme (tanto da consentire previsioni e proiezioni politiche molto attendibili anche partendo da campioni assai modesti). La società di massa pensa e agisce in modo massificato, quindi prevedibile. Ciò molto di più di quanto accadeva una volta, quando la coesione era garantita da un vasto analfabetismo di fondo.
Fin qui nulla da dire. Oppure, in effetti, ci sarebbe molto da dire ma nel senso di fare qualcosa per spaccare questa uniformità, per farla diventare critica e contraddittoria, confusa e disperata, e non per mantenerla inerme e consenziente.
In pratica accade il contrario. E ciò proprio all’interno del movimento rivoluzionario che dovrebbe realizzare o, almeno, farsi carico, l’operazione di dissacrazione e di rottura. Qui viene accettato l’“immaginario” come un referente possibile, cioè come un qualcosa di omogeneo e di già costituito su cui fare pressione. Un qualcosa – non chiaramente distinto – da utilizzare a scopi rivoluzionari.
Quando questa pretesa è più fondata, il che accade raramente oggi, con la grossa carenza analitica di cui siamo circondati, si fa il discorso che l’“immaginario” riassume i diversi livelli di coscienza di classe o, per dirla in parole semplici, trasforma in sensazioni e immagini personali le realtà della differenza tra le classi, della situazione produttiva, del grado di mobilità sociale, delle strutture in cui risulta divisa la società, ecc., per cui il singolo ha la possibilità, attraverso questo filtro abbastanza uniforme, di cogliere la sua “posizione” all’interno del corpo sociale arrivando alla autoidentificazione con una classe anziché con un’altra.
A noi sembrano urgenti alcune considerazioni.
Primo, il concetto di “immaginario” (sociale o collettivo) si avvicina “pericolosamente” al concetto di “mito”. Non che Sorel ci faccia paura, ma ci fa paura un uso sconsiderato e acritico dei processi irrazionali di massa, specie quando questi sono presi in considerazione in una prospettiva rivoluzionaria.
Secondo, non è affatto vero che ci sia un rapporto diretto tra “immaginario” e livello della coscienza di classe complessiva, se non altro perché non è possibile, attraverso i processi di formazione dei sentimenti collettivi indotti, quali appunto quelli formati attraverso l’impiego dei grandi mezzi di informazione, arrivare a una corretta separazione tra sfruttati e sfruttatori. Prendiamo l’“immaginario” della “paura” del nucleare, così come, a esempio, si è sviluppato dopo Chernobyl. È una unità amorfa, variamente diffusa in tutte le classi sociali, che tende proprio a superare un discorso di “differenza” per accomunarci tutti sotto il comune denominatore della morte atomica. Impostando un discorso su questo elemento dell’“immaginario” (sociale o collettivo), ne viene fuori non un raccordo con i livelli di coscienza, ma un collegamento con una reazione collettiva irrazionale. In altre parole, siamo ben al di sotto del progetto del “mito dello sciopero generale” di cui parlava Sorel che, almeno, poteva essere avvertito (ma non realizzato) solo dal proletariato.
Terzo, il fatto stesso di sapere che esiste un patrimonio disponibile di tal sorta, come un contenitore di potenzialità facilmente raggiungibile, dove attingere per qualsiasi progetto rivoluzionario vogliamo realizzare, è certamente negativo perché ci porta a ipotizzare possibile un uso del mezzo di grande informazione per stornare a vantaggio del movimento rivoluzionario quel patrimonio (cioè l’“immaginario”) che invece può essere solo raggiunto, accresciuto o, comunque, modificato a beneficio esclusivo dei progetti di potere. In questa ottica siamo portati ad accettare per buone solo le azioni di attacco che risultano facilmente leggibili in chiave “immaginaria”, e non ci rendiamo conto che questa chiave è gestita dal potere attraverso la “sua” informazione.
Ma, vediamo la cosa da un altro punto di vista, che sembra più interessante.
Che l’“immaginario” (sociale o collettivo) sia “un’organizzazione di immagini” è fatto da ammettersi senz’altro, in caso contrario perché mai usare questo neologismo orribile? Infatti, non è pensabile che chi lo usi abbia in mente un’accozzaglia farraginosa e impenetrabile di immagini, ma un tutto avente una certa struttura più o meno chiara. Quindi, se si vuole usare questo termine, lo si usi nel senso di un qualcosa di organizzato, a livello immaginativo, cioè di simboli, di sentimenti, di sensazioni, di immagini (appunto), che vengono prodotti dalla realtà (fatti socialmente significativi) e, poi, trasferiti alla collettività con lo strumento classico dei grandi mezzi di informazione.
Ora, a ben considerare, il concetto di “un’organizzazione di immagini” è lo stesso usato da Sorel per definire il “mito”. Si tratta, in effetti, delle stesse parole. Egli diceva: “Il mito è un’organizzazione di immagini”.
Negli ultimi anni (e ciò spiegherebbe l’emersione confusa di questo concetto all’interno del movimento rivoluzionario) c’è stata non tanto una rivalutazione del sorelismo, quanto una rivalutazione del concetto di mito, con le analisi che vanno da Lévi-Strauss a Barthes, fino a Douglas e Godelier. Ciò è accaduto parallelamente a una profonda modificazione nella struttura produttiva e sociale, con nuovi stimoli culturali e con la caduta dei vecchi luoghi comuni del centralismo e del dirigismo. In una realtà piena di tensioni e di provvisorietà, mentre tutte le certezze del passato cadono e vengono sostituite da modelli probabilistici, mentre il capitalismo si avvia a ristrutturare se stesso sulla base di una “provvisorietà” stabile, il concetto di “mito politico” riprende la sua strada sotto la nuova veste di “immaginario sociale” (o collettivo).
Non solo non condividiamo un uso acritico del termine, ma, principalmente, riteniamo indispensabile un approfondimento delle conseguenze di una sua presenza all’interno della progettualità rivoluzionaria. E ciò in particolar modo oggi, in una situazione fortemente disgregata, mentre abbiamo bisogno di elementi di chiarificazione che ci facciano capire come agiscano i poteri di convincimento, come si muovono le forze irrazionali (quindi, anche immaginative) che la profonda modificazione strutturale della società sta mettendo in moto, come stiano per essere sostituiti ai vecchi idoli nuovi concetti altrettanto affascinanti e altrettanto mistificatori.
Non vogliamo dire che siamo per una fredda analisi che metta le cose in chiaro, che impianti un solo albero ideologico al posto di una rigogliosa e variegata giungla spontanea di piante esotiche. Vogliamo solo dire che non si possono accettare concetti “operativi” tanto complessi e contraddittori come se fossero fatti ormai acclarati e messi definitivamente fra gli strumenti da utilizzare tutti i giorni nella nostra lotta contro lo Stato e il capitale.
Il nostro referente privilegiato resta l’insieme degli sfruttati, in modo particolare quella parte di sfruttati che sta per essere messa fuori dal mercato del lavoro a seguito dei processi di ristrutturazione del capitale. Questo insieme è senz’altro raggiungibile attraverso quel flusso di “organizzazione di immagini” che il potere stesso realizza per i suoi scopi, ma che non può considerarsi un processo assolutamente perfetto. Al suo interno si aprono spiragli contraddittori. La gente si convince di una cosa, ma non può fare a meno di alimentare sospetti e potenzialità di rivolta. Quest’ultima potenzialità, evidentemente aumenta man mano che a fianco del convincimento che il potere cerca di ottenere (consenso e adesione), si delineano nettamente i sistemi di sfruttamento (ristrutturazione feroce e distruzione delle antiche identità lavorative). Il potere non può evitare che anche tutto ciò entri in quel processo di “organizzazione di immagini” che insiste a produrre. Ed è qui che si inserisce il nostro intervento.
Quindi, soltanto parzialmente possiamo tenere conto di quello che impropriamente viene definito “immaginario”. Precisamente possiamo usare quella parte che il potere non riesce a controllare, non l’insieme del flusso organizzativo delle immagini che riesce a trasmettere e a impiantare nella gente. E questa parte è data soltanto dagli stimoli di rivolta, dagli aspetti – se si vuole – irrazionali, che vengono messi in moto come conseguenza diretta delle modificazioni violente nella struttura produttiva, e anche causati (indirettamente) dal passaggio stesso del flusso di informazioni e dal suo controllo centrale.
Suggeriamo quindi un approfondimento critico del concetto di “immaginario”, in modo da potere pervenire alla individuazione di questi elementi “accidentali” o “non controllabili” da parte del potere. Pensiamo che il movimento rivoluzionario possa fare riferimento esclusivamente a essi e non a una ipotetica unità “immaginaria” collettiva intesa come immenso serbatoio da cui attingere eventuali potenzialità sovversive.
[Pubblicato su “Provocazione” n. 3, marzo 1987, p. 6 col titolo “Ma cos’è l’immaginario?”]
Impoverimento culturale
La questione, innanzitutto, che determinati popoli siano poveri di linguaggio è assolutamente infondata. Chi l’ha detto che sono poveri di linguaggio? Il fatto che gli Amerindi parlano una lingua diversa non significa che sia povera. Tu mi fai l’esempio dei popoli cosiddetti “sottosviluppati”, o “selvaggi”, e dici il loro linguaggio è più povero del nostro. Chi l’ha detto? Ogni linguaggio ha ricchezze infinite. Quello che invece potrebbe accadere è l’impoverimento del linguaggio, quindi si tratta di un’altra cosa. C’è un processo di impoverimento del linguaggio correlato con il progetto essenziale del capitale, cioè con la regolamentazione del mercato del lavoro, quindi fornire persone adeguate a quelle che saranno le richieste del lavoro domani. Quest’aula universitaria, dove siamo noi in questo momento, cosa credete che produca? Una volta serviva a produrre i dirigenti, da qua sono usciti magistrati, giudici, medici. L’Università era un luogo per produrre la classe dominante. Ora questa classe dominante di domani, di cui hanno evidentemente ancora bisogno, se la producono in altre sedi, non in queste aule, in altre sedi più ristrette e più specializzate, perché si tratta di gruppi numericamente più piccoli. Mentre in questa sede produrranno non la classe dominante, ma la classe intermedia che servirà per fini intermedi di gestione del lavoro, in quanto si sono modificate le condizioni della produzione. Avete sentito parlare che c’è un processo in corso, una rivoluzione tecnologica, una rivoluzione telematica, le catene di montaggio sono diverse, c’è la robotizzazione: ecco, in questo contesto che se ne fanno di tutti questi laureati?
[Parte del dibattito seguito alla Conferenza dal titolo “Anarchismo e democrazia” da me tenuta a Bologna il 16 marzo 1995 presso la Facoltà di lettere e filosofia. Trascrizione della registrazione su nastro]
Innocuo piccolo esame
Che il sistema scolastico inglese fosse più rigido di quello italiano dal punto di vista delle selezioni di accesso ai vari livelli di studi, lo si sapeva. E si sapeva pure che con queste selezioni non si voleva tanto scegliere i migliori, ma porre i rampolli delle classi più ricche in condizioni di fare valere la propria superiorità di partenza, usufruendo di tutti gli appoggi culturali e sociali che la loro origine mette a disposizione.
Le selezioni sono state sempre, nel sistema inglese, una occasione per scremare i ragazzi. Adesso questo crivello è arrivato all’inverosimile.
La più recente proposta è di realizzare una sorta di esame di ammissione all’asilo, a partire dai bambini di due anni. Le domande a cui il piccolo deve rispondere sono ovviamente adeguate all’età e non presentano difficoltà particolari, ma, in linea di massima, un bambino così piccolo, proveniente da famiglie povere, e quindi costretto a vivere in condizioni disagiate, potrebbe avere difficoltà ad affrontare un confronto basato su domande che richiedono una risposta, per quanto semplice questa possa essere.
Quasi sempre nelle condizioni familiari più degradate non si discute molto col bambino, non lo si ascolta: ci si limita a spostarlo come un oggetto più o meno gradevole o ingombrante, quando non gli si danno ordini o non lo si picchia. Certo, le violenze sui piccoli sono possibili anche in altri contesti familiari, ma nelle condizioni economicamente privilegiate, molto più spesso, ci sono minori tensioni o, comunque, quando queste ci sono (ché in effetti, nella vita che tutti conduciamo, esse non mancano mai), si possono creare barriere artificiali per attutire l’impatto diretto sul bambino.
Risultato, la selezione a due anni garantisce di già un buon avviamento per la futura vita del perfetto cittadino inglese, quello stesso che poi andrà nelle scuole pubbliche (che da noi corrispondono alle scuole private), per finire in quelle poche università di prestigio che fanno in modo che i posti di comando restino sempre in mano delle poche famiglie dominanti.
[Pubblicato su “Canenero” n. 19, 17 marzo 1995, p. 3]
Internazionalismo
Il capitale, nelle sue molteplici espressioni, sia a livello di formazione economico-sociale, sia a livello di progettualità repressiva e di controllo, si estende su tutta la superficie del globo, nessun piccolo recesso geografico escluso. Ciò comporta, com’è ormai comunemente accettato, un processo relazionale costante, nel senso che non c’è azione, qui, in questa parte del mondo, che non si possa porre, e di fatto non si ponga, in relazione con le situazioni di tutte le altri parti del mondo. Ciò determina conseguenze, spesso non visibili a livello immediato, ma che si insinuano nei rapporti del capitale e ne modificano i processi.
Ora, a causare queste conseguenze, non sono soltanto i progetti repressivi e di controllo, i quali stanno ripassando i confini Stato-capitale, per fare la strada inversa a quella che avevano percorso agli inizi degli anni ’80, ma sono anche le azioni di resistenza e di attacco che vengono poste in essere dai movimenti rivoluzionari, dalle organizzazioni specifiche che combattono contro il nemico di classe, dai movimenti insurrezionali di massa che si vanno formando un po’ dappertutto, ecc.
Tutte le manifestazioni che, dichiaratamente, si pongono nell’ottica dell’internazionalismo rivoluzionario, cioè nell’ottica di lottare a fianco dei popoli oppressi, in tutte le parti del globo, a partire dal posto dove ci si trova o, comunque, a partire da un momento particolarmente significativo, in cui il capitale, a livello internazionale, celebra i suoi programmi, assumono un atteggiamento politicamente corretto.
Questo modo di porsi nei riguardi delle lotte riscuote consensi dappertutto e anche noi ci siamo posti in senso favorevole, per cui le brevi note critiche che qui appaiono vogliono soltanto essere un momento di riflessione più generale sulle possibilità e, perché no, sui limiti della lotta internazionalista rivoluzionaria.
Per prima cosa, la “scadenza”. A fissarla, quasi sempre, a ben riflettere, è il potere. Il movimento gli va dietro come un cane dietro una salsiccia fumante. Ciò comporta tutta una serie di rischi. Non è detto, infatti, che la scadenza fissata sia veramente importante. Può esserlo a livello di propaganda, cioè nel senso che in certi momenti il potere internazionale del capitale si programma incontri, conferenze, congressi, o altre diavolerie del genere, per camuffare i processi decisionali più significativi che vengono presi altrove. Spesso, ancora, in certi momenti, proprio perché diretti alla platea, si fanno discorsi che sono “accettabili”, progetti umanitari, sbandieramenti di disponibilità che lasciano stupefatta la gente, la quale non è preparata per capire i motivi di un dissenso, proprio nel momento in cui tutti si dimostrano disponibili a risolvere il problema. E tutto ciò mentre altrove, nel chiuso dei consigli di amministrazione, nelle sale ristrette dove si riuniscono i gruppi di sotto-potere, nei dialoghi a due o a tre, si prendono le decisioni traumatiche che condizionano milioni di vite, che causano milioni di morti.
In secondo luogo, il mito della “massa”, nel senso che si pensa sia indispensabile convogliare, in queste grandi occasioni, il maggior numero di compagni, o di persone, per far vedere quanta e quale sia la forza del movimento. In sostanza, questo secondo punto, limitante se ben si riflette, è strettamente connesso col primo. Se si sceglie la strada di manifestare – in un modo o nell’altro, qua non si sta facendo questione di metodo – nel corso dei grandi momenti celebrativi del potere del capitale internazionale, non si può fare diversamente, se non altro per non sembrare troppo pochi per impensierire chicchessia. E qui casca un’altra riflessione, connessa a queste scelte, la pretesa di potere “pubblicizzare” l’intervento facendo ricorso ai grandi mezzi di informazione, i quali non possono tacere di fronte ad azioni del genere. Quest’ultimo punto non merita di essere affrontato, sia perché ne abbiamo parlato molte volte, sia perché pensiamo ormai sia chiara la possibilità che hanno questi mezzi d’informazione di recuperare e rimacinare tutto quello che accade a uso e consumo del potere. Scadenza esterna, massa e pubblicizzazione sono quindi tre elementi che dovrebbero essere sottoposti a un serio dibattito critico da parte del movimento, nell’ottica dell’internazionalismo rivoluzionario.
Manifestazioni di massa potrebbero altrettanto bene essere organizzate contro questi centri reali del potere, risultando non meno (se non di più) efficaci. Solo che questi centri reali dovrebbero essere individuati e ciò riporta il discorso alle effettive possibilità del movimento rivoluzionario di avere le necessarie informazioni. Ma queste informazioni non vengono regalate da nessuno, devono essere espropriate, cioè sottratte, rubate, violentemente prese a quegli organismi che le tutelano e le difendono con ferocia proprio perché consci della loro grande importanza. Quanto è invece più facile leggere semplicemente il giornale e apprendere che il giorno tale, nel tale paese, c’è la tale manifestazione. Si fa prima, si corre allora all’appuntamento, qualcosa a metà tra gita in campagna ed esercitazione sado-masochista per ragazzi muscolosi, incerti tra l’essere boy-scout o hooligan. In alcuni paesi, come l’Inghilterra, a esempio, queste occasioni sono momenti molto ricercati per dare sfogo a quello che potrebbe essere definito lo sport nazionale più recente e praticato, cioè fare a botte con la polizia. Questa mentalità è equamente condivisa anche dai cop inglesi, armati quasi sempre solo di pesanti randelli di caucciù, i quali reagiscono con furiosi ma, in fondo, abbastanza corretti, corpo a corpo agli assalti condotti dal movimento inglese con spirito sportivo tipicamente anglosassone.
Ecco, non diciamo che non si verificano anche altre cose, o che non esiste anche un’altra mentalità, e ciò sia altrove che nella stessa Gran Bretagna, diciamo che la prima mentalità è decisamente prevalente.
Comunque, qualora queste manifestazioni di massa dovessero risultare poco appetibili se condotte nei confronti dei centri effettivi delle decisioni di potere, o essere considerate cose troppo pericolose (quei centri sono sempre protetti e con sistemi e metodi molto più brutali e immediati di quanto non accada nelle occasioni delle grandi assise del potere dove la protezione è in massima parte fatta per colpire l’immaginazione delle grandi masse), allora si può sempre ripiegare sulle azioni minoritarie, propedeutiche o meno a eventuali future azioni di massa. Considerare questa decisione uno sganciamento dalle masse, una classica fuga in avanti, ci pare veramente eccessivo. La realtà sta davanti al naso di tutti, occorre saperla cogliere attraverso le opportune documentazioni, questo è certamente difficile, ma non è impossibile. Dal momento in cui queste documentazioni si possiedono sorge il problema se decidersi per un coinvolgimento di massa nell’azione di disturbo, o di attacco, o distruttiva, o semplicemente di denuncia – qui non facciamo questioni in questo senso – in caso contrario resta sempre la possibilità di un’azione minoritaria.
Una volta si affrontava il problema del vecchio rapporto – tipico anni ’70 – tra la situazione dei paesi più diseredati, sottosviluppati e in miseria, e le grandi metropoli dove si intendeva scatenare una lotta di sostegno a opera del movimento e del (possibile) proletariato metropolitano. Allora si pensava di “trasportare” il “terzo mondo” nelle metropoli. Non è questo il luogo per accennare alle lunghe e tragiche conseguenze di questo “guevarismo” di rimessa che per fortuna è cessato. Solo che, messo in cantina, a chiare lettere – nel senso di affermare apertamente, anche da parte dei sostenitori di ieri, che non lo si vuole più – non si è sentito il bisogno di proporre qualcosa di diverso. In sostanza si è detto: quello che si faceva una volta era praticamente un’illusione, non è andato avanti, anzi è stato una delle cause del fallimento delle grandi organizzazioni chiuse di carattere armato, come a esempio RAF o BR, non bisogna più fare in questo modo. Ma qual è l’alternativa che viene indicata? Nessuna in senso specifico. Non è stato seriamente approfondito il problema del rapporto tra lotte nelle metropoli, o comunque nei paesi avanzati, e situazioni dei paesi più poveri, sottosviluppati, terzomondisti, ecc.
Internazionalismo va bene. Ma quale? Quello delle vecchie “brigate” che prendevano armi e bagagli e si trasferivano nei paesi dove era in corso una lotta più avanzata fra le classi, per dare il loro contributo in senso rivoluzionario? Oppure quello del guevarismo di rimessa? Oppure quello del sostegno platonico fondato sulla denuncia e sul dissenso? Oppure il boicottaggio, il sabotaggio, l’attacco diretto contro gli interessi periferici del capitale internazionale nelle sue forme più coinvolte in questa o quella zona del mondo che si pone alla nostra attenzione? Una risposta non è facile. Se non altro sul piano dei possibili effetti.
Prendiamo il caso del Sudafrica [1988], di Israele, del dominio inglese in Irlanda del Nord o di quello spagnolo nei paesi Baschi. Prendiamo il caso della Francia in Corsica o in Nuova Caledonia, dell’URSS nei vari paesi satelliti e così via. Il capitale internazionale è interessato a queste situazioni. Non solo la Shell in Sudafrica, ma gli interessi ebraici negli USA o quelli dei grandi paesi industriali nelle recenti prospettive gorbacioviane in URSS. Attaccare è sempre possibile, ma come evitare che l’attacco medesimo si trasformi in platonico dissenso, per cui si finisce per non vedere la differenza tra l’effettiva distruzione di certi interessi, sia pure periferici, e la manifestazione di un’opinione discordante? Il problema non è affatto semplice.
Dobbiamo qui dare per scontata la capacità di tanti compagni di capire che la strada delle grandi manifestazioni di massa, a livello più o meno d’opinione, è ormai bloccata. Montalto di Castro e Comiso, sono finiti, perché è finita un’era del capitale e delle sue capacità di risistemare il dominio. Ciò comporta la necessità di rivedere le strategie di una crescita quantitativa che se era accettabile, se non altro in termini di illusione ideologica, per gli schieramenti che si richiamavano al pensiero marxista (più o meno rivisitato), era certo contraddittoria per gli anarchici. Si possono ripresentare “occasioni” di lotta di massa, occasioni che occorrerà sfruttare per condurle verso uno sbocco più o meno coscientemente insurrezionale, ma non possiamo pensare ancora di impostare, a priori, un lavoro nella sola ottica di uno sbocco del genere. Se questo si presenterà, forse, lo sapremo sfruttare, ma la realtà sta andando verso altre forme di ristrutturazione e quindi “pretende” altre forme di intervento rivoluzionario.
Pensiamo che queste forme non siano tanto “nuove” nella loro fattispecie esteriore, quanto lo sono nella prospettiva in cui vogliamo usarle. A esempio, la condanna a priori di interventi minoritari, ritenuti troppo “avanguardistici” ci sembra un luogo comune della più tarda retorica del rivoluzionarismo di massa. Andava bene, impostata in questi termini, in epoche in cui ci si illudeva di potere smuovere, in tempi brevi, le grandi masse, sul modello in base al quale queste venivano mosse dai partiti della sinistra e dai sindacati in vista di obiettivi diversi. Ci si illuse, in un’epoca non remota ma che adesso pare mille anni lontana, che bastava modificare le motivazioni perché la gente si muovesse come fatto ineluttabile, quasi deterministicamente necessario. Oggi bisogna intendersi. Dobbiamo muoverci, ora, non domani, quando saranno cambiate le prospettive del movimento, e anche il capitale avrà aggiustato i termini della sua azione. E muoversi oggi significa attaccare. Quello che manca non sono tanto le “masse”, quanto le documentazioni. In questo senso, riteniamo, si debba lavorare ancora molto.
[Pubblicato su “Anarchismo” n. 21, dicembre 1988, pp. 1-4 col titolo “Internazionalismo pratico. Alcune tesi”]
Lavoro
L’immaginario rivoluzionario di un secolo, fino agli anni Settanta, dal mio punto di vista, si è sviluppato attorno a un concetto di organizzazione spontanea, che era più o meno questo: esisteva il nemico, che era l’organizzazione politica statale e capitalista, distruggendo il quale questa organizzazione spontanea si sviluppava, si autorganizzava, e la rivoluzione era proprio questo.
Ovviamente, c’erano le varie differenze di interpretazioni e le varie tendenze politiche, anche all’interno del movimento anarchico, c’era chi parlava della democrazia diretta con la quale si poteva organizzare questa società, chi propugnava il sindacalismo come strumento organizzativo, chi lo criticava, ma comunque il lavoro era il perno. Era infatti dal lavoro che si riorganizzava l’intera società, o meglio l’organizzazione spontanea della società, come totalità che si poteva autoprodurre e costruire, una volta tagliata fuori quella parte individuata come nemica, cioè la struttura politica capitalistica. Secondo me, oggi, questo stesso immaginario viene meno.
Innanzitutto il discorso del lavoro, che è un discorso che richiederebbe molto tempo. Il lavoro non può più essere considerato il perno dell’organizzazione spontanea della società. Per esempio: distruggere il mondo capitalistico e mantenere in piedi la produzione che c’è oggi non ha assolutamente senso. E questo è soltanto un aspetto. Le organizzazioni del capitale, oggi, a livello delle grosse formazioni produttive, formano qualcosa di diverso di quello che costituivano negli anni Settanta. Difatti il discorso, per esempio, del municipalismo, che è un erede, diciamo, di quell’immaginario rivoluzionario, si basa su un altro punto che è la collettività (che è in fondo il suo punto di maggiore significatività). Se esistono nuove possibilità tecnologiche per realizzare nuove forme di partecipazione, il municipalismo non va al di là di quello che lo stesso sistema sta attrezzando per rafforzare il proprio potere, quindi si tratta di un immaginario che non è più rivoluzionario, diventa, addirittura, una “avanguardia” rispetto alle progettazioni che il sistema sta attuando.
Quello che chiedevo prima era: come si possono individuare e quali sono le forme attuali dell’ordine spontaneo della società, le forme spontanee della vita nell’attuale società? Tenendo presente quell’altro aspetto della società degli inclusi e degli esclusi, e il fatto che questa società impoverisce sempre più la vita degli esclusi, e l’impoverisce a partire proprio dalle capacità di immaginare una vita diversa e in fondo migliore.
[Parte del dibattito seguito alla Conferenza dal titolo “Anarchismo e democrazia” da me tenuta a Bologna il 16 marzo 1995 presso la Facoltà di lettere e filosofia. Trascrizione della registrazione su nastro]
Rose Fitzgerald Kennedy
Un simbolo della fede, del coraggio e del patriottismo.
Rose Fitzgerald Kennedy è morta a 104 anni di età. Da più di dieci, un rudere su di una sedia a rotelle. Per molti americani ha costituito il simbolo della madre che sopporta tutti i dolori per il bene dei suoi figli, nella realtà era una solerte collaboratrice della morte. Educando i suoi figli alla competizione e al dominio, semina dappertutto orrori e disgrazie. Il primo figlio maschio Joseph accetta in aviazione di provare una specie di superbomba e finisce ammazzato (era stato il solo a presentarsi); John diventa presidente e viene ucciso, il fratello Bob viene allora spinto dalla dolce Rose a succedergli e viene ucciso anche lui. La prima figlia, Kathleen, tenta di fuggire alla dittatura materna ma non ha vita facile: un incidente aereo risolve i suoi problemi; la seconda figlia, Rosemary, con qualche problema psichico, viene fatta lobotomizzare sotto anestesia parziale su espressa richiesta della dolce Rose, diventando un vegetale. Se a questo si aggiunge il collaborazionismo con i nazisti del marito Joseph, inviato da Roosevelt come ambasciatore a Londra per ringraziarlo del sovvenzionamento della propria campagna elettorale, e l’ammirazione per Hitler del primogenito Joseph, noto antisemita, il quadro è completo.
La triste storia di Rose e del suo sogno americano è tutta qui.
[Pubblicato su “Canenero” n. 13, 3 febbraio 1995, p. 11]
Henri Laborit
Solo per denaro.
Henri Laborit, scienziato (a suo dire) anarchico, è morto a Parigi qualche giorno fa. Neurologo e biologo, si laurea presso la scuola navale di Bordeaux. Chirurgo militare, fa parte del contingente inviato in Nord-Africa nell’ultima grande guerra. Tornato a Parigi intraprende gli studi di farmacologia che lo portano al brevetto della clorpromazina, il primo tranquillante che sfruttato a livello industriale negli U.S.A., lo arricchisce in breve tempo. Si interessa di studi sull’ibernazione e anche di ricerca sul comportamento sociale. Partecipa alla sceneggiatura (e compare fra gli interpreti) del film Mon oncle d’Amerique, dove vengono sviluppate le sue tesi riassunte poi nel libro Elogio della fuga, che ha riscosso applausi in un certo ambiente anarchico, anche di casa nostra. Tutto nella vita dipende da livelli di organizzazione, sostiene la sua teoria, anche a livello cosmico. Per tutta la sua vita scandalizza gli assopiti spiriti dei francesi con dichiarazioni irridenti e battute scherzose. Anche molti anarchici che da sempre aspettano il frutto maturo della scienza cadere nella loro bocca aperta, sono rimasti per anni in adorazione delle sue battute umoristiche travestite da teorie scientifiche. Tutto questo ora è finito.
Era tempo.
[Pubblicato su “Canenero” n. 28, 26 maggio 1995, p. 11]
Lavorare quanto?
Meno. Questo è il primo punto su cui si sono incontrati padroni e sindacati. Gli operai, è ovvio, anche loro sono d’accordo. Ma una riduzione del lavoro significa, oggi più che mai, una soluzione indiretta del problema occupazionale. Infatti, a una riduzione delle ore di lavoro, poniamo a 32 settimanali, corrisponde una riduzione del salario (diciamo per la metà del costo aziendale) e per l’altra metà il recupero attraverso gli oneri sociali. Ma chi paga questo recupero? Evidentemente gli strati più deboli, attraverso il progressivo indebitamento dello Stato e l’aumento del costo della vita. Così, il lavoratore non risolve il suo problema: i costi individuali più elevati non sono difatti quelli del puro e semplice lavoro/fatica, ma in massima parte quelli dello spostamento casa/lavoro, cosa questa che resta intatta anche di fronte a una riduzione parziale di orario di lavoro. È il lavorare niente, che minaccerebbe veramente la situazione sociale nel suo complesso. Ma qui entriamo nel campo dell’indicibile.
[Pubblicato su “Canenero” n. 13, 3 febbraio 1995, p. 7]
Liala
Tutto lo zucchero di un’epoca di fiele.
Liala, mitica scrittrice di romanzi “rosa”, è morta a Varese all’età di 98 anni. Il suo vero nome non interessa, sebbene nella famiglia, di antica nobiltà, si rintraccino un papa, un industriale e non pochi comandanti d’armata. Nobile e isolata, con gli amori e i tormenti specifici delle pargole di famiglie del genere, ormai scomparse con le ultime giravolte acrobatiche del Barone Rosso, Liala deve il proprio nome d’arte a D’Annunzio che volle così fissare per sempre il ricordo dell’“ala” traditrice che scaraventa nelle acque di un lago il velivolo su cui si trovava l’uomo da lei amato. Per decenni, la donne italiane si nutrono dei sdilinguimenti contenuti nei romanzi di Liala, mentre su di loro passano gli anni infuocati del fascismo, la seconda guerra mondiale e i drammi degli ultimi decenni, mentre l’esile e rossochiomata marchesa continuava a vergare pagine su pagine.
Una droga come un’altra.
[Pubblicato su “Canenero” n. 23, 14 aprile 1995, p. 11]
Liberazione nazionale
Tra i più contrastati principi della lotta anarchica si trova quello che individua nella dimensione nazionale la possibilità – sia pure circoscritta – di sviluppare un intervento rivoluzionario.
Le paure e le incomprensioni, in merito a questo problema, sono sempre state tantissime.
Si è detto che l’anarchismo è internazionalista quindi non si vede perché si debba preoccupare di faccende relative alle singole realtà nazionali. Poi si è aggiunto che lo scontro di classe pone sullo stesso piano tutti i proletari contro gli sfruttatori, quindi non è possibile ritagliare una parte della guerra sociale restringendola all’interno del territorio di una singola nazione. Poi si sono elencati i pericoli, così come sono emersi nelle diverse situazioni storiche, di una involuzione, di trasformazioni della lotta di liberazione nazionale in un novello e florido nazionalismo, o, per un altro verso, i pericoli relativi a una considerazione privilegiata che viene spontaneo dare alla borghesia nazionale nei confronti delle borghesie straniere. E altri ancora argomenti di critica e di discussione, per la verità, non sempre serena e approfondita.
Molti compagni, su questo spinoso problema, non sono sufficientemente preparati, quindi esprimono giudizi in base a loro preconcetti e non in base a valutazioni dei limiti e delle possibilità di una lotta per la liberazione nazionale condotta da anarchici e impostata su princìpi antiautoritari.
In pratica non si vede perché, ammettendo che non è pensabile lo scoppio della rivoluzione in tutte le realtà sociali del pianeta e nello stesso tempo, non sia ipotizzabile lo scoppio o, comunque, l’approssimarsi degli eventi rivoluzionari in un dato posto. Ora, se questa ipotesi, come appare, è abbastanza ragionevole, si deve per forza ammettere che, valutando attraverso una corretta analisi anarchica, quali sono i punti di maggiore tensione, si possa intervenire in un modo organizzato e strategicamente chiaro.
Esistono nel mondo situazioni di tensione rivoluzionaria aventi in prevalenza contraddizioni di tipo nazionale. Perché mai gli anarchici dovrebbero restarne fuori? Forse perché l’esperienza recente ci ha fatto vedere che queste situazioni hanno spesso sbocchi reazionari? Forse perché in quasi tutte queste situazioni dominano le posizioni marxiste? Non sono due buoni argomenti. Al primo si può rispondere che non esiste una situazione che garantisce a priori uno sbocco rivoluzionario o soltanto progressista, ma che questo sbocco diventa più facile ad attuarsi proprio grazie alla presenza degli anarchici nella loro lotta. Al secondo argomento si può rispondere dicendo che il rapporto tra marxismo e lotte di liberazione nazionale, spurio e contraddittorio in sede teorica, viste le condanne in tal senso dei padri della chiesa marxista, è, allo stato attuale delle cose, soltanto strumentale. Cioè i popoli in lotta hanno adottato – specie quelli del terzo mondo africano o latino-americano – alcuni elementi marxisti non avendo altro a disposizione. E questa, non è forse una colpa degli anarchici?
Quindi siamo per un intervento nelle diverse lotte di liberazione nazionale. Non solo per un generico intervento di solidarietà, o, peggio ancora, un intervento che si traduca sistematicamente in una serie di distinguo politici, ma siamo per un intervento attivo.
Per intervento attivo intendiamo non soltanto la “reale” solidarietà internazionale, che consiste nell’attacco ai nemici comuni; ma anche un intervento fondato su analisi e su proposte organizzative.
[Pubblicato su “Anarchismo” n. 52, maggio 1986, p. 29 col titolo “Fuori dagli equivoci della lotta di liberazione nazionale”]
Enrique Lister
Una questione di pochezza morale.
Enrique Lister, il massacratore delle comuni anarchiche spagnole del ’36, è morto all’ospedale Jimenez Diaz di Madrid per una emorragia cerebrale. Dopo un periodo di addestramento, pratico e ideologico, nel 1933 in URSS, ritornò in Spagna partecipando alla guerra civile come comandante del 5° reggimento, distintosi particolarmente nel controllo prima e nella distruzione poi di tutte le iniziative anarchiche, sia all’interno stesso dell’esercito repubblicano, sia nelle nuove forme di organizzazione economica e sociale basate sulle comuni. Naturalizzato cittadino sovietico divenne generale dell’Armata rossa e uno dei comandanti degli eserciti in Polonia e in Jugoslavia. Tornato in Spagna nel l977 vi fondò il Partito comunista operaio spagnolo, di nessun successo elettorale. Di un lacché stalinista come lui, di un traditore delle lotte proletarie spagnole, sarebbe tanto facile parlare da correre il rischio di sparare non sul carro funebre, ma sulla croce rossa. Non lo facciamo. Il nome di Lister, in fondo, parla da solo, e racconta una lunga e tragica storia di nefandezze. Tutto qui.
[Pubblicato su “Canenero” n. 8, 16 dicembre 1994, p. 11]
Lotta insurrezionale
A parte alcune frange non molto significative, il movimento anarchico internazionale ha posizioni teoriche di carattere rivoluzionario. Le venature liberali e socialdemocratiche riguardano accenni che, se pure sono importanti in quanto fanno vedere una possibile linea di involuzione, restano comunque ai margini.
La quasi totalità delle posizioni rivoluzionarie anarchiche, con sfumature diverse, ammettono l’insurrezione come fase necessaria del percorso rivoluzionario.
Ma questa insurrezione è vista come un sommovimento di masse a causa di determinate forze economico-sociali che servono da scatenamento. Il ruolo dell’organizzazione anarchica si dovrebbe limitare a cogliere queste condizioni e queste contraddizioni sia economiche che sociali per farle meglio capire alle masse. Insomma un ruolo di propaganda e di controinformazione.
Spesso, anche compagni anarchici che sono per la lotta violenta e senza mezzi termini contro le strutture dell’oppressione, si limitano a questa parte dell’analisi e non si ritengono in dovere di andare avanti. Le masse – essi dicono – devono poi fare tutto da sole, in quanto sarebbe autoritario un comportamento diverso da parte dell’organizzazione specifica anarchica e porterebbe a risultati disastrosi.
Penso che questa sia la visione insurrezionalista che andava bene quando la quasi totalità del movimento anarchico era su posizioni di sintesi, cioè collocata nell’ottica delle grandi (o meno grandi) organizzazioni quantitative che, attraverso lo strumento delle organizzazioni sindacali, si prefiggevano di riassumere l’insieme delle lotte sociali ed economiche in attesa dello scatenamento oggettivo della situazione rivoluzionaria.
A mio parere c’è un modo diverso di concepire la lotta rivoluzionaria in chiave insurrezionalista. Penso che l’organizzazione anarchica, purché informale, possa contribuire alla costituzione di nuclei autonomi di base i quali, in quanto organismi di massa, possano programmarsi attacchi contro strutture della repressione sociale, economica e militare come contro le strutture del reperimento del consenso. Questi attacchi, anche se parziali e circoscritti hanno tutti le caratteristiche metodologiche e pratiche dei fenomeni insurrezionali. Solo che non sono lasciati alle forze cieche dei conflitti sociali ed economici, ma possono essere ricondotti all’interno di una progettualità anarchica basata sui princìpi dell’autonomia, dell’attacco diretto e costante e del rifiuto di ogni compromesso.
[Pubblicato su “Anarchismo” n. 52, maggio 1986, p. 31 col titolo “Brevi chiarimenti sul nostro modo di impostare la lotta insurrezionale”]
Lord Lovat
Soltanto un miserabile eroe.
Lord Lovat, comandante dei commando inglesi che sbarcarono in Normandia il 6 giugno del 1944, è morto nel suo castello di Beaufort (clan dei Fraser) nel Nord della Scozia. Come ogni massacratore in divisa è coraggiosissimo e non arretra di fronte a nessuna audacia. In questo modo causa decine di migliaia di morti e viene odiato dai suoi uomini alla stregua di uno dei peggiori boia della storia militare inglese. Naturalmente i Capi di Stato lo amano e lo temono. Churchill gli dà le più alte onorificenze dell’epoca. Hitler gli mette 100.000 marchi di taglia sulla testa. Quando i soldati sentono il suono delle sue cornamuse e vedono il suo famoso maglione bianco muoversi in testa alla colonna, si apprestano subito a contare i cadaveri. Di altre imprese intorno al mondo, nel corso delle quali cumuli di cadaveri si sono ammonticchiati un po’ dappertutto a causa dello zelo militaresco di Lord Lovat, non mette conto parlare.
Quando un procuratore della morte come lui crepa, non si può non essere contenti.
[Pubblicato su “Canenero” n. 20, 24 marzo 1995, p. 11]
Ma lavorare stanca
La gente vuole il lavoro, almeno così sembra a vedere “movimenti” di “lotta dura” come quelli di Napoli: bastonate ai poliziotti, cassonetti della spazzatura bruciati, pietre, bottiglie rotte e improperi a non finire. Ma la violenza di certi scontri, da per se stessa, non dice nulla più di quello che si vede: qualche testa rotta, ora di poliziotto, ora di disoccupato, tutto qui. Da quel che sembra, la stessa logica di un lavoro fisso è contraria agli attuali orientamenti dell’economia capitalista. E su questo piano si incontrano perfettamente: da un lato la crescente dequalificazione professionale, dall’altro il bisogno di adattare in maniera flessibile gli addetti alle macchine e alla produzione. Difatti, gli scontri di Napoli erano solo per un briciolo di assistenza sociale, per quei corsi di preparazione professionale che danno un poco di denaro a chi si presenta a chiederlo (spesso con le buone, qualche volta con le cattive).
[Pubblicato su “Canenero” n. 13, 3 febbraio 1995, p. 7]
Mafia
Di Mafia si parla dovunque. Nelle sedi dei Palazzi e nelle piccole stanzette “alternative”. L’accademia è zeppa di ricercatori armati di buona volontà. Carabinieri studiano a fianco di ex sovversivi, mentre il materiale si accatasta diventando, in breve, non solo inutile ma anche funzionale alla confusione.
Proponiamo di dividere i risultati analitici fin qui raggiunti in tre grandi categorie:
1) Le analisi di storno, sono quelle che hanno lo scopo di indirizzare altrove quelle poche forze che per motivi di contraddizione interna allo Stato, vorrebbero fare qualcosa “contro” la Mafia. Vedremo più avanti in che cosa consiste questo “fare” e i limiti dentro cui si circoscrive.
2) Le analisi illustrative, sono destinate a dare, della Mafia, un’immagine di grande forza e compattezza, facendo ancora restare in piedi l’iconografia del passato di una specie di “giustizia” dal basso contrapposta all’ingiustizia dall’alto, un’analisi che sta molto a cuore agli intellettuali siciliani.
3) Le analisi “alternative”, sono denuncie contro il fatto mafioso, spesso anche dettagliate, ma si appellano a una possibilità di lotta che non può intaccare il corpo attivo della Mafia, la sua reale possibilità operativa. Vedremo più avanti perché.
In queste note proponiamo un discorso diverso per i seguenti motivi: a) le analisi, in se stesse, lasciano ormai il tempo che trovano; b) diventa sempre più difficile distinguere tra “Mafia” e Stato; c) occorre fare subito qualcosa che sia realmente contro la Mafia.
Il ruolo dello Stato c’è senz’altro. Cercare di minimizzarlo per non correre il rischio di accorpare tutto nel supremo negativo statale, è uno sbaglio. La Mafia è certo qualcosa di diverso, di specifico, e, come tale, va capita e spiegata, prima di essere affrontata, anche per studiare quali sono i possibili mezzi da impiegare contro di essa. Ma questo studio deve essere costantemente correlato con quello del cambiamento dei processi di gestione del potere statale.
C’è, difatti, una notevole correlazione tra evoluzione del potere mafioso e del potere statale. Non vale, a questo punto, chiedersi se è più dannoso il secondo o il primo. Senza il secondo il primo non ci sarebbe. Senza il primo, il secondo lo inventerebbe.
La Mafia nasce e si sviluppa per vie storiche che non mette conto approfondire qui, ma che tenevano presenti interessi parimenti (e insufficientemente) tutelati dallo Stato. Diventa, quindi, prima di ogni altra cosa, un correttivo statale in funzione della gestione di un potere più razionale (paternalistico) e più efficiente (meno sprechi).
La nascita è quindi di natura correttiva. I gruppi che si formano, anche in America, sono legati insieme per mantenere un potere che altrimenti verrebbe loro strappato di mano dalla logica della produzione. Il funzionamento è il medesimo del modello statale, almeno quello delle origini, cioè quello fondato sulla rapina e la ripartizione delle prede del vinto. Stati certamente “forti”, come quelli dichiaratamente totalitari, a esempio la Germania del Terzo Reich, avevano connotazioni mafiose notevoli sul piano ideologico, su quello dell’amministrazione della cosiddetta giustizia, e su quello della divisione degli utili ai vari livelli della piramide.
Fin dagli inizi, la Mafia utilizza la violenza diretta, come l’omicidio e l’intimidazione, che poi sono la forma di violenza più a buon mercato, per motivi politici e di controllo sociale, oltre che per motivi di riappropriazione di capitali per altro immessi nel medesimo ciclo riproduttivo.
Quando, a esempio, la Mafia americana d’importazione siciliana, si organizza per il controllo della vendita dell’olio d’oliva, non fa altro che imporre sul mercato un prodotto sostituendo la violenza della pubblicità (che deve ancora venire) con quella del più convincente mitra. Solo in un secondo tempo, quando l’accumulazione primitiva consente un allargamento degli investimenti in altri settori, si avrà l’interessamento politico (controllo della polizia, della magistratura, delle cariche amministrative locali, ecc.) per arrivare, più o meno, a una intima collusione tra Mafia e Stato, cioè al mercato del reclutamento politico dei voti. Da questo punto in poi, siamo in piena Mafia moderna.
Vediamo le diverse facce della Mafia. Non ce n’è solo una e non c’è solo la Sicilia, né tanto meno solo Palermo.
Ma differenze ne sussistono diverse. Per quanto non siano molto significative. A esempio, il rapporto tra la camorra e la criminalità polverizzata è di maggior controllo della prima nei riguardi della seconda, di quanto non accada con il controllo della Mafia siciliana che si limita solo a interdire alcune attività (poniamo i sequestri). Per la ‘ndrangheta calabrese, a esempio, si potrebbe notare una maggiore polverizzazione delle strutture organizzative e un coinvolgimento capillare della classe politica locale, anche al di là degli schieramenti di partito.
Comunque, sono differenze che indicano un corpo abbastanza omogeneo, se non a livello di appoggio reciproco o di contatti internazionali, almeno per quello che riguarda la gestione del potere, della ricchezza, del comando.
Ed è anche costante la capacità, di queste diverse facce, di inserirsi nelle varie occasioni che le vicende del capitalismo internazionale offrono. Questa duttilità della Mafia merita una riflessione.
La Mafia è stata sempre in grado di inserirsi all’interno dei traffici internazionali. Non tanto per la sua vasta disponibilità finanziaria, raccattata anche a livello capillare tramite la gestione dell’industria della protezione privata, quanto perché il capitalismo di ogni genere consente spazi notevoli per imprenditori capaci e col gusto del rischio.
Non sappiamo molto sulle varie forme mafiose che agiscono [aprile 1989] nell’Unione Sovietica, come a esempio quella azerbaigiana, ma quando queste notizie si sapranno si vedrà all’opera un meccanismo non molto diverso.
Settori come quello della droga, delle armi, della prostituzione, del gioco, delle scommesse, ecc., consentono una duplicazione dell’intervento di gestione, cioè permettono che si sovrapponga la gestione ufficiale, voluta e garantita dagli Stati, con una gestione “clandestina”, tollerata e, spesso, cointeressante gli Stati medesimi o, almeno, alcune loro componenti politiche.
E la Mafia gestisce direttamente a livello locale queste attività e, quando il caso lo impone, a livello internazionale fissa accordi e firma trattati di collaborazione.
Ora, siccome la velocità di circolazione monetaria, in base a una notissima legge economica, aumenta la quantità di moneta, ne deriva che un giro d’affari con riproduzione del capitale investito ad altissima velocità, com’è quello della droga, consente un’agilità di movimento e una capacità di investimento senza precedenti.
Ciò non può restare senza conseguenze.
L’entrata nel mercato della droga ha modificato profondamente la struttura delle organizzazioni mafiose.
Una maggiore possibilità di guadagno, immediato e altissimo, a livello della base della piramide, ha portato molti piccoli e subordinati esecutori di ordini ad avere una grande autonomia. Ciò li ha spinti, specialmente i più giovani e inesperti, verso la tentazione di “mettersi in proprio”, spesso senza rispettare patti e anzianità, senza stare tanto a perdere tempo e così via. Da ciò azioni, come quelle delle vendette trasversali, su bambini e donne, che le generazioni precedenti non avrebbero mai pensato o permesso.
Si è avuto così un appiattimento della piramide, con una ridotta capacità gestionale di quella che impropriamente viene definita cupola, se si tiene conto del numero delle azioni, del giro d’affari e del quantitativo di persone coinvolte nelle attività non controllate.
Addirittura si è arrivati a una specie di ricatto commerciale imposto dalla base verso il vertice, il quale ultimo, pur controllando le fonti di produzione a livello internazionale, non è più in grado di controllare i singoli mercati di sbocco, almeno in forma capillare.
Da qui spaccature e guerre interne. Sanguinose come non mai e pericolose per l’equilibrio degli stessi Stati, oltre che per gli interessi dei politici direttamente coinvolti.
Vediamo la guerra nella guerra. Le organizzazioni più forti, come abbiamo visto, subiscono sì il ricatto della distribuzione ma non temono confronti nell’approvvigionamento alle fonti e neppure nella collocazione, sul piano internazionale, dei grandi capitali ricavati.
Tutti i tentativi di superare il controllo delle fonti si traducono subito in stroncature delle iniziative che provengono dalla piccola manovalanza. Queste stroncature sono a volte iniziativa dello stesso vertice mafioso, a volte vengono stimolati interventi degli strumenti repressivi dello Stato.
Nel settore, invece, degli investimenti internazionali, più in alto si sale, più i capitali si purificano, fino a diventare investimenti inattaccabili. Il traffico internazionale delle armi, in cui lo Stato ha il suo evidente interesse di produzione, viene alimentato dai proventi del mercato della droga. Per questo motivo, a esempio, in Stati come la Gran Bretagna, con prevalenti interessi di sviluppo dell’industria delle armi, la lotta alla droga, se non altro in termini di efficienza spettacolare (non certo di risultati concreti), è più attutita che altrove. Lo stesso dicasi per gli USA che bilanciano attentamente i propri interventi contro i centri di produzione internazionali, senza intaccare però le grandi vie di smistamento e i grandi produttori i quali sono i medesimi che gestiscono alcuni fra i più importanti sbocchi del mercato delle armi.
Le perturbazioni politiche. Comunque, l’appiattimento della piramide mafiosa, o il suo ulteriore sbriciolamento per quanto riguarda altre strutture parallele, tipiche di altre condizioni geosociali, ha causato alcuni perturbamenti di natura politica, i quali illustrano meglio il rapporto intrinseco tra Mafia e Stato.
Il mercato dei voti si è modificato. Spostamenti nell’ordine di centinaia di migliaia di voti si sono verificati nel giro di pochi anni. La Mafia catanese, a esempio, della CISL, legata a Scalia, si è sbriciolata sotto l’incalzare della guerra per bande (vincenti e perdenti) che nei primi anni Ottanta ha causato quasi 800 morti in questa sola città. Anche il reclutamento palermitano gestito dal vice di Andreotti in quella zona, Salvo Lima, ha avuto smottamenti notevoli a favore del PCI che sta recuperando con le cooperative le quali hanno una loro serie di rapporti, sempre di natura mafiosa, con strutture più piccole e spesso polverizzate. Qualcosa di simile è accaduto nel trapanese con le cooperative di viticoltori del PSI.
Se poi si considerano i due imperi, orientale e occidentale, costruiti in Sicilia nel settore dell’edilizia di grande scala (aeroporti, autostrade, ponti, dighe, ecc., in tutto il mondo), si capisce come la Mafia di vertice recuperi i tentativi di gestione in proprio provenienti dal basso. Tutti i perturbamenti causati da queste intenzioni imprenditoriali della violenza, vengono spenti con la violenza (mafiosa o statale) e vengono poi riassunti a un livello più alto, cioè utilizzati come mezzo di pressione per rivendere la vecchia merce della protezione.
I tentativi recenti di sponsorizzare, a tutti i livelli, una lotta contro la Mafia, devono essere letti anche attraverso questa nuova condizione. Lo schema di intervento non si libera di un luogo comune obbligato. A esempio, nel campo della droga, si tengono d’occhio i risultati terminali, il dilagare dei tossici, i pericoli delle infezioni, le violenze indotte (rapine, furti, stupri, ecc.), ma non si tiene d’occhio l’evolversi del fenomeno. La gestione del flusso dei rifornimenti è affidata a persone che non vengono toccate da questi provvedimenti. Si colpiscono, di tanto in tanto, gli intermediari, facendo così proprio il gioco del vertice mafioso, il quale trae profitto dagli ostacoli che lo Stato pone ai facili arricchimenti della base, e lo trae trasformandolo, questo profitto, in migliore capacità di gestione imprenditoriale, sia nello stesso posto che in tutti gli altri Stati.
La contrattazione dei voti può quindi porsi in modo diverso. Il flusso viene garantito verso i partiti che sanno fare una intelligente politica contro il livello (intermedio) delle strutture mafiose, una politica che sia ora repressiva e ora un po’ tollerante, ora imponga un inasprimento delle pene, ora elargisca condoni e amnistie. E questo lavoro di fino non lo può fare solo la DC, ma anche il PCI e, principalmente, il PSI. Ciò spiega il ricco approvvigionamento di voti che quest’ultimo partito ha avuto alla fine degli anni Ottanta nel Sud e, principalmente, nel Nord.
Lo Stato ha quindi, da sempre, coabitato con la mentalità e con la pratica mafiosa.
Lo ha fatto perché il potere, nei vari aspetti in cui si consolida, ha sempre una faccia che si ripresenta nella continua mutazione: quella della violenza cieca e del controllo oppressivo.
Adesso, con l’evolversi delle cose, questa coabitazione si avvia verso nuovi lidi. Innanzi tutto a livello decisionale. Nella magistratura, nella polizia, nei carabinieri, nei servizi segreti, oltre che, come è evidente, nelle istituzioni parlamentari, vi sono uomini controllati, voluti o condizionati, direttamente o indirettamente, dalla Mafia. Presidenti di tribunali, generali, questori, prefetti, sindaci sono mafiosi essi stessi o legati a interessi mafiosi. Ciò garantisce un controllo di quegli elementi che per una loro ritrosìa personale, per onestà individuale, o semplicemente per paura, evitano di mettere le mani in pasta. Il controllo indiretto, di questo tipo, è sempre esistito ed è il più efficace, l’omicidio, l’intimidazione diretta, il sopruso simbolico e immediato, sono le armi terminali, le meno efficaci e più costose, che vengono usate solo come estremi rimedi.
Come qualsiasi gruppo di pressione, la Mafia esercita un potere effettivo sul potere dello Stato e ne condiziona la politica. Certo, questo condizionamento non può prevaricare del tutto le necessità della gestione “democratica” di un paese come l’Italia, che ha necessità sue, come quelle dei grandi Stati industriali avanzati, ma è una componente da tenere presente. Questo condizionamento ha costi sociali incalcolabili, determinati da ritardi e persistenze di danni che non sarebbero pensabili in situazioni diverse.
D’altro canto, il reperimento del consenso è un fatto di rielaborazione ideologica di realtà oggettive, ma è anche un fatto di gestione delle clientele e queste ultime, strumenti di potenza in se stesse, non sono esenti da interessi di parte. Per quanto possa crescere il livello di autonomia finanziaria della Mafia, questo non potrà mai raggiungere la forza di farla dichiarare non più d’accordo a mantenere una coabitazione con le forze politiche, coabitazione che comunque risulta ancora oggi lucrosa.
La coabitazione economica. Merita una breve riflessione il presupposto, avanzato da una certa parte della cosiddetta sinistra pensante, che uno sviluppo economico possa realmente creare condizioni di mercato talmente favorevoli da nientificare l’azione della Mafia, se non altro nelle aree dove questa insiste con l’offerta di protezione.
Contro questa tesi ci sono da fare alcune considerazioni. Prima di tutto il mercato, per quanto possa ingrossare, e questa è una legge del capitalismo, avrà sempre condizioni produttive periferiche, sulle quali potrà agire la proposta mafiosa. Secondo, non è vero che oggi, nelle condizioni poniamo di arretratezza del meridione italiano, non vi siano realtà produttive di alto livello e molto remunerative, le quali sono lo stesso sotto il controllo “protettivo” mafioso se non, a volte, sotto la stessa gestione mafiosa. Uno sviluppo in termini crudamente capitalisti della realtà meridionale comporterebbe un rafforzamento delle capacità economiche, e quindi anche politiche, delle strutture mafiose attuali. Non il suo contrario.
E l’esperienza passata dei poli industriali conferma questa riflessione. Allora, la Mafia intervenne nel momento di gestire l’utilizzo dei terreni, così come intervenne per la costruzione delle infrastrutture (basti pensare all’aeroporto palermitano di Punta Raisi e alla decisione “criminale” che lo scelse), ma si astenne poi dall’intervenire nella produzione vera e propria di situazioni economiche che apparivano condannate fin dal loro nascere. Al contrario, invece, la Mafia persistette accanitamente negli interventi collaterali, diretti a mungere quanto possibile dalle produzioni indotte, spegnendo quelle sia pur piccole possibilità che si mettesse in moto il meccanismo di sviluppo che quei giganti nel deserto pretendevano realizzare.
Le joint venture dell’epoca non si possono certo paragonare con quelle di oggi, ma anche allora le cose andavano bene per gli intrallazzatori politici nazionali e internazionali. Sulla fine di Mattei non è mai stata fatta chiarezza e non c’entrano solo gli interessi algerini e francesi, ma anche quelli più specificamente mafiosi.
Per capire il movimento nazionale di Sindona occorrono conoscenze di finanza internazionale, come pure per capire perché lo Stato lascia tranquillamente uccidere Moro, ma muove mari e monti per salvare Cirillo. Pensate cosa succederebbe se rapissero Lima [successivamente alla stesura di questo scritto, Lima verrà ucciso. Nota del 1999.]. Andreotti in persona scenderebbe giù per pagare il riscatto.
I carrieristi dell’antimafia. Che l’essere contro la mafia costituisca una moda è un fatto innegabile. Costa poco – almeno costa poco esserlo a parole – e frutta abbastanza. Carriere, verginità politiche e perfino fortune economiche, si sono costruite in questo modo. Il “contrario” alla mafia “vecchia maniera”, poniamo un Pantaleone o uno Sciascia, era in genere un intellettuale medio, poco organico a un potere disorganico per eccellenza, ammiratore sotterraneo dei picciotti intraprendenti e coraggiosi, e denigratore critico ufficiale. Non c’è pagina, si può dire, di Sciascia, ma anche dello stesso Pantaleone, che non sottolinei i valori tradizionali del rispetto, dell’omertà e della giustizia mafiosi, valori traditi dalla “nuova” mafia. Insomma, la tesi che poi verrà sposata, in chiave di collaborazione con le polizie, da Buscetta e soci.
Il nuovo “contrario” alla mafia è in genere un carrierista politico (e, per quello che oggi vale, può anche essere professore universitario), magistrato, giornalista, studioso di “nienterie” varie, raccoglitore di interviste e intervistato egli pure. È, in fondo, una brava persona, che si arrampica come può anche lui, e tira a prendere lo stipendio.
Spesso, a certi livelli, corre anche dei rischi e, quando si perturbano equilibri che a lui sfuggono, perché non controllabili a media e bassa levatura, finisce anche sotto le ruote dell’ingranaggio e ci lascia la pelle. Molte di queste morti onorate sono troppo variegate di motivi per essere causate nettamente da decisioni mafiose, comunque vanno annoverate nel cumulo complessivo delle vittime della Mafia. Per altro, non sposta nulla un computo diverso. I mafiosi veri non si impressionano per così poco e non battono ciglio (quasi sempre) davanti alle chiacchiere.
Lo Stato dà anche una risposta militare e su questa ci costruisce la sua bella pubblicità. Gente come il generalissimo ucciso a Palermo, o il neo commissario contro la Mafia, Sica, evidente candidato come futuro cadavere eccellente, o il giudice Falcone, anche lui in odore di prossima santità [puntualmente ucciso dopo la stesura di questo scritto. Nota del 1999.], sono i depositari di una risposta apparente che si autonega fin dall’inizio. Fanno quindi bene i defezionisti intelligenti che al minimo segno di intorpidimento delle acque, voltano gabbana e mandano a quel paese lo Stato e il suo preteso atteggiamento virile.
Fare esercitare l’esercito sull’Aspromonte è stata la dimostrazione più plateale ed evidente dell’inefficienza non solo del nostro apparato militare, e questa è una buona cosa che tutti sapevamo, ma della assoluta mancanza di intenzioni serie per combattere una guerra.
Circa trent’anni fa, quando si propose in Parlamento un impegno più serio contro il banditismo sardo, vi fu chi suggerì di bruciare tutti i boschi della Sardegna per fare uscire i pastori, cioè il sostrato su cui si basava e si basa l’attività dei sequestratosi sardi. Da un punto di vista militare quella proposta aveva quel tanto di barbaro e di radicale che contraddistingue tutte le iniziative militari serie e venne, ovviamente, accantonata perché non c’erano le condizioni politiche e sociali per realizzarla. Oggi queste condizioni non ci sono nemmeno, quindi fare sfilare le divisioni in montagna è un’esercitazione come un’altra, solo costosa per il bilancio dello Stato. In compenso quest’anno [1989] si è evitato di fare sfilare le stesse divisioni in via dei Fori imperiali a Roma.
Quindi, non solo inefficienza tecnica, ma, principalmente, non adeguatezza all’attuale situazione politica e sociale, quindi impossibilità oggettiva di usare quello strumento, con tutti i limiti e le impreparazioni che comporta.
La risposta della Chiesa. Nel coro generale delle banalità etiche fatte scendere in campo per confortare la gente, quelle dei preti sono di gran lunga le più esilaranti. Non siamo più ai tempi di Ruffini, cardinale legato direttamente a interessi mafiosi, il quale si rifiutava sistematicamente anche di prendere in considerazione il problema, ma siamo in tempi in cui si è capito che il modo migliore per ovviare (e quindi negare) il problema è proprio quello di parlarne. E la Chiesa ne parla. Dal pulpito vengono indirizzate esortazioni di buon comportamento ai mafiosi i quali, da parte loro, sono maestri di buon comportamento. Infatti, questi hanno un loro codice morale molto stretto che, per alcune cose, è addirittura più stretto, più tradizionalista e più rispettoso dei tabù sociali e religiosi, della stessa Chiesa.
In fondo, la Mafia, sotto certi aspetti, si riconosce nella Chiesa e nella mentalità che specialmente i vertici di quest’ultima portano avanti. Gli affari che la Chiesa ha fatto con la Mafia sono vasti, Marcinkus insegna. E, al contrario, non per nulla un personaggio come Greco si fa chiamare il Papa e assume atteggiamenti ieratici in pieno tribunale.
Da parte sua, la fetta più consistente dei movimenti cristiani pacifisti e riformisti, agganciati alle parti più o meno retrograde dei movimenti di base ecclesiastici o meno, si fa coinvolgere in queste chiacchiere e la tensione etica serve bene come elemento di recupero. In questa prospettiva tali movimenti non si differenziano dall’altro chiacchiericcio di diversa matrice politica.
Nascita, sviluppo e morte di un’opposizione fittizia. Una volta, l’opposizione alla Mafia era circoscritta agli ambiti intellettuali di specialisti che, per l’appunto, erano definiti “meridionalisti”. Ma la maggior parte di loro, quando non aveva sostanziali interessi che li faceva andare decisamente in pratica e meno in teoria a favore del potere mafioso, aveva sempre un sottile affetto per la mentalità paternalista e apparentemente “giusta” del paterfamilias.
Poi vennero gli anni dell’opposizione fittizia del fascismo, che selezionò nella sua prospettiva autarchica e colonialista i mafiosi “buoni” e li separò da quelli “cattivi” che collocò al confino.
Poi fu la volta dei “liberatori” americani che si misero d’accordo prima con i vari Lucky Luciano e soci e facilitarono talmente l’avanzata del generale Patton da farlo arrivare a Messina prima di Montgomery (comandante degli Inglesi) che pure doveva percorrere un tratto di strada di molto minore, meno accidentato e meno difeso (lo sbarco comune, come si ricorderà, avvenne a Gela).
I mafiosi “cattivi” ridivennero “buoni”, cooptarono una parte della mafia vincente, superarono gli scontri anomali, come quello relativo alla banda Giuliano, e impiantarono il potere democristiano nell’isola dopo avere cancellato il tentativo, non riuscito ma significativo, del separatismo.
Con l’avvento del dominio democristiano, parentesi milazziana compresa, non ci fu, in sostanza, nemmeno un’opposizione fittizia alla Mafia. Gli affari si facevano in “santa” pace e con la benedizione del cardinale Ruffini.
Certo, si potrebbe ricordare il numero non piccolo dei sindacalisti uccisi, come, il più conosciuto di tutti, Carnevale, ma il fatto che questi proletari si facessero uccidere in nome di un ideale in base al quale altra gente, meno ingenua di loro, ingrassava a più non posso, non toglie nulla al fatto che quell’opposizione diretta a sensibilizzare le masse per opporle a una gestione mafiosa del potere locale, non si possa definire altrimenti che fittizia.
In un ventennio in cui la gente andava al Nord o all’estero per trovare lavoro, chi voleva un pezzo di pane in Sicilia, doveva dividerlo con la Mafia e non si trattava tanto di organizzare le masse dei lavoratori per condurle in manifestanti imponenti quanto impotenti, ma si trattava di scatenare una guerra civile.
Per la verità, un progetto del genere l’aveva proprio la banda Giuliano, ma venne ben presto fagocitata dalla Mafia e poi fatta cadere, con la complicità di alcuni suoi componenti, nella trappola di Portella della Ginestra. Comunque, con tutti i limiti teorici, che il buon Turiddu aveva, fu senz’altro uno dei pochi che capì la necessità di risolvere il problema della Sicilia con la guerra civile. Ma, vista l’improponibilità, almeno in quel momento, di uno sbocco realmente rivoluzionario, e vista la coabitazione che Giuliano manteneva con elementi del potere locale e nazionale, si può dire che fu un tentativo abortito in partenza, quindi anch’esso da considerare fittizio.
Poi ci sono i movimenti “alternativi” che cercano di coinvolgere la gente in manifestazioni e denunce che non impensieriscono la Mafia in alcun modo. Il fatto che ogni tanto qualcuno dei partecipanti viene ucciso, o è iniziativa di capetti locali, o è compresenza di cause molteplici.
Resta da notare che all’interno di questa opposizione fittizia si riciclano elementi di origine mafiosa, perché proprio in questo fronte variopinto questi capiscono che si nasconde il segreto della futura possibilità di riuscire a fare tollerare, in modo diverso, la presenza e gli intrecci degli interessi mafiosi. La nuova mafia potrebbe bene essere rappresentata da questo genere di personaggi, intelligenti e preparati, i quali andrebbero a sostituire le vecchie “coppole storte”. Il problema della ricomposizione dei quadri dirigenti è tale anche per la Mafia in senso stretto.
Nelle pieghe di questo movimento, ciarliero e silenzioso nello stesso tempo, si annidano anche elementi ortodossi del PCI, che partecipano a commissioni e ad altre iniziative, organizzano dibattiti, ma che hanno lo scopo di non arrecare troppi danni alle personali clientele, a quelle del partito e, cosa importante, al crescente sviluppo delle cooperative. Al loro fianco emergono sparuti drappelli di vecchi stalinisti, che animano centri di documentazione, partecipano a manifestazioni e a dibattiti e aspettano pazientemente che il mondo torni ad assumere i colori della loro vecchia bandiera. I mafiosi veri, da parte loro, quelli non hanno problemi di colori o di bandiere.
Poi vi sono i cattolici, con in testa i gesuiti, che animano una parte del movimento che sostiene trasparenza in politica e onestà in amministrazione. Insomma una logica progressista, mediata da quei volponi di antico pelo che sono i seguaci di S. Ignazio, i quali vogliono riciclare, all’interno delle istituzioni, un equilibrio che minacciava a “sinistra”.
E, in questo calderone, con patetici tentativi di distinguersi utilizzando parole d’ordine diverse ma pratiche di intervento ormai inflazionate, ci stanno pure gli anarchici.
A questo punto, bisogna decidersi. Il movimento “contro la Mafia”, nel suo complesso, è praticamente morto. Ognuno vuole trarne la massima utilità per il proprio orto, per i propri interessi, realistici o ingenui che siano.
Chi ha avuto la pazienza di leggere queste pagine avrà anche avuto l’intelligenza di cogliere, fra le righe, nel taglio dei giudizi, nelle cose dette e in quelle tralasciate, una proposta che per diventare operativa abbisogna soltanto di qualche modesta aggiunta.
Essendo anarchici siamo per le metodologie antiautoritarie e per le soluzioni autogestionarie, ma non essendo stupidi, vogliamo che questo formulario che in una situazione come quella di cui ci occupiamo, rischia di diventare pura teoria, venga calato nella realtà.
Evitare ogni collusione, anche con quelle forze che si dicono contrarie alla Mafia, è un elemento negativo (nel senso di negazione) che va benissimo, anzi è l’indispensabile introduzione, ma non è sufficiente. Occorre andare più avanti. Se ci limitassimo qui a suggerire che dietro la maschera del sindaco Orlando, con la sua faccia pulita, ci sta ancora la vecchia lupara con in più i suoi consiglieri laureati a Oxford, diremmo una grande verità, ma saremmo anche noi scarsamente pratici e per niente operativi.
Occorre quindi un ribaltamento positivo, una presa di iniziativa, sia pure commisurata all’attuale livello delle possibilità del movimento rivoluzionario in genere e anarchico in particolare. Vediamo di precisare un po’ meglio.
Organizzare una contrapposizione attiva capillare, nelle situazioni in cui si concretizza il potere mafioso. Questa forma organizzativa può essere la più svariata, e deve basarsi sempre sulle reali disponibilità della gente di sovvertire un rapporto tradizionale di sudditanza. Ma questo non può iniziare da dove la Mafia si presenta nella sua forma classica, ortodossa, a esempio con le intimidazioni e con le estorsioni o gli omicidi. Deve, al contrario, partire dalle realtà in cui il potere mafioso è costretto a coabitare con il potere politico e amministrativo. In queste realtà, la Mafia non è sola, deve fare i conti con una capacità di opposizione che gli stessi interessi politici ufficiali non possono schiacciare. A esempio, gli uffici di collocamento, le USL, gli enti locali, gli uffici amministrativi, ecc., sono obiettivi di possibili aggregazioni di lotta. Ma, a questo bisogna aggiungere un contenuto di denuncia e di documentazione, un elemento attivo che deve anche avere la forza di far capire alla gente come la “soluzione” del controllo mafioso non è una vera soluzione ma un ulteriore aggravamento, un peggioramento che è la stessa gente a pagare.
Comunque, fin qui saremmo nell’ordine delle cose possibili, cioè delle cose che sono patrimonio di lotta di tutti gli anarchici. Il passo successivo che bisognerebbe cominciare a tratteggiare sarebbe quello dell’azione, sia ristretta che allargata, azione diretta a colpire gli interessi mafiosi, nei luoghi e nelle persone dove questi interessi si materializzano. Con questo non vogliamo ipotizzare un possibile scontro diretto, spalla contro spalla, con un apparato militare che è senza ombra di dubbi, in questo momento, irraggiungibile. E poi, questa sarebbe una variante della vecchia soluzione militare che, come sappiamo, non può sconfiggere nessuna forma di potere, quindi nemmeno quello mafioso. Stiamo soltanto affermando che non ci si può fermare alla mobilitazione popolare attraverso forme di intervento autogestionario, ma che è necessario fare un passo avanti, un piccolo contributo capace di fare crescere la lotta.
Ma questi problemi sono ancora tutti da esaminare. Per il momento non possiamo che considerarli come un apporto teorico, diretto a far capire meglio tutte le possibili sfaccettature della situazione.
[Pubblicato su “Anarchismo” n. 63, luglio 1989, pp. 1-9 col titolo “Il potere mafioso. Ombre e luci di un’analisi per un possibile approccio pratico”]
Malattia
La malattia, cioè il cattivo funzionamento dell’organismo, non è una caratteristica dell’uomo. Anche gli animali si ammalano, e perfino le cose, a modo loro, possono presentare difetti di funzionamento. Questa concezione della malattia come anormale funzionamento è quella classica, sviluppata dalla scienza medica, nel caso specifico dell’uomo, e mutuata dallo sviluppo complessivo delle scienze, almeno fino agli inizi del Novecento.
La risposta alla malattia, in queste condizioni analitiche di fondo, per la maggior parte dovute all’ideologia positivista, di cui ancora oggi la medicina è dominata, resta sempre quella della cura, cioè di un intervento esterno, scelto sulla base di alcune pratiche specifiche, diretto a ricostituire condizioni di presupposta normalità.
Non bisogna credere che la ricerca delle cause della malattia sia stata sempre parallela a questo bisogno scientifico di ricostituire la normalità. Per lunghi secoli, i rimedi non andavano per nulla di pari passo con lo studio delle cause. Quest’ultime erano a volte assolutamente fantastiche, mentre i rimedi potevano anche avere una loro logica, specie quando si fondavano su di una conoscenza empirica di alcune forze della natura.
In tempi più recenti, la critica al settorialismo delle scienze, e quindi anche della medicina, si è sviluppata da più parti ed è stata fondata sul concetto di totalità dell’uomo come entità costituita da diversi elementi naturali, intellettuali, economici, sociali, culturali, ecc. È in questa nuova prospettiva che si è sovrapposta l’ipotesi materialista e dialettica del marxismo. La totalità variamente articolata, al fondo della quale si poteva ricostituire l’uomo nuovo, vero, reale, e non quello diviso in settori a cui il vecchio positivismo ci aveva abituati, venne incapsulata un’altra volta dall’interpretazione marxista in un determinismo a senso unico. La causa della malattia veniva così ricostituita esclusivamente nel meccanismo del capitale che alienando l’uomo attraverso il lavoro, lo espone a un rapporto distorto con la natura e quindi con quel concetto di normalità che resta sempre l’antitesi della malattia.
Penso che non si possa accettare né la tesi positivista di una malattia dovuta al cattivo funzionamento di elementi precisi dell’organismo, come non si possa accettare nemmeno la tesi marxista che riconduce tutto ai misfatti del capitale.
Le cose sono un po’ più complicate.
In linea di principio, non possiamo affermare che in una società libera non ci saranno più malattie. E non possiamo nemmeno affermare che le malattie in questo felice caso si ridurranno solo al semplice indebolimento di una ipotetica forza vitale, ancora tutta da dimostrare. La malattia penso che sia connaturata al vivere dell’uomo in società, cioè corrisponda a un certo prezzo che bisogna pur pagare per correggere di quel tanto le condizioni ottimali della natura per ottenere la necessaria artificialità su cui costruire la più libera delle società.
Certo, da una società libera, in cui le artificialità e quindi gli scompensi fra gli individui sarebbero ridotti allo stretto indispensabile, a una società fondata sullo sfruttamento, com’è quella in cui viviamo, la crescita delle malattie è esponenziale. Ne consegue che la lotta contro le malattie fa parte integrante dello scontro di classe. Non tanto perché le malattie sono causate dal capitale, che sarebbe un’affermazione determinista e quindi da rifiutare, ma perché in una società più libera, esse sarebbero diverse, più vicine, pur nella loro negazione della vita, al nostro essere uomini, espressioni esse stesse, proprio in quanto malattie, della nostra umanità, allo stesso modo in cui oggi tendono a essere soltanto espressioni della nostra terrificante disumanità.
Per questo motivo, non sono mai stato molto d’accordo con la tesi un po’ semplicistica riassunta molti anni fa dalla frase “fare della malattia un’arma”, anche se si trattava di una tesi di tutto rispetto, specialmente per le cosiddette malattie mentali. Non si può, infatti, proporre all’ammalato una cura fondata esclusivamente su di una lotta contro il nemico di classe. Qui siamo davanti a una semplificazione troppo radicale per essere umanamente reale. La malattia è anche dolore, sofferenza, confusione, incertezza, dubbio, solitudine, e tutti questi elementi negativi non si limitano a segnare oggettivamente il corpo, ma intaccano anche la coscienza e quindi la volontà. Stilare proclami di lotta impostati in questo modo è veramente irreale e spaventosamente inumano.
Ma la malattia può diventare un’arma una volta che la si capisca, sia nelle sue cause che nei suoi effetti. Può essere importante conoscere i responsabili esterni della mia malattia, capitalisti e sfruttatori, Stato e capitale, ma tutto ciò può anche non bastarmi, io posso anche avere bisogno di chiarire il mio rapporto personale con la “mia malattia”, che può non essere soltanto sofferenza, dolore e morte, ma può essere anche mezzo per meglio capire me stesso e gli altri, la realtà che mi sta davanti e le cose da fare per trasformarla, anche per capire meglio le stesse possibilità rivoluzionarie.
Gli errori che in passato sono stati fatti su questo argomento, tutti provenienti da un non ben chiarito rapporto con l’interpretazione marxista, si basavano sulla pretesa di impostare un rapporto “diretto” tra malattia e capitale. Penso che oggi questo rapporto debba essere “indiretto”, cioè attraverso la presa di coscienza della malattia, non della malattia in generale, come situazione di “anormalità”, ma della “mia malattia”, come componente della mia vita, come elemento della mia “normalità”.
E poi, la lotta, contro la malattia, anche se non tutte le lotte si concludono sempre con una vittoria.
[Pubblicato su “Anarchismo” n. 67, maggio 1991, pp. 18-19 col titolo “Malattia e capitale”]
Mia Martini
Il niente dello spettacolo.
Mia Martini, una cantante qualsiasi del paradiso delle imbecillità canore nostrane, è morta in circostanze non proprio chiare. Le cronache, per il momento, non dicono altro. L’accorata attesa dei lettori di cronache rosa resterà a lungo in sospeso. Una piccola donna senza idee e con un poco di voce, contrastata da una sorella dalla voce forse ancora più piccola e dalla idee, se possibile, meno chiare. I costruttori di romanzi per signorine, i collaboratori dei rotocalchi, i paparazzi al servizio dei giornali e delle televisioni perderanno occasioni per le loro chiacchiere e le loro immagini. La miseria di un mondo del tutto privo di contenuti, sia pure per un attimo, si è aperta in tutta la sua abissale portata: una sorella isterica, un padre che parlava della morte della figlia come un general manager parlerebbe di un’operazione finanziaria andata a male, qualche fantasma del mondo dello spettacolo costretto ad alzarsi dal letto troppo presto per non avere l’aria, appunto, di un fantasma. E poi, tutti intorno, fantasmi compresi, in preda a un raptus continuo di toccamenti e giaculatorie varie, nel disperato tentativo di difendersi dalle influenze maligne della morta, la quale, in vita, aveva una non trascurabile fama di menagramo. Siccome chi scrive la presente nota non crede a queste dicerie, da buon sostenitore della forza della ragione, ha voluto correre il rischio di parlare del ferale evento, toccando debitamente ferro.
Va da sé.
[Pubblicato su “Canenero” n. 27, 19 maggio 1995, p. 11]
Massa
Il problema dell’organizzazione di massa è molto complesso.
Penso che la lotta rivoluzionaria sia principalmente, anche se non esclusivamente, una lotta di massa. Quindi sono sempre stato dell’opinione di costruire delle strutture che possano organizzare gruppi di sfruttati quanto più numerosi possibile. Ho però sempre considerato la prospettiva sindacalista in modo critico, sia per la limitatezza congenita dello strumento, sia per la sua tragica involuzione storica che nessuna riverniciatura anarchica potrà sanare. Da ciò la costruzione di nuclei autonomi di base non aventi le caratteristiche di mini-sindacati, ma costituiti con altri scopi e con altri rapporti organizzativi.
Per prima cosa la formazione di nuclei autonomi di base non è solo possibile nei luoghi della produzione, ma in tutti gli spazi sociali che vivono le contraddizioni dello sfruttamento capitalista. Per questo motivo, insieme a tanti altri compagni, abbiamo parlato anche di “Strutture zonali astensioniste”, allo scopo di organizzare tutti coloro che sono contrari alla partecipazione alle elezioni ma che considerano troppo limitante la semplice astensione. Nella stessa linea di analisi abbiamo, a suo tempo, costituito le “Leghe contro la costruzione della base missilistica di Comiso”. Mentre più vicino alla realtà lavorativa era il “Movimento autonomo dei Ferrovieri del compartimento di Torino” che, appunto, si strutturava sulla base di nuclei autonomi.
L’organizzazione interna di questi nuclei aveva alcune caratteristiche fondamentali, a) l’autonomia da qualsiasi forza politica o sindacale; b) la conflittualità permanente (cioè non partecipazione a lotte indette ufficialmente e poi ritorno alla “normalità” del lavoro); c) l’attacco (cioè rifiuto di ogni compromesso nei riguardi dell’obiettivo da raggiungere).
In merito agli scopi questi vengono di volta in volta, individuati dagli stessi nuclei, e consistono in attacchi contro strutture della repressione: militari, produttive, di reperimento del consenso, ecc.
Questi attacchi vengono organizzati dai nuclei in collaborazione con le organizzazioni specifiche anarchiche che forniscono un sostegno pratico e teorico e partecipano in quanto strutture informali agli attacchi stessi seguendone tutto il corso fino alla loro conclusione positiva o negativa.
In questo metodo si vede chiaramente la prospettiva insurrezionale che la struttura specifica informale anarchica persegue e si vede anche la prospettiva di lotta intermedia e, a volte, semplicemente rivendicativa, che invece persegue il nucleo autonomo di base in quanto struttura di massa.
Questo metodo è stato accusato di parzialità e di non tenere conto che un attacco contro una o più strutture dello sfruttamento finisce quasi sempre per fare aumentare la repressione. Su queste accuse i compagni possono riflettere da soli. Ritengo che non è mai possibile prevedere cosa può venire fuori da una lotta, anche parziale, e quali possono essere i suoi sviluppi, anche più impensabili. Dopo tutto, il passaggio dalle varie insurrezioni – limitate e circoscritte – alla rivoluzione non è garantito a priori da nessun procedimento. Noi andiamo avanti per tentativi. Chi possiede un metodo più sicuro faccia pure la sua strada.
[Pubblicato su “Anarchismo” n. 52, maggio 1986 p. 30 col titolo “Un embrione di massa”]
Il massacratore e i massacratori
Ai primi di dicembre del 1990 un jet Macchi Mb, dell’areonautica militare, partito dalla base di Verona Villafranca, si abbatteva sull’Istituto Tecnico di Casalecchio di Reno, nei pressi di Bologna, uccidendo 12 studenti e ferendone altri 88. Un massacro.
Alla guida del velivolo, il tenente Bruno Viviani, che adesso affronta il processo a Bologna, insieme ai suoi superiori, mandanti diretti del massacro: Eugenio Brega e Roberto Corsini.
Che dire della faccenda. In linea generale poco e nulla. Un boia in divisa d’aviatore, con tutte le idiozie che contiene una testa di cadetto aviere, portate alle estreme conseguenze dal fatto di maneggiare un arnese di qualche milione di dollari. Un tipo del genere, uno dei tanti ragazzi semi-idioti e semi-tecnici, sfornati dalle nostre scuole di alta specializzazione militare, si trova ad avere noie col motore. Applica il regolamento che gli impone di dirigersi verso la pista di atterraggio più vicina e, al limite, di lanciarci col paracadute. Lo fa e determina un disastro. Adesso si cerca di dimostrare che è solo lui il responsabile, per non avere diretto il suo jet in mare e per non essere rimasto alla guida fino all’ultimo momento, rischiando di morire, ma al volante, nella tradizione gloriosa degli eroi dello spazio: Baracca in testa.
No, il problema, a me sembra non essere qui. Non è di un eroe che c’è bisogno nel momento del pericolo, ma della distruzione preventiva e assoluta di tutte quelle condizioni istituzionali che rendono possibili, se non altro, questo genere di pericoli. Sarebbe stato molto comodo per l’areonautica avere un Viviani morto, cui intestare una medaglia e una lapide, invece di quei dodici ragazzi morti. Ma le cose non sono andate in questo modo, il bravo pilota ha cercato di salvare la pelle. Come rimproverargli questo atto di umana codardia? Come farlo di fronte alle tante altre cose che possiamo rimproverargli?
La sua responsabilità è quella di avere accettato quel mestiere e quei rischi. Giustamente scriveva Sartre: “Se sono mobilitato in una guerra, questa guerra è la mia guerra: essa è a mia immagine ed io la merito. La merito in primo luogo perché potevo sottrarmici con il suicidio o con la diserzione: queste possibilità ultime devono sempre esserci presenti quando si tratta di affrontare una situazione”. Quindi Viviani è un massacratore, e non per non essere stato un eroe, che di eroi abbiamo piene le tasche, ma perché non ha saputo tirarsi indietro per tempo da un mestiere di merda che invece lui continua a considerare prestigioso e, miseria dell’intelligenza umana, perfino utile.
Dei suoi superiori neanche a spender parola. Massacratori anche loro.
[Pubblicato su “Canenero” n. 12, 27 gennaio 1995, p. 3]
Matematica
Voglio prendere adesso il problema dell’esperienza matematica come problema dell’apertura alla tensione. Chiarisco subito che le discussioni tradizionali sull’uso della matematica si debbono ricondurre al problema dell’accumulazione del senso, anche se le possibilità che lo strumento in se stesso qualche volta offre possono accelerare alcuni aspetti dell’inquietudine. La paura per alcune di queste possibilità è visibile nel progetto iniziato in Francia a partire dal 1935, chiamato col nome di progetto Bourbaki, secondo il gioco inventato da un gruppo di giovani brillanti matematici francesi degli anni Trenta che continua anche oggi. Col titolo di Elementi di storia della matematica, sono usciti fino a ora circa trentacinque volumi che si propongono la riscrittura e la sistematizzazione di tutta la matematica dai Greci fino a oggi. Ciò allo scopo di dimostrare la razionalità, la unità profonda e la consequenzialità di tutto l’universo matematico. Il che significa, in altre parole, che diversamente dalla scienza in generale, e in particolare della scienza fisica, i cui risultati finiscono per avere effetti complessivi all’interno di tutto il sistema teorico, modificandolo in continuazione, e ciò riconfermerebbe l’idea della catalogazione del senso, la matematica non potendo essere dimostrata errata non si accumula ma semplicemente si allunga nelle sue ineluttabili verità, separate una dall’altra. La meccanica aristotelica era sbagliata mentre la geometria euclidea era ed è giusta. Ma qui il problema di sbagliato e giusto è esso stesso sbagliato, quindi fa cadere tutta la premessa sulla infallibilità della matematica. Infatti, secondo questa tesi, in fisica, giusta sarebbe la corrispondenza con la realtà, affermazione che stranamente ricorda una memoria di Stalin, giusta in matematica sarebbe la semplice consistenza logica. Io penso che tutta la ricerca matematica rimane prigioniera di questa idea del contenuto, cioè di questa sua aderenza al senso, e ciò a prescindere dalla maggiore o minore funzionalità che di volta in volta può scoprirsi. Anche non volendo, il pensiero va qui agli spazi non euclidei e alla malinconica polemica di Lenin contro un machismo da libretto di propaganda controrivoluzionaria. La conclusione di Einstein dell’esistenza di un numero infinito di spazi in movimento, l’uno rispetto all’altro, ha posto su di un diverso livello il problema dell’accumulazione del senso. La progettualità essenzializzata è certo uno strumento di notevole potenza per conoscere, ma per conoscere che cosa? La spiegazione analitica, il chiarimento, sono forse conoscenza? Certo, anche questa è conoscenza, ma in un senso direi subordinato. La matematica è creativa in quanto deve cogliere non solo una spiegazione più semplificata di un fenomeno, ma anche deve saperlo e poterlo fare in un modo differente. Deve quindi creare un’ipotesi di forma che possa anche essere riassorbita in una struttura determinata, ma senza che ciò sia strettamente necessario. Ciò può avvenire solo con un inserimento della qualità. Il luogo comune, accuratamente custodito all’interno dell’idea che la matematica, semplificando la struttura della realtà, la razionalizzi o, almeno, cerchi di correggerne le irragionevolezze, non ha fondamento, come hanno a suo tempo indicato dapprima le inquietudini e poi le aperte dichiarazioni di sfiducia fatte da Pareto verso la matematica. Se la matematica è strumento per capire la realtà, fatto che non può essere revocato in dubbio, ciò non vuole dire che essa sia razionale, come non vuole dire che a essere razionale sia la realtà. Se la matematica fa capire meglio i problemi del comportamento delle strutture fisiche, ciò non vuole dire che queste strutture siano vere, esatte, giuste o altre affermazioni del genere. Comunque, a parte ogni altra considerazione, non è certo la funzionalità a giustificare la ricerca matematica. Cogliere la realtà nel senso di conoscerla dal punto di vista totale, quindi eminentemente qualitativo, non significa necessariamente spiegarla o capirla, cioè costringerla all’interno del meccanismo dell’accumulazione. E le intuizioni di Cantor scalzavano di già a partire dal 1877 le pretese della geometria non euclidea di chiudere definitivamente il cerchio delle possibili conoscenze. Cambiava cioè il concetto di dimensioni. Agli inizi del Novecento venivano costruite, per la prima volta, figure capaci di mettere in crisi il senso comune, in quanto intermedie tra il punto e la linea, tra la linea e il piano, tra il piano e il volume, dove mai la loro dimensione matematica poteva essere tradotta in un numero intero. Con le attuali ricerche sui frattali [1989] si aprono due direzioni. Da un lato, si cerca di matematicizzare la natura, ricostruendo, con i computer, l’interno dei polmoni, un albero, il corso di un fiume o la struttura del cervello, un antico sogno, ancora una volta sistematico, che subordina la matematica alla realtà utilizzando la prima come semplice strumento esplicativo della seconda. Da un altro lato, questi nuovi spunti teorici propongono il recupero di una funzione diversa della matematica, un ruolo svincolato dal senso e dalla spiegazione della struttura, un contenuto nelle mani della inquietudine che visualizza, allo stesso modo di un pittore, forme dotate di una tensione che la pretesa corrispondenza con la struttura non possiede. Dalla elaborazione matematica delle curve frattali vengono fuori relazioni che possono o meno avere un senso, cioè possono o meno essere riportate al di qua, verso un controllo della coscienza immediata, ma, da per se stesse, quelle curve hanno il medesimo valore estetico di un paesaggio nuvoloso, di un muro scrostato, di una macchia dove ci si sbizzarrisce a cercare simboli e oggetti, al limite della propria immaginazione. In quanto flussi non orientati, cioè non ricondotti al senso, essi sono espressioni della realtà, non possono essere, almeno per il momento, sottoposti a precise tecniche di conquenzialità logica, sono cioè inutili, come lo è Guernica o altre fantasie picassiane. La differenza tra una teoria matematica coerente, diretta in modo specifico a rivestire di spiegazioni una struttura, e uno sviluppo matematico che non si pone questo obiettivo, è che tale sviluppo, se si vuole più modesto sotto gli aspetti strumentali, è anche più ambizioso, più audace e finisce per essere più pratico, ma indirettamente, per via diversa, in quanto contribuisce alla trasformazione. Penso che non si sia riflettuto abbastanza sull’importanza dell’assenza in matematica, cioè di una tensione che non c’è ma che sta sviluppando conseguenze le quali, per il momento, considero trascurabili. Penso che l’insieme degli elementi conosciuti, i cosiddetti fatti, la loro autorità accumulativa, le previsioni possibili, le tecniche di falsificabilità delle ipotesi, i risultati di già acquisiti, non concludono il cerchio di quanto viene elaborato dal pensiero matematico e ciò proprio perché si presentano sempre come sistema coerente da accettare e da collocare accanto ad altri sistemi coerenti, strumenti vicino ad altri strumenti. Ma la coerenza è una qualità e non può venire fuori dall’assenza dal senso, sarebbe una coerenza fittizia, di cui la matematica, e la realtà con essa, non ha bisogno. L’interpretazione è fatto complesso e notevolmente contraddittorio e i matematici sanno il valore del mascheramento nella loro scienza, cioè la funzione positiva di un dato falso e inesistente che, comunque, sviluppa una serie di conseguenze precise e perfino prevedibili. La matematica, come la logica, appartiene al mondo del senso.
[1989]
Cipriano Mera
Riguardo la questione della rivoluzione spagnola. Il mio non era un giudizio complessivo di condanna di tutta quella esperienza, ma un giudizio che cercava di individuare a ritroso il percorso degli anarchici che vi parteciparono, partendo dalla presenza anarchica nell’esercito repubblicano. Io stesso ho parlato con Cipriano Mera, e mi ricordo che lui negava strenuamente di avere pronunciato le famose parole: “Se io do un ordine a un colonnello, il colonnello, anarchico, deve rispondermi signorsì, e se il colonnello lo dà a un maggiore anche lui deve rispondere signorsì”. Strano che Mera rifiutasse la paternità di queste parole, per me giustissime. Mi spiego: a parte il fatto che esse furono pronunciate nel corso di un meeting pubblico, con centocinquantamila persone presenti, erano parole giustissime, secondo me, perché se io sono un generale anarchico in una guerra di linea, in una guerra regolare, e do un ordine a un colonnello anarchico, il colonnello non può rispondermi “senti compagno io la penso in maniera diversa”, in questo caso la guerra non si fa più. L’errore non è nel dare l’ordine a un colonnello, o nel pretendere che il colonnello ubbidisca, ma l’errore sta a monte, nell’aver scelto una strada che doveva necessariamente finire nella partecipazione alla guerra. Comunque queste sono opinioni. Io volevo dire che quando tu entri in una logica di massa, puoi fare tutte le esperienze che vuoi, però devi accettare determinate condizioni, devi accettare la polizia, le carceri, devi accettare l’esercito, devi accettare che il generale dia l’ordine e che il colonnello risponda: signorsì. Questo volevo dire.
[Parte del dibattito seguito alla Conferenza dal titolo “Anarchismo e democrazia” da me tenuta a Bologna il 16 marzo 1995 presso la Facoltà di lettere e filosofia. Trascrizione della registrazione su nastro]
Misure: 86 – 55 – 86
Queste le misure di Carla Bruni. La mannequin più intelligente del momento è un’oca saccente alta un metro e 76 che ha la sola qualità di restare magra anche mangiando tantissimo. Per il resto non si differenzia molto dalle sue colleghe: si muove aggraziata, sculetta poco essendo priva di sedere, si acconcia con grazia quei quattro stracci che avveduti speculatori vendono a suon di milioni. Ma, più di ogni altra cosa, focalizza l’attenzione di milioni di impecoriti ammiratori addomesticati dalla tirannica egemonia delle foto di moda.
Per la verità, questa Carla stupida non è, ha anche qualche ideuzza. Per carità, nulla di speciale, qualcosa di terra-terra. Esce da una famiglia d’alto lignaggio economico, ma cerca i soldi, tanti soldi, per avere poi fra le mani una vita di merda: poveri amanti rincoglioniti, squallide stanze d’albergo, di certo non abbellite dal cumulo di bagagli e cianfrusaglie che la dea si porta dietro per dare da mangiare alla propria coscienza affamata.
Ma una cosa l’accomuna alle sue colleghe, se possibile ancora più oche di lei: non parla. La dea è muta, e nell’olimpo delle altre dee che sfilano con tanti stracci colorati addosso o facendo ignobili boccacce con le labbra coperte dall’ultima merda da pubblicizzare, non viene meno alla consegna del silenzio. La mannequin è muta. Per questo ha soppiantato come simbolo della bellezza mercantile l’attrice di ieri. Il mondo delle pecore dalla lingua tagliata, che oggi ingrossa il mercato degli acquirenti potenziali, gradisce molto questo silenzio, che corrisponde esattamente all’agghiacciante atrofizzarsi di qualsiasi pensiero nelle loro teste vuote.
Il resto è soltanto brusìo giornalistico: meno che merda.
[Pubblicato su “Canenero” n. 10, 13 gennaio 1995, p. 7]
Le minacce aeronautiche
Un jet impazzito da diversi milioni di dollari, guidato da un tenentino appassionato di guerre stellari, Bruno Viviani, il 6 dicembre 1990 andava a sfondare il muro d’una scuola di Casalecchio, vicino Bologna, uccidendo sul colpo dodici studenti e ferendone gravemente altri 88. Il bravo pilota s’era, nel frattempo, lanciato fuori salvandosi da morte sicura. Fino all’ultimo, per come prescrivono i regolamenti e i manuali, aveva evitato di condurre l’aereo ingovernabile verso il mare, e quindi verso una soluzione catastrofica di possibili minori conseguenze mortali.
Alcuni giorni fa, il tribunale di Bologna ha condannato Viviani e i suoi superiori a qualche anno. Una formalità giuridica con la quale si vuole affermare il principio sacrosanto in base al quale lo Stato può correggersi e mettere in evidenza le malefatte dei suoi accoliti.
Ovviamente questi ultimi non sono d’accordo. Pretendono di avere man salva nelle loro azioni, quali esse siano. Un poliziotto che uccide liberamente per strada, aspettando in un agguato da Far West i probabili rapinatori in arrivo, è considerato un salvatore dell’ordine pubblico. Un militare alla guida di un aereo da combattimento che uccide dei ragazzi seduti in un’aula scolastica, viene invece condannato come un criminale. La cosa è sembrata ingiusta, e i bravi ragazzi in divisa blu hanno fatto una sorta di dimostrazione: si sono rifiutati di levarsi in volo.
Niente di grave, per carità. Intendiamo. Non hanno “scioperato”, che l’esercito di ogni tipo non può scioperare, che ne sarebbe infatti della “sicurezza nazionale”? Ma hanno fatto sentire un piccolo brontolio. Che di animale a pelo lungo si tratta è fatto evidente. Brontola oggi, non potendo alzare la voce, ma minaccia di azzannare domani. L’areonautica è arma dal passato se non prestigioso, di certo ricco di privilegi. È l’arma azzurra che domina i cieli, quella che fa sognare pacificamente nei suoi modesti sonni il pacifico bottegaio che pensa alla pacifica maniera con cui continuerà a scorticare viva la sua clientela. È l’arma che ci tutela dalle invasioni straniere, dai marziani in tutina verde, come dagli eredi dei Russi di ieri, dei nemici di sempre, che potrebbero passare in un battibaleno i sacri confini della nostra patria e conquistarci, uccidendo e stuprando, e tutto il resto della iconografia mortale della propaganda militarista.
E adesso questi bravi ragazzi vengono condannati da un tribunale della Repubblica. Indegno misfatto, anche se commesso con le migliori buone intenzioni da parte dei giudici che vorrebbero dimostrare le capacità autocorrettive dello Stato.
Che ciò non si ripeta, e che possibilmente ciò, nella sua specifica fattispecie, venga cancellato, hanno ammonito gli alti gradi delle aquile azzurre. Per il momento solo una piccola sospensione dei voli di addestramento.
Domani, chissà?
[Pubblicato su “Canenero” n. 18, 10 marzo 1995, p. 5]
Misere glorie militari
A San Piero a Grado, nei pressi di Pisa, c’è un reattore nucleare del Centro ricerche esperienze e studi applicazioni militari (Cresam). Il progetto, nato negli anni Cinquanta, si chiamava una volta, più succintamente: Centro applicazioni militari energia nucleare, poi, con l’ipocrisia che caratterizza queste operazioni, si è cercato di camuffarne almeno il nome.
Sabato scorso, nel primo pomeriggio, una delle parti essenziali del reattore è stata invasa dalle fiamme. L’incendio si è sviluppato proprio dove vengono svolte tutte le operazioni di smaltimento dei rifiuti radioattivi. Trattandosi di struttura militare le notizie vengono controllate prima e fornite poi dall’esercito, anzi dalla marina militare che gestisce ed è responsabile del centro. Il reattore di cui discutiamo è stato sospeso in quanto progetto ormai pronto a entrare in funzione, una decina di anni fa, quando il parlamento decise di chiudere con l’incredibile (e poco pubblicizzato) progetto della marina militare italiana di dotarsi di un proprio sommergibile nucleare.
Il reattore di San Piero a Grado proviene da un rudere attivo negli Stati Uniti e poi riciclato e riattivato in Italia col nuovo nome di “Galileo Galilei”. L’arretratezza e la pericolosità di questo reattore era di già evidente fin dal suo trasferimento in Italia dal paese fornitore, ma solo qualche anno fa esse sono state ufficialmente riconosciute e quindi deciso il programma di spegnimento e di smaltimento dei rifiuti tossici, cosa che durerà molti anni.
L’operazione di distruzione di questi rifiuti è cosa molto difficile e delicata, e l’incendio di cui discutiamo, per quel che riportano le cronache, imprecise se si può più del loro solito, si è sviluppato proprio nella zona dedicata a queste operazioni.
[Pubblicato su “Canenero” n. 29, 2 giugno 1995, p. 7]
Modernità
Ancora una volta non è questione di parole. C’è in un certo senso un luogo comune del ragionamento che vuole ben divisi i conservatori del passato e i sostenitori di un futuro ancora tutto da costruire. I primi vengono raffigurati come vecchi e stupidi, legati a istituzioni e strutture che il tempo ha superato; i secondi invece sempre dediti a trasformazioni e innovazioni. Nel mezzo starebbero poi non ben identificate mezze decisioni, volute dai cosiddetti riformisti, che hanno i piedi nel passato e la testa nel futuro.
Ora, c’è subito da dire che quasi tutti siamo convinti che questa divisione ha fatto il suo tempo, ma continuiamo ad averla in testa. Una categoria mentale di cui non riusciamo a liberarci perché non la vogliamo approfondire. La maggior parte di noi non ammetterebbe mai che gli elementi del binomio: futuro (modernità) e rivoluzione (trasformazione violenta), possano stare altrimenti che insieme. Ma è proprio così?
Una concezione progressista della Storia non può di certo fare a meno di un’impostazione del genere. Ma lo storicismo dove ci ha portato? In ogni caso ha costruito lager, poi anche carceri modello, ma queste sono venute dopo. In nome dello spirito oggettivo che si avvera nella Storia, e quindi si realizza man mano nel futuro e nella modernità, sono stati uccisi milioni di uomini, e con la migliore delle buone intenzioni.
E siccome siamo tutti, più o meno, figli dello storicismo, anarchici compresi, almeno fino a prova contraria (e che genere di prova ci vorrebbe! un dibattito da fare rizzare i capelli), se ne deduce che siamo più o meno tutti seguaci del progresso (nessuno ammetterebbe il contrario!) e crediamo che si stia tutti andando verso la catastrofe finale o verso un profondo e radicale cambiamento nei valori. Questa, faccenda della Storia che cammina verso un suo destino, è qualcosa di rassicurante, anche quando pensiamo questo destino come olocausto generalizzato.
Il fatto di non essere capaci di mettere in discussione queste nostre origini culturali, storicismo in primo luogo, determinismo, scientismo, eclettismo (su questo punto, quanto sarebbe necessaria una decente analisi sul pensiero di Malatesta!), ci impedisce di vedere meglio la nostra attuale condizione.
Che siamo “post” qualcosa, lo crediamo un po’ tutti. Personalmente penso che siamo in un’epoca postindustriale, e lo penso almeno, con sufficiente chiarezza, dalla fine degli anni Settanta, ma, adesso, questa specificazione comincia a voler dire poco. L’industria per come se la erano immaginata Ford, Taylor e Marx, ha fatto il suo tempo, ma anche i sindacati, anche quelli che ci eravamo immaginati noi, hanno fatto il loro tempo. La gestione complessiva della formazione capitalista, a livello mondiale, sta assumendo connotati sempre meno riconducibili a una concezione della vita basata sul valore dell’accumulazione. Ciò vuol dire, fuori da ogni dubbio, che se l’industria era la base delle trasformazioni sociali che portarono al mondo moderno, quello delle macchine e della misura del lavoro, tanto per intenderci; la fine dell’industria, sostituita da una produzione diffusa e controllata elettronicamente, segna la fine del mondo moderno.
Un nuovo Medioevo? Domanda assurda, come lo sono state le risposte date da più parti. Non significa nulla andare alla ricerca di “ripresentazioni” storiche. Il pragmatismo politico degli aggiustamenti quotidiani, riproduce un insieme sociale che, nei tempi lunghi, trova risistemazioni sue, spesso innovative, dove si collocano nuove possibilità del dominio e nuove forme di lotta contro l’oppressione. Il banco di prova dello scontro di classe è sempre la realtà, in tutte le sue forme, e queste, singolarmente prese, non possono essere considerate più moderne di altre che nel tempo passato furono soppiantate per una loro più o meno effettiva non corrispondenza agli scopi da raggiungere. Questo essenzialismo filosofico delle scelte è semplicemente ipotetico. In sostanza, le cose vanno diversamente. Le scelte stesse sono possibili, in un ampio raggio di varianti, perché esistono valori di fondo che influiscono sui giudizi che quelle scelte producono. Questi valori, concretamente considerati, cioè nell’azione che essi svolgono nella realtà, in quanto elementi di trasformazione, non sono mai né antichi, né moderni. Il concetto stesso di progresso, applicato a essi è antitetico e produce incredibili equivoci.
Poniamo, l’uguaglianza è un valore antico o moderno? Non si può rispondere a questa domanda. Dato che essa, in realtà, non è mai esistita, se ne deduce che dovrebbe essere un valore futuro. Ma il futuro, è moderno? Non lo sappiamo. Ci sono, però, diversi modi di pensare possibile la realizzazione o l’impedimento dell’uguaglianza, e questi modi, di volta in volta considerati, in relazione alla loro efficacia e alla loro rispondenza alle condizioni sociali di sviluppo della società in un dato momento storico, possono essere considerati antichi o moderni. E, per il capitale, il valore dell’accumulazione, è antico o moderno? Date le condizioni attuali, si potrebbe rispondere che non è più un valore moderno, e che nuovi scopi si stanno profilando all’orizzonte dei dominatori. La differenziazione potrebbe essere uno di questi nuovi valori, la distanza tra due concezioni del mondo: quella di coloro che hanno le leve del comando (gli inclusi) e quella di coloro che debbono solo eseguire e a questo sono preordinati e condizionati (gli esclusi). Anche i valori riduttivi del nichilismo, del neo-formalismo, dell’alfabetizzazione, del velocismo, del super-nazionalismo, ecc. sono valori moderni, e conducono tutti alla riconferma di questa separazione definitiva (fino a un certo punto) tra inclusi ed esclusi. Ma è possibile considerare questi valori in senso storicistico, come più avanzati nei riguardi di quelli corrispondenti del passato? Penso proprio di no.
Ci siamo tante volte chiesti se era veramente il caso di distruggere la tecnologia o se non era invece il caso di garantire un passaggio rivoluzionario (ovviamente) a un suo possibile futuro utilizzo. Poi ci siamo accorti che questa tecnologia, quella del computer e del controllo universale contemporaneo, non è utilizzabile in una società che parte dal valore della liberazione reale e non illusoria, per tutti e non solo per una minoranza privilegiata. Per cui, la distruzione come fatto necessario, come valore. Moderno? Non lo sappiamo. Anche in passato ci sono state distruzioni che alla luce di alcune miopie erano sembrate reazionarie (c’è ancora chi parla della Vandea in senso dispregiativo, ma lo fa per sua personale ignoranza storica) e poi sono state meglio approfondite. Le insurrezioni dei contadini che bruciavano i castelli. Erano esse moderne? Non ce ne importa nulla. È oggi moderna una lotta contro il neo-macchinismo elettronico? Per noi sì, perché cerchiamo, con difficoltà, di metterci da un punto di vista non totalmente storicistico (almeno, ci proviamo).
Pensate al discorso sul nucleare [1989]. Noi contro, i padroni (alcuni) a favore, ma sui due lati del fronte dello scontro, l’ala allucinante dei cavalieri dell’Apocalisse. Effetto senza dubbio della comune cultura storicistica. Per cui divenne poi facile, per i padroni, a un certo punto, ripudiare il nucleare e trasferire altrove i loro impegni e i loro progetti.
Lo stesso per la guerra atomica e per quell’aria di catastrofe millenaristica che si sta respirando anche in questi giorni. La fine del millennio si avvicina e il cerchio si ripresenta sempre uguale a se stesso e sempre diverso. La rapida distruzione delle risorse comuni a opera degli attuali predoni dominanti è un fatto ineluttabile di questa forma di dominio e cesserà o si trasformerà quando gli inclusi di domani si costruiranno un mondo su misura per i loro bisogni e uno per i bisogni degli altri. In altre parole, anche la battaglia attuale contro lo sperpero delle risorse naturali può diventare l’industria di domani, la base per il futuro sfruttamento di domani. Ecco perché siamo per l’attacco oggi, sistematico, contro tutte le forme dell’espressione capitalista, sia quelle più arretrate, legate ancora allo sfruttamento rapido e irrazionale; sia quelle più avanzate, legate al controllo elettronico del pianeta. Ambedue, in un futuro non molto lontano, si daranno la mano, schiacciandoci in mezzo.
Per far questo occorre trovare il coraggio di guardare anche indietro, non solo avanti. Indietro alla ricerca di alcuni valori che oggi non sono più considerati “moderni”. In questa ricerca possiamo individuare alcuni fondamenti dell’agire umano: la coerenza, il coraggio, il rispetto per il fratello (uomo o animale), la durezza con se stessi, la frugalità, la giusta considerazione dell’ambiente. Ma non solo questi, anche altri, solo apparentemente in contrasto: il gioco, l’amore, la fantasia, la gioia, la tenerezza, il sogno.
Facendo propri questi valori, criticamente, non come dogmi imposti da una concezione globalizzante del mondo, andiamo incontro a un contrasto radicale con la situazione sociale di oggi nel suo insieme. Non siamo disposti ad accettare compromessi, non siamo punti di riferimento scontati per nessuno, non vogliamo sommatorie illusorie, non forniamo indicazioni per crescite quantitative.
Ora, questa posizione ci pare contraddica fortemente alcuni punti essenziali dello storicismo. Non solo per la scomparsa dello spirito che si realizza nella Storia, ma per l’azzeramento di ogni possibile punto di riferimento privilegiato, nemmeno quello, tanto per intenderci, dell’anarchia. Essere contro il potere, lo Stato, il dominio di classe e contro ogni genere di sfruttamento, d’accordo, ma contrapporre a tutto ciò, invece dell’azione, una giustapposizione ideologica e dogmatica, no, assolutamente no. Se dobbiamo ridurre l’anarchia a questa pratica riduttiva, in nome del nostro bello ideale, non sono d’accordo. Chiunque pratichi questo sport domenicale lo faccia pure con comodo, non saremo certo noi a impedirgli di passeggiare, però non rompa le scatole se ci mettiamo a correre, accampando i suoi diritti di libero passeggiatore post-prandiale. Di questi diritti non abbiamo mai voluto sentirne parlare.
E contraddiciamo lo storicismo, o almeno così ci pare, con la nostra smania di agire. Non possiamo aspettare che qualcosa si conchiuda senza la nostra presenza. Vogliamo essere della partita. Vogliamo che la nostra volontà aiuti la trasformazione. Nel senso che riteniamo giusto, non nel senso di un dogma cristallizzato per sempre. Non possiamo aspettare, quindi agiamo qui e subito, perché non riconosciamo nessun punto di riferimento dove depositare le nostre speranze e le nostre attese. Non riconosciamo né uno “spirito oggettivo”, né un dio laico che lavori per noi alla nostra liberazione. Nella notte fonda in cui tutti i valori tendono all’azzeramento, se qualcosa si deve accendere vogliamo che siano i lampi delle nostre esplosioni.
[Pubblicato su “Provocazione” n. 20, maggio 1989, p. 7 col titolo “Ma noi, siamo moderni?”]
Monaci
Nell’abazia di Saint-Wandrille, in Francia, i cinquanta monaci che vi abitano lavorano nel campo dell’elettronica. Fin qui nulla di strano. Dai codici miniati del passato il lavoro dei servi di Dio si è evoluto. Qualche anno fa producevano cera per restauri, adesso producono sofisticati sistemi per due grandi ditte che lavorano per l’esercito: la Tomson, che si occupa di radar, e la Framatome che tratta materiali nucleari.
I benedettini di Saint-Wandrille sono espertissimi e hanno messo su un sistema di computer che è costato quasi quattro miliardi di lire. Adesso guadagnano un sacco di soldi con il lavoro che fanno, lavoro per altro ad altissimo livello tecnico.
A comandare il gruppo di monaci è padre Didier Le Gal, che ha studiato ingegneria nella scuola speciale militare di Saint-Cyr. “Comunque”, ha precisato il superiore interrogato dai giornalisti, “fra tutte le richieste di lavoro, scartiano quelle che hanno a che fare con l’immoralità e la pornografia. Per quanto riguarda i prodotti di interesse militare, non ci siamo sottratti: un paese deve avere la possibilità di difendersi”.
[Pubblicato su “Canenero” n. 30, 9 giugno 1995, p. 12]
Movimenti studenteschi
Nessuno vuole mettere il carro davanti ai buoi, per carità, e poi gli anarchici non sono deterministi, quindi si aspettano sempre il meglio dai movimenti sociali che si producono e si riaccartocciano continuamente. E, difatti, questo è un bene, perché almeno così dovremmo essere pronti a capirli meglio questi movimenti, a diventarne parte attiva, per quel che le condizioni obiettive ci concedono, e spesso anche a parteciparvi come parte propulsiva. Mi chiedo, comunque, a parte queste considerazioni di principio, se qualcosa del genere è accaduto, e sta accadendo, nei riguardi del problema degli studenti come categoria sociale.
Dapprima una considerazione scontata: gli studenti universitari, e ancor più quelli della scuola media, sono giovani e tranne una fascia tanto minima da essere trascurabile, sono in attesa di un futuro lavoro, quindi costituiscono un elemento di pressione sul mercato, elemento che di regola non può stare fermo, in quanto subisce due sollecitazioni, da un lato il nucleo familiare che preme per una prospettiva, dall’altro le condizioni produttive che questa prospettiva non sempre la garantiscono o la fanno considerare possibile. Ciò relega i movimenti studenteschi, da che la scuola si è costituita come corpo separato della società, quindi non dall’altro ieri e fors’anche nemmeno dall’Ottocento, all’interno di una miseria corporativa che li perseguita come una condanna. Il mondo studentesco è un mondo miserabile perché privo di serie prospettive immediate per proporre una soluzione del proprio problema. Allo studente, come anche al giovane in generale, mancano gli strumenti per una vera azione contro le due forze nemiche che lo contrastano, la famiglia alle spalle e lo Stato davanti.
Ma questa conclusione è tutt’altro che negativa. Infatti, se è vero che la condizione studentesca è miserabile, è anche vero che la doppia pressione di cui sopra (famiglia-Stato) è esercitata su di un corpo sociale non ancora stabilizzato, cioè non radicato nella società stessa, capace di individuare interessi propri e prospettive di sviluppo della propria condizione economica e sociale. Questa integrazione è vaga e provvisoria, ed è un bene che sia così, mentre costituisce una tragica farsa il tentativo di alcuni interventi politici di suggerire obiettivi di lotta concreti, come a esempio una legge qualsiasi, le dimissioni del ministro, la privatizzazione, la creazione di un’università democratica e di massa. La scarsa integrazione degli studenti, e quindi di tutti i giovani, costituisce una mina vagante per il potere, ma a condizione che riesca a trovare i giusti collegamenti con le condizioni esterne alla specifica parte sociale studentesca, cioè con altre parti sociali che lo Stato s’incarica di tenere separate per meglio garantire lo sfruttamento: lavoratori dei settori più esposti al pericolo della disoccupazione, immigrati, fasce più o meno fuori della salarizzazione, realtà di quartiere, realtà di zona interessate ai problemi dell’inquinamento, ecc. Se quella mina non si incontra con altri potenziali esplosivi, o se per motivi diversi questi potenziali non sono in questo momento disponibili all’incontro e quindi perseguono loro tragitti autonomi (a seguito del successo della politica statale di separazione), non succede proprio niente: il movimento degli studenti viene recuperato all’interno della propria miseria e continua a parlare dei propri interessi corporativi.
Anche le occupazioni, di per sé, sottolineate come bollettini di guerra tratteggianti il territorio sottratto al nemico, non sono segno di vitalità del movimento, se si eccettua l’occasione favorevole che esse rendono possibile, consentendo l’incontro di giovani al di fuori dell’asfissia regolamentare tipica degli adulti. Ma, come è parso evidente, se alcuni di questi stessi studenti, o per mania dirigista, o perché impauriti realmente da possibili prevaricazioni politiche, o perché mal consigliati, si incaricano da se stessi di darsi una bella regolata, autogestita, naturalmente, la frittata è più o meno la stessa, e stare seduti nei banchi o per terra, non fa molta differenza.
Il problema dell’autogestione va anch’esso ridimensionato, in parallelo con quello delle occupazioni. Non è possibile autogestire una scuola, per il semplice motivo che non esiste autogestione parziale di qualcosa se non si inserisce in un’autogestione della lotta e della produzione. E non si può pensare seriamente che qualche lezione voluta (?) dagli studenti possa considerarsi autogestionaria. Gli ostacoli a una pratica del genere che sia reale e non fittizia sono di due tipi: a) la lotta studentesca è eminentemente corporativa e fin quando resta tale non può autogestirsi neanche come lotta perché o si limita all’inefficacia delle parole, o viene distrutta nell’isolamento non appena appare leggermente più significativa; b) la lotta studentesca non si realizza all’interno di realtà produttive, l’università non produce nulla se non disponibilità generalizzata, preparazione traslata nel tempo di una mano d’opera particolarmente flessibile. Non si può ragionevolmente pensare a un’autogestione di qualcosa del genere. In condizioni diverse, cioè con un collegamento sia pure embrionale con altre realtà di lotta, realtà produttive, e con i dovuti limiti, si possono tentare esperimenti autogestionari che comunque non significano neanche in quel caso una soluzione del problema.
La strategia statale contro il movimento degli studenti è quindi tutta racchiusa nel concetto di isolamento. Contrastare questa strategia significa creare elementi di raccordo. Ma come fare se c’è fra i piedi lo spettro della strumentalizzazione politica? Ecco il vero problema, non tanto quello di spiegare meglio quali sono i rapporti tra ricerca universitaria e capitale, quali sono le condizioni del mercato del lavoro, quali le prospettive della logica produttiva.
L’unica strada, secondo me, sarebbe ancora quella di spiegare nei dettagli la miseria di questo isolamento e le possibilità di un’apertura, chiarendo in contemporanea quello che il movimento studentesco, in quanto movimento di giovani è, e non quello che vorrebbe essere, cioè un movimento egemonico capace di imporre una propria strategia di gestione del potere. Gli obiettivi di un impegno del genere devono per forza essere minimali, circoscritti a possibili aperture, lotte comuni contro gli obiettivi più facilmente individuabili, mentre il massimo sforzo dovrebbe essere fatto nella individuazione di questa base comune, che non sempre è visibile e che viene spesso accuratamente nascosta dalle chiacchiere sulla strumentalizzazione politica.
Anche su questo argomento bisognerebbe abbassare i toni, che sono stati alti, specialmente da parte anarchica, toni che non hanno raggiunto l’effetto sperato, ma che al contrario si sono dimostrati soltanto capaci di rafforzare la paranoia contro l’infiltrazione di politici. Ora, se come è sempre stato, questa presenza “estranea” non può essere esclusa, perché ogni forza politica ha le sue organizzazioni giovanili che sono, se non altro individualmente, dentro la scuola media e dentro l’università, tanto vale darla come presente e denunciarla per non essenziale, nel bene come nel male, dimostrando come questa presenza indirizzi non tanto alla “politicizzazione” quanto all’isolamento, proponendo anche in forma “spoliticizzata” obiettivi di lotta che in sostanza isolano e tornano utili solo al recupero statale e alla stabilizzazione.
Io mi chiedo come possa un movimento degli studenti, in generale, qualsiasi movimento di studenti, distinguere sagacemente tra “rivoluzionari” e “professionisti della politica”, io penso che non ci siano elementi di distinzione immediata, salvo che forse i primi non portano la cravatta e i secondi la portano. I discorsi non si distinguono molto bene perché i “rivoluzionari” sono obbligati a smorzare i loro toni e le loro analisi per calarsi nella realtà, e quindi finiscono per avvicinarsi pericolosamente (e indistintamente) a quei “politici” a cui basta soltanto specificare un po’ meglio i loro discorsi fumosi per trovarsi a loro agio. Insomma, parlando di una legge qualsiasi, da cosa si distinguono le due tesi se non da un ricorso a tematiche più ampie e ad analisi più elaborate riguardo le condizioni del capitale nel loro insieme? Ed è mai possibile pensare che tutto ciò possa essere colto al volo?
Si può oggi affermare seriamente che la scuola deve essere retta con metodi libertari, autogestionari, scelti dai diretti interessati, e si può contrapporre una logica produttiva a una logica non produttiva riguardo la gestione dell’università? Se noi proponessimo tesi massimaliste del genere, slegate da una realtà che è quella che è, faremmo affermazioni di principio e non daremmo indicazioni di lotta. Certo, io posso capire che slegandosi dai lacci dell’isolamento, un movimento studentesco, proponendosi come interlocutore di altre condizioni sociali altrettanto isolate e sfruttate, faccia proprie simili indicazioni di massima, ma quella sarebbe un’altra situazione, dove il movimento degli studenti avrebbe il compito suo proprio, in quanto movimento giovanile e non ancora integrato, di spezzare l’uniformità del di già dato per aprirsi all’utopia e all’inverosimile. Non mi sembra che siano queste le condizioni attuali.
[Pubblicato su “Provocazione” n. 24, giugno 1990, p. 10 col titolo “Gli studenti tra essere e non essere”]
Muscoli europei
I sette paesi se hanno dimostrato qualcosa ad Halifax [1995] è questa: la loro assoluta incapacità di intervenire nei conflitti mondiali. A esempio sulla questione bosniaca il loro ruolo è apparso del tutto subordinato a quello russo. Il che ha significato, a sua volta, una cooptazione forzata sul piano economico del colosso in difficoltà.
Se dapprincipio una mossa più formale che sostanziale voleva far apparire al mondo l’alleato di riserva come elemento secondario, come ruota di scorta, il bubbone della Bosnia ha conferito un’altra volta a Eltisn il ruolo di arbitro della “pace” mondiale, pace che per diventare realtà economica deve prima essere “pace militare”.
A deteriorarsi di più è proprio l’immagine dello Stato onnipotente. L’America non può che volare da un capo all’altro del mondo e mostrare i muscoli, ma non potendo fare più di questo, per condizioni oggettive e per paure proprie (la destra interna incalza e l’isolazionismo non è solo un ricordo del passato), il suo ruolo ridiventa un’altra volta secondario.
Ora, ragioniamo in modo semplice. Se un paio di conflitti locali (ex Jugoslavia e Cecenia) pongono tanto in alto il ruolo della Russia come mediatrice degli equilibri militari del pianeta, pensate cosa succederebbe se i conflitti fossero più di due, diciamo quattro o cinque.
Queste considerazioni le fanno, forse più degli stessi Stati Uniti, proprio i loro partner europei, e quindi anche il nostro paese, con tanto di apparato militare da sempre ansioso di fare la guerra sul serio e imballato in confezioni guerresche in miniatura da almeno cinquant’anni. Ecco perché c’è tutto un ritorno di intenzioni guerresche, e i vari commentatori politici concludono le loro considerazioni col “ricorso alle armi”.
Anche persone dal passato illustre di “uomini di sinistra” dicono la stessa cosa, anche se con parole diverse. L’Europa, in assenza del decisionismo americano, ha il ruolo storico – dicono questi splendidi provveditori di morte – di risvegliare la volontà e l’orgoglio dei grandi Stati padroni del mondo. La Francia, e a ruota la Gran Bretagna, hanno di già risposto seriamente a questo appello. L’Italia potrebbe non tardare.
[1995]
Edda Mussolini
Elettra non c’entra.
Edda Mussolini è morta a Roma per una grave infezione renale all’età di 85 anni. Figlia del Duce e moglie del conte Galeazzo Ciano, fatto fucilare da Mussolini a seguito delle decisioni a lui avverse dell’ultima seduta del Gran Consiglio del Fascismo, Edda viene da questa tragedia portata a un primo piano storico che non le compete. Povera di spirito, stupida, senza carattere, vive la sua non breve vita coperta dall’ombra orrenda del padre, insieme a tanti altri poveri esseri, aborti di quella famiglia, che s’aggirano sulla scena italiana degli ultimi cinquant’anni come tanti pagliacci, eredi compresi. L’attuale resurrezione della Destra italiana cerca di esaltare aspetti positivi del carattere (se non altro) di questi imbecilli. Ma ogni tentativo si conclude con uno scacco. Forse un certo ruolo questa donna l’ha avuto nel passaggio dalla Repubblica sociale al Movimento sociale, e nella giustificazione politica di quest’ultimo come partito. Ma questa è storia veramente misera, che quasi tutti conosciamo, fino agli ultimi avvenimenti.
Il resto è merda.
[Pubblicato su “Canenero” n. 23, 14 aprile 1995, p. 11]
Non solo Napoleone
Al largo dell’Angola, in pieno Oceano Atlantico, proprio dove finisce l’orizzonte della passeggiata a mare di Mocamedes, si trova l’isola di Sant’Elena. Felice ricordo per tutti noi, che da ragazzi apprendemmo che sul suo territorio non proprio ospitale si spense uno dei più feroci torturatori dell’umanità, l’Imperatore dei Francesi, quel Napoleone che aveva qualche anno prima riempito di cadaveri la Beresina per poterci passare sopra col proprio cavallo fuggendo di fronte agli attacchi dei guerriglieri-cosacchi.
L’isola aveva una bella caratteristica, oltre al ricordo di Napoleone che bello non era, quella di non possedere la televisione. Adesso, grazie a un nuovo satellite della Bbc, la stanno installando. Con l’occasione l’Università di Cheltenham ha organizzato uno studio a tappeto avente per oggetto le conseguenze dei programmi televisivi sulla popolazione (7.000 abitanti circa).
[Pubblicato su “Canenero” n. 23, 14 aprile 1995, p. 2]
Non solo produttori
Il lavoratore è stato reclutato dall’azienda. Non solo per le sue residue capacità produttive, cioè per quello che le sue competenze specifiche gli permettono di fornire alla struttura che lo dirige e utilizza in cambio di un salario, ma anche per la sua partecipazione alla gestione dei processi qualitativi. Cosa significa?
Significa che una delle possibili soluzioni dei guai capitalisti, in base alla quale si potrà uscire in un futuro ormai alle porte dalle difficoltà di collocare i prodotti sul mercato, è data dalla “qualità totale”. Ogni azienda non lavora più cercando clienti, ma caratterizzando fortemente la “qualità” dei propri prodotti, differenziandosi così dalle altre e cercando di raggiungere il massimo.
Per far crescere la qualità del prodotti occorre però ristrutturare tutto il processo produttivo, dividerlo in processi separati, uno che controlla l’altro. Come se nella stessa azienda un settore fosse cliente di un altro settore, per cui il settore che commissiona una parte del prodotto, quando lo riceve (per continuare la produzione) lo controlla e insiste nel chiedere il meglio, e in caso di non corrispondenza a quanto richiesto, è obbligato a denunciare alla direzione il cattivo funzionamento del primo settore, e così fino al completamento del ciclo produttivo.
In questo modo i singoli processi in cui si è divisa la produzione (all’interno della singola azienda) fanno partecipare il lavoratore non solo alla produzione (partecipazione che è ormai piuttosto circoscritta nelle grandi unità produttive in quanto l’inserimento della robottistica ha trasformato il classico processo), ma in primo luogo al controllo.
Gli incentivi alla qualità sono infatti una carota sbandierata sotto il naso dei lavoratori e che li trasforma in poliziotti produttivi all’interno dell’azienda, smembrando definitivamente ogni traccia di unità, ogni ricordo di solidarietà.
[Pubblicato su “Canenero” n. 20, 24 marzo 1995, p. 5]
Obiezione fiscale
In diverse occasioni abbiamo manifestato una critica all’obiezione fiscale contro le spese militari, ma non abbiamo mai, o quasi, avuto modo di approfondire questa critica, lasciando le cose in una fase generica, da cui emergeva soltanto un dissenso e una diversa concezione della lotta.
Parlando con molti compagni abbiamo anche visto come, sull’obiezione fiscale, siano in circolazione molti equivoci, alcuni dei quali dovuti a una scarsa conoscenza del problema tecnico, cioè del fatto di come funzionano i finanziamenti statali all’apparato militare, di come questi finanziamenti emergono dalle voci “ufficiali” del bilancio dello Stato, di come non sia possibile una netta separazione tra le diverse voci di questo bilancio, di come non si possa sottoscrivere una condanna “soltanto” per i finanziamenti militari, perché in questo caso tutti gli altri verrebbero considerati “legittimi”.
Comunque, poiché la confusione è notevole, e non vogliamo contribuirvi anche noi, cercheremo di essere quanto più chiari possibile.
Cominciamo col dire che non si può parlare di una “tassa”. Il cittadino non paga una “tassa” per il “servizio” che lo Stato pretende di fornirgli con il suo apparato militare (difesa del territorio, ecc.). Il cittadino paga le imposte, che sono di diversa natura, una parte di queste imposte viene poi – teoricamente (e vedremo perché) – indirizzata a sovvenzionare la struttura militare.
Il concetto di “tassa” è diverso e questo errore viene anche fatto da quasi tutti i giornali (da cui molti compagni, in definitiva, attingono le proprie informazioni). La tassa è il “prezzo” che viene pagato per un “servizio” dello Stato che sia traducibile in una divisione ben precisa. A esempio, si paga un prezzo (pubblico) comprando il francobollo con cui si affranca una lettera, o un biglietto ferroviario, ecc. Ora, non è possibile una obiezione riguardo le tasse, cioè non è possibile un qualsiasi dimezzamento di quanto lo Stato impone di pagare per i servizi che si possono suddividere in unità di misura (lettera, numero di chilometri, ecc.) perché nel caso lo si facesse (poniamo si affrancasse con un francobollo di minor valore) lo Stato o non procede a “vendere” il “servizio” o applica una multa al destinatario.
Il concetto di “imposta” è diverso e non è commisurato all’entità del “servizio” che lo Stato pretende fornire. A esempio, con l’apparato militare, lo Stato pretende provvedere alla difesa della “nazione”. Per far questo, per fornire cioè di armi e di attrezzature questa immensa struttura che per facilità di espressione chiamiamo esercito, lo Stato – in sede di bilancio – provvede a staccare una quota dell’ammontare previsto delle entrate finanziarie, e la destina a tale scopo. Il cittadino può certamente pagare di meno, cioè decidersi, autonomamente, di tagliare una quota delle proprie imposte, ma ciò non modifica il finanziamento che lo Stato assicura all’apparato militare, perché qui non siamo davanti a una “tassa”, il “servizio” che lo Stato propone non è diretto a “difendere” il cittadino contro ipotetici pericoli esterni, quanto a difendere lo Stato stesso contro i pericoli che potrebbero venire da una trasformazione del qualunquista cittadino in cosciente individuo capace di fare valere i propri diritti con un’azione rivoluzionaria. Ora, questa funzione, che lo Stato considera primaria, verrebbe finanziata comunque, anche qualora lo Stato si trovasse davanti a una totale obiezione fiscale per la quota che ipoteticamente dovrebbe detrarre dal bilancio per finanziare la struttura militare. Vuol dire che non farebbe altre cose, non finanzierebbe i teatri, non curerebbe alcuni malati, non darebbe l’assistenza sociale che oggi fornisce, ridurrebbe alcune spese, o, molto più semplicemente, aumenterebbe l’imposizione fiscale costringendo il cittadino a pagare di più gli altri settori che si è detto disponibile a pagare. Ma altre contraddizioni esistono alla base del concetto di obiezione fiscale contro le spese militari.
Primo, il bilancio dello Stato non è più – da molto tempo – un documento contabile “leggibile”, nel senso che non può essere paragonato al bilancio di una società per azioni. Preventivi di spesa possono spostarsi di anno in anno, il concetto di unità di bilancio è venuto meno per la presenza di bilanci contabili allegati relativi alle amministrazioni separate, vi si trovano spese previste che però poi saranno utilizzate in modo diverso da parte di organi dello Stato a ciò autorizzati, non è chiara la specificazione delle spese. Su quest’ultimo punto, si capisce benissimo come si possono fare molti giochi di potere. In pratica c’è una distinzione in bilancio tra “spese correnti” e “spese in conto capitale”: le prime servono per far funzionare il meccanismo statale e sono specificate con attenzione (si fa per dire, in quanto migliaia di miliardi più o meno non fanno differenza); le seconde, quelle in conto capitale, servono invece per realizzare quegli investimenti produttivi che lo Stato fa per ottenere dei redditi con cui poi provvederà a fare funzionare altre strutture del proprio meccanismo. È evidente che questa parte del bilancio non può essere molto chiara e, ancor meno, si potranno prevedere i redditi futuri che si ricaveranno con quegli investimenti. E poi, nel momento in cui lo Stato ha bisogno di maggiori fondi (poniamo se l’obiezione fiscale aumentasse) per finanziare a esempio la struttura militare, potrebbe valutare in eccesso i risultati di quegli investimenti (cosa molto facile a farsi, bastando una sopravvalutazione delle giacenze di magazzino delle industrie statali) e quindi trovarsi nelle mani un reddito più alto con cui finanziare quello che vuole.
Secondo, e questa è una contraddizione che riguarda tutte le obiezioni parziali concernenti una riduzione di pagamento. La stessa mentalità di chi opera questa scelta è fondata su di un atteggiamento perbenista e democratico. Infatti, riducendo le imposte da pagare si afferma che non si intende pagare la quota relativa ai finanziamenti alla struttura militare ma, poi, nello stesso momento, si paga tutto il resto, cioè tutte quelle quote relative al funzionamento delle altre strutture dello Stato, le quali, in forza dello stesso ragionamento, risultano “buone”, allo stesso modo per cui la struttura militare risulta “cattiva”, non solo, ma la stessa attività dello Stato nel suo insieme (escluso la parte militare) risulta legittimata e quindi considerata “positiva” e da finanziarsi.
Terzo, iniziative del genere possono trovare una certa rispondenza di massa, appunto perché riscuotono la simpatia di quel ceto perbenista che ha subìto l’influsso degli ultimi venti anni di propaganda di sinistra in Italia, ma non hanno nulla di significativo dal punto di vista della lotta. Sono semplicemente una manifestazione simbolica di dissenso. Infatti, questo potenziale di massa si disgrega non appena arrivano le prime ingiunzioni di pagamento e i primi pignoramenti. Infatti, la cosa è logica. Chi paga (le imposte, per la quota che ritiene legittima) lo fa perché ha un reddito che vuole tutelare, perché ha qualcosa da difendere, perché non vuole avere le seccature che normalmente si hanno quando non si “paga” lo Stato. Ora, queste seccature scattano subito non appena lo Stato si accorge dell’obiezione fiscale e della riduzione di pagamento. Da qui le azioni giudiziarie e le relative sbracature. Ipotizzare una capacità di “resistenza” è contraddittorio, in quanto allora sarebbe stato più logico “non pagare” lo Stato in blocco, eliminando almeno la contraddizione precedente, cioè quella che finisce per legittimare le attività dello Stato diverse da quella militare.
Concludendo, non siamo d’accordo per un intervento degli anarchici nel campo dell’obiezione fiscale contro le spese militari. Salvo che non si voglia inserire la lotta anarchica all’interno di un ampio progetto simbolico di dissenso nei riguardi della struttura militare, progetto che molto più efficacemente e logicamente di noi alcune forze riformiste e (più o meno) parlamentari possono portare avanti. Utilizzare forme di lotta nei confronti delle quali, prima o poi, gli anarchici devono arrivare a prendere le distanze in modo critico, non fa altro che disperdere le nostre forze.
[Pubblicato su “Provocazione” n. 2, febbraio 1987, p. 6 col titolo “Perché siamo contro l’obiezione fiscale”]
Omosessualità
La lettera che pubblichiamo [qui di seguito] ci ha lasciato sorpresi e amareggiati. Possibile che fra compagni si possa essere costretti a tacere su alcuni argomenti, ad avere delle riserve mentali, a nascondere un aspetto così importante della propria vita com’è quello che concerne la propria sessualità?
Sulle prime la cosa sembra incredibile. Ma poi, riflettendo meglio tornano alla mente tante cose, alcune delle quali non trascurabili e che cogliamo qui l’occasione per elencare brevemente.
La diffusione epidemica dell’AIDS ha avuto un grande riscontro pubblicistico mentre da parte anarchica il problema è stato affrontato poco e male. Certo, è più che logico che non si corra dietro alle mode e ai discorsi ricorrenti che si trovano in tutti i rotocalchi, ma l’occasione per prendere il problema del “diverso” c’era ed è stata tralasciata. Perché? Forse non siamo tutti “diversi”? Forse non occorre avere qualcosa di “diverso” per essere anarchici? Forse la coscienza di classe non è una coscienza “diversa”? E allora perché il silenzio o, peggio, la disinformazione, la superficialità, la connivenza davanti alla condanna e al sospetto che cominciano a serpeggiare in un clima di caccia alle streghe?
Abbiamo anche noi un cadavere nell’armadio?
Da quanto appare dalla lettera che pubblichiamo [qui sotto] sembrerebbe di sì. Personalmente mi sono spesso trovato ad affrontare con alcuni compagni, anche tra i più avanzati nell’approfondimento della problematica anarchica e rivoluzionaria, il problema della sessualità e ho avvertito quasi un rifiuto, come il senso di disagio che si avverte perfettamente bene quando si entra in un terreno delicato, in una zona privata dove bisogna andare con i piedi di piombo per non turbare la tranquillità della proprietà privata.
Certo, lungi da me l’affermazione che il nostro comunismo deve potersi estendere tanto da diventare diritto alla violazione dell’individuo e del suo io, per quanto stranamente contorto quest’ultimo possa essere agli occhi “illuminati” di chi ha una concezione più ampia della realtà (ma poi quanto più ampia? e quanto più illuminato quel pensiero?). Però dall’imprescindibile diritto alla propria individualità, in base al quale respingere ogni assalto fastidioso e indagatore nel terreno della propria gelosa intimità, al rifiuto per principio di affrontare i problemi che derivano da questa pretesa “intimità”, la strada è notevole.
Spesso mi è parso di cogliere in molti compagni non solo la preclusione davanti a possibili esperienze sessuali “diverse” da una sclerotizzata routine che è poi alla base di non poche incertezze che scopriamo dappertutto nella nostra vita di tutti i giorni e nel nostro stesso impegno politico, ma anche la condanna delle esperienze stesse, una condanna assoluta in nome di una visione conservatrice e monocentrica dell’esperienza sessuale che ripete fino alla pazzia il ritmo continuo della famiglia-riproduzione e della fabbrica-produzione.
Di più, spesso mi è anche accaduto di sentire dopo il rifiuto e la condanna anche una spiegazione della condanna basata sul fatto che chi ha preoccupazioni di “quel” genere non può essere un “buon” compagno in quanto prima o poi i suoi “interessi particolari” per un problema così marginale (come da questi compagni è considerata la vita sessuale di ognuno di noi), finiranno per renderlo inadatto alla lotta rivoluzionaria. Tempo fa, noi della redazione di Catania di “Anarchismo” ricevemmo un volantino redatto a Bologna da alcuni compagni che si dichiaravano favorevoli alla “pedofilia” e che si lamentavano di un certo comportamento tenuto nei loro confronti da altri compagni. Purtroppo, mancando l’indirizzo in quel volantino non potemmo entrare in contatto con loro e quindi la cosa fini lì. Ma si tratta di un problema di notevole interesse [che oggi, 1999, è diventato addirittura pericoloso da affrontare]. La libertà sessuale del bambino e la conseguente libertà nei rapporti sessuali tra bambino e adulto è un punto di fondamentale importanza nello spostamento del tabù.
L’elenco potrebbe continuare a lungo ed è importante che qualcuno trovi la volontà di fare queste analisi. Purtroppo siamo ancora ai tempi del Congresso di Amsterdam del 1905 dove Kropotkin e Most (se non vado errato) impedirono alla Goldman di parlare dei problemi della sessualità perché la cosa poteva disturbare il referente operaio che si voleva organizzare.
Occorre rendersi conto che la libertà va cercata ovunque e che non esistono terreni in cui è preferibile tollerare la discriminazione e la repressione per uno scopo sia pure bellissimo come è quello che noi anarchici ci prefiggiamo. O cerchiamo la libertà con mezzi di libertà o troveremo sempre nuovi lager e nuovi fili spinati.
«Cari compagni,
«sono un compagno anarchico di * e da diverso tempo volevo scrivervi in merito a un problema che, da sempre ma specialmente in questi ultimi tempi, mi ha sorpreso e dolorosamente colpito.
«In base al grande parlare che si sta facendo in merito all’AIDS è venuto fuori anche il problema dell’omosessualità e – a prescindere da vere o presunte relazioni tra quest’ultimo modo di vivere la propria sessualità e quella malattia – sono state dette tante cose, la maggior parte delle quali ampiamente dettate dall’irrazionale moto di repulsione che sentiamo di fronte a tutti i “diversi” o presunti tali.
«Non mi interessa, almeno adesso, il problema dell’AIDS ma mi interessa il modo di porsi nei riguardi dell’omosessualità.
«Sono un compagno anarchico e sono omosessuale. Ebbene, da sempre non sono riuscito a trovare il “coraggio” di rivolgermi ai compagni non solo in quanto militante, ma anche in quanto omosessuale.
«Sono certo che non sarà difficile trovare coloro che mi rimprovereranno di questa “mancanza di coraggio” e, senza dubbio, potrebbero avere ragione. Ma c’è una cosa che noto all’interno del movimento anarchico italiano (e straniero, almeno per quel poco che mi è dato conoscere): una chiusura davanti al problema, una scelta di origine chiaramente pietistica, se non proprio reazionaria, una preclusione nel considerare le scelte sessuali come elemento non scindibile dalla propria militanza rivoluzionaria, quando non mi pare di cogliere i chiari sintomi di un sospetto e di un’insofferenza che fanno veramente star male».
[Pubblicato su “Anarchismo” n. 48, settembre 1985, p. 4 col titolo “Si può essere anarchici e omosessuali?”]
Ordine
Ognuno ha le sue opinioni. Io ho ascoltato con attenzione il tuo intervento, tu hai una posizione, quella classica: la lotta di massa, creazione di certe strutture che si possono fare interpreti di questa necessità della massa, filtrare queste necessità, sintetizzarle all’interno di un progetto politico, ecc. Io non condivido un’ipotesi del genere, non da un punto di vista astratto, ma pratico: ritengo che le condizioni in cui viviamo sono mutate, per cui, davanti a una trasformazione reale, consistente e veloce del capitale, e della condizione economica, quel tipo di impostazione sia superata; questa potrebbe essere un’opinione come un’altra. Mentre a me non sembra un’opinione, ma una critica puntuale.
Invece, i rapporti che ci sono tra i gruppi di affinità possono dare vita a delle organizzazioni informali che si muovono diversamente e che possono anche raggiungere considerevoli livelli di intervento nella realtà, ma non organizzare direttamente la gente, non organizzare la massa. Ecco: quel tipo di progetto evidentemente non può essere portato all’interno di un discorso che parte dai gruppi di affinità. Ognuno ha il suo modo di vedere. Io non condivido l’ipotesi, a esempio, del municipalismo libertario, ma non la condivido non perché la parola mi fa antipatia, non la condivido perché non la ritengo uno strumento di lotta adeguato. Non mi piace, non mi attira, la vedo spostata nel tempo, la vedo erede di alcuni errori del passato che andrebbero sottoposti a una maggiore critica. Tutto qua.
È chiaro che sia in un’ipotesi, chiamiamola, consentite, di organizzazione di sintesi, come potrebbe essere un’organizzazione libertaria che guarda alle lotte di massa come un possibile referente per proporre determinati indirizzi; sia in un’ipotesi come quella di un’organizzazione di natura informale, che non parte da questi presupposti, ma si fa le sue cose partecipando alle lotte; queste due ipotesi di lavoro rivoluzionario, o attività, come vogliamo chiamarle, partono ambedue da una condizione di partenza, che è quella dell’esistenza nella realtà di movimenti spontanei, che hanno capacità di autorganizzarsi. Senza questa condizione di partenza, sarebbero cieche le due soluzioni, non avrebbero alcuna prospettiva. Quindi l’ipotesi di un’organizzazione di sintesi, che invece si struttura in maniera permanente per costituire un punto di riferimento stabile nella realtà, verrebbe, sotto molti aspetti, a negare questa capacità autorganizzativa che sta all’esterno. Ho detto dentro certi aspetti, non in assoluto, perché non è un governo o un partito. E questo costituisce un problema che deve essere chiarito, non so in quale sede. Mentre, viceversa, l’organizzazione informale dà per scontato che questo movimento autorganizzativo, questo ordine spontaneo nella realtà esiste, che non sia liberamente identificabile in qualunque occasione, in qualunque momento, ma che sia presente come forza spontanea delle cose. Penso che questo aspetto sia stato sempre trascurato. Non sto parlando di un discorso deterministicamente indirizzato verso la realizzazione di certi obiettivi, come è stato accennato, non sto suggerendo la presenza all’interno della storia di una linea progressiva che va dal passato negativo verso il futuro positivo, anzi sono su posizioni nettamente contrarie. Non sto suggerendo di rivalutare l’ipotesi del seme sotto la neve di Kropotkin, o cose del genere. Non c’è nulla dentro la storia che possa garantirci, nessun meccanismo che realizzi, secondo come ipotizzava Hegel, lo spirito oggettivo della realtà o lo spirito del tempo che si realizza nella storia.
È tutto da giocare, secondo come la penso io, e quindi il nostro intervento deve inventarsi le condizioni che possono esistere, perché è chiaro che nella storia non c’è nessun progresso. Facciamo un ultimo esempio, pensavamo che condizioni come Auschwitz fossero per sempre finite e per sempre passate, come appartenenti alle mostruosità del passato, e invece ce le troviamo di nuovo sotto gli occhi nell’ex Jugoslavia, la barbarie del passato ritorna un’altra volta nel presente. Non c’è nulla che possa essere considerato definitivamente superato, tutto si oltrepassa in un movimento storico che non è mai garantito, perché possa essere tranquillamente affidato verso un indirizzo futuro. Quindi io non sto parlando di un ordine spontaneo nel senso di un ordine della storia, ma di un ordine spontaneo nel senso della vita nella società. Ricondurre la società degli uomini (e il fatto di vivere), soltanto alla sua dimensione storica, cioè a dire al fatto di essere tenutaria, depositaria, di un passato e passiva spettatrice di un futuro che si avvicina, è questo uno degli errori più grossi che sono stati commessi.
Quindi, quando parlo di ordine spontaneo intendo riferirmi all’ordine spontaneo della società, non a un meccanismo supposto intrinseco alla storia.
[Parte del dibattito seguito alla Conferenza dal titolo “Anarchismo e democrazia” da me tenuta a Bologna il 16 marzo 1995 presso la Facoltà di lettere e filosofia. Trascrizione della registrazione su nastro]
Pagliacci
Accade sovente che ci si faccia scudo con i sacri princìpi dell’umanità. Per quanto possa sembrare strano, trattandosi a volte di idee in circolazione da tanto tempo, da avere il più delle volte perduto la loro originaria pregnanza e forza d’urto, quanto più esse sono nebulose, tanto più risultano idonee a nascondere il coniglio che le utilizza.
Il problema dell’altro uomo, del nostro simile, o fratello in “umanità”, è certamente uno di quelli in cui più frequentemente accade di sentire il bisogno di nascondersi dietro le solite quattro chiacchiere retoriche fondate sui grandi principi. Difatti, nello specchio delle preoccupazioni più intime, ognuno di noi riflette il proprio destino e l’incapacità di gestirlo, di indirizzarlo verso un minimo di progetto concretamente realizzabile, e di queste incertezze ama illudersi che sia gestore l’individuo isolato, con la sovranità delle sue scelte esistenziali, mentre dappertutto danzano davanti dai suoi occhi fantasmi e rappresentazioni facilmente catalogabili. Che poi la realtà non sia proprio così, la cosa ha poca importanza, se riusciamo bene o male a sopravvivere considerandola “come se fosse” in questo modo.
È degli altri che non vogliamo sentir parlare, se non filtrando il riflesso che avvertiamo fin dentro la nostra profondità di vita, attraverso idee rassicuranti, meccanismi retorici di consolazione e sostegno. Ci arrivano, in questo modo, collocazioni individuali, identificazioni di classe, ceti e strati sociali, qualificazioni di categorie, separazioni fittizie, colorazioni di pelle, differenze di sesso, di abitudini, di costumi, di gusti, di desideri, di sogni. Ogni stimolo, ogni urto, ogni singola pressione, esercitati su di noi, costituisce sollecitazione e disturbo. Non possiamo tollerarli a lungo, così ci inventiamo una fede, una dichiarazione di appartenenza a schieramenti ben precisi. Vogliamo che tutti sappiano, e noi in primo luogo, che apparteniamo a qualcosa o a qualcuno, che siamo sotto il riflesso di un’idea o di un gruppo, associazione o partito, congrega o assembramento mafioso, insomma un’entità capace di dare sanzionamento pratico alle idee retoriche dietro cui continuiamo a nasconderci.
Di regola ci sfugge un punto semplice ed essenziale. Tanto semplice ed essenziale che mi sono chiesto molte volte se il fatto di lasciarcelo sfuggire, sistematicamente, dipenda da nostre incapacità o da una strategia sottile della coscienza, qualcosa di simile a un meccanismo di difesa che ci fa sistematicamente retrocedere di fronte al pericolo, un condizionamento procurato dalla necessità di sopravvivenza. Tanto la riflessione è facile, che incute timore. La dico in due parole: nessuna affermazione teorica, di per sé, ha senso se non la si vive nella realtà, nella propria realtà, nella vita di tutti i giorni. Uno può tranquillamente dirsi antirazzista e poi impiegare una moltitudine di schiavi negri al proprio servizio. Le due cose non sono, di per sé, impossibili a realizzarsi contemporaneamente. Il fatto di richiamarsi a un raggruppamento, un’idea, un simbolo, un insieme di teorie, non qualifica nessuno in pratica, non obbliga nessuno a un comportamento al posto di un altro. La vita è piena di contraddizioni e non sarà una in più o in meno a renderla impossibile. Ci diciamo antirazzisti, ma ci limitiamo soltanto a dire qualche giaculatoria da conventicola, togliendoci il gusto di frequentare alcuni ambienti, anziché altri, di vedere alcuni film al posto di altri (ma quale film, ormai, potrebbe essere considerato razzista?), di sorridere paternalisticamente al nero che ci chiede di acquistargli l’ennesimo accendino, facendo uno sforzo per concedergli quel piccolo obolo che gli permetterà di sopravvivere nella propria miseria. Naturalmente ci indigniamo esterrefatti davanti ai comportamenti aggressivi di beceri razzisti, i quali neanche loro sanno bene quello che fanno, ma attaccano imbestialiti ciò che ritengono estraneo e diverso dalla propria imbecillità e miseria, affermando in questo modo l’ineluttabile e insuperabile limitatezza di ogni pratica non assistita dalla riflessione e dal sentimento.
Nel momento in cui, con un poco di analisi in più, ci disponiamo a riempire di contenuti quelle quattro chiacchiere retoriche fondate sull’umanitarismo, la nonviolenza, l’uguaglianza, la libertà, la fraternità, ci rendiamo conto di avere poca roba da mettere dentro. Tutta la nostra pratica di vita è sistematicamente estranea a quei princìpi, come può essere estranea la realtà alla fantasia o il concreto al fittizio. Possibili parallelismi si possono certo riscontrare, ma si tratta di accostamenti accidentali, parziali sempre, inaccessibili reciprocamente. Tutta la nostra vita è fondata su pratiche che negano sistematicamente quei valori astratti, i quali possono essere accettati, in pieno e acriticamente, proprio perché sono esterni alla nostra realtà. La sera chiudiamo ben bene la porta d’ingresso, serriamo stretti nel nostro pugno quei quattro soldi che siamo riusciti a strappare al meccanismo della produzione capitalista, prostituendoci in qualche modo più o meno onorevole, contribuiamo nei limiti strettamente indispensabili al mantenimento di quel parco-opinioni da cui possiamo attingere per le nostre necessità consolatorie, sigilliamo la nostra cerchia di “conoscenze”, “amicizie” e “frequentazioni”, avvertendo un leggero brivido su per la schiena quando siamo costretti a spezzare più o meno bruscamente le garanzie del ghetto. Altre volte, scendendo dall’empireo delle nostre considerazioni a priori, ci abbassiamo fino agli altri, scimmiottando “diversità” che non sono le nostre allo scopo di farci accettare in un altro ghetto, dove viviamo malissimo, gratificandoci però con l’idea del grave sacrificio che stiamo sostenendo per il bene dell’umanità.
Potremmo accreditarci di qualcosa, forse modesta ma sempre concreta, se realmente avessimo l’intenzione di comportarci in modo adeguato a quei princìpi che andiamo sostenendo. Non l’uguaglianza nell’appiattimento, ma nella diversità, e per far questo non limitandoci ad affermare che tutti gli uomini sono uguali, cosa per altro non vera, ma che sono diversi e come tali ugualmente titolari della propria diversità, senza che nessuno possa arrogarsi il compito di schiacciarla in uniformazioni o subordinarla ad accettazioni sgradite in nome di bisogni superiori, economici o ideologici. E di questa “diversità”, diventata adesso patrimonio di tutti, farci difensori e affermatori indefessi, in quanto ogni attacco subito da essa diventa un attacco alla nostra propria identità, si trattasse pure di un singolo individuo sperduto nel più remoto angolo di mondo. Ma, fermandoci a questo punto, pur avendo di certo fatto un passo avanti, non saremmo ancora in grado di concedere fondatezza alle nostre idee, genericamente umanitarie, quindi inconsistenti per definizione. Dovremmo quindi fare il passo decisivo, dovremmo trovare la forza per identificare e attaccare coloro che, nella pratica, anche dicendosi antirazzisti, favoriscono, consentono e facilitano la reale segregazione delle diversità, di tutte le diversità, impedendo un superiore livello in cui ogni diversità contribuisce a creare il patrimonio comune da cui tutti possiamo attingere.
Ma qui torna fastidiosamente il contrasto tra l’essere e il voler essere. Non basta avere coscienza di dover fare una determinata cosa, occorre anche farla, e si può passare tutta una vita in angosciosa attesa del momento in cui si potrà fare qualcosa che comunque da tempo andava fatta, senza riuscire mai a decidersi di farla. La lotta fondamentale è ancora una volta contro tutti quegli ostacoli che ci legano alle condizioni in cui viviamo, condizioni di fatto, specifiche, amaramente riverniciate allo scopo di farle sembrare diverse da quello che sono: tragiche catene di schiavitù.
Nel mondo baluginante della retorica non c’è posto per la concretezza. Viceversa c’è sempre modo di dare spazio alle polemiche e alle critiche, osservando quello che gli altri fanno, per identificarvi il piccolo pelo che non può minimamente paragonarsi alla trave che ospitiamo nel nostro occhio. Più ci rendiamo conto di essere imbroglioni e pagliacci, recitanti una farsa triste e ripetitiva, più cerchiamo di coprire le nostre incapacità e i nostri inutili tentativi di ingannare gli altri e noi stessi, con una serie puntigliosa di critiche ai comportamenti altrui, a coloro che pur errando, a volte, qualcosa cercano di fare, identificando obiettivi e colpendoli, non troviamo di meglio che sottolineare l’incapacità di questi attacchi a risolvere il problema dello scontro di classe, come se quelle azioni avessero mai preteso affrontare un qualsiasi problema e, tanto peggio, risolverlo. La puntigliosa cattiveria che manifestiamo in questi casi è, per molti aspetti, il segnale chiarissimo di desideri insoddisfatti, della tragica amarezza che circonda le nostre giornate di impiegati al catasto, di professori rincoglioniti nelle ricerche del nulla, di operai incartapecoriti nella buccia vuota della propria idea centrale di classe, leva della rivoluzione. I rivoluzionari non fanno eccezione. Se non sono capaci di leggere criticamente nella propria vita, non rappresentano altro che la propria miseria reificata, il sogno d’una cosa che per realizzarsi si vede costretto a trasformarsi in semplice fantasia, in immaginazione di ciò a cui si è rinunciato fin dall’inizio.
[Pubblicato su “Anarchismo” n. 67, maggio 1991, pp. 34-36 col titolo “L’antirazzismo come esercitazione retorica”]
Partecipazione
È probabile che in futuro il carcere si espanderà nel territorio. La vecchia ideologia della correzione sociale, che si illudeva (in cattiva fede) di modificare con la pena, sarà sempre di più sostituita con l’ideologia del controllo e del consenso.
Il luogo chiuso dà, in effetti, scarse garanzie di controllo. Oltre ad alimentare tensioni sociali, il carcere, nella sua forma tradizionale, diventa sempre più contraddittorio e dispendioso.
Più facile la costruzione di un muro attorno alla classe dominante. Ma non un muro di mattoni, un muro di “diversità”: diversità di linguaggio, di interessi, di scala di valori, di prospettive, di cultura, ecc.
Non sarà facile scavalcare questo muro. Per gli irriducibili, per coloro che daranno segni di notevole pericolosità per le mire di controllo del potere, saranno sempre pronte le carceri tradizionali, rese sempre più isolate, più “super”, più “speciali”.
L’annientamento fisico sarà sostituito alla vecchia ortopedia sociale. Il carcere tornerà al vecchio ruolo di sistema razionale per ottenere, nel più breve tempo possibile, la morte del detenuto. Le illusioni illuministe tramonteranno definitivamente.
Ma, a parte questa minoranza di irriducibili, quello che conta, per il potere, è il controllo della gran massa degli sfruttati. E questo controllo dovrà per forza essere realizzato in modo “consensuale” e non in modo “obbligatorio” o violentemente contraddittorio.
Il primo obiettivo da raggiungere da parte del potere sarà, quindi, quello della “partecipazione”. Il maggior numero di persone dovranno essere incluse in progetti di “recupero”, a tutti i livelli, con i quali tutti avranno l’illusione di “partecipare” alla gestione della cosa pubblica, alla programmazione della propria vita.
Ogni struttura sociale verrà impostata sulla partecipazione ma, nello stesso tempo, una piccola parte (tenuta maggiormente segreta) funzionerà con scopi tutt’altro che partecipativi.
La produzione sarà senz’altro più alleggerita, con turni meno gravosi, ma una netta separazione si avrà tra gli “inclusi” che daranno gli ordini e gli “esclusi” che dovranno metterli in pratica.
L’istruzione sarà realizzata attraverso la scuola di massa, che potrà perfezionare il superiore meccanismo di “esclusione”, fornendo un linguaggio ridotto e una cultura costruita apposta per gli “esclusi”; ma, nello stesso tempo, si avranno posti, per privilegiati, in cui l’istruzione verrà fornita a livelli altissimi, per rendere possibile proprio la continuazione della divisione in classi.
La vita delle città sarà sconvolta anche dal punto di vista urbanistico, con la sostituzione dei quartieri ghetto con i grandi palazzoni dormitorio. Ma le classi del privilegio si ritroveranno altrove, ben chiuse nella loro “incomprensibilità” nei riguardi degli esclusi.
In una società così profondamente controllata, in cui la divisione fondamentale in classi (tra esclusi e inclusi) viene camuffata da una “partecipazione” a tutti i livelli (parlamentare, sindacale, scolastico, lavorativo, sanitario, amministrativo, ecc.), non è più possibile parlare di repressione in termini tradizionali.
[Pubblicato su “Anarchismo” n. 52, maggio 1986, p. 14 col titolo “Carcere e partecipazione sociale”]
Dalla parte degli operai
I fighter di Greenpeace hanno litigato con la Shell nel Mare del Nord. Il problema di per sé non avrebbe richiamato la nostra attenzione se non ci fosse stato il risvolto del modo in cui la lotta si è svolta questa volta e delle caratteristiche dei partecipanti.
La materia del contendere riguardava la piattaforma petrolifera Brent Spar che la Shell vuole spostare da dove si trova e affondare in pieno Atlantico a migliaia di metri di profondità. Gli ecologisti sono contrari perché la piattaforma porta con sé un carico di 100 tonnellate di arsenico, cadmio e piombo, oltre a 30 tonnellate di rifiuti radioattivi.
L’attacco della nave di Greenpeace, la “Moby Dick”, è stato respinto dalla Shell con potenti getti di acqua che hanno gettato in mare molti manifestanti e fatto rovesciare una scialuppa.
Ed eccoci al fatto da sottolineare. Spesso gli uomini di Greenpeace si scontrano con la polizia, e qui, prima di ogni lotta, fissano i termini del confronto: gli strumenti da usare, le regole del gioco, i limiti da non superare. Non è un caso che non ci sono mai stati gravi incidenti, né fra gli assaliti, né fra gli assalitori. Ma questa volta, a difendere la Shell, la “loro” Shell, non c’era solo la polizia, e il servizio d’ordine della compagnia petrolifera, ma anche gli operai della piattaforma e quelli delle piattaforme vicine. Insomma, questa volta lo scontro è stato tra “ecologisti” da un lato e “operai” dall’altro. E gli operai non scherzano. Quando difendono il proprio lavoro non scherzano.
Cosa volete farci? gli operai sono così.
[Pubblicato su “Canenero” n. 31, 16 giugno 1995, p. 8]
Particola
È stato giustamente messo in rilievo l’anacronismo di comportamento della Chiesa cattolica nei confronti di alcuni suoi aderenti che modificavano imprudentemente la composizione della particola sacra in cui si consolida e prende vita il corpo e il sangue del dio vivente.
Che questa massa incredibile di stupidaggini attiri anche oggi l’attenzione della Chiesa cattolica e la veda sollecita a rimproverare coloro che modificano la sostanza del suo simbolo eucaristico non deve sorprendere. In effetti tutta l’impalcatura di potere di questa organizzazione si fonda sullo spirito oggettivo, cioè sul contenuto materiale del simbolo, a prescindere dalla volontà e dalle decisioni dell’individuo. Questo è stato sempre un punto di forza della struttura di potere cattolica.
In pratica, nella messa, il sacrificio divino (trasformazione del pane e del vino nel corpo del dio) avviene automaticamente al semplice pronunciare di alcune precise parole da parte dell’officiante (a sua volta investito in modo permanente di precisi poteri da parte dei suoi superiori). In questo modo la struttura gerarchica è assicurata in assoluto. Il dipendente vede nel superiore colui che possiede il segreto di trasformare la realtà, di cancellare i peccati, di imprimere un carattere, di contrarre un legame, a prescindere dalla sua persona, dal suo valore come individuo. Ciò tranquillizza e rende docili.
In questo modo si spiega il dilagare di incredibili nefandezze commesse da questa organizzazione durante tutta la sua storia: dalle atrocità delle torture dell’Inquisizione, alle condanne a morte sul rogo; dal sostegno dato dovunque a tutte le forze al potere (nazisti compresi), agli imbrogli finanziari, alle speculazioni, agli arricchimenti, agli stupri.
Quella stessa persona [a esempio, Marcinkus] che maneggia miliardi attraverso la Banca vaticana (IOR), e che ha avuto i suoi intrallazzi con la mafia di Sindona, con gli imbrogli speculativi della Banca Privata e della Franklin Bank; quella stessa persona, basta che alzi le mani e dica determinate parole. perché tutti possono stare certi che il mistero della reincarnazione avvenga senza dubbio e senza possibilità che qualcuno (superiori compresi) lo possa modificare.
La forza della Chiesa cattolica è proprio in questo gigantesco meccanismo di ubbidienza assoluta all’oggetto, alla parola, al rito, al simbolo. Nessuno può impedire un processo oggettivo, nemmeno il papa in persona. Pensate alla grande potenza di convincimento che un’idea del genere ha esercitato per secoli.
In fondo la gente vuole che qualcuno indichi un meccanismo che funzioni anche contro la loro stessa volontà, che sia oggettivo, che nessuna forza contraria possa modificare. La cosa rassicura e consente piccole deviazioni, comportamenti diversi che però presuppongono un ritorno sul binario diritto dell’oggettivamente eterno.
In questo modo qualsiasi misfatto si giustifica, purché il meccanismo continui a funzionare.
Allo stesso modo funzionava fino a qualche tempo fa il mito del meccanismo oggettivo dello sfruttamento che doveva portare, secondo la Chiesa marxista, alla liberazione sociale. Poi ci si è accorti che questo meccanismo subiva continue modificazioni da parte del capitale e che senza un intervento soggettivo degli sfruttati la cosa poteva continuare all’infinito. Ma quella illusione aveva cullato i sogni dei proletari e dato anche una giustificazione al loro comportamento accomodante e contraddittorio. Adesso facciamo la guerra, ci accordiamo col padrone, lavoriamo in una fabbrica di armi, accettiamo la tutela sindacale; tanto il meccanismo oggettivo funziona per conto suo e lavora al nostro posto per la rivoluzione. Questo colpevole ragionamento è assai simile a quello che la gente si fa nei riguardi del mito oggettivo della Chiesa cattolica.
L’appello alla responsabilità personale, alla critica, all’indagine, all’approfondimento è sempre spiacevole in quanto revoca in dubbio le certezze acquisite, risveglia dai torpori, mette in corpo inquietudine e desideri dapprima ignoti.
Ma questo, in fondo, è il compito dei rivoluzionari anarchici: distruggere le illusioni dappertutto, dentro i tabernacoli religiosi e dentro le casseforti dei partiti.
[Pubblicato su “Insurrection” n. 2, settembre 1984, p. 14 col titolo “The Church and the Objective Spirit”]
Un piccolo uomo a Singapore
La Barings è una piccola banca d’affari londinese assurta alle prime pagine di tutti i giornali per il crack subito a seguito delle disastrose operazioni in cambi condotte nella Borsa di Tokyo da un suo dipendente, l’operatore Nick Leeson, agente nella filiale di Singapore.
Di per sé la notizia non meriterebbe nessuna attenzione se non quella dilettantesca e folcloristica che da decenni ormai, il giornalismo scandalistico di tutto il mondo riserva alle vicende economiche, riducendole a una sorta di storia rosa nell’ambito delle famiglie dominanti gli affari, la finanza e la produzione industriale.
Ma che vuol dire, realmente, quello che è accaduto? È il segno di una mentalità speculativa che si va diffondendo non solo fra le piccole banche, alle quali è dato muoversi come pericolose torpedini nel mare sempre più burrascoso delle principali Borse internazionali, ma anche fra i colossi del settore. La possibilità di realizzare guadagni eccezionali è talmente facile da modificare non solo la disponibilità dei singoli all’avventura e al rischio del gioco, ma anche i progetti dei più avveduti e prudenti banchieri.
Uomini come Leeson non sono nulla di eccezionale. Sono qualcosa in più, ma proprio poco, di semplici impiegati di banca che operano come intermediari nelle borse. Operatori che trasmettono ordini di acquisti e vendita nell’ambito dei cambi e delle valute. Nell’ottica di questo flusso di denaro fittizio, ma traducibile in moneta sonante al momento dei rendiconti periodici, quando cioè si tirano le somme di quello che si è comprato e venduto, la crescita delle somme contrattate è senza limiti. In più, la telematizzazione dei contratti di acquisto e di vendita ha reso possibile variazioni velocissime che prima erano impensabili.
Ciò ha parecchie conseguenze. Accenniamo a due fra le più importanti. Queste speculazioni, fino a poco tempo fa impensabili, permettono dentro certi limiti di riportare in equilibrio il mercato internazionale (almeno quello delle Borse dominanti), dando tempo e modo ai colossi dell’economia mondiale di correre ai ripari, cioè di attutire i colpi che reciprocamente si danno nella conquista dei mercati, nella ricerca delle migliori commesse, nella scelta dei programmi e delle linee produttive, nell’imposizione di nuovi prodotti e nuove idee di consumo. Mentre prima, di fronte ai rischi di un crollo in Borsa, le strategie delle singole multinazionali erano più discrete e prudenti, adesso si sono fatte più arrembanti. Piccoli e insignificanti omuncoli come Leeson, lavorano come schiavi, nel chiuso delle loro gabbie dorate, per rendere possibile questa nuova realtà telematica.
Secondo punto. Le banche hanno assurto adesso a una importanza senza precedenti. Non sono più cassieri, ma sono anch’esse operatrici economiche. Lavorano cioè in proprio, progettano e gestiscono larghe porzioni del mercato finanziario. Infine, si creano livelli di scommessa sempre più alti (come quello basato sui cosiddetti “derivati”, cioè sull’andamento degli indici delle varie Borse mondiali), dove non c’è più il rapporto con la concretezza, sia pure rarefatta, delle singole imprese produttive.
È ovvio che alla fine di tutto ciò, nel crack di una singola banca e nella ovvia copertura da parte delle altre banche chiamate a correre ai ripari, c’è un costo da pagare.
Vi lasciamo immaginare chi pagherà questo costo.
[Pubblicato su “Canenero” n. 18, 10 marzo 1995, p. 2]
Giandomenico Pisapia
La ruota esterna del carro statale.
Giandomenico Pisapia, avvocato penalista fra i più noti, è morto a Milano. Dalla carriera bruciante, è un giovanissimo e brillante avvocato, poi arriva anche la laurea in filosofia, poi la docenza prima a Modena e infine a Milano, di Diritto penale e di Procedura penale. Temuto nelle aule dai giudici, sceglie con accuratezza i processi, non soltanto sulla base di quanto c’è da guadagnare, ma anche, come nel caso del processo al giornalino dei ragazzi del Parini, “La Zanzara”, sulla pubblicità che ne ricava. Nel processo per il disastro del Vajont difende l’Enel. Uno dei suoi ultimi processi è quello in cui difende Muccioli dalle accuse di avere incatenato i ragazzi a San Patrignano. Nel processo Enimont difende La Malfa. Infine, il Codice di procedura penale, dovuto in massima parte al suo impegno. Un monumento, come ogni codice, all’idiozia umana e al sogno dei “giusti” di giustiziare tutti i colpevoli con giustizia.
Tutto qui.
[Pubblicato su “Canenero” n. 17 del 3 marzo 1995, p.11]
Polizia
La concezione moderna della polizia, per quanto strano possa sembrare, è tale proprio perché regge un significato restrittivo, cioè si chiude all’interno della pubblica sicurezza, della sicurezza dei cittadini. Oggi si parla di polizia proprio perché è diventato possibile staccare un’attività politica di natura differente, cioè come organizzazione del potere statale in senso più ampio e sufficientemente astratto. Non è senza interesse guardare all’evolversi di questa distinzione, anche perché essa potrebbe avere ormai fatto il suo tempo e si potrebbero ripresentare, come di fatto si annunciano, tentativi di accorpamento tra le due attività di potere.
I Greci non possedevano una polizia, né avevano l’idea di un sistema organizzato di pubblica sicurezza. Anche i Romani ne mancavano e vi supplivano con la medesima struttura politica dello Stato, da cui l’antico termine politica, ricalcato dal greco politeia. In epoca moderna, per trovare teoricamente una concezione della polizia nel senso della sicurezza interna occorre arrivare all’epoca dei teorici della Ragion di Stato, cioè Botero e altri. Nel secolo scorso, in Italia, Tommaseo poteva addirittura considerare come assente dalla lingua italiana il termine polizia e valutarne l’uso come qualcosa di scorretto, un grecismo da condannare. Frattanto, di fronte ai problemi linguistici, la pratica dei delegati di polizia andava diffondendosi e, il fatto, come sempre succede, sostituiva la teoria. Gli Inglesi si preoccupavano, nel Settecento, di distinguere tra police, intesa come governo di una città, di un luogo, e policy, l’arte del governo di un regno o del “commonwealth”, dove la distinzione si fece anche dalle nostre parti con quelle due attività che vennero precisate reciprocamente come “bassa” e “alta” polizia.
Di queste incertezze pratiche e teoriche, dove non era secondario il problema della virtù da ricercarsi nell’alta polizia, mentre nella bassa ogni commercio di manutengoli veniva tollerato, si vede ancora l’eco moderna nelle incertezze teoriche che si collegano al termine politica. L’antica politeia ignorava il problema della sicurezza pubblica, perché poteva limitarsi alle regole e alle formule in base alle quali si vive insieme in una comunità, ricca certamente di conflitti, ma dove i conculcati avevano uno stato loro irrimediabile, la schiavitù, che non poteva far pensare a ribellioni se non talmente estreme da attenere direttamente alla guerra civile. Né custodia di beni e persone potevano far sorgere problemi attuali, quando la maggior chiarezza della distribuzione di classe permette di identificare consistenti masse di persone fortemente in credito di beni, e quindi vogliose di rimettere la bilancia in pareggio, in qualsiasi modo. E la paura che questa pressione enorme ha provocato non ha fatto solo allargare le viuzze medievali (dove ci si difendeva agevolmente dai saccheggiatori e dai pirati, e poco agevolmente da una sommossa popolare), ma ha creato corpi permanenti di pubblica sicurezza.
Lo Stato moderno, astrattamente, giustifica se stesso come unico garante della condizione “civile” che consente ai cittadini la certezza della propria esistenza fisica, priva da attacchi ingiustificati. Questa finzione trova, di volta in volta, limiti di applicazione mutevoli in conseguenza dei rapporti di forza consentiti dallo scontro di classe, comunque, al di là di questi mutamenti, trova anche un limite concreto nell’istituzione poliziesca. Il fondamento fittizio non sta tanto nella pretesa di garantire, perché lo Stato in effetti garantisce mediamente qualcosa e non solo ai benestanti, ma nella pretesa di indicare, nello sviluppo storico progressivo delle istituzioni di sicurezza, un miglioramento certo della convivenza civile. La polizia, come attività statale non è sfuggita, nei moderni Stati democratici, a questa illusione storicista, per cui oggi sembrerebbe potersi concludere, e di fatto in questo modo si conclude a ogni nuovo attacco fuorilegge, che tanto più si sviluppa la polizia, tanto più aumenta la sicurezza, equazione che si dimostra errata non appena viene posta con un minimo di correttezza non ideologica.
Nelle linee di sviluppo attuale dello Stato, nell’ambito delle grandi potenze postindustriali, sembrerebbe legittimo individuare movimenti riorganizzativi delle attività di polizia in senso stretto, cioè di pubblica sicurezza, e ciò al di là delle istituzioni specifiche che queste attività svolgono diciamo da un secolo e mezzo a questa parte. Sono due i corpi statali che sembra stiano per essere coinvolti: l’esercito e le comunità locali dei cittadini. Quest’ultima espressione della vita in comune, su cui si hanno poche considerazioni che non siamo macchiate di preconcetti deterministi, andrebbe studiata a fondo e non ne possiamo trattare qui in dettaglio. Voglio solo dire che strutture, poniamo, come i sindacati e i partiti, o come i comitati di quartiere, per finire nelle parrocchie o nei gruppi polisportivi di zona, sono di già mature per assumere un ruolo preventivo poliziesco, supportando nei fatti le attività repressive dirette. La televisione, integrandosi con i programmi di coinvolgimento in atto nelle scuole e in tutte le altre attività sussidiarie del tempo libero, sta a poco a poco rendendo possibile tutto ciò.
L’esercito, da parte sua, sta velocemente trasformandosi in corpo di polizia interno. Sulle modificazioni riguardanti l’assetto politico internazionale, verificatesi in questi ultimissimi anni, tutti siamo sufficientemente edotti, quindi non vale la pena fornire dati, ma pochi penso stiano riflettendo a fondo sul significato di una trasformazione del militarismo tradizionale nel senso poliziesco vero e proprio. Le preoccupazioni di pubblica sicurezza si allargano, nello stesso momento in cui i compiti tradizionali dell’esercito si restringono all’interno in quanto fattispecie poliziesca. Ne risulta che questa restrizione che potrebbe fare mugugnare qualche vecchia pelle nostalgica delle parate militari, corrisponde di fatto a un allargamento delle funzioni militari e, per un altro verso, a una forma tutta moderna e impensabile appena qualche anno fa, di militarizzazione della società.
Ciò fa apparire inadeguato il discorso antimilitarista così come l’abbiamo impostato fino a oggi, raffrenato nell’antagonismo fittizio verso simboli e divise, bandiere e giaculatorie. Come spesso accade, più si sta attenti agli effetti esteriori, meno si capisce dove ci stanno indirizzando senza farcene accorgere. La funzione di polizia torna a diventare implicita al termine professionale della politica, e lo Stato che correva il rischio di apparire stupidamente repressore, se ne viene fuori rifondandosi completamente tutto sulla repressione, ma di nuovo conio. La tutela della società intesa come “bene comune” serve, ancora una volta, a contrabbandare la tutela esclusiva degli interessi di una parte della società contro le pretese dell’altra parte.
Le trasformazioni produttive della società postindustriale rendono quindi indispensabili altrettante modificazioni nel complesso istituzionale delle forze armate di un paese democratico di considerevole importanza e di una certa dimensione. La funzione di polizia interna, quindi di ordine pubblico, rimbalza direttamente a livello internazionale, producendo interventi di polizia nei riguardi di Stati che si trovano in una posizione economica subalterna e che quindi possono presentare elementi di instabilità politica ed economica. Cambia la mentalità militare, come cambia la formazione del complesso industriale e militare. Adesso gli eserciti non si proiettano più nella fase classica di difesa, ma cercano di prevenire possibili movimenti interni ed esterni, ponendo le basi per interventi ortopedici anche a medio termine. Il concetto stesso di difesa si allarga e viene a sovrapporsi a quello di interessi produttivi del singolo paese o dei diversi gruppi di paesi che si fronteggiano in una mai sopita concorrenza economica. Lo spazio per la circolazione di una determinata tecnologia, corrisponde più o meno esattamente a quel primitivo e arcaico modo di concepire lo spazio vitale che a suo tempo dette vita all’avventura hitleriana verso Est. Ciò riporta allo scoperto i legami che esistono tra le maggiori aziende industriali e le forze armate, legami che si concretizzano sia nella rotazione delle commesse, come nella collaborazione reciproca, scambi di personale, interventi politici, autorizzazioni, funzioni esecutive di controllo e tutela interna ed esterna. I processi produttivi finiscono così per compenetrarsi con gli interessi e le prospettive militari, con assumere decisioni in contemporanea, in quanto eventuali valutazioni errate potrebbero danneggiare le intenzioni e i progetti di una delle due componenti, per concludere con una gestione coordinata anche delle condizioni di allarme in cui bisogna tenere la società allo scopo di rendere legittime e possibili non solo le decisioni produttive, ma anche le coperture militari spacciate come strumenti per mettere fine a quell’allarme.
L’antica ipotesi, cara alla sociologia americana degli anni Trenta, di uno Stato guarnigione, dove tutta la vita sociale è dominata da ideali e provvedimenti di tipo militare, risulta assolutamente lontana dalla realtà degli Stati capitalisti avanzati di oggi. Ma, osservando bene, lo Stato guarnigione sussiste, anche se ha smesso, almeno nelle sue manifestazioni più odiose, di suonare tamburi e calpestare selciati al passo dell’oca. E questo permanere degli ideali militaristi si è incrementato, proprio perché più nascosto, quindi più cosciente e più astuto, per cui più difficile da denunciare. Il dominio si trova di fatto, in queste formazioni statali, nelle mani di una minoranza unificata, in cui l’espressione economica, militare ed esecutiva sono separate solo formalmente. Senz’altro oggi non ci sarebbe un’industria avviata a sostituire le proprie strutture con la conversione al terziario, se non ci fossero stati gli investimenti e le ricerche belliche, per cui a ben ragione possono dire i fautori del progresso pompato dalla guerra, che se questo è progresso, esso è stato determinato dal preparare e dal fare, senza soluzione di continuità, guerre e ancora guerre. Ma tutto questo è progresso? Pensiamo di no.
Sarebbe interessante studiare i passaggi che si stanno realizzando tra le vecchie collocazioni produttive, dovute a un rapporto diretto tra grande industria – dotata di impianti fissi – e commesse militari; tra queste commesse e i progetti tecnologici di guerra; e, infine, tra la guerra moderna, così come l’abbiamo vista in atto nel Golfo, qualche anno fa, e il passaggio dalla produzione industriale a quella postindustriale. Resta da vedere se l’antica ideologia militare scomparirà del tutto, trattandosi di una zavorra fra le più pesanti da buttare via. Di questo i tecnocrati al potere sono convinti, meno convinti sono i militari stessi che temono, buttando a mare le stellette e i simboli uniformati, di vedersi privati di alcune prerogative secolari che fanno comodo e che in tempi di formalismi grami tornano utili come surrogato di risultati economici più concreti, risultati che nella logica della spartizione ineguale non sempre riescono ad accaparrarsi. Un passo in questa direzione sta avvenendo a livello d’istruzione tecnica fornita ai quadri militari dirigenti. Questi frequentano in sostanza gli stessi master dell’economia e della politica e ricevono, più o meno, la medesima istruzione privilegiata. Tutto ciò, con un pizzico in meno di tradizionalismo, potrebbe fare avanzare di molto il dominio sostanziale del complesso militare, permettendogli una migliore integrazione nell’insieme della formazione politica ed economica dei grandi Stati democratici di oggi.
E, per dirla con Tacito, sine ira et studio, sarebbe bene andare un po’ oltre le nostre analisi sul problema militare.
[Pubblicato su “Anarchismo” n. 69, giugno 1992, pp. 21-23 col titolo “Rivalutazione della polizia”]
Sempre poliziotti restano
Carmine Mancuso, poliziotto palermitano diventato senatore della Rete, aveva il padre comunista che si chiamava Lenin e faceva il poliziotto. Anche il nonno era comunista (e chi se non lui avrebbe potuto mettere quel nome al figlio). Ora, il poliziotto Lenin venne ucciso nel corso dell’attentato mafioso contro il giudice Terranova, mentre il poliziotto Carmine iniziava la sua carriera come sbirro e come politico di sinistra. Ma sbirri si resta per tutta la vita. Adesso l’estremista Carmine manifesta chiare simpatie per l’“aitante” Fini (sono parole sue) e per la grandezza politica del presidente di AN. Per il momento non passa, armi e bagagli, ai fascisti, ma si limita a dichiarare la legittimità democratica di questi ultimi. I suoi colleghi della sinistra non sanno che pesci pigliare. Dopo tutto, non sono democratici anche loro?
Lei è la poliziotta di colore che tutti conoscono, Dacia Valent, ex europarlamentare, prima del PCI e poi di Rifondazione comunista. Adessa la signora ha scoperto che anche la destra è antirazzista, quindi, presentando al momento più certezze di scalata sociale di quanto non ne fornisca la sinistra, è bene trasferirsi.
Ma, in fondo, i poliziotti restano sempre poliziotti, l’uomo forte del destino non può mancare di affascinarli. Essendo abituati a ubbidire e a chinare il capo, miseri strumenti di un gicoo che neanche capiscono bene, cercano sempre un capo verso cui rivolgere gli occhi imploranti e desiderosi di protezione. E Fini ha secondo me il piglio adeguato per soddisfare simili libidini.
[Pubblicato su “Canenero” n. 13, 3 febbraio 1995, p. 2]
Karl Popper
Karl Popper, uno dei filosofi più chiari ed evidenti di questo secolo, è morto a Londra di cancro allo stomaco. Da sempre privo di capacità filosofica era riuscito a farsi eleggere a uno dei gradini più alti del cosiddetto pensiero contemporaneo, lavorando per aumentare la generale fiducia nella progressiva perdita di capacità intellettive e culturali dell’uomo. Con lui il livello dell’analisi filosofica è arrivato a un punto talmente basso da fare sperare che in futuro non riesca a scendere ancora più giù. Ovviamente la società telematica, che fa dell’idiozia generalizzata il fondamento del controllo, si è giovata molto delle sue teorie e delle sue elaborazioni. Le sue concezioni politiche, d’una disarmante vacuità, costituiscono una delle basi teoriche della nuova destra, e fanno il paio con le approssimazioni e le inconsistenze della sua concezione epistemologica. Il vecchio è morto. Per noi, ormai da tempo, era un cadavere ambulante. Registriamo soltanto un banale evento anagrafico.
Tutto qui.
[Pubblicato su “Canenero” n. 1, 28 ottobre 1994, p. 12]
Pornografia
Compito autoimposto di ogni autore è la denuncia del verosimile, l’aderenza della forma al contenuto. Questo gioco è sempre rispettato, trasferendosi a volte dal contesto sintattico all’insieme strutturale ma non sfuggendo dal messaggio.
Nessuno trasalisce leggendo nella cronaca quotidiana i dettagli di una carneficina. L’universo è racchiuso in quelle righe poco aggettivate. Niente è altrove. Anche le considerazioni ideologiche sono rintracciabili se non nel recinto medesimo del testo, senz’altro nell’insieme del messaggio, nello strumento di comunicazione o nell’atmosfera che quello strumento di comunicazione e quel messaggio veicolano.
Ma proprio questa preoccupazione oggettiva, questo inventario costantemente sottomano, sottraggono l’elemento scrittura o l’elemento figura alla staticità della ripetizione all’infinito. La preoccupazione del dire consente mille letture mostrandosi imprecisa e onirica. Il verosimile si scioglie nel sogno di chi legge, guarda, ascolta; il messaggio si centuplica e diventa flusso culturale, strumento di solidificazione del consenso e possibile elemento di disturbo (a seconda di come si pone il rapporto).
Proprio in questo scontro tra autore e fruitore si coglie il senso profondo del lavoro comunicativo. Venendo a mancare lo scontro, la solidificazione di un gesto si scolla in assurde freddezze metafisiche, simboli d’epoca, di maniera, di sconcerto logico. Il lettore (o chi per lui) può catalogarle per passatempo, collezionista maniaco di fossili freschissimi, ma non può aprirle, smontarle, ascoltarne il significato.
Di regola lo scontro è voluto, almeno dalla parte costruttiva, spesso è cercato involontariamente anche dalla parte fruitiva. Più spesso ancora, e senza rendersene conto, le parti si capovolgono, il prodotto si modifica, cresce, si snatura, si abbandona a nuove violenze, si veicola in molti modi, entra negli occhi della gente.
Nel testo pornografico (dando alla parola “testo” il massimo significato possibile) lo sforzo contenutistico è immenso. Il dettaglio, il particolare del dettaglio, la minuzia, assurgono a discorso centrale. L’inquadramento scende nel microcosmo, abbandona la visione dell’insieme, il contesto strutturale, i sensi linguistici, i colori d’abitudine, le prospettive polivalenti. Ogni pezzo è appiattito, isolato, reso anatomicamente asettico. Il significato è quindi altrove. I grandi pornografi sono proprio i peggio riusciti. La loro arte, di notevole levatura, li riporta continuamente dentro, e quindi il corretto contenuto di assenza svapora in aggiunte di qualità (se si vuole), di gusto, ma che hanno ben poco a che fare con la pornografia.
Questi contenuti sono tutti dislocati, cioè rimandano l’un l’altro a un superiore sentimento d’unità che però non deve mai essere colto, se non nell’eccitazione appagata, nel superamento dell’agone solitario.
Gli schemi devono, infatti, avere caratteristiche di uniformità. In caso contrario il valore pornografico decade a ricerca delle dissonanze, l’attenzione si distoglie in stimolazioni coscienziali, riflessioni su valori esogeni alla realtà microcosmica, anatomicamente ordinata in lunghi, spesso noiosi, cataloghi per collezionisti.
Chi ha il gusto di queste cose (e non se ne vergogna) finisce per acquistare anche una discreta abilità di fruizione. Difatti non è molto facile venire a capo di un discorso fondato su di un contenuto altro. Occorre costanza e forza d’animo. Il ricorso al giudizio etico viene spontaneo. Il pregiudizio ideologico consegue naturalmente.
In questo modo si riconferma la condanna ufficiale del godimento.La pornografia può essere piacevole o spiacevole non tanto in base agli individui (perché tutti gli individui amano scatenare la propria fantasia), quanto in base ai loro pregiudizi.
Quello che fa paura, in fondo, è che si possa aumentare il livello di godimento. Godere e parlare, scrivere, leggere, guardare, ascoltare, ecc. In questo modo si esce dalla cifra stabilita dal potere, si entra in zone d’ombra che rasentano e spesso costituiscono devianze per i progetti uniformanti del controllo sociale.
Si potrebbe rispondere che la pornografia è un’industria del potere, e anche abbastanza remunerativa. Ciò è vero proprio perché viene mantenuta in condizione di colpevolezza. Nel rapporto tra messaggio pornografico e fruitore non si stabilisce in modo netto l’altrove del godimento, ma si inserisce l’elemento stabilizzante della colpevolezza che da un lato dà giustificazione alle ritrosie morali del fruitore, dall’altro storna e deteriora le sue intenzioni di godimento. Lo scambio viene negato da questo elemento di disturbo che riporta l’insieme all’uso solo consentito: quello dell’addormentamento dei sensi, della soddisfazione fittizia, del rinvio del desiderio a un futuro abbandono di cui non si sa nulla.
Non si spiegherebbe altrimenti il fatto che la pornografia sia stata spesso usata come elemento di critica e di attacco al potere, non tanto nell’elaborazione dei suoi contenuti che, come si è detto, sono altrove, quanto nella modificazione di questo elemento estraneo (artistico, ideologico, ecc.). Da notare, fra l’altro, che i più efficaci critici politici che hanno fatto ricorso allo strumento pornografico avevano scarse qualità artistiche, mentre, al contrario, la presenza di contenuti di notevole valore creativo finiva per attenuare l’impatto dissacrante del microcosmo pornografico inteso nel suo significato tecnico.
Un’altra riflessione meriterebbe il fatto che l’elevata qualità delle riproduzioni della moderna pornografia di massa, con i suoi colori perfetti e i suoi dettagli fedelmente riprodotti, finisce per ricondurre all’interno del contesto una parte di ciò che deve essere necessariamente altrove, con un’accentuazione del grado di dispersione proprio in conseguenza delle necessità del mercato che non accetterebbe moduli troppo approssimativi o peggio artigianali.
[Pubblicato su R. De Michele, La gatta di Maria, Carrara 1984, pp. 9-11 col titolo “L’altrove pornografico”]
Produrre che cosa?
Può il mercato essere il luogo in cui, attraverso lo stimolo dei bisogni, si decide, sulla base delle leggi della domanda e dell’offerta, quali bene produrre? Certo che no, se non si vuole scatenare quello che vediamo sotto i nostri occhi: lotte inqualificabili per diversificare prodotti che diversi non sono, imbrogli economici e politici, ferocia e morte. Ma, per un altro verso, può la programmazione sostituire il mercato? Certo che no. Pochi beni in circolazione per un piccolo paesello di appena cento abitanti richiederebbero una programmazione che qualunque computer non riuscirebbe a realizzare. La conclusione è che non esiste possibilità di fissare i prezzi dei prodotti se non attraverso i genocidi e la morte, magari gli uni e l’altra lontani nello spazio, caricati su popolazioni considerate “sub-umane”. E se non esiste questa possibilità, non esiste fondamento logico all’economia, e questa gente che ci governa e ci regola da sempre ci ha imbrogliato con le sue chiacchiere scientifiche e ci ha costretto con la forza delle sue baionette.
[Pubblicato su “Canenero” n. 13, 3 febbraio 1995, p. 7]
Il Processo
Ci si può abituare all’orrore? Purtroppo sì. E l’abitudine all’orrore è più impressionante dell’orrore stesso. Tutto sembra ridiventare normale. Si è certi che almeno uno dei giuristi che studiarono gli aspetti formali delle leggi razziali tedesche era un lettore del Processo di Kafka, in quanto ci sono testimonianze successive alla fine della guerra che lo videro intento a leggere il libro nelle diverse anticamere dei successori dei nazisti. L’orrore di cui parlano i romanzi kafkiani è inimmaginabile perché sconosciuto, una macchina in moto, tra gli ingranaggi della quale ci si è venuti a trovare senza sapere perché. Ma, a lungo andare, la macchina, con il suo rumore monotono e assassino, diventa familiare e quasi non la si sente più, non se ne avverte più l’orrore. Qualcosa del genere è accaduto con gli effetti dell’olocausto degli Ebrei. Mano a mano che sono stati resi noti, la visione di enormi cataste di scheletri, o di esseri viventi non molto differenti dagli scheletri, ci abituò a una visione dell’orrore che alla fine divenne quasi ovvia, quindi necessaria e datata, qualcosa contro cui non c’è nulla da fare se non una vaga protesta, un sussurro appena, proprio quel tanto per mettersi l’anima in pace. Capovolgendosi i termini storici del problema, lo stesso sta avvenendo oggi [1989] con la repressione condotta da Israele contro i Palestinesi, specialmente nei Territori occupati. Ora, nelle pagine del Processo, più che una vicenda c’è un’atmosfera creata attraverso l’impiego di un linguaggio estremamente efficace. In quest’atmosfera si conosce l’estrema rarefazione dell’orrore, la persecuzione senza motivo, in nome dell’ordine, di un ordine di cui il perseguitato non ha cognizione, e da cui è escluso per sempre. Nelle alterne vicende dei genocidi non so fino a che punto, coloro che ne subiscono le conseguenze, siano in grado di capire i motivi del persecutore, del torturatore, dell’aguzzino. Nel Processo emerge con chiarezza soltanto l’esistenza del meccanismo di catalogazione, e viene fatto capire che tutta la civiltà, tutta la realtà, nel suo naturale progredire, regredisce di fatto a puro meccanismo. Il senso, nel Processo, appare tanto importante da assolutizzarsi e da scomparire in quanto contenuto, in quanto significato, per diventare meccanismo di catalogazione e basta, quasi del tutto vuoto di senso, se si esclude il residuo, in cui i simboli di una perduta qualità, perduta per sempre, si essenzializzano solo attraverso il dettaglio. Rileggendo questo testo a distanza di più di trent’anni, mi rendo conto che quelle lontane interpretazioni, pubblicate all’interno delle mie giovanili ricerche sull’Esistenzialismo, oggi cozzano con una cognizione dell’orrore che è diversa. Allora, la vicenda ero portato a interiorizzarla in un percorso tutto della coscienza immediata, una debolezza tra ruote estranee che la schiacciavano e la travolgevano senza dire nemmeno perché, oggi mi rendo conto che quelle ruote fanno parte della coscienza stessa, anche di quella di chi viene travolto e sbalordito. Anche lui fa parte del meccanismo, e l’autore di tanta perfezione meccanica, in primo luogo. Oggi, una maggiore conoscenza della vita mi fa capire meglio non solo i limiti tipici del fenomeno kafkiano, ma tutto quello che ne viene fuori, un modo di stendere veli e passaggi non reali, mascherature. Adesso conosco bene persone che vivono realmente una vita molto simile a quella che è stata descritta nel Processo ma non lo sanno, perché il segreto è qui, che chi fa veramente e totalmente parte del meccanismo, non lo sa, e non lo sa nemmeno chi descrive il meccanismo e nemmeno chi comincia a inorridirne, per poi, come si dice, farci il callo. I giovani soldati israeliani che oggi massacrano i giovani palestinesi sono figli di coloro che sopravvissero ai massacri dei lager. La coscienza chiude il cerchio delle assurdità dell’orrore senza motivo. Nessuno capisce il perché, né i vecchi massacratori nazisti capivano bene il perché di una ideologia razzista che era stata imballata malamente anche dal punto di vista culturale, né i nuovi massacratori che non capiscono come il nuovo Israele si possa costruire sui campi di concentramento che somigliano molto a quelli delle vecchie fotografie al cui orrore si sono ormai abituati. A me pare che nel Processo la coscienza si mangi tutto, senza inquietudini, tutto, anche l’autore.
[1989]
Qualche piccolo regalo
Il vescovo di Reggio Emilia, poveretto andava in Uno, vecchia e scassata, un bravo fedele, il senatore DC Franco Bonferroni, mosso a pietà per le tristi condizioni locomotorie del presule, gli regala una Croma fiammante. L’uomo di Dio non guarda in bocca al caval donato e per diversi anni si fa scorazzare seduto come un papa. Adesso si viene a sapere che il bravo fedele è uno dei tanti politici concussi e mafiosi e che la macchina regalata proveniva da una bella estorsione fatta a carico di un qualche imprenditore della zona. Il vescovo è sceso dalla macchina ed è risalito sulla vecchia Uno. Tristi tempi quelli in cui bisogna guardare in bocca ai cavalli per vedere se hanno qualche dente guasto.
Il generale di corpo d’armata Angelo Sion e alcuni colonnelli, suoi dipendenti, avevano detratto dal bilancio delle caserme sotto la loro giurisdizione circa venti milioni, aumentando il costo della cancelleria per gli uffici, e con questa somma, comprato un chilo d’oro, si erano fatti fare dei bracciali piuttosto vistosi da regalare alle signore ospiti delle cene al circolo ufficiali. Quanto lontana l’epoca in cui l’esercito aveva il diritto di saccheggio e di stupro. Adesso per qualche braccialetto da nulla si inquisisce perfino un generale. Che tristi tempi quelli in cui un militare non può nemmeno fare il galante regalando un gioiello alla puttana di turno che transita in caserma.
[Pubblicato su “Canenero” n. 13, 3 febbraio 1995, p. 3]
Il progetto repressivo
Gli elementi del dominio
Si trova spesso chi si meraviglia della necessità di tornare ad affrontare l’eterno argomento del nemico: i suoi progetti repressivi. Ormai ne sappiamo a sufficienza, siamo al corrente di tutto – insistono alcuni – occorre trovare nuove analisi, nuovi interessi, nuovi orizzonti di riflessione per potere procedere, più speditamente possibile, all’azione, alla lotta, alla costruzione di quanto ci sta a cuore. [Cfr. [A. M. Bonanno], “Progetto repressivo e possibilità rivoluzionarie”, in “Crocenera” n. 25, maggio 1983, pp. 8-10].
Tornando alle indicazioni di sempre, alla ripetizione di cose già dette e forse mal capite perché non facilmente decifrabili nelle condizioni di fatto che ne deformavano la lettura, dobbiamo ammettere con una certa riluttanza di non essere portatori di grandi novità. Coloro i quali scambiano concretezza con rimescolamento delle carte si mettano l’animo in pace: qui non troveranno la seconda discutibile abilità mentre, se avranno sufficiente pertinacia nel vedere e supereranno il luogo comune del guardare, troveranno, forse, qualche traccia di concretezza.
La possibilità di comprendere la struttura del dominio è in relazione al nostro modo di disporci verso la realtà delle lotte. Staccandoci da un intervento attivo le nostre capacità si riducono all’indagine sociologica, ai sentimenti umanitari di origine cristiana, agli stimoli della falsa coscienza. Viviamo allora il dominio come un progetto lontano e imperscrutabile, completo in tutte le sue parti, perfetto proprio perché è imperfetta la nostra reale conoscenza dei suoi limiti.
Avvicinandoci alle lotte reali, partecipando direttamente e personalmente ai fatti e non vivendoli esteticamente come momento di sublime esaltazione metafisica, possiamo capire come il dominio sia costruito da uomini e comporti tutti i limiti che gli uomini possiedono. Esso è irrazionale come sono irrazionali i sentimenti, è contraddittorio come sono contraddittori i desideri. E sentimenti e desideri spingono non solo gli sfruttati ma anche gli sfruttatori. Nel nostro immane odio verso questa brutta espressione dell’uomo abbiamo finito per convincerci che i padroni e i loro servitori sono macchine perfettamente in grado di formulare piani di dominio coerenti e razionali. Vedendo in che modo questi piani si basano sull’uso di tecniche quantitative e matematiche ci siamo convinti che devono per forza essere completi in tutte le loro parti e in grado di procedere a una automatica correzione degli errori. E, invece, le cose non stanno così.
Gli elementi del dominio sono diversi e, spesso, nemmeno ben coordinati tra di loro. Il capitale è certamente uno degli aspetti del dominio ma, come tutti sanno, è legato a una sua situazione fortemente contraddittoria dipendente dal mercato, dai limiti della produzione, dai rapporti esistenti tra bisogni, consumo, produttori e dominati. In fondo nessuna programmazione razionale può mettere ordine nella contraddittorietà del comportamento dei singoli capitali, come nessuna forza esterna può massimizzare le azioni produttive del capitale nel suo insieme. Ci saranno sempre grosse sfasature costituenti altrettanti spiragli dentro cui incuneare le lotte degli sfruttati.
Lo Stato è un altro degli aspetti del dominio. Riassume in sé l’aspetto produttivo nel senso di formazione del valore nel campo più esteso della produzione di pace sociale. Tra il settore dell’economia e il settore dell’esecutivo e dell’amministrazione non esiste una netta diversità in quanto la produzione di valore in senso specifico è uno dei momenti (non separati) della produzione di pace sociale. C’è però il fatto che più grande diventa l’estensione dell’attività statale, più si moltiplicano i campi in cui si fa sentire il suo peso, e più la produzione di pace sociale ha prevalenza sulla produzione di valore in senso stretto. Ciò significa che si passa da una maggiore contraddittorietà del capitale a una più puntigliosa regolamentazione da parte dello Stato. Tutto ciò in termini relativi, in quanto nessun valore assoluto potrà mai sostituirsi a questi indici di tendenza. In altri termini, non si potrà mai arrivare a una produzione assoluta di pace sociale, come non si potrà mai tornare a inesistenti eden di libero mercato (produzione perfetta di valore). Per un altro verso, il perfezionamento della produzione di pace sociale (massicci interventi dello Stato) si paga sempre in termini di maggiori costi e sacrifici in sede di produzione del valore (settore dell’economia in senso stretto). Ora, questi sacrifici non possono essere spinti troppo avanti in quanto, pur avendo un aumento di pace sociale, si potrebbe verificare, improvvisamente, una rottura del sistema nel suo complesso. Ma lo Stato non possiede elementi e mezzi per programmare una ricerca ideale del punto di equilibrio tra produzione di valore e produzione di pace sociale. Il fatto stesso di essere in balìa di scelte spesso non valutabili a priori o non indirizzabili in modo preciso (meccanismi elettorali incerti, notevoli sfasature nel parlamento e nell’esecutivo, effetti di rimbalzo dovuti allo stesso controllo dell’informazione, difetti nei meccanismi di recupero e loro eccessiva viscosità, ecc.), tutto ciò consente di individuare larghi spazi d’intervento per le lotte degli sfruttati.
Il consenso chiude il cerchio del dominio. Senza il consenso non è possibile esercitare lo sfruttamento e il controllo, quindi non è possibile il dominio nel suo significato più profondo. Il consenso esiste a tutti i livelli del dominio. Ma non è mai assoluto e senza riserva. Può essere basato esclusivamente su interessi precisi (interessi di classe), su ideologie o su flussi di informazioni controllati, in ogni caso, comunque, presenta sempre andamenti contraddittori: ora si sviluppa anche venendo a negare i propri interessi specifici a seguito della divulgazione di sentimenti e ideologie non sempre chiari, ora si riduce facendo prevalere i moventi più immediati e più facilmente coglibili: la sopravvivenza, la difesa di classe, l’attacco contro gli sfruttatori, ecc. Sia lo Stato che il capitale si rendono conto di non potere pervenire a una legittimazione del dominio se non chiudono il cerchio del consenso. Ma per ottenere un indice ottimale di consenso bisogna pervenire alla soluzione del problema dell’equilibrio tra produzione di valore e produzione di pace sociale. In fondo, alla base della ricerca del consenso ci sta una situazione contraddittoria che non può non avere conseguenze anche sull’andamento del consenso e sulle possibilità di un suo controllo per gli scopi del dominio. Qui si collocano le possibilità rivoluzionarie e si aprono i varchi della contraddizione entro cui può penetrare l’azione degli sfruttati.
La mentalità repressiva è una degenerazione del dominio, una vera e propria malattia del progetto di controllo. La repressione come strumento e come progetto è solo una parte del dominio nel suo insieme, e una parte limitata. Quando questa parte si espande e penetra nelle altre sezioni del dominio, vi porta una mentalità poliziesca che finisce per entrare in contraddizione sia con la mentalità efficientista della tecnocrazia che con la mentalità permissiva del capitalismo vecchia maniera. Siamo davanti altre contraddizioni. Il capitale è, in fondo, socialdemocratico per natura, tende a inglobare all’interno della propria logica anche gli strati proletari che, in pratica, costituiscono il referente privilegiato della produzione. Questi strati devono essere controllati ma non tartassati. Occorre con loro un dialogo, un’apertura alla discussione, una collaborazione. La logica dei sacrifici non può arrivare fino alla coabitazione tra proletariato e carabiniere. Il tecnocrate invece è più rigido. Si sente importante. Chiamato a mettere ordine nel capitale (di cui non capisce la logica) veste la divisa dell’economista, dell’amministratore, del politico, ma nell’animo rimane un efficientista. Per lui il carabiniere è sempre lo strumento di riserva che deve restare a portata di mano, ma deve essere uno strumento efficiente. In quanto politico egli vuole che il carabiniere sia democratico, in quanto amministratore vuole che sia efficiente, dotato di mezzi opportuni. In questo modo il carabiniere si viene a trovare dilaniato tra due tendenze: da un lato la socialdemocrazia capitalista che lo vuole vigile ma limitato nei suoi interventi, con poche possibilità d’azione, dall’altro lo Stato tecnocratico che lo vuole efficiente ma subordinato all’esecutivo e ai piani di progressivo controllo che questo cerca di mettere in atto. In quanto corpo armato il carabiniere (e tutte le altre strutture parallele che ragionano con la mentalità frustrata dei militari) si sente depositario di una forza mal impiegata per cui, spesso, fa sogni di gloria per conto suo. Non c’è chi non veda quante contraddizioni si sviluppano all’interno delle diverse posizioni. Prospettive e interessi si intrecciano con diversi progetti e con contrastanti velleità. Anche qui c’è spazio per portare avanti il lavoro rivoluzionario.
In pratica, l’esistenza di queste contraddizioni e dei relativi spazi di lotta rivoluzionaria è stata sospettata un po’ da tutti, anche da coloro che hanno finito per concludere con la tesi della repressione. Spesso questi spazi sono stati definiti come limiti delle garanzie, con una concezione difensivista della lotta e quindi con una prospettiva di resa a medio o a lungo termine.
In una dimensione insurrezionale, e quindi in un metodo e in una pratica insurrezionali, le contraddizioni del dominio aprono spazi che sono altrettanti momenti d’iniziativa da parte degli sfruttati i quali non si scontrano per la difesa di quegli spazi che sono effetto delle contraddizioni, ma per allargare queste stesse, per impostare una strategia d’attacco che intende alzare il livello dello scontro.
La lotta contro la repressione non è quindi diretta – come spesso può sembrare – a ottenere da parte del potere “prestazioni corrette”: il carabiniere deve fare il posto di blocco ma non deve sparare, deve rispondere al fuoco solo dopo avere intimato l’alt, non deve torturare, non deve provocare, non deve mettere le bombe, non deve schedare clandestinamente, non deve operare fermi senza autorizzazione, ecc. Lasciamo questi compiti agli imbrattacarte della cosiddetta sinistra. Denunciando la repressione – nelle carceri, nei quartieri, nelle fabbriche, insomma nel sociale complessivo – non siamo pietisti che si appellano ai sentimenti umanitari. Il carabiniere torturatore non ci impressiona, come non ci impressionano i magistrati massacratori che macinano condanne all’ergastolo o i ministri ricattatori che commerciano in pentimenti e sconti vari. Ognuno vende la merce che ha.
Nel denunciare la repressione, anche quella camuffata e meno eclatante, intendiamo aprire di più le contraddizioni nel potere. Non le contraddizioni tra capitale e Stato, quanto le contraddizioni tra dominio e consenso. Saranno poi queste ultime contraddizioni ad avere effetti riflessi e non secondari anche sulle prime.
Ma il lavoro rivoluzionario non si arresta alla denuncia e all’acutizzazione delle contraddizioni del nemico: deve andare oltre, verso l’organizzazione dello scontro di classe. Limitarsi a “fare conoscere” quanto è cattivo chi ci sta davanti, ha spesso il risultato di migliorare il suo atteggiamento rendendo più ragionevole (e quindi più efficace) la repressione, oppure ha il risultato di abituare l’ascoltatore agli orrori repressivi.
Nell’azione contro chi gestisce la repressione si sviluppa quindi l’analisi sulla repressione diventando analisi rivoluzionaria e non semplice controinformazione, passando da un contenuto di fatti a un contenuto di indicazioni e prospettive.
Carcere e società
Consideriamo ancora centrale la lotta per la distruzione del carcere, per la distruzione, non solo fisica dei luoghi della segregazione (di tutti i luoghi in cui si realizza l’istituzione totale separata), ma anche della concezione che tutti noi abbiamo del carcere come fatto separato, come fenomeno specifico da affrontare con mezzi particolari. [Cfr. [A. M. Bonanno], “Carcere e società, nuove prospettive di lotta”, in “L’Anarchia”, Numero unico, novembre 1982, p. 7].
Abbiamo fornito per anni informazioni sul carcere, sulle condizioni di detenzione, sugli abusi e le illegalità, sulle torture. Non volevamo certo condurre con ciò una campagna per il miglioramento delle condizioni di prigionia, campagna che seppure utile, in quanto rende più ampia la capacità di lotta dei compagni in galera, non è altro che una verniciatura delle sbarre. Volevamo con quegli interventi contribuire a portare il carcere fuori della propria caratteristica di realtà specifica, separata dalla società.
In pratica non ci siamo riusciti. Siamo spesso caduti nell’equivoco del punto di maggiore tensione dello scontro di classe. Le analisi provenienti dal carcere venivano, spesso, considerate la punta avanzata di quanto si era in grado di capire proprio perché dovute alla riflessione di compagni che avevano pagato di persona. Si spalmava così il sentimento su di un’obiettività che non avrebbe mai dovuto fare difetto. Spesso non ci si sentiva in grado di sviluppare una critica ragionevolmente fondata, solo perché non si voleva superare una tesi elaborata in carcere.
Più o meno siamo usciti adesso da questo modo di considerare le cose. Non esistono momenti privilegiati dello scontro di classe, come non esistono luoghi fisici in cui questo scontro assume maggiore o minore importanza.
Il carcere, come istituzione totale repressiva, costituisce di fatto uno dei luoghi fisici in cui vengono a cadere alcuni aspetti del paternalismo riformista. Ma ciò non basta. Spesso gli equivoci delle lotte parziali, della difesa degli spazi interni di agibilità, della propaganda limitata alle condizioni interne finiscono per prevalere sul quadro complessivo dell’istituzione carceraria che risulta incomprensibile se non lo si riconduce alla società nel suo insieme.
La lotta dei compagni prigionieri dovrebbe tendere ancora alla riappropriazione di una soggettività rivoluzionaria che l’istituzione vuole a qualsiasi costo schiacciare. Tra gli elementi che concorrono a distruggere questa soggettività, si trovano anche i progetti politici autoritari di quelle organizzazioni politiche che, richiamandosi a un bieco stalinismo coltivano orticelli di potere all’ombra delle sbarre. I nostri compagni hanno dovuto spesso lottare su due fronti: un nemico interno e uno istituzionale (interno/esterno).
Ma questa lotta avrebbe dovuto coordinarsi con tutte le lotte esterne al carcere, cioè con le lotte che gli anarchici sostengono nel sociale. Quindi: da un lato la riappropriazione della soggettività, dall’altro lo sviluppo dell’organizzazione di lotta. Questi due poli dovrebbero dare il segno di un rapporto tra il carcere e quella parte di lavoro rivoluzionario che è possibile realizzare nei diversi settori d’intervento sociale.
Bisogna quindi riprendere i raccordi di questo progetto. Solo così si possono spezzare i confini altrimenti invalicabili che l’istituzione costruisce attorno al carcere. La gente non deve ricevere sporadiche informazioni sulle condizioni dei carcerati, ma deve essere calata nella vera e propria realtà del carcere. Ogni intervento che gli anarchici realizzano deve contenere un raccordo col carcere. Si tratta di una cosa possibile in quanto non esiste aspetto della vita sociale di oggi che non veda riflesso in se stesso il carcere come deterrente o come modello. Se facciamo un intervento nella scuola possiamo far vedere come esistano precisi parallelismi tra istituzione-scuola e istituzione-carcere. Se lavoriamo davanti a una fabbrica non possiamo fare a meno di parlare della prospettiva della disoccupazione senza far vedere come il carcere sia una delle armi di cui i padroni si fanno forti. La lotta antimilitarista comporta per forza un discorso sul carcere. Non esiste possibilità di intervento nei quartieri se non si parla in modo chiaro della presenza del carcere.
L’istituzione carcere si può attaccare solo facendola entrare in tutti gli aspetti del sociale, costringendo la gente a rendersi conto che essa non è una possibilità limite da evitare, ma un elemento costante della loro vita di tutti i giorni.
Il carcere domani
In prospettiva il carcere tende a essere dislocato nel territorio. Gli spazi chiusi non garantiscono una sufficiente uniformità del controllo sociale causando dissonanze che vanno comunque sanate e recuperate. La sensibilità media cresce e si adombra davanti la brutalità, sotto qualsiasi forma questa appare. Reagisce quindi negativamente nei confronti del cosiddetto trattamento differenziato che viene riservato al detenuto, a qualsiasi detenuto. Questa nuova sensibilità pretende dallo Stato non più armonia in prospettiva, ma attuale perfetta corrispondenza delle esteriorità, adeguati moduli uniformi di comportamento. Si dichiara pronta al controllo, accetta anche l’ipotesi della mistificazione autoregolata, ma impone un adeguamento del codice. Non potendo eliminare le cause delle difformità sociali, lo Stato provvede ad appiattirle dall’alto, nascondendole sotto un’apparente normalità e sacrificando la sua vecchia ideologia ortopedica. [Cfr. (A. M. Bonanno), “Il carcere domani”, in “Crocenera” n. 35, settembre 1984, pp. 21-28].
Per il momento le carceri si continuano a costruire e le condanne prevedono la segregazione per lunghi periodi (e anche a vita), ma il supporto ideologico di questo processo si sta erodendo. Lo Stato si va rendendo conto che l’ortopedia sociale è un mito legato – almeno nella sua formulazione originaria – al liberalismo inglese della prima metà dell’Ottocento. Colui che contravviene alle leggi, secondo l’idea progressista e migliorativa di queste brave persone, in gran parte uomini d’affari e industriali, funzionari statali di alto grado e proprietari terrieri (landlord), colui che non accetta le leggi del posto dove vive, si mette fuori legge, cioè si colloca in uno spazio sociale diverso, si ghettizza (e quindi viene ghettizzato). A questa sua scelta, sempre resa necessaria dalla situazione di classe, ma sempre considerata come una colpa se non come una tara, deve corrispondere un luogo fisico anch’esso diverso. Come chi fa le leggi (o le fa fare) appartenendo alla classe privilegiata si rinchiude (anche per difendersi meglio) all’interno del proprio palazzo-prigione, così chi contravviene alle leggi deve essere rinchiuso in un luogo sicuro per separarlo da coloro che fissano le regole del gioco sociale e dalla gran massa di coloro che si adattano a seguirle.
Questa divisione corrisponde alle altre che coprono lo spazio sociale: le fabbriche, le scuole, le caserme, gli uffici pubblici, le banche, le residenze della classe dirigente, le zone dei quartieri dove abitano le fasce intermedie dei lavoratori, i quartieri-dormitorio per gli operai, i ghetti per i sottoproletari, gli ospedali, i manicomi. I profondi cambiamenti che si sono verificati e continuano a verificarsi all’interno di queste strutture, una volta molto più rigide, non potranno non indurre modificazioni di notevole portata nella struttura del carcere e nel suo significato sociale.
L’ideologia liberista dell’ortopedia sociale prevedeva la netta separazione dello spazio sociale. Ognuno all’interno dei suoi confini. Sontuosi e dorati quelli della classe privilegiata, miserabili e dolorosi quelli della classe sfruttata.
Il vecchio liberista chiudeva gli occhi davanti la miseria mettendosi il cuore in pace con quelle poche iniziative assistenziali che le dame di carità realizzavano. Per questo le prigioni, i manicomi, i ghetti operai e sottoproletari erano ben circoscritti e chiusi, possibilmente lontani (anche oltremare, nelle colonie di sterminio), perché non offendessero, con la loro presenza, il senso del gusto dei privilegiati.
Col crollo delle illusioni liberiste, il tramonto dell’ideologia vittoriana e lo sfasciarsi dei vari imperialismi, si vide, con maggiore evidenza a partire dalla seconda guerra mondiale, che la barca dei poveri era in fondo la stessa su cui navigavano anche i ricchi e che quindi era molto pericoloso continuare a lasciarla affondare.
C’era, a dire il vero, all’interno della vecchia ideologia codina un aspetto di recupero, anche se con la puzza sotto il naso. Si trattava di “rieducare” la classe sfruttata, conducendola verso il risparmio, la limitazione delle nascite, la coscienza del proprio livello sociale e del proprio ineluttabile destino di sfruttati. Era l’epoca delle scuole speciali per i figli di operai, dei corsi serali per lavoratori, dei riformatori, degli ospedali psichiatrici, delle conferenze contro l’alcolismo, delle letture pubbliche della Bibbia e delle apocalittiche prediche quaresimali dei cattolici. Anche questa pedagogia della separatezza è ormai tramontata.
Il capitale e lo Stato moderni si sono resi conto che uno finisce per essere complementare all’altro e che ambedue si fondano sul consenso e sulla pace sociale.
Il reperimento del primo e l’instaurazione della seconda, sia pure a tempi medi, si basano sulla partecipazione.
Così la scuola del privilegio si è aperta all’assemblea, alla discussione e alla socializzazione dei rapporti, ma ha ridotto drasticamente i contenuti culturali per assegnarli a una piccola minoranza dirigente, in luoghi separati, dove è possibile raggiungere una notevole specializzazione.
Così la fabbrica si è aperta al territorio, coinvolgendo una vasta rete di produttori autonomi e non distinguendosi più dal lavoro nero, ma selezionando unità ad altissima tecnologia, in luoghi separati, unità capaci di fare a meno della manodopera non specializzata e quindi più riottosa e di difficile controllo.
Così la gestione della cosa pubblica si è democratizzata allargando comicamente il movimento assembleare fino alla base (consigli di fabbrica, comitati di quartiere, consigli scolastici, comitati delle unità sanitarie, ecc.), ma svuotando di significato le relative proposte per racchiudere, nel breve spazio sociale dei vertici politici ed economici, le decisioni effettive, spesso lontane dalle proposte di base.
Così i manicomi sono stati aperti ma i soggetti ritenuti più pericolosi (in base a decisioni fondate sul grado di sopportazione del dominio) vengono rinchiusi, torturati e uccisi in luoghi ancora più ristretti, più anonimi e più abietti dei vecchi ospedali psichiatrici.
Così i quartieri-ghetto vengono sventrati e sostituiti con grandi palazzoni fuori città, costruiti da grandi architetti e facilmente controllabili con pochi blindati. La vecchia omogeneità della miseria (che era però anche elemento culturale di coesione di classe) si annega, man mano, nei larghi spazi alberati dei viali solitari e scarsamente illuminati delle nuove anonime periferie.
Così anche le caserme avvertono una ventata di modificazione nella disciplina, si riduce la ferma, si prospetta l’instaurazione di un esercito a ranghi ridotti, ma professionale e altamente specializzato. Nello stesso tempo la forza armata di controllo sociale (carabinieri) viene potenziata come primo nucleo del futuro esercito di professionisti.
E così anche il carcere.
Dividere e fare partecipare. Questi sono i due punti di forza del nuovo potere. Ogni struttura parallela deve essere divisa in una serie di strutture intermedie, capaci di controllarsi a vicenda. Ciò avviene con i sindacati, i grandi partiti, il sistema bancario, quello industriale, la magistratura, l’esercito, la mafia, ecc.
Alla fase di crescita segue quella della divisione in strutture intermedie. Lo sviluppo della triplice sindacale è stato possibile in quanto si otteneva così anche lo scopo di mettere l’una contro l’altra le diverse anime sindacali (e partitiche), provvedendo a un controllo delle componenti di disturbo che, a un dato momento, avevano assunto una certa dimensione. I grandi partiti si controllano con il gioco delle correnti. L’apparente monoliticità del partito comunista è solo, per l’appunto, apparente, come si è visto recentemente a proposito delle discussioni sul nucleare, e dipende da un errore di prospettiva degli osservatori. Le correnti interne al più grosso partito “proletario” d’Europa sono visibili e sono tutte dirette a rintuzzare le componenti (più o meno vicine all’antica matrice stalinista) che vorrebbero un ritorno a concezioni di lotta politica meno socialdemocratiche. Per le altre grandi strutture non vale spendere parole. Il controllo derivante dalla loro divisione interna è evidente a tutti. Qualche cosa bisogna invece dirla per la mafia. L’entrata delle vecchie “famiglie” nel giro internazionale della droga pesante ha determinato un afflusso enorme di denaro (che aumenterà per più di mille volte con lo sviluppo del giro della cocaina la quale ha una fascia di consumatori molto più ampia e danarosa dell’eroina) verso la base della piramide mafiosa. Ciò ha comportato una diminuzione dell’autorità dei capi-famiglia e un aumento delle possibilità finanziarie dei piccoli spacciatori i quali, spesso, finiscono per mettersi in proprio con guadagni da capogiro. Con tutto questo si è avuto un appiattimento della tradizionale piramide e una tendenza alla trasformazione della base in ceto imprenditoriale stabile, con investimenti “puliti” e con autonomie che prima non erano pensabili. Fra qualche anno le vecchie famiglie saranno sgominate (ecco perché parlano Buscetta e compagni, ed ecco perché gli arresti recenti – specialmente a Catania – del cosiddetto terzo livello). In pratica si è avuta una “democratizzazione” della struttura mafiosa con il trasferimento del comando non più nel senso verticale e diretto, tipico dell’antica mentalità patriarcale, ma nel senso “indiretto” e funzionalista delle grandi multinazionali. A dirigere la mafia di domani non saranno più i don Calogero di ieri, ma le grandi banche e i centri finanziari di raccolta di fondi internazionali. In questo modo si è sconfitta la mafia e la mafia ritorna a dominare nella sua veste più consona allo sviluppo dei tempi. Negli spazi specifici del capitale internazionale la fenice mafiosa risorge dalle sue ceneri.
Abbiamo quindi un accordo legalitario tra Stato e capitale e, di conseguenza, un recupero a livello imprenditoriale dei comportamenti illegali che ieri venivano recuperati attraverso un immenso e stupefacente armamentario tradizionalista basato sull’onore e sulla parola data, faccende ormai fuori del tempo. Ben presto ogni singolo imprenditore nel commercio della cocaina (in modo specifico sarà questo il grande affare degli anni ’80-’90) potrà rifornirsi alla fonte con mezzi propri: corrieri, aerei personali, compagnie di navigazione, ecc. E altrettanto presto il giro d’affari sarà tanto elevato da non risultare più distinguibile la cosiddetta imprenditoria sana da quella mafiosa, come adesso, tanto per fare un esempio, non sono distinguibili i finanziamenti provenienti dai petrodollari arabi.
La esclusione e la specializzazione diventano paradossalmente gli elementi fondamentali della partecipazione. Tutti possiamo intervenire e dire la nostra proprio perché nessuno è più in grado di far sentire la propria voce. Allargando la partecipazione il potere ha negato nei fatti il protagonismo, riconducendolo, per altre vie e con altri mezzi, sulle vecchie strade delle decisioni di vertice.
Il più clamoroso equivoco è proprio quello elettoralistico. La democrazia si basa sull’ignoranza e il disinteresse delle masse, ma anche sull’acuta intenzione speculatrice ed egemonizzatrice di piccole minoranze di potere che intendono imporre una loro concezione del dominio.
Certo le masse devono essere messe in condizioni di non nuocere: un minimo di partecipazione al reddito, una miriade spesso incontrollata di bisogni mai del tutto soddisfacibili, una razionalizzazione del tempo libero fin nei minimi particolari, una circolazione delle idee e delle informazioni standardizzata e controllata.
Ognuno si rinchiude nella propria specificità. Chi possiede un orientamento più ampio degli altri finisce per possedere anche una possibilità di dominio sugli altri, possibilità che condizioni oggettive e capacità soggettive trasformano poi in fattualità concreta.
Il progetto capitalista e statale non è mai completo in tutti i suoi aspetti. Il dominio è sempre una linea di tendenza. Dividendo all’infinito si indebolisce l’avversario ma si perdono anche i suoi contorni, che sfumano in una incertezza pericolosa per chi deve fare i piani di reperimento del consenso e di mantenimento dell’ordine.
La cosa sta diversamente per chi è interessato alla distruzione di un ordine che significa solo morte. Il rivoluzionario è uomo di parte, per prima cosa egli non condivide l’atteggiamento di coloro che aspettano che tutti siano d’accordo su di un argomento perché quest’ultimo sia accettabile. Egli agisce, anche da solo, o con pochi compagni, anche nella generale contraddizione, anche nel pieno della disapprovazione degli altri. Egli agisce sulla base delle proprie idee e dei propri progetti analitici, ma anche sulla base delle esperienze, della cultura e delle forme organizzative di cui si fa propugnatore.
Questa specificità è ben altra cosa della divisione imposta dal potere. È la separatezza che viene fuori dal modo diverso di concepire la lotta, dai propri diversi interessi e non dal modo in cui una necessità estrinseca finisce per collocarci nella stratificazione sociale.
Più la divisione imposta dal potere si fa frazionata e disumanizzante, più il rivoluzionario anarchico va alla ricerca di “ricuciture” che non sono tentativi idioti di sanare un tessuto sociale irrimediabilmente lacerato, quanto semplici progetti che intendono mettere in contatto le differenti diversità, allo scopo di studiare un’azione comune, diretta a distruggere la fonte di tutte le diversità.
L’illusionismo parte da un’ipotesi di superamento della separatezza e predica una concezione di massa (partito, sindacato, movimento pacifista, grandi manifestazioni spettacolari, ecc.). La concretezza si rende conto dell’impossibilità di costruire un grande movimento rivoluzionario di massa e insiste sul fatto che di questa specificità si faccia un’arma, non più di sostegno del potere, ma adatta a essere usata contro chi esercita il dominio.
Se ne riceve l’insegnamento che l’estremo limite della separatezza sociale è proprio l’elemento di connessione per la ricostruzione del tessuto rivoluzionario. Non mettendo insieme il tessuto strappato o nascondendone i buchi, ma proprio mettendo in evidenza le lacerazioni e le sofferenze, la povertà emergente che fa controcampo ai centri di potere e di benessere sempre più circoscritti e ben difesi.
Noi siamo quindi per la divisione contro la divisione, per la separazione contro la separazione. Siamo rivoluzionari proprio quando i veri divisori e separatori parlano a bocca larga di partecipazione e democrazia.
Nel regno della separatezza costruito dal potere il carcere occuperà domani un posto di rilievo. Piccolo, separato in modo totale, corredato di tutti gli accorgimenti per la tortura in camice bianco, sarà destinato a un nucleo di irriducibili avversatori del sistema di potere. Intorno a questa forma disumana di separazione e differenziazione si farà meno pubblicità possibile, essendo ormai ammessa da tutti i sapienti al servizio delle istituzioni la scarsa capacità ortopedica dello strumento carcerario.
I detenuti di domani non saranno dentro perché ci si aspetta da loro qualcosa. A esempio, un ravvedimento o una modificazione del loro modo di agire o di ragionare. Saranno rinchiusi al solo scopo di essere distrutti il più rapidamente possibile.
Nella logica della separazione il potere deve accettare la possibilità di commettere errori. Ed è su questi errori che dobbiamo far leva per ribaltare la situazione.
Per quanto difficile, nel regno dei compartimenti stagni, la circolazione delle idee e delle informazioni è sempre possibile. Sarà nostro compito allora fare conoscere fuori le condizioni del carcere distruttivo, ricollegando queste condizioni alle situazioni generali (e separate) della società nel suo complesso. Si potrà così sviluppare un’analisi destinata a capovolgere i significati imposti dal potere.
In questo senso il nostro lavoro è già cominciato.
Non possiamo più considerare il carcere come un anacronismo in una società permissiva, qualcosa che può essere cancellato con accordi e assicurazioni di buon comportamento. Lo dobbiamo per forza considerare come elemento di un progetto complessivo che non contraddice il significato dell’insieme proprio perché si inquadra perfettamente nell’apparenza permissiva e nella sostanziale mentalità di controllo.
Per lo stesso motivo non lo possiamo considerare come una “faccenda nostra”, un problema dei compagni in carcere, qualcosa che si impone per la sua importanza perché la nostra presenza “dentro” è talmente alta da farlo diventare elemento centrale della nostra azione rivoluzionaria.
Ogni impostazione del genere risulta non valida per due motivi. Primo, non è comprensibile nelle diverse “separatezze”, essendo leggibile – per giunta in termini molto contraddittori – solo nella nostra separatezza o, per meglio dire, nel nostro ghetto. Provando a uscire fuori dal chiuso dei nostri giri, diventiamo astrali non appena poniamo il problema del carcere in termini di “compagni in carcere”. Tutti i nostri fogli, che del carcere hanno fatto l’elemento centrale della problematica affrontata, si sono così chiusi ogni prospettiva diversa.
In tempi grami è bene avere le idee chiare. Occorre trovarsi. Ma per trovarsi bisogna cercarsi. La prima cosa da fare è quindi cominciare a cercare sulla base delle affinità leggibili attraverso le righe, perché non è il caso di parlare di programmi, progetti, punti o altre faccende del genere.
Sappiamo che queste affinità esistono. Ebbene, facciamole venire fuori, alla luce del sole. Non condanniamole alle beghe di corridoio. Mettiamo a tacere, una volta per tutte, chi tra noi, per un mal compreso purismo alimenta inutili tempeste in un bicchiere d’acqua, per poi essere pronto a stornare le intenzioni di chi vuole agire al momento opportuno, dichiarandosi non d’accordo e in perenne attesa di un segno dei cieli.
Pensiamo che non si possa più parlare di un problema “carcere” se non attraverso un’ottica precisa, cioè quella di riportare questo problema all’interno delle lotte complessive del movimento rivoluzionario. Se la dimensione di queste lotte sarà piccola, anche piccolo sarà lo spazio degli interventi contro il carcere e lo Stato continuerà a portare avanti i suoi progetti di restringimento degli spazi sociali.
Ma una vaga affinità non basta. Si può essere affini con alcuni compagni e vedere come gli interessi di questi ultimi vengono polarizzati da altre cose: dal proprio lavoro, dalla propria situazione familiare, dai propri gusti e bizzosità personali, dal proprio estetismo o dal proprio scetticismo. Tutta l’affinità del mondo finisce per annegare davanti a questi affievolimenti’ che snaturano l’individuo e lo pongono in balia degli avvenimenti di ogni giorno.
È tempo di dire che non possiamo più andare in cerca di splendide individualità da tirare fuori dalla merda. Come non possiamo, a uso e consumo del singolo, assumere atteggiamenti più o meno simpatici per riuscire meno sgraditi alla sua riluttante volontà di coinvolgimento.
L’affinità va cercata sulla base delle idee, delle azioni e dei progetti personali a breve e medio termine. Non è sufficiente un accomodante gesto di simpatia, o la sottintesa complicità su alcune prese di posizione. Ci vogliono fatti, idee, contributi chiari. In caso contrario ognuno è bene che vada per la propria strada.
In questo senso è possibile parlare dello specifico rivoluzionario. Un pugno di uomini, non un’accozzaglia di orecchianti della rivoluzione. Un minimo di decisione e non sempre l’incertezza e il piangersi addosso. Francamente di lacrime, commiserazioni e diatribe di quartiere ne abbiamo fin sopra i capelli.
Ciò non toglie che molti compagni possono avere livelli diversi di affinità e intendere la loro partecipazione alla lotta nei limiti, precisi e dettagliati, di questa loro situazione. Se ciò è chiaro fin dall’inizio nessuno può avere sorprese se non positive, quali, a esempio, il superamento di quei limiti iniziali e non un passo indietro (quanto mai pericoloso) nei confronti di iperboliche prese di posizione iniziali, massimaliste e del tutto campate in aria.
Incontrarsi, mettersi d’accordo. Decidere un progetto insieme. Non definitivo e irrevocabile, ma progressivo e adattabile al modificarsi delle situazioni. Cominciare da qualche punto, ma avendo una visione complessiva quanto più ampia possibile. Evitare di partire dalla denuncia di torti subiti o dalla recriminazione di passate possibilità non sapute sfruttare. La gente non ama sentire parlare di sconfitte, persecuzioni e minoranze afflitte. Raccoglieremmo sempre l’attenzione e la benevolenza pelosa di una ristretta cerchia di benpensanti che si fanno gli affari propri mettendo facilmente a tacere la propria coscienza.
Torniamo alla lotta aperta. Nel campo del lavoro, nei problemi della casa e dei quartieri, nei problemi dei servizi, nella scuola, nelle carceri, nelle caserme e dovunque dilaga la separatezza sociale.
Torniamo adesso con un minimo progetto, anche circoscritto e risibile (per alcuni che si sognano le grandi campagne controinformative che lasciano tutto come prima), ma torniamo alle cose concrete.
Limitiamo il momento controinformativo, condensandolo e circoscrivendolo nel contenuto e nello spazio. Proponiamo una struttura organizzativa e uno sbocco di azione, avendo cura che nella prima e nel secondo ci siano i nostri contenuti: autonomia organizzativa, conflittualità permanente, occupazione o esproprio o presa in carico di quanto non ci appartiene legalmente ma è nostro socialmente. Prepariamo anche la difesa di questa lotta, diamoci i mezzi per portarla avanti, di ogni genere (non esistono momenti particolari che rendono inadatti alcuni mezzi, chi ragiona così è un reazionario che si dà arie non sue).
Prepariamo la prossima insurrezione.
Varianti repressive: la tortura
La strada descritta nelle pagine precedenti riguardo una possibile evoluzione degli strumenti repressivi non può negare la possibilità di alcune varianti repressive, prima fra tutte la tortura. [Cfr. (A. M. Bonanno), “La tortura e il silenzio. La tortura sistematica”, in “L’Anarchia”, Numero unico, novembre 1982, p. 6].
Impiegata sistematicamente nelle caserme e anche nelle carceri costituisce il primo livello d’intervento per estorcere confessioni, indicazioni di correità e anche per indurre a pentitismi e a collaborazionismi vari.
Ogni qual volta trapela qualcosa la cosiddetta sinistra si mette subito il cuore in pace con alcune interrogazioni parlamentari. Dopo, passata l’ondata del dibattito e il rumore abbastanza velato dei pochi articoli nei giornali, tutto torna alla normalità. Ma la normalità del potere è proprio fondata sulla possibilità di usare, all’occorrenza, la tortura nel silenzio e nella indifferenza di tutti.
I compagni in carcere che intendono mantenere la propria soggettività rivoluzionaria, vengono sottoposti a speciali norme di isolamento che costituiscono una tortura psicologica tra le più terribili: mancanza d’aria, mancanza di letture, mancanza di oggetti personali, cibo ridotto. La strada verso i sistemi delle colonie penali francesi è sempre aperta. L’antica Cayenna rivive in versione ammodernata.
I proletari che cadono nelle mani della polizia e dei carabinieri vengono sistematicamente passati al vaglio del bastone. Questo metodo, tipico del fascismo, possiede, nella stravolta fantasia dei tutori dell’ordine, un valore pedagogico: chi lo subisce, anche se innocente, se lo ricorda e quindi riga dritto in futuro. Questa mentalità da Inquisizione è praticamente ineliminabile nelle nostre polizie, per quante chiacchiere si possano fare sulla loro democratizzazione.
Tacere significa aprire la strada verso un maggiore impiego della tortura. Oggi l’acqua salata viene fatta bere (mista a sabbia e a olio di ricino) ai compagni e ai proletari arrestati con le armi in pugno. Domani un simile trattamento potrebbe essere applicato anche per la distribuzione di un volantino, per la stampa di un giornale, di un libro, per uno sciopero. Anche se l’insieme complessivo del progetto di repressione si orienta verso un impiego di mezzi diversi, le varianti di cui discutiamo sono sempre pronte all’uso.
Per questo motivo tacere significa dare spazio a una gamma vastissima di torture in camice bianco. Il medico che uccise Serantini in carcere negandogli il soccorso era un torturatore, allo stesso modo dei poliziotti che bastonarono a morte il nostro compagno sulle rive dell’Arno.
Torturatori sono tutti coloro (magistrati, poliziotti, agenti di custodia, giornalisti, medici, avvocati, ecc.) che utilizzano mezzi di pressione (fisici, psichici, diretti e indiretti) per ottenere da un prigioniero un comportamento diverso da quello che quest’ultimo ha deciso di tenere. Allo stato attuale dello scontro di classe, esistono ancora precise norme legali che limitano la detenzione alla sola privazione della libertà e non prescrivono o rendono possibile il ricorso a mezzi aggiuntivi, allo scopo di costringere a fare cose contro la propria volontà.
Questo concetto è importante e non si basa soltanto su di un vago garantismo, ma parte dal punto essenziale degli spazi di agibilità che ancora possediamo e che vanno utilizzati.
Occorre denunciare tutti i comportamenti delle autorità – e in primo luogo della polizia – che intendono ridurre questi spazi di agibilità. Questa non è solo una lotta diretta alla “difesa del detenuto”, ma assume un significato più ampio, in quanto difende tutti coloro che si trovano ad affrontare una situazione di sfruttamento sul posto di lavoro, nei quartieri, nelle scuole. Tortura diventa anche il lavoro non sufficientemente garantito, la disoccupazione, il lavoro nero, l’isolamento delle donne proletarie, il vivere nei ghetti e nella miseria, la mancanza di igiene, la mancanza di strade, di acqua, di mezzi di trasporto a basso costo, di cultura, di libri gratuiti, ecc.
Ancora più grave è il silenzio nei confronti della tortura che viene sistematicamente applicata nei confronti dei proletari arrestati. Si tratta di un problema più grave perché non riesce a raggiungere i livelli della grande informazione e viene considerato come faccenda di normale amministrazione dalla cosiddetta coscienza pubblica. Di più: gli stessi proletari arrestati ritengono “normale” il trattamento che subiscono nelle caserme e cercano, in tutti i modi, di ricorrere a procedimenti vari per ridurre al minimo i danni subiti. Tranne i casi eclatanti, che scoppiano quando qualcuno viene ucciso nelle stanze delle varie questure o in qualche caserma, il resto passa sotto silenzio.
Prima regola aurea per i proletari è quella di non dichiarare mai di essere stati torturati, specialmente non dire mai nulla al giudice, tanto non si ricava niente di utile e si aumenta la dose dei futuri pestaggi. Seconda regola: quando si è presi e condotti in questura cercare, con tutti i mezzi, gettandosi su di un vetro o tagliandosi la faccia con qualsiasi oggetto a portata di mano, di farsi delle ferite evidenti e quindi obbligare gli inquisitori a farsi portare all’ospedale. Terza regola: fingere di collaborare, confessare a metà, mettersi d’accordo, ecc. Si tratta di un codice di sopravvivenza che finisce per fare entrare nella stessa logica inquirenti e arrestati, una logica della violenza e del sopruso.
Sconfiggere questa mentalità non è facile. La stessa attenzione che si è rivolta verso i compagni torturati, e il gran parlare che se ne è fatto, non fa altro che scavare di più un solco di differenziazione. Occorre fare di tutto per documentare e denunciare la tortura sistematica nei confronti dei proletari, così come viene realizzata nelle caserme, per ricomporre una possibile unità di lotta che viene continuamente messa in forse. Intervenendo nei quartieri proletari ciò è possibile, la gente che ci ascolta sa perfettamente di cosa parliamo, ed è un modo di portare il problema del carcere nella realtà esterna, nei posti dove i proletari affrontano i problemi di tutti i giorni.
Si può così affrontare il fenomeno della tortura senza quell’aria di sbalordimento e di indignazione che è senz’altro fuori luogo. Il potere impiega questo mezzo “di regola” e non “eccezionalmente”. Solo che lo impiega quando lo ritiene opportuno. Deve essere quindi smascherato nel suo agire di tutti i giorni e non nella particolarità di un momento di tensione. Si può così contribuire a fare cadere la maschera ipocrita di tutti quei benpensanti che sono pronti a mettere una mano nell’acqua fredda quando si tratta di detenuti politici, ma non vogliono fare nulla per i proletari prigionieri torturati giornalmente.
Varianti repressive: i pentiti
La legge speciale sui “pentiti” presenta caratteristiche di accordo tra strutture di potere diverse che sono normali per lo Stato e i suoi organi esecutivi. [Cfr. (A. M. Bonanno), “Pentiti e strategia del potere”, in “L’Anarchia”, cit., p. 7].
Questa legge e l’accettazione non certo marginale che di essa si è avuta fra gli appartenenti ad alcune organizzazioni armate, indicano il fallimento di qualcosa. Non della lotta armata, che in quanto metodo non può né fallire né avere successo, ma di alcuni progetti politici che l’avevano assunta come veicolo privilegiato di intervento nello scontro di classe.
Il governo e il parlamento hanno tagliato apposta le norme legislative per consentire una specie di soluzione negoziata a un problema che, collocato sul piano strettamente militare, poteva andare troppo per le lunghe e restare significativo anche nei prossimi anni, cioè in un periodo in cui si prevede la crescita di una conflittualità generalizzata, conseguenza dell’acuirsi delle contraddizioni sociali, dell’incapacità di ristrutturazione, degli scompensi produttivi, ecc.
I vari punti della “riduzione di pena”, della “non punibilità”, della “scarcerazione per iniziativa del governo per i grandi collaborazionisti”, della libertà provvisoria per chi si consegna “spontaneamente”, ecc., trovano un significato diverso in due prospettive: da un lato i delatori, cioè coloro che partecipano attivamente alla denuncia e al massacro dei propri ex compagni di lotta, cioè coloro che si mettono al servizio dei torturatori, degli sbirri, dei magistrati, i vermi più abietti nella scala zoologica di quanti si scoprono l’anima del traditore, dall’altro lato, coloro che si “chiamano fuori”, cioè che dichiarano il fallimento della propria attività politica e vogliono fare marcia indietro, contribuendo così a gettare una luce di colpevolezza sui compagni che non intendono fare “marcia indietro”. Gli appartenenti a questo secondo tipo risultano, in pratica, delatori indiretti.
In questa ripartizione si inseriscono sfumature varie e sottigliezze di secondaria importanza. Quello che conta è che tutti costoro, in un modo o nell’altro, con maggiore o minore misura, sono responsabili delle torture, delle esecuzioni, delle condanne, delle intimidazioni che i compagni subiscono in carcere e che tutti gli altri compagni, anche fuori del carcere, sono costretti ad affrontare quando si impegnano attivamente nello scontro di classe.
Ognuno sceglierà di presentare a questi vermi i conti dei misfatti compiuti, esigendone il saldo. Per il momento c’è da fare una considerazione di massima. La partecipazione di tutta questa gente, nei confronti dei quali è stato per diverso tempo impropriamente usato il termine di “compagni”, allo scontro di classe è stata velleitaria e incompleta, fondata su illusioni romantiche o banditesche, assolutamente inadatte a far vedere nella propria realtà il fondamento del problema rivoluzionario. Il loro stesso “reclutamento” è stato un fenomeno dissennato e acritico, una specie di corsa pazza verso il quantitativo, senza tenere conto della crescita della coscienza individuale e collettiva. Così si pagano le illusioni del partito armato, dello strumento intermedio tra la minoranza guida e il proletariato, del mitico depositario della memoria rivoluzionaria.
Occorrerà in futuro rendersi conto più approfonditamente di questi problemi e specialmente del fatto che nessuna efficienza tecnica e organizzativa potrà mai sostituire lo sviluppo progressivo e armonico della coscienza del soggetto rivoluzionario.
Varianti repressive: i dissociati
Il “cedimento” è un’espressione dell’animo umano. In quanto tale non può suscitare giudizi a priori ma soltanto, quando si presenta, una valutazione oggettiva. [Cfr. (A. M. Bonanno), “Da marcire a marciare”, in “Anarchismo” n. 43, giugno 1984, p. 38].
Nessuno è coerente all’infinito con se stesso e con le proprie idee. Posti davanti a pressioni e sofferenze, davanti a lunghi anni di carcere e a dolori inimmaginabili, molti di noi possono “cedere”, ammettere la propria debolezza, venire a patti col nemico.
Tutto ciò è umano e non meraviglia nessuno.
Molti compagni che si trovano in prigione da molto (da troppo) tempo, cercano un modo per uscire dalla loro situazione, alcuni fra loro cercano un modo qualsiasi, altri un modo che sia dignitoso, altri un modo che non li costringa a entrare a patti con le proprie idee.
Tutto ciò è evidente. Nasconderlo non è utile a nessuno.
Restano solo da dire due cose.
Primo. Perché nascondere un “cedimento” sotto un enorme accumulo di chiacchiere vestite degli abiti smessi di una teoria che non ci appartiene? Mi sembra molto più corretto dichiarare la propria impossibilità fisica e personale a continuare. Nessuno avrebbe nulla da obiettare, nessuno potrebbe permettersi di avanzare una critica. Poi, dopo questa iniziale dichiarazione, si potrebbero costruire – a uso e consumo della controparte – tutte le elucubrazioni teoriche di questo mondo. Invertendo l’ordine delle cose si rischia di ingenerare fra i compagni molta più confusione di quella che oggi esiste. Si determinano conflitti fittizi, si alimentano i tentativi dello Stato di criminalizzare quella parte di compagni che non è disposta ad accettare cedimenti (dentro e fuori del carcere).
Secondo. I tempi si vanno facendo più duri. Le cose possono peggiorare, e di molto. In questa situazione tutti i compagni (dentro e fuori del carcere) che si interessano ai problemi della repressione devono riflettere bene prima di prendere una posizione o un’altra, prima di dare indicazioni o sviluppare analisi. Accade, infatti, che molti compagni, per quanto in buona fede, non abbiano sufficiente intelligenza rivoluzionaria per avanzare ipotesi operative o sviluppare analisi, come accade anche che altri compagni non abbiano sufficiente documentazione. Eppure si continua a fare l’uno e l’altro, con conseguenze disastrose.
Facciamo un solo esempio. Alcuni compagni hanno sostenuto (e sostengono) la necessità di una lotta per l’amnistia non rendendosi conto che così si allineano a fianco della risma peggiore di mestatori politici, allineamento che per quanto in buona fede e dovuto soltanto alla loro scarsa capacità di analizzare il problema,–, non per questo diventa meno pericoloso. Il fatto che questi compagni sostengano la necessità di mobilitare il movimento in azioni dirette ben precise (quindi fondate sulla negazione. della delega) per ottenere l’amnistia, nulla toglie all’ingenuo confusionarismo della loro posizione.
Ripetiamo che i tempi stanno diventando molto duri e occorre avere il coraggio delle proprie azioni. Non il coraggio dell’avventatezza ma quello che si basa sull’analisi, la conoscenza dei fatti, le idee chiare. Pretendere di continuare ad andare avanti con lo spirito dell’assistenza e della solidarietà, senza guardare alle posizioni che si assumono pensando soltanto al fatto che i compagni si trovano in galera, potrebbe dare amarissimi frutti in un futuro molto più vicino di quanto si pensi.
Per un altro verso non saranno certamente le considerazioni politiche quelle che ci porteranno a esprimere giudizi. Nessuno, lo diciamo ancora una volta, può arrogarsi questa pretesa, a condizione che da parte di tutti i compagni ci sia l’intenzione di fare chiarezza e non di contribuire a rendere ancora più confusa la situazione.
[Tratto da Alfredo M. Bonanno, Teoria e pratica dell’insurrezione, prima edizione, Catania 1985, pp. 227-247. Non inserito a partire dalla seconda edizione]
Psicoanalisi
Qualche anno fa, uno degli intellettuali più in vista del movimento anarchico nostrano, ci faceva sapere di avere individuato la debolezza teorico-pratica dell’anarchismo odierno in una carenza di ricerche psicologiche. La cosa, a suo tempo, mi sorprese non poco, anche per gli strani consigli che la degna persona sunnominata dava allo sprovveduto lettore, allo scopo di mettere una pezza definitiva sulle non mai opportunamente sottolineate deficienze anarchiche.
Che la psicologia sia stata, spesso, se non proprio in tempi recentissimi, uno degli abbagli dei teorici anarchici, si spiega col fatto che lo scientismo dei nostri padri putativi aveva collocato in alto alcune porzioni del sapere umano (si pensi alla statistica) e vi aveva riposto tutte le speranze di liberazione. Sostituendo il potere politico con la semplice gestione amministrativa, quelle scienze sarebbero subito dopo (o poco prima) diventate strumenti di liberazione. Le cose non stavano, e meno che mai stanno, in questo modo.
Anche i ritornelli elogiativi in morte di Musatti [aprile 1989] mi hanno fatto riflettere sulla faccenda. E sono rimasto un poco perplesso. Più di trent’anni fa scrissi qualcosa sull’argomento, dopo avere letto il Trattato di Musatti che, all’epoca, mi aveva lasciato forse un poco più perplesso di quanto non lo sia oggi. Più di vent’anni fa scrissi su di un giornale anarchico alcune riflessioni sulla sessualità e la psicoanalisi e, per quello che posso ricordarmi adesso, le mie idee non sono cambiate di molto. Nel luogo dove mi trovo [carcere di Bergamo] non posso andare a rivedere quei miei vecchi scritti, per cui riprendo la discussione con me stesso, e spero con quei pochi compagni che hanno a cuore lo scopo principale di ogni ricerca, che sarebbe l’azione rivoluzionaria, con la speranza suppletiva di non essere subito frainteso.
Questo Musatti a me stava sulle palle per una sua certa aria di superiorità nei riguardi delle parti. Era troppo dolce e troppo buono per riuscirmi simpatico. Socialista, si lasciò passare sotto il naso tutti gli imbrogli di questi mestatori. Vicino ai comunisti, sorrise accondiscendente davanti ai misfatti degli anni Cinquanta e sorrideva ancora davanti alle stupidaggini di oggi. Forse capiva poco, forse molto. Non lo so, e non me ne importa quasi niente.
La cultura, e quindi anche la psicologia e la psicoanalisi, sono strumenti fondamentali per intraprendere una trasformazione del mondo nel senso della liberazione degli oppressi e degli umili, degli offesi e degli esclusi, ma ha un difetto: è gestita in proprio dagli intellettuali, che ne fanno un uso mafioso e corporativo. Espropriare questa ricchezza fa parte della lotta di classe e segue gli alti e i bassi di questo scontro. Occorre però, quando si espropria qualcosa, prendere roba utilizzabile e non zavorra che torna utile soltanto al dominio in carica. E il lavoro critico nei riguardi della cultura è un processo parallelo a quello di espropriazione, non può essere fatto né prima né dopo, ma deve essere contemporaneo.
Ciò vale, in primo luogo direi, per gli strumenti più subdoli e pericolosi che usa la classe dominante, cioè quegli strumenti culturali che manipolano l’individuo: filosofia, psicologia, religione, ecc., con tutti i settori subordinati, per arrivare poi agli strumenti che manipolano il corpo dell’individuo, gli animali, le cose, ecc. Ora, la psicoanalisi è uno strumento specialistico che arriva a livelli di manipolazione molto pericolosi. Alleandosi, come di fatto avviene, col potere repressivo e con quello chimico-farmaceutico-medico, realizza i massimi sistemi di distruzione totale dell’uomo.
C’è da chiedersi, però, se essa – perché della psicoanalisi stiamo parlando – può essere espropriata e stornata contro i suoi attuali utilizzatori. Questo non è possibile dirlo, per cui, al momento, ci si dovrebbe limitare a una critica del corpo analitico, nel suo insieme, e a una presa di distanza ben precisa nei riguardi dei suoi attuatori, cioè gli psicoanalisti. Non so se questo sia possibile. Dividere teorie da uomini che le sostengono è un’ipotesi idealista che non mi ha mai visto d’accordo. E questi uomini, come sempre, sono tutti dentro le istituzioni, anche il buon vecchio Musatti, col suo sorriso da perfetto idiota-intelligente.
Certo, anche molti compagni, e tutt’altro che in malafede, utilizzano riflessioni psicologiche e, spesso senza saperlo, anche psicoanalitiche, ma bisogna vedere perché lo fanno. Lo scopo immediato sarebbe quello di scoprire le tracce fuorvianti della propria coscienza, portare alla luce quello che vogliamo effettivamente dire e fare al posto di quello che invece diciamo e facciamo. Lodevole scopo, ma è proprio così che vanno le cose? Possiamo tirarci fuori dal compromesso e dalla complicità col potere, semplicemente riflettendoci sopra?
E poi c’è il problema della cura. La psicoanalisi è un discorso terapeutico, e qui si capisce meglio la sua connessione con la tradizione psicologica sperimentale. Vuole salvare il singolo (possibilmente a pagamento), interpretandone i segni, i simboli, le comunicazioni. E qui tanti si sono illusi che una spinta la si poteva dare sollecitando all’azione. Specie in tempi di riflusso, un analista serio può spiegare ai vari desistenti (traditori compresi) che la strada per uscire dal tunnel è l’impegno. Lo stesso potrebbe fare (e di fatto fa) con quei benedetti drogati che la sorte (e la programmazione capitalista) ci sta mettendo fra i piedi in questi giorni. L’azione come salvezza, come rimozione, come sublimazione, come super-qualcosa che salvi noi e, con noi, il mondo.
A parte una irriducibile avversione per tutti i salvataggi, sia di moribondi che di superuomini, penso che l’azione non può essere frutto di una fuga, né protesi suggerita da una cura intelligente. Se la coscienza è malata, l’azione non può curarla, questa, se portata avanti, rifletterà i sintomi di quella malattia, pretenderà di trasferire sugli altri i propri fantasmi e le proprie illusioni e, soprattutto, eviterà con ogni mezzo di essere effettiva trasformazione sociale, sconvolgimento e messa in discussione.
Ho un profondo disprezzo verso coloro che consigliano l’azione come rimedio ai guasti della psiche, come verso coloro che consigliano l’approfondimento e lo studio per avere i mezzi “per stare meglio”. La propria situazione di disagio, la stessa malattia, la follia al limite – se volete – possono essere occasioni per ricomporre un progetto di coscienza, una unità logica decisionale, sia pure momentanea, per andare oltre, contro il nemico. Questo sì, ma non possono mai essere un espediente terapeutico.
[Pubblicato su “Provocazione” n. 20, maggio 1989, p. 6 col titolo “Psicoanalisi e perplessità”]
Ràfia
Se, per quanto mi è dato sapere, la ràfia si sviluppa e avvinghia con sottile capacità, tanto da legare spesso in modo inestricabile cose tra loro (apparentemente) lontane, non è certo agli intellettuali che bisognerebbe chiedere, visto che sono senza dubbio cultori di questo prodotto, ma non sanno assolutamente cosa fare per impedire la sua crescita. Le risposte finirebbero (e spero di venire contraddetto) per essere elusive e superficiali.
In un ambito che della ràfia fa forza collante e simbolo di reciproco controllo, chi potrebbe dirci qualcosa di serio (e di vero) sugli effetti dannosi di questo prodotto?
La ràfia è, senz’altro, un qualcosa fuori di noi, ma è anche – nel suo essere “legame” – qualcosa che è dentro di noi, in modo particolare di coloro tra noi che dell’arte del nulla hanno fatto sistema per il proprio sostentamento (quasi sempre non proprio modesto).
E poi, quando mai qualcuna di queste “primarie personalità della cultura italiana” si è fatto male utilizzando la ràfia, riflettendo su di essa o fornendo indagini e analisi intorno al suo modo d’uso?
La ràfia, signori miei, mi pare una cosa seria. Tanto seria che sta là, immobile, come una cosa degna di questo nome, poco curandosi delle chiacchiere che su di essa si fanno. E tanta poca cura di queste chiacchiere essa si prende che non mi pare di ricordare che il suo rigoglioso sviluppo sia stato raffrenato da speculazioni filosofiche.
Al contrario, anzi. Spesso, e mi auguro involontariamente, dall’arte narrativa di qualche uomo dabbene essa ne esce come rinvigorita, certo come messa in una luce provvidenziale e spettacolarmente invidiabile, tanto da suscitare nell’ignaro fruitore del messaggio un senso di desiderio per quanto concerne le presunte virtù di una sua “giusta” elargizione di legami e stringimenti.
Anche i racconti neri hanno il loro fascino.
Penso quindi che non sia stata una buona idea quella di andare a chiedere ai chierici cosa sia la ràfia, in quanto essi sono – anche se non in prima persona – coltivatori ed estimatori, non certo avversatori concreti e operativi del suo sviluppo.
Anche se meno in grado di cogliere sottili (e non sottili) omofonie, altri strati sociali sarebbero stati molto più espliciti e costruttivi.
Comunque, mi auguro di non essere nel giusto.
[Pubblicato su “Carte Siciliane” n. 2, ottobre-dicembre 1985, pp. 4-5]
Razzismo
Il razzismo può essere definito in molti modi, la maggior parte dei quali tende a giustificare un atteggiamento di difesa e di attacco contro altri uomini che si pensa possano, nell’immediato o in un prossimo futuro, danneggiare i nostri interessi. Alla base del razzismo e sotto le sue coperture mitiche legate a fantasie e irrazionalismi vari, c’è sempre una precisa motivazione economica alla cui difesa si indirizzano, opportunamente sollecitate, le paure e le fantasie che tutti abbiamo nei riguardi del diverso.
Mi è accaduto di leggere diverse tesi sulla crescita del razzismo in Italia, dove si affermavano incredibili inesattezze. Mi pare quindi utile cominciare queste “inattualità” scomode con qualche riferimento più preciso. Il razzismo accompagna la storia dell’umanità ed è sempre legato alla paura del “diverso”, disegnato nei modi più incredibili e fantastici.
Senza volere andare troppo in là, ben prima delle teorizzazioni razziste del Novecento e del secolo che l’ha preceduto, la Chiesa cattolica è stata non solo lo strumento del razzismo violento e distruttore per diversi secoli, ma è stata anche il luogo dello sviluppo teorico della teoria del sangue, teoria applicata per la prima volta contro gli Ebrei spagnoli e i loro disperati tentativi di convertirsi al cattolicesimo allo scopo di sopravvivere.
Lo scientismo del secolo scorso, nella medesima lotta contro la Chiesa e le sue teorie, comprende contraddittoriamente un filone teorico – da Gobineau fino a Chamberlain – che recupera le tesi sul sangue e la condanna atavica contro gli Ebrei e le inserisce in una sorta di evoluzionismo deterministico, da cui trova anche oggi fondamento un residuo della teoria razzista ortodossa moderna, quella sostenuta in poche parole dai nazisti.
Ma queste teorie sarebbero rimaste, fin dalla “reconquista” della Spagna ai nostri giorni, nel cassetto degli orrori storici del pensiero umano, se non avessero, di volta in volta, trovato una base economica su cui esercitarsi, interessi economici da tutelare, paure di possibili espropriazioni da esorcizzare. La crociata cattolica contro i Mori, vincitrice, aveva paura che la situazione generale delle ricchissime provincie spagnole lasciate dagli Arabi, non potesse essere controllata se non si procedeva subito a una persecuzione degli Ebrei, a una loro ghettizzazione e a un loro successivo controllo, in quanto questi, praticamente lasciati liberi in ogni senso dagli Arabi, avevano in mano le leve economiche dell’economia spagnola.
Le vicende della repressione e del genocidio degli Ebrei da parte nazista sono conosciute, come pure la giustificazione economica accampata, dove venivano utilizzati fatti concreti e elementi mitici. In effetti era vero che il governo tedesco, dopo la sconfitta della prima guerra mondiale, con l’inflazione del marco, decisa in larga parte su influenza dei gruppi dirigenti ebraici, aveva danneggiato i piccoli risparmiatori e i salariati, ma non aveva nulla di vero la deduzione successiva che la colpa era dovuta tutta al fatto che gli Ebrei agivano come “nazione estranea”, tutti in blocco, e quindi andavano tutti in blocco sterminati. In questo modo trovarono la morte, non poche decine di grossi industriali, ma milioni di poveracci la cui sola colpa era di essere Ebrei.
Allo stesso modo, il problema dei Giamaicani in Gran Bretagna si basa sul fatto che sono diventati un peso per lo Stato. Fatti affluire a decine di migliaia subito dopo la fine della seconda guerra mondiale, per sostenere la ricostruzione del paese, adesso li vorrebbero fare tornare da dove sono venuti, non tenendo conto che la maggior parte dei giovani, che costituiscono l’elemento più irrequieto, sono nati lì e non vogliono per niente tornare in un posto a loro sconosciuto, da cui non sono mai partiti.
Il razzismo israeliano contro i Palestinesi ha il medesimo fondamento economico, gli interessi sionisti adesso non possono tollerare una riduzione di territorio e neanche una coabitazione, che a lungo andare si rivelerebbe distruttiva con un possibile Stato palestinese, capace di diventare la punta di diamante economica di un mondo arabo potenzialmente molto ricco. Non dobbiamo dimenticare che l’intellighenzia araba è quasi tutta palestinese e questo fa paura agli Israeliani e li spinge a combattere più del simbolo mitico della grande Israele che si dovrebbe estendere fra i due fiumi storici.
Il razzismo arabo, che si concretizza nelle continue dichiarazioni di “guerre sante”, per altro mai effettivamente concretizzate nel senso classico del termine, ha anch’esso un fondamento economico ed è diretto sempre a impedire l’isolamento politico e lo sfruttamento da parte di altre nazioni del periodo favorevole, e limitato, dell’estrazione del petrolio.
Il razzismo italiano ha avuto in passato le sue espressioni consistenti e significative, non solo teoriche, ma anche pratiche. Certo, nulla da paragonare alle capacità dell’“ordine teutonico”, ma sempre a un buon livello. La rivista italiana “La difesa della razza”, il cui segretario di redazione era Almirante, negli anni della sua pubblicazione raccolse tanti nomi di quella che sarà poi la cultura ufficiale antifascista e democratica. Ma lasciamo stare. Queste sono minuzie paragonate ai massacri perpetrati dall’esercito italiano in Libia, in Etiopia, in Jugoslavia. Ognuno fa quel che può.
Adesso, l’“uomo nero” sta facendo la sua comparsa sul territorio sacro della nostra patria e comincia a diventare “visibile”. Fin quando si trattava di poche decine di “neri” la cosa poteva essere tollerata, anzi stuzzicava la superficiale verniciatura democratica di qualcuno, spingendo a dichiarazioni azzardate di antirazzismo. Lo stesso per qualche accampamento di “zingari’ e per le comunità di Cinesi, Filippini, Slavi, Polacchi e via dicendo. Molti si dicono continuamente: “Va bene che questa gente è come noi, anche se ha la pelle di un diverso colore, mangia altre cose, si muove diversamente, parla un’altra lingua, ma purché si renda conto che deve restare al suo posto”. Ecco, il nostro antirazzismo è tutto qua: il nero, che riassume in sé tutte le caratteristiche più estreme della diversità razziale, è come noi, è un uomo anche lui, non è una bestia, ma deve capire il “bene” che gli stiamo facendo, dandogli l’occasione di godere delle briciole che cadono dalla nostra tavola ultracarica di ogni bene consumistico. Deve imparare a lavorare, a lungo e bene, sopportare i lavori più duri, essere gentile ed educato, fare finta di non capire, abituarsi a subire lo sfruttamento (lavoro nero – come lui per altro –, lavoro saltuario, lavoro di piccolo commercio, prezzi altissimi per un singolo letto in una stanza piena di topi, necessità di imparare la nostra lingua – visto che siamo tanto ignoranti da non saper parlare altro che questa inutile e periferica lingua italiana – e così via).
Ma questo decalogo dell’antirazzismo di casa nostra era valido prima che l’afflusso di immigrati, più o meno razionalizzato, diventasse così consistente, senza prospettive di una sua riduzione o effettiva regolamentazione. Da questo momento in poi è scattata la molla non solo del danno economico, ma della vera e propria paura dell’uomo nero. Per quanto possa sembrare strano, ho idea che il vero pericolo in questo momento non sia costituito da qualche sparuto gruppo di picchiatori nazisti, ma da un ben più profondo e radicato sentimento di pericolo che irrazionalmente viene avvertito da larghe fasce sociali. Non si tratta soltanto dei bottegai, che si vedono danneggiati dal venditore ambulante, ma anche della borghesia impiegatizia (dentro cui si colloca praticamente tutta la struttura poliziesca di ogni ordine e grado, compresa quella militare professionista) e perfino alcune fasce salariate e instabili del vecchio proletariato che hanno visto in questi ultimi anni condurre una battaglia sindacale per salvaguardare i residui posti di lavoro.
Che a Firenze siano state assoldate delle squadracce [aprile 1990] è un segno, pericoloso certo, ma ancora un segno. Più grave invece il comportamento razzista costante di chi forse si crede antirazzista. È questo comportamento che potrebbe domani trasformarsi in pochi attimi in vero e proprio razzismo cosciente e suscitare una catastrofe. Il pericolo è costituito da milioni di razzisti che si credono democratici e antirazzisti. È questa la riflessione “inattuale” che propongo ai compagni.
Io sono meridionale, quindi diverso, e ho sentito, non solo a livello di pelle, come questa mia “diversità” venisse avvertita, e quasi desse fastidio, a chi è abituato a vivere in ambienti “settentrionali”, a sentirsi “superiore” perché figlio di una “cultura” pensata come superiore, di una condizione economica certamente superiore e perfino depositario di una “lingua” ritenuta superiore.
Ho avvertito questa latente ostilità alla fine degli anni Cinquanta nell’ambiente culturale di Torino, dove la testardaggine nel sottolineare continuamente il mio accento siciliano mi veniva rinfacciata come incapacità e provincialismo. Ho fatto conferenze e comizi, sia fuori che nell’ambito del movimento anarchico, un po’ dappertutto in Italia, e ho trovato le maggiori difficoltà a Firenze e in Toscana. Non voglio dire che i toscani siano peggiori degli altri. Ho amici e compagni toscani che sono le persone migliori del mondo, ma c’è in loro, in tutti loro, il cattivo convincimento di “parlare italiano”, di essere direttamente depositari della lingua madre, senza avere l’ostacolo del filtro dialettale da eliminare. Questo errato punto di partenza, che li fa non soltanto parlare male, ma scrivere peggio (sempre con le dovute eccezioni), è un elemento di razzismo latente. Una conoscenza la si acquisisce attraverso lo studio, non per dote naturale legata al fatto di nascere in un determinato posto. Quest’ultimo è un concetto pericoloso. L’italiano è una lingua artificiale, composta da molti elementi, in corso di trasformazione, e così via, come tutte le lingue. Ciò vale anche per il dialetto, certamente, ma la minore capacità del dialetto, e delle lingue ridotte al rango di dialetto, di “costruire” una letteratura colta e diffonderla, li racchiude all’interno di uno spazio territoriale più o meno definito.
Io mi sono sempre rifiutato di “impostare” il mio accento in modo “corretto” proprio per non venire colonizzato, come accade alla maggior parte di coloro che prendono la cosiddetta “aria del continente” e che dopo una permanenza a Milano, sembrano, tornati alla natia Canicattì, milanesi purosangue. La difesa della propria specificità, accompagnata da una consistenza operativa, intellettuale e pratica considerevole, scatena sempre una reazione di fastidio e di paura.
Così ci accade davanti all’omosessuale che la nostra cultura democratica e antifascista considera “diverso” e che tollera, purché sia riconoscibile, cioè assuma quegli atteggiamenti da “donna fallita” che ci permettono di individuarlo e tenerlo a distanza, ovviamente in modo tollerante. Ma l’omosessuale che ci appare “uomo come noi”, ci mette in difficoltà, ci impaurisce, ed è quello che temiamo di più. Insomma, tutti noi ci siamo fatti un mondo ben ordinato, con certezze e luoghi di tutto riposo e non possiamo accettare che qualcuno “diverso” da noi arrivi e sconvolga tutto in pochi attimi.
Allo stesso modo, c’è un razzismo latente, e quindi inconsapevole, in tutti i tentativi di difesa localistica che dimostrano l’importanza e la validità di una realtà etnica senza collegarla con le altre, facendone notare nello stesso tempo l’intrinseca diversità, ma anche la profonda comunanza con le altre realtà. Quando molti anni fa ripresi all’interno del movimento anarchico italiano la tematica della lotta di liberazione nazionale, ci furono due reazioni, ambedue sbagliate, secondo me. Da un lato, coloro che dissero subito che quelle tematiche erano di destra, con buona pace del grande lavoro di Bakunin e compagni e di quasi la totalità del movimento anarchico internazionale. Dall’altro, coloro che raccolsero quelle tematiche, ma ne fecero una faccenda localistica, diretta ad approfondire le caratteristiche di un contesto sociale, etnico e non, a collegarle al contesto internazionale nel suo insieme.
Un altro elemento sotterraneo del razzismo, elemento che attraversa tutto il percorso dell’antirazzismo dominante, è costituito dalle chiacchiere politiche in favore di questa o di quella lotta per la liberazione dei neri sudafricani [1990], dei Palestinesi, dei neri inglesi, dei Kanaki, ecc. La solidarietà internazionale fatta solo a parole è una forma di razzismo latente, difatti viene sottoscritta anche dai governi illuminati e dai gruppi di benpensanti che diffondono la buona novella nel mondo. Ma quando si tratta di esaminare cosa in concreto si possa fare per sostenere quella solidarietà, per danneggiare gli interessi economici di coloro che stanno esercitando la repressione, allora le cose cambiano e subito vengono prese le debite distanze. È un altro aspetto dell’antirazzismo che tollera il nero purché resti al suo posto, un modo diverso per mantenere le distanze, per mettere in pace la propria coscienza e per fare continuare il razzismo lontano dal cortile di casa propria.
Così adesso siamo arrivati, qui dalle nostre parti, a pensare possibile che la polizia e i carabinieri diventino paladini e difensori dei neri, quindi sostenitori della politica antirazzista del governo italiano. Ma è mai possibile una cosa del genere? Chi ha visto anche una sola volta all’opera nelle strade questi massacratori in divisa, non può nutrire illusioni in merito. Questi corpi armati, costituiti in massima parte di meridionali, una volta messa al sicuro la “pagnotta” diventano i più feroci aguzzini proprio dei meridionali, che pensano e immaginano come la forza d’urto che potrebbe sollecitare possibili mutamenti capaci di rimettere in discussione un’altra volta l’ideale atavico dei loro padri: la conquista del pezzo di pane. E se questo l’hanno pensato e lo continuano a pensare nei riguardi dei meridionali, pensate quale può essere il loro atteggiamento nei riguardi dei neri, dei Cinesi, dei Filippini, degli Zingari, dei Polacchi, ecc. Altro che tolleranza democratica. L’altro giorno nella fretta di picchiare (presto e bene non vanno insieme), non si sono accorti che stavano picchiando anche una loro collega (parlamentare) che purtroppo aveva la faccia nera. Qua il razzismo è tutt’altro che latente, ma mettiamolo lo stesso nella categoria del pericolo possibile e non in quella del pericolo certo.
Ma anche i lavoratori possono essere facilmente convinti di un pericolo nero costituito da questi immigrati venuti a togliere loro quel poco di lavoro rimasto. Spostamenti anche massicci in questo senso trovano senza difesa le rappresentanze sindacali e politiche, queste hanno da sempre impostato tutta la loro strategia soltanto sull’elemento di salvaguardia economica e normativa. Ogni chiacchiera umanitaria, adesso, verrebbe a rimbalzare loro addosso, sarebbero in breve tempo costretti a farsi difensori di una fascia di lavoro istituzionalmente separata, sottopagata e garantita in modo diverso, con minori salari e minori tutele, insomma una sorta di apartheid. Una logica del genere, senza mezzi termini, è applicata regolarmente negli Stati Uniti e solo in questi ultimi anni [1990] le condizioni differenziate di tutela si stanno alleggerendo solo in contemporanea a una crescita della rabbia non solo dei neri ma principalmente di altri immigrati: Portoricani, Cubani, Messicani, ecc.
Al fondo di questo problema, apparentemente risolvibile da parte del potere, ci sta un ostacolo senza soluzione: l’antirazzismo vero, concreto, dovrebbe partire da una reale uguaglianza di tutti, uomini e donne, di qualsiasi origine, di qualsiasi provenienza, di qualsiasi cultura o religione. Ma nessuno Stato potrà mai realizzare, e nemmeno ipotizzare, un’uguaglianza concreta, per cui tutti gli Stati sono condannati a diventare focolai di conflitti razziali che nessun perbenismo parolaio potrà camuffare più di tanto. Le esplosioni di violenza, nell’uno e nell’altro senso, resteranno sempre possibili, fin quando non saranno eliminate le condizioni sociali ed economiche che producono le differenze e le stratificazioni di classe. Il razzismo è un problema economico reale e come tutti i problemi economici è risolvibile soltanto con la rottura rivoluzionaria.
Se ne conclude che è indispensabile per i rivoluzionari differenziarsi da tutti coloro – e sono una pletora – che si dicono, a parole, antirazzisti, a cominciare dai governi democratici di mezzo mondo, per finire ai cosiddetti governi degli ex Stati del socialismo reale, dove il razzismo è sempre esistito come è sempre esistita la disuguaglianza. Differenziarsi quindi praticamente dai furfanti che si dicono antirazzisti attaccando, con azioni precise, tutti i simboli del razzismo e tutti i suoi sostenitori man mano che si sviluppano e si fanno avanti, diffondendo nello stesso tempo una critica delle paure e degli irrazionalismi che sono dentro tutti noi e che riguardano ogni cosa che ci appare diversa, allo stesso scopo di ridurre quell’entroterra dove il razzismo più stupido, e quindi più evidente, trova il proprio inesauribile alimento.
[Pubblicato su “Provocazione” n. 24, giugno 1990, pp. 1-6 col titolo “Inattualità sul razzismo”]
Religione
La conoscenza non può accettare altra guida che se stessa se vuole andare avanti nella sua strada, deve cioè accettare fino alla fine quest’unica guida, se non vuole negare se stessa, e lasciare senza fondamento tutte le sue acquisizioni.
Ora, se è così, nessun interesse riscuote l’eventuale soluzione teorica del conflitto tra religione e filosofia, perché la prima non può ritenere vere che le ipotesi sue e non le altre.
Tutte le religioni pretendono di essere vere, anzi ciascuna pretende di essere la sola vera. Hanno la pretesa d’imprigionare il sentimento religioso dentro alcune regole e quindi condannano ogni altra forma di religiosità che qualcuno potrebbe considerare dotata di un maggior grado di perfezione. E non può essere altrimenti, in quanto in caso contrario la religione non sarebbe fede delle moltitudini. Nello stesso tempo è vero che nessuna analisi dogmatica particolare esaurisce l’idea religiosa, ed è ugualmente vero che il sentimento della religione è profondamente connaturato nell’animo umano, pur cambiando continuamente tutte le forme particolari della coscienza religiosa.
Spinoza pensò i cambiamenti storici delle religioni come trasformazioni di formule, attraverso le quali il fondo ultimo della religiosità resta immutato: forse la paura, forse il bisogno generato dall’indigenza non solo fisica ma morale. Le formule appaiono come progressive, hanno qualche volta disuguale capacità di leggere il mondo, ma nessuna può pretendere di essere assoluta, non essendo altro che una formula, una particolare rappresentazione storica dell’immaginazione umana. Il contenuto solo è eterno, lo sforzo dell’uomo di andare verso qualcosa di completo, di definitivamente e totalmente perfetto. Il valore delle varie formule si ricava per l’appunto dalla loro maggiore o minore considerazione di questo contenuto.
Se il contenuto della religione è la completezza possibile, questa prende la forma di condizione assolutamente altra, quindi “soprannaturale”. Ciò è rifiutato all’unisono dalla scienza e dalla filosofia, che intendono restare nei limiti di un’esperienza possibile in quanto possibile.
L’intelletto educato alla disciplina della riflessione, cerca il rapporto causale, l’ordine naturale e obiettivo delle cose, e non ammette l’intervento di forze soprannaturali. Poi si accorge che le regole spesso vengono cambiate e che non esistono leggi fisse da nessuna parte, nemmeno nel cosiddetto campo scientifico inteso in senso stretto. Chi avverte la vicinanza della completezza, intesa come antitesi della propria parzialità continuamente emergente da ogni tentativo di acquisizione, intuisce una sorta di incomprensibile “miracolo”, ma non può non ammettere che questo evento eccezionale è incompatibile tanto con la perfezione divina, quanto con l’ordine della natura. Difatti l’evento eccezionale, quello che sorprende e fa sentire l’assolutamente altro vicino, quasi dietro la porta, non è l’essenza della religione, che quasi sempre nelle sue dimensioni storiche resta prigioniera del rito.
La religione nasce come interpretazione della sollecitazione animistica, cioè in una forma che se appare naturale alla immaginazione dell’uomo primitivo e della cultura che lo caratterizza, che crea quella interpretazione, appare soprannaturale appena compiuto il primo passo successivo sulla via della riflessione sul movimento naturale della realtà. Allo stesso modo, siccome ogni nuova religione non è il prodotto della riflessione scientifica e non si diffonde tramite l’insegnamento scientifico, siccome nasce in un’atmosfera immersa nel meraviglioso, ed è produzione in parte inconsapevole, anche nella mente e nell’animo dei suoi pensatori più autorevoli, così si spiega come si presenti con l’aureola del soprannaturale, e nella forma della rivelazione soprannaturale. La religione si mostra come un gran fatto razionalizzatore, nel quale preponderano successivamente elementi vari, ma tutti diretti a mettere ordine in manifestazioni spontanee precedenti che stanno come il “giudizio di Dio” ai processi dell’Inquisizione.
Essa nasce, come conseguenza della necessità biologica della conservazione, nella fantasia, nella intelligenza, nel sentimento e nel desiderio umano, poi si distacca dalla natura con la creazione del soprannaturale, e finalmente continua nella storia come religione morale. Le oscillazioni, le deviazioni, i ricorsi, le assurdità come le coerenze, sono quasi infiniti in un’opera, nella quale l’intelligenza è strettamente avviluppata nella trama del sentimento e dell’immaginazione. Ma bisogna considerare che la metafisica dogmatica ha nella religione una funzione subordinata, perché l’interesse delle religioni non è tanto conoscitivo quanto pratico. Nella formazione dei dogmi, laboriosissima, non prevale sempre un dogma più razionale sopra uno meno razionale, ma viceversa questo su quello, perché, per condizioni speciali della teoria e della storia religiosa, il meno razionale riesce più pratico. Il culto che da principio è un mezzo di propiziazione, non è, in questa forma, essenziale, se non in certi stadi dell’evoluzione religiosa. Così finisce di essere quello che era primitivamente, e si cangia o in una maniera di manifestazione del sentimento religioso, o in mezzo di edificazione e di conservazione della comunità religiosa,.
Non è dunque agevole fissare il contenuto essenziale della coscienza religiosa, e il determinarlo non è possibile se non in rapporto alla forma perfetta e finale. Questo contenuto è stato anche variamente determinato dai maggiori filosofi di tutti i tempi, e nel secolo scorso in rapporto alle tre funzioni essenziali della coscienza: l’intelligenza, il sentimento, la volontà. Hegel ha dato la maggiore importanza al contenuto speculativo, Schleiermacher al sentimento, Kant alla moralità.
Di per sé la religione è una funzione complessa, che investe tutte e tre queste attività, e prende da ciascuna di esse una parte del suo contenuto essenziale. Questo si restringe spesso al concetto di un Dio-Spirito, al sentimento di dipendenza da un potere infinito e da una ragione assoluta e di cooperazione con essi, alla costante volontà e attuazione della morale perfetta attraverso la corruzione e la morte. Tutto il resto è simbolo, o mito, cioè idea o fatto naturale tramutato in storia fantastica.
Ognuna di queste affermazioni richiederebbe un largo sviluppo, che qui non è possibile dare; ma ammesso che il contenuto essenziale della religione si riduca a questi punti, è possibile risolvere teoricamente se esista un’antitesi inevitabile tra la religione e la filosofia? Certo, e si risolve negativamente, ma a condizione che la filosofia non contraddica al contenuto, contenuto che è il solo importante per la coscienza religiosa.
Ora, una sola forma della filosofia contraddice apertamente con questo contenuto, ed è il materialismo; perché in esso lo spirito (o meglio, la coscienza) è considerato come un accidente transitorio in un mondo ostile o indifferente. Perché la religione sussista, la coscienza umana deve scorgere nel mondo un potere con cui allearsi, col quale lo spirito finito coopera, e che conduce tutto, anche le forze contrarie alla realizzazione del divino. Ora questo è impossibile nel puro materialismo.
Però, non appena ci si riflette un poco sopra con attenzione, il materialismo puro e semplice appare penalizzante per la stessa coscienza, non solo a causa del fatto che per fare uscire il mondo dalla materia primitiva occorre metterci dentro molto più di quello che il materialista riesce a vedere. Occorre dunque, come diceva Diderot, “elargir le materialisme”, e metterci dentro la vita e il pensiero, l’attività trasformativa della coscienza. Tutto ciò non come altro dalla semplice espressione fisica, ma come altrimenti, e radicalmente altrimenti.
E d’altra parte il materialismo classico, chiuso nella sua dimensione naturalistica e fisiologica, ci lascia a bocca asciutta di fronte all’enigma dell’infinito, che tutte le religioni hanno simboleggiato, che la filosofia ha riconosciuto nella totalità, che la poesia ha espresso in potenti immagini. Insomma, l’uomo, nel sogno religioso, cerca una cosa sola, ritrovare la propria completezza.
Nessun pensiero è stato più consapevole dell’impossibilità di questa meta del pessimismo. Esso ha avuto da sempre le carte in regola per lottare contro la religione, pur non negandone il principio, ma solo considerando il percorso dell’esperienza religiosa come una strada per la perfezione, quindi una via infettata dall’ottimismo. Secondo Strauss il pessimismo sostiene che questo mondo è il peggiore dei mondi possibili, la qual cosa, per un ottimista come me, è segno di trovarsi davanti alla peggiore delle filosofie. Eppure, storicamente, il pessimismo è riuscito a creare forme di vita religiosa e anche filosofie (naturalmente pessimistiche) capaci di venire penetrate da intensa religiosità mistica. Né il fenomeno è inesplicabile, in quanto le religioni pessimistiche, se concepiscono l’esistenza come male, propongono l’annullamento, o ciò che è lo stesso, la conquista di una forma di esistenza vacua, utopicamente vuota, che indirettamente riconferma in modo tragico il valore dell’esperienza altra, di cui quella religiosa è una parte non indifferente.
Eccetto i sistemi metafisici prima indicati, nessun altro contraddice al contenuto essenziale dell’esperienza religiosa, né il teismo, né l’ateismo, né lo stesso naturalismo monistico tipo spinoziano, e neppure lo spiritualismo o il razionalismo. Chi afferma che la dimostrazione della naturalità dell’essere è nello stesso tempo, e necessariamente, la negazione della religione, finisce per considerare la natura in un senso molto limitato, e considerare la coscienza o come qualche cosa di soprannaturale, o come qualche cosa di meno che naturale, come un accidente o un fenomeno periferico.
La comunità e insieme la distinzione della natura umana e divina, che il panteismo afferma, è la più propria e la più favorevole all’esistenza del vincolo religioso che stringe insieme la coscienza infinita con l’idea di completezza infinita. Chi non ammette questo anelito verso la totalità, verso un completamento che mai si attinge, è costretto a ridurre l’infinito a una mera possibilità, e fare il tentativo che sarebbe mortale per il pensiero se non fosse vano, di rinchiudersi nei limiti del finito.
La redenzione, che è l’idea cardinale della maggior parte delle religioni, la redenzione in Dio e per Dio, nella quale l’Uomo-Dio è il mediatore, non ha senso posta l’assoluta trascendenza della natura divina. L’uomo non può adorare se stesso e neppure l’umanità, che è un momento nella totalità dei movimenti, e come fine è inesatto e ridicolo. Ma può desiderare la forma assoluta, infinita e perfetta di quella stessa essenza, la quale può offrire come rappresentazione simbolica della verità un gran numero di formule consolatorie – compito perfettamente adempiuto nella storia – quasi sempre prodotto spontaneo della stessa coscienza religiosa popolare personificata nei suoi più significativi rappresentanti.
La religione è nell’anima popolare una filosofia collettiva fatta di sentimento e d’iniziazione, è la fantasia terribile e controllora della coscienza comune, il tentativo di una ricerca dell’ideale. Essa non può essere sostituita dalla filosofia, perché questa non è la via maestra attraverso la quale passa la coscienza. Le considerazioni di quest’ultima, come le sue paure, non possono essere confortate dalla filosofia, non più di quanto non sia possibile con qualsiasi altro prodotto della fantasia mitologica. Pensare a un’educazione a lunga scadenza non è impossibile, è stato fatto e continuerà a essere fatto, ma per avere risultati apprezzabili occorrerebbe un tempo così lungo, che non è possibile calcolarlo. E posto che ci si arrivasse, il risultato non si otterrebbe se non attraverso l’esistenza di una coscienza collettiva di cui non si riesce mai ad ascoltare a pieno la voce se non nella fattispecie di “opinione”, fabbricata negli appositi palazzi del potere.
Lo schietto razionalismo è altrettanto inefficace per la vita religiosa, e tutti i tentativi fatti di religioni filosofiche sono falliti. Così è accaduto dei “trascendentalisti” kantiani, e dei “cosmisti” spenceriani in America, per non accennare neanche alle loro grottesche affermazioni riguardanti i metodi su cui impostare la propria vita religiosa.
Qualunque cosa si pensi della possibilità di sostituire la filosofia alla religione nella coscienza individuale, pare lo stesso impossibile sostituire la filosofia alla religione nella funzione sociale e di controllo che quest’ultima esercita efficacemente da sempre. Quella che deve considerarsi come una vera prerogativa della funzione religiosa nello spirito umano è la razionalizzazione delle intelligenze, delle volontà, del sentimento nell’ambito del rito e delle speranze ritualizzate. In questo senso essa è un’opera essenzialmente collettiva, come un’associazione a delinquere. Il sentimento religioso individuale è ben altra faccenda.
La religione cerca di risolvere l’arduo problema di dare l’aspetto della verità all’ordine sociale, cioè a quelle strutture sociali che proprio per tale loro qualità sono così chiamate a dominare la volontà dei singoli, a stimolarne potentemente il sentimento di paura e di abbandono, oltre che la speranza dell’attesa. La religione usa per tal fine il simbolo, la storia analogica, raccoglie commoventi leggende, dà loro l’espressione e il significato della vita, apre uno spiraglio nel destino umano. Come potrebbero la filosofia e la scienza sostituire in questo la religione?
La migliore prova che niente può sostituire la religione nel suo compito di controllo (per cui la religione potrà cessare come fatto sociale solo quando non ci sarà più necessità di controllo, non soltanto quando il controllo sarà abolito per decreto), è data dal fatto che essa stessa fallisce nel suo compito quando sottilizza troppo le sue pretese, si consegna totalmente nelle mani della dogmatica e della polemica speculativa. Le coscienze più profondamente religiose non sono quelle sottili dei teologi. La pietà di un mistico appare senza dubbio più viva e più sincera (in fondo, quindi, più umana e più lontana dai vincoli del rito e del controllo razionale) di quella di un dottore della Scolastica.
Si può affermare che il valore morale di un uomo si valuta dal fatto se c’è in lui un ideale per cui è pronto a dare la vita. Chi non può rispondere affermativamente a questa domanda, o tergiversa con quelle piccole battute scettiche che sembrano (ma non sono) soltanto intelligenti, e perfino chi tace per paura del ridicolo, non è capace di trasformare il mondo, e il solo modo di essere veramente in grado di affrontare la vita è di non retrocedere davanti alla morte. Certo tutto questo non è un privilegio delle coscienze religiose. Anzi, al contrario, spesso uomini dotati di una retta coscienza materialista affrontano la morte con maggiore serenità, ma non è assolutamente il caso di collocare qui una supremazia dell’intelletto: la morte e la ragione dominante fuggono una dall’altra. I ragionatori, quasi sempre, riflettono tanto a lungo, o quanto basta, finché gli viene a mancare il coraggio.
Ecco perché la coscienza religiosa non si riduce mai a una semplice e unilaterale meditazione sulla morte. Se Paolo pensava di vincere la morte, lo suggeriva nell’ottica costruttiva del partito, di cui fu il primo vero e proprio teorico, in quanto nel partito cristiano si immerge l’individuo e risorge superando la morte nella più ampia dimensione perenne della Chiesa che non muore. Ma si tratta di processi di razionalizzazione parecchio scoperti per essere ancora pericolosi come lo furono un tempo. «Incominciamo a morire – dice Pico – proprio quando incominciamo a vivere e la morte dura quanto dura la vita». (De ente et uno, 5). Il mistero della morte non è l’ultimo mistero che, come è stato detto, forse sarà penetrato dal pensiero umano, ma il primo. Il che sarebbe come dire che essendo il primo non c’è mistero che il pensiero umano finora abbia penetrato.
«La morte – precisa Roger Mehl – mi appare come l’impossibile comunicazione di me stesso a me stesso, la mia scomparsa come coscienza», (Le vieillissement et la mort, ns. tr., Paris 1956, p. 70) e vuole così segnare un livello limite, la presenza di un gran velo gettato dalla natura stessa sugli esseri, copertura che li rende indeterminati e indeterminabili, come le domande più pungenti della realtà umana.
«L’intuizione della nostra durata – scrive Bergson – […] ci mette in contatto con tutta una continuità di durate, che noi dobbiamo tentare di seguire sia verso il basso, sia verso l’alto. In un senso e nell’altro noi possiamo dilatarci indefinitamente, con uno sforzo sempre più violento; e in entrambi i casi noi trascendiamo noi medesimi. Nel primo senso, avanziamo verso una durata sempre più sparpagliata, le cui palpitazioni, più rapide delle nostre, dividendo la nostra sensazione semplice, ne diluiscono la qualità in quantità: al limite sarebbe il puro omogeneo, la pura ripetizione, con cui definiremo la materialità. Avanzando nell’altro senso, andiamo verso una durata che si tende, si restringe, si intensifica sempre più: al limite sarebbe l’eternità. Non più l’eternità concettuale, che è una eternità di morte, ma un’eternità di vita». (Matière et mémoire, ns. tr., Paris 1896, p. 210).
[1976]
Repressione
Che lo sviluppo del capitale, nei suoi processi tecnologici di ristrutturazione, comporti l’uso di strumenti repressivi di nuovo tipo, è quanto vado sostenendo da quasi dieci anni [1993] e le pagine che seguono lo riconfermeranno. Ma qui mi sembra utile cogliere l’aspetto non sempre visibile di questo processo di sofisticata modernizzazione, quello che fa da pendant, l’uso cioè di strumenti vecchi, a volte vecchissimi, che un’ottimistica ideologia del progresso considerava finora relegati nelle cantine della storia.
Ma non è a una illustrazione di questi strumenti che dedico queste pagine, né a quelli nuovi né a quelli vecchi. Altre occasioni ho utilizzato per questo lavoro, altre ne utilizzerò in futuro. Qui mi interessano invece le domande che concernono la necessità dell’uso di strumenti tanto contrastanti fra loro. Per esempio, quale motivo può esserci per utilizzare nello stesso tempo, sia pure in luoghi geografici differenziati, strumenti repressivi come la dequalificazione professionale (ottenuta con la maggiore richiesta di flessibilità sul posto di lavoro e la riduzione degli strumenti culturali messi a disposizione dalla scuola) e la pulizia etnica (ottenuta spesso con gli stupri di massa, i campi di concentramento, i genocidi, le feroci esecuzioni tribali), qual è il motivo di questa apparente contraddizione?
La risposta classica, che per altro è stata data, e che anch’io ho dato, è quella che il capitale e lo Stato non conoscono frontiere nell’uso degli strumenti repressivi, e che utilizzano lo strumento più adeguato alla situazione: in condizioni di capitalismo avanzato usano la dequalificazione (oltre ad altri strumenti, comunque considerati sempre democratici), in condizioni di capitalismo arretrato usano il genocidio (non dimenticando per altro anche gli strumenti più sofisticati come la propaganda televisiva sui valori della tradizione nazionalista o l’impiego organizzato di squadre di manovali della scure bipenne). Ma non appare risposta soddisfacente, almeno non in sede di analisi specifica.
In effetti qui siamo davanti a una delle contraddizioni più profonde del capitalismo postindustriale che ci sembra importante analizzare, allo scopo di trarne utili insegnamenti sulle possibili pratiche di attacco e di distruzione degli assetti produttivi e repressivi di quest’ultimo.
Cerchiamo di articolare meglio questa contraddizione.
Tra capitalismo e democrazia non c’è una corrispondenza esatta. Questa considerazione è stata fatta da numerosi economisti che l’hanno, specie negli ultimi tempi, utilizzata per scopi diversi ma tutti attinenti alla difesa del neo-liberalismo dall’accusa di inefficienza atavica. A noi qui serve per aprire il discorso sul reale funzionamento del capitale e sul fittizio fondamento di tutte le chiacchiere ideologiche intorno alla democrazia.
La violenza del capitale, sia che si eserciti attraverso strumenti repressivi nuovi o vecchi, non consente un uso coerente dello strumento democratico. A un certo punto, la volontà politica deve essere modificata nella decisione dei rappresentanti, e questa decisione è fatto differente da qualsiasi opinione di base, sia pure quella raccattata attraverso l’opera disinformativa dei grandi mezzi d’informazione. Nessuna opinione media governa il mondo, ma solo la decisione estremista e dura di pochi rappresentanti degli interessi del dominio. Resta da vedere, e noi siamo convinti di no, se un’utopistica opinione della gente riuscirebbe a fare andare meglio le cose. Dei discorsi da filobus affollato sono piene le fosse delle fucilazioni in massa. Lo sciovinismo delle masse non ha pari che nella ferocia, questa organizzata e rispettosa di alcune regole sia pur minime, dei massacratori statali in divisa. La democrazia è un fantasma che viene impiegato come copertura, non esiste nessun governo esclusivamente democratico, quindi non esiste la democrazia, ma esistono processi di aggiustamento democratico del potere, ed è a questi che mi riferisco. Essi stessi, questi processi, sono in contraddizione col capitalismo, anche quello postindustriale. Ed è qui che si pone il problema.
Come mai un sistema di gestione economica, e politica del mondo è costretto a utilizzare uno strumento che in fondo non gli è congeniale, sia pure attraverso il filtro della coerenza ideologicamente costruita dello strumento stesso? La risposta, anacronisticamente, sta nell’estremizzazione realizzata dalle economie di piano, apparenti antitesi del capitalismo moderno. I regimi del socialismo reale, capitalisti anch’essi, utilizzavano l’organizzazione globale del mercato come strumento repressivo, e in questo processo mettevano a nudo l’essenza del capitalismo, che è violenza e barbarie, e la mettevano a nudo con la chiarezza di tutte le cose portate alla loro estrema espressione. Il capitalismo postindustriale impiega la democrazia neo-liberale come strumento di recupero e di consenso, col quale nasconde la sua sottostante e ineliminabile brutalità, ma di questo impiego non può dirsi mai definitivamente contento, in quanto poniamo, per tornare all’esempio di cui sopra, forse non può ridurre di molto la dequalificazione se non vuole trovarsi senza neanche gli operai semi-automatici che gli servono. Ma forse si tratta di un’ipotesi rosea e invece questa riduzione potrà effettuarsi radicalmente, appiattendo l’uomo al livello della macchina? Chi lo sa?
In una condizione di esclusione completata, quando il muro tra inclusi e esclusi sarà innalzato, fra gli esclusi si potrebbe veramente realizzare un regime definitivo di reale democrazia, e ciò per il motivo invero semplice che questi dovrebbero soltanto gestire liberamente la loro miseria. L’idea non deve apparire improbabile, almeno non più di quanto appaia allucinante.
Sotto ben altro aspetto, osservando le considerazioni che si traggono dal fallimento di qualsiasi economia di piano, ci si chiede se l’attività produttiva dell’uomo, certamente ineliminabile, fin quando non si perderanno i vizi radicali di mangiare, bere, vestirsi, dormire al coperto e riprodursi, possa essere organizzata in modo libero, il che equivale a chiedersi se la società potrà essere un giorno libera, domanda non diversa da quella riguardante la possibile concreta realizzazione dell’anarchia.
Come anarchico, al di là della fede che è cieca e come l’amore si impadronisce di noi all’improvviso al di là dei vincoli della ragione, non possiedo un’idea chiara su questo punto. La cosa non mi disturba più di tanto, oggi, visto che le condizioni di una realizzazione futura del genere non sono proprio, diciamo, dietro la porta, ma potrebbero costituire uno degli assilli maggiori di domani. E rileggendo il mio vecchio libro sull’Autogestione non vi trovo, oggi, a distanza di quasi vent’anni, motivi di maggiore conforto. Se non altro sotto gli aspetti tecnici. Molti oggi tagliano a fette l’amministrazione dell’esistente, e fanno bene, visto che orrendi ordigni di morte ci stanno circondando da tutte le parti. Ma non so quanti di questi intagliatori di luoghi comuni saprebbero rispondere alla mia domanda.
Siamo anche noi tragicamente ingannati dal mito della democrazia? E di certo, per quello che adesso possiamo chiaramente comprendere, lo siamo stati dal mito del progresso, poniamo, almeno quella parte di noi contro la quale strillai a lungo a suo tempo, come voce nel deserto, e che adesso finisce per strillare più forte di quanto non mi riesca contro l’amministrazione dell’esistente. Dal fondo dell’abisso arrivano voci ammalianti, tutto vi ribolle dentro, la metafisica economica dei programmatori e quella rivoluzionaria dei nientisti che albeggiano soddisfatti sulle rovine del mondo; non possiamo stare ad ascoltare a lungo queste voci, i richiami dal profondo sono sempre pericolosi.
Resta di certo l’essenzialità del problema, la domanda senza risposta: perché l’uso tanto contraddittorio di strumenti repressivi vecchi e nuovi? La complessità del progetto capitalista deve per forza ricorrere a questi due tipi di strumenti repressivi. Se non altro perché la scomparsa della centralità operaia pone il problema dell’incanalamento dell’antagonismo che resta ancora leggibile in termini di classe, e quale migliore occasione di indirizzarlo verso il falso antagonismo dei nazionalismi? Infatti, la liberalizzazione della concorrenza a livello mondiale rende necessaria la gestione globale dei produttori, ormai non più accorpati nell’antica composizione di classe antagonista e quindi finalmente disponibili per entrare a far parte in forma definitiva di quell’altra anima del capitale, l’anima oggettiva, quella che produce ma non prende decisioni, se non fittizie, precostituite nei centri del pensiero dominante.
Allo stesso modo in cui il socialismo reale faceva vedere la vera e propria composizione del capitalismo, estremizzandola nell’economia di piano, così il capitalismo postindustriale fa vedere la vera e propria composizione dei produttori estremizzandola nella partecipazione produttiva del mondo degli esclusi. Per la prima volta, nel mondo del muro definitivo, gli esclusi potrebbero realizzare il loro sogno di pensarsi, ma soltanto pensarsi, non inevitabilmente destinati al fare coatto, alla produzione di valori concreti, di oggetti definiti. Si attuerebbe così il sogno dei produttori di tutti i tempi di distanziarsi definitivamente dal capitale, ma solo a condizione di non capire più il senso di quest’ultimo, né quello delle sue operazioni. Questo sarebbe alfine il regno della democrazia, la scomparsa, forse e comunque in prospettiva, di qualsiasi uso di strumenti repressivi “vecchi”, il sogno di tutti i capitalisti di ridurre stabilmente il lavoro a merce codificata una volta per tutte.
Mi sembra chiaro a questo punto come l’imposizione della decisione, da parte dei centri di potere, sia fatto non del tutto riconducibile a un piano razionale, per quanto le condizioni presenti del capitalismo postindustriale possano presentarsi come le migliori per una progettualità del genere, naturalmente a breve termine. Se l’atto della volontà dominante è sempre riduzione delle differenze dei dominati a un comune denominatore (ieri la classe operaia, garantita artificialmente come soggetto politico da partiti e sindacati, oggi gli emergenti nazionalismi), è anche vero che questa riduzione non si può mai operare senza proporre ulteriori differenze, sia pure nell’intenzione di avvicinarsi all’esclusione totale.
Da parte degli esclusi, la ricerca di un movimento diretto a contrastare i progetti di riduzione delle differenze, non può però essere fatta nella semplice difesa corporativa, o nazionalista, di queste ultime, ma deve farsi nell’oltrepassamento dei limiti della differenza stessa, la qual cosa è possibile solo nell’individuazione di affinità comuni, sia pure tenui ma potentemente sovvertitrici di qualsiasi processo di esclusione.
Se non altro nell’immediato, questa ricerca delle affinità ci sembra importante per costituire punti di risposta adeguata alle misure repressive del capitalismo postindustriale che appaiono molte volte provenire direttamente dalla notte dei tempi. Allo stato attuale delle cose, non è possibile prevedere se la ricerca dell’affinità possa costituire elemento di ricomposizione di classe o, ancora più difficilmente, di quel tessuto sociale su cui si andranno a innestare i processi rivoluzionari. Tutto in questo campo appare poco chiaro e non esistono strumenti validi in circolazione, adatti a capire meglio il movimento della realtà.
In fondo, sconosciamo quasi del tutto i processi che gettano le loro radici nel tessuto più profondo di ogni singolo individuo. Feroci riduzioni sociologiche sono state impiegate fino all’altro ieri per farci vedere la compattezza del mondo attraverso la lente deformante di un’ideologia del dominio riverniciata come ideologia della liberazione. Tutte le nostre inattuali considerazioni, spesso, sono passate inosservate, non lette e qualche volta anche non capite. Per altro, dobbiamo qui dire, che non tutte le conseguenze di quelle affermazioni ci erano a suo tempo chiare, almeno non nel modo in cui lo sono adesso.
Di tante considerazioni, quello che mi appare evidente, ed è poco, debbo ammetterlo, è soltanto la discontinuità del meccanismo repressivo, la sua divergenza da qualsiasi piano, e in questa affermazione pongo in primo luogo la progettualità economica. Ma è anche evidente la nostra incapacità di capire il passato, quello che ci sta alle spalle, il senso dei nostri errori. Il vecchio che continua a pesare sul nuovo e ci oscura la comprensione, mentre il nuovo precipita nel vecchio e lo modifica presentandolo come ultima novità repressiva, mentre non è altro che un rimasuglio della cantina degli orrori.
Tutto appare come replica di eventi già conosciuti, sofferti, niente ha inizio ora, non c’è nessun evento sorridente nella natalità dei morti. La rottura di questo processo, in cui tutto è vecchio e nuovo nello stesso tempo, significa la ricerca di un luogo dove riguadagnare una propria differenza nella costruzione di progetti di affinità comuni, quindi capaci di individuare le costanti del passato, quelle linee che non sono ancora scomparse, inghiottite dall’appiattimento paradigmatico del nuovo capitalismo.
Solo che questa contraddizione, tra ricerca della differenza (speculare all’appiattimento operato dal potere) e costruzione dell’affinità (anch’essa speculare alla disgregazione operata sul corpo della vecchia classe lavoratrice), non può superarsi con un semplice atto di volontà. Si tratta di una contraddizione troppo inserita all’interno della realtà, troppo speculare ai processi ordinativi e repressivi del capitale, per potersi gestire con un semplice segno cambiato.
La rivoluzione, come oltrepassamento qualitativo di questa contraddizione, potrebbe, da sola, proporre altre differenze e altre affinità, e quindi metterci di fronte a un diverso utilizzo del passato, a un diverso confronto col futuro che così non precipiterebbe più nel passato uccidendolo e modificandolo in tradizione.
E questo è certamente un altro discorso.
[Pubblicato su “Anarchismo” n. 71, gennaio 1993, pp. 1-4 col titolo “Strumenti repressivi vecchi e nuovi”]
Ribelle
Io penso che bisogna fare di tutto per mettere in risalto quella piccola luce individuale che si crea dentro ognuno di noi. Ciò è importantissimo. È questo punto di partenza che spesso ci fa considerare diversi, portatori quasi di una “malattia”. Non dobbiamo avere paura di questo. Non dobbiamo avere paura delle critiche di chi ci guarda da lontano e nell’ambito delle sue attività organizzative ci dice: “Ah, un momento, questa è una vostra fisima, è una vostra torre d’avorio, voi vi sentite superiori, ecc.”. Non è vero che ci sentiamo superiori, ci sentiamo, probabilmente, in maggiori ambasce, con minori certezze. Perché queste ambasce? Certe volte usciamo la mattina e non sappiamo che cosa fare, certe volte la nostra stessa identità entra in discussione.
Guardate che il concetto di identità è estremamente negativo, però viene spacciato come qualcosa di positivo: identità significa duplicazione, significa una cosa mortale per l’individuo, che dovrebbe essere sempre diverso; però l’individuo, se è troppo diverso, di volta in volta, comincia ad avere paura. Allora stiamo così ipotizzando la figura abbastanza diffusa di un compagno. Potrebbe, questo compagno, con questi problemi, fare il professore? Potrebbe questo compagno prendersi una laurea, in buona e tranquilla attività didattica? Potrebbe fare un lavoro? Certamente, se lo fa, e di fatto lo fa, con gravissimi costi personali, che non sono argomenti da mettere da parte; è la nostra vita, di cui si discute! Che cazzo mi interessa delle lotte di massa e di organizzare la gente, se quando io vivo con me stesso la sera non riesco nemmeno a chiudere gli occhi perché ho bisogno della pillola per dormire, perché mi sento un coglione? Questa è la realtà, di questo dobbiamo parlare, perché la nostra vita è una sola ed è questo il problema centrale, non soltanto l’organizzazione di massa di un domani, di cui mi interesso poco, perché non risolverà il mio problema, non mi appagherà, non mi farà contento, non mi farà felice.
Quando parliamo di questi problemi, altro che torre d’avorio, qui si tratta di problemi gravissimi, di ordine personale, problemi di indebolimento. Noi ci sentiamo più deboli, non più forti. Voglio fare un esempio solo: io ho visto nella sede della CNT a Parigi, la sede dei rifugiati in esilio, alle spalle del tavolo dove si facevano le conferenze, l’immagine della CNT. Sapete che cos’era, era un forzuto operaio muscoloso che apriva le fauci del leone. Ora, ditemi, ragazzi miei, che cosa significa un uomo muscoloso, bello, al sole nascente dell’avvenire, che spalanca le fauci del leone, perché è più forte di lui? Significa tante cose. Significa essere sicuri, avere sicurezza di sé, significa, e perché no?, anche maschilismo; significa tante cose. Perché non è una donna a spalancare le fauci al leone? No, è un uomo, un uomo muscoloso. Io non mi sono mai sentito muscoloso, almeno non in questo senso, mi sono sempre sentito pieno di problemi, di incertezze.
Ma poi entra in gioco l’indole dell’individuo, il carattere. Si tratta di distinzioni assolutamente di ordine personale, di nessuna validità teorica, però importanti perché valgono a livello personale, però possono valere anche per molte persone, per questo le dico. Io faccio una distinzione tra il ribelle e il rivoluzionario. Magari non una differenza precisa, magari non una differenza netta, in quanto mi piacciono tutt’e due, e la mia affinità viaggia verso tutt’e due, ma la faccio. Pur essendo un rivoluzionario, non sono un ribelle. Penso che il ribelle sia colui che a un certo punto dice: “Mi avete rotto le palle, combatto ed è finita, non voglio avere nessuna compromissione con qualsivoglia progetto, discorso intermedio, lotta, ecc.”. Il rivoluzionario, invece, è uno che, come me, si dà i suoi mezzi. Io esco dalle università, però non sono andato avanti, perché mi sono reso conto che non potevo continuare a fare il mestiere che facevo prima. Il rivoluzionario è uno che ha certi progetti, ma non rigetta i mezzi, perché pensa di poterli utilizzare. Però non casca nell’illusione di ficcarsi dentro l’istituzione, pensando di trovarvi una strada propria, però nemmeno è un ribelle che dice basta, mi avete rotto le palle, ecc. Secondo me c’è questa distinzione da tenere presente.
[Parte del dibattito seguito alla Conferenza dal titolo “Anarchismo e democrazia” da me tenuta a Bologna il 16 marzo 1995 presso la Facoltà di lettere e filosofia. Trascrizione della registrazione su nastro]
Riduzione
Si sa bene che la diversità, per portarsi dietro una traccia della coscienza deve entrare in conflitto con il senso. Non può rifiutarlo tutto, in quanto essa stessa è senso, non può accettarlo tutto, in quanto non sarebbe più l’altro della coscienza. I contenuti che vengono deformati nel territorio ricognitivo che ho individuato ai margini periferici della immediatezza, si possono rivelare mezzi d’apertura, oppure possono essi stessi assoldare una critica teorica e affiancare un discorso di recupero verso l’accumulo, un discorso di ritorno a casa. Certo, anche nell’interpretazione c’è il rischio di sterilizzare eccessivamente l’effetto duplicativo delle qualità, per cui il movimento funziona lo stesso, ma la diversità nel proprio interpretare invece di andare avanti verso lo sviluppo simbolico della cosa, si sofferma eccessivamente sui contenuti elaborati, cercando di assolutizzarli. A me sembra il caso dei più recenti tentativi di Beckett. Prima di avanzare nel territorio della cosa, proprio nella fase interpretativa, egli cerca di prevedere quello che vi troverà. Ecco perché si spoglia e spoglia la struttura di tutto quello che può sembrare superfluo. Essenzializzare significa ridurre all’osso, ma l’osso si può anche polverizzare, e la polvere spargerla intorno all’albero, all’unico albero del proprio giardino, in attesa della prossima riduzione in briciole. È un meccanismo anche questo, un meccanismo relativo al senso. La tensione, se c’è, somiglia molto a quella di un acrobata sul filo, mette a repentaglio la sua vita, ma non la coinvolge sul serio, sapientemente la mantiene sempre sull’orlo del baratro, in bilico sul filo. A questo punto, non sai più se è pura abilità o coinvolgimento vero e proprio, e il problema diventa tanto centrale da spegnere l’altro problema, quello della qualità. Ecco quindi che la diversità o diventa essa stessa, almeno arrestandosi nella fase iniziale, possesso e dominanza di strumenti, oppure è pura balordaggine. Scarnificandosi si essenzializza fino all’inverosimile, così il salto, unica strada possibile, risulta più facile, anzi direi quasi obbligatorio. Non c’è dubbio che Beckett si sia posto questo problema, se non altro per quel che riguarda l’atto della immaginazione diversa, e per quel che mi accorgo leggendo Quello che è strano è che se lo è posto in termini molto vicini al mio modo di pensare, ma il suo scopo è puramente nichilista, scarnificatore, spopolatore. Il sistema impiegato è interessante e merita qualche cenno. Non consiste in una riduzione al silenzio, dopo tutto un letterato deve scrivere, ma in una riduzione all’ambito della cosa. Ora, considerando la particolare natura del territorio della cosa, non c’è differenza alcuna tra un territorio ristrettissimo e uno estremamente esteso, ridondante. Non ci sono unità di misura o di tempo nel territorio della desolazione. L’elencazione di minuti particolari si circoscrive a un oggetto, un contenitore, nientificato esso stesso proprio a causa dei diversi particolari che lo descrivono. Il senso, perseguito quasi fino in fondo, si esaurisce per mancanza. Lo stesso per la qualità di cui si presentano residui che presto scompaiono nel fondo di una coscienza immediata essa stessa banalizzata. È stato affermato che in questi scritti non accade niente, io penso sia più esatto dire che non c’è niente, essendo l’accadere e perfino il fare, elementi che presuppongono l’esistenza della coscienza, se non proprio inquieta, almeno attenta. In ogni caso, si scriverà ancora per poco.
[1989]
Rivoluzione Francese
Condizioni esterne [1989, mi trovo nel carcere di Bergamo] impongono di lavorare in una situazione non proprio ideale per una ricerca teorico-storica, utilizzando cioè quegli strumenti che la difficoltà del problema e la sua importanza meriterebbero.
Mi vedo quindi obbligato a lavorare di memoria e spero che i compagni terranno conto delle lacune inevitabili che troveranno nel presente lavoro.
Per un altro verso, ed è questo un aspetto positivo, ho avuto modo di riflettere a lungo in questi ultimi mesi su tante cose e anche sul concetto (pratico e operativo) di “rivoluzione”.
Ed è di queste riflessioni, rapportate con la grande esperienza francese di due secoli fa, che vorrei mettere a parte i compagni partecipanti al Convegno [su: “1789-1989. Due secoli di rivoluzione”, Napoli 1989].
Né quella, famosa oltre ogni dire, che Kropotkin definiva “Grande”, né le altre, tante o poche che queste seconde siano, si possono considerare rivoluzioni “modello”, punti di riferimento a cui commisurare le iniziative e le pratiche dell’oggi e del domani.
E questo, dell’insegnamento che viene dal passato e che una scienza opportuna, la Storia per l’appunto, rende possibile utilizzare nella pratica dell’oggi, è un problema di notevole significato in quanto coinvolge non solo una concezione utilitarista della riflessione sulla storia, ma anche una scelta pratica sulle decisioni da prendere.
Siamo costretti, se non vogliamo andare avanti come i non vedenti, a decidere cosa fare del comune bagaglio filosofico dello storicismo, che ci sta ancora fra i piedi e che minaccia di non farci fare nemmeno un piccolo passo avanti.
Figlio del lumi e quindi padre, o, almeno, co-genitore della Rivoluzione, quella grande, appunto, lo storicismo nasce in un clima di riassetto del pensiero ordinativo, un clima che doveva pur venire fuori dalle ambasce in cui era finito per cadere il razionalismo cartesiano, proprio nel momento in cui apriva la nuova Europa al pensiero scientifico della misura e non più della vecchia essenza.
Ma Cartesio non aveva saputo fondare seriamente su qualcosa di concreto il suo dubbio sistematico, andando a finire, come tanti altri, fra le braccia del “buon Dio”.
Il Settecento, con tutto il suo protervo anticlericalismo, non era riuscito del tutto a liberarsi da questa ipoteca, se non scendendo al livello di un materialismo semplice, come quello di Lamettrie.
Queste idee, e i loro divulgatori, sommuovevano il mondo, mettevano in discussione circoli teorici e commuovevano signori benestanti in vena di buone azioni.
Con il senno del poi, cioè con la conoscenza dello sviluppo filosofico della storia, è stato detto che era l’idea che si faceva strada e trovava, proprio nel volgere del secolo decimo ottavo, la sua naturale conclusione rivoluzionaria.
Oggi, un’affermazione del genere fa più o meno ridere. Ma non fanno ridere, almeno non lo dovrebbero, le conseguenze che stanno dietro questa affermazione, conseguenze che sono foriere di danni e pregiudizi di portata immensa.
Lo storicismo, perché quella sarebbe un’affermazione di tal natura, si afferma e si sviluppa dopo la Grande Rivoluzione, in un clima di rinnovamento non solo degli imperi europei, ma anche delle loro produzioni industriali. E il pensiero nasce, più acuto perché più doloroso, proprio in quella parte della vasta Europa che è meno consolidata politicamente, in quella Germania piena di piccoli Stati, di grandiosi progetti e di reboanti parole.
L’idea si trasforma in un essere capace di agire, viene vista muoversi, modificare le cose, entrare e uscire da sé e dagli altri, avventurarsi nel mondo, e infine realizzarsi in qualcosa, in uno spirito oggettivo. Tutto ciò in forma lineare, come un destino luminoso e senza ostacoli – se non risibili e momentanei – e con una etichetta riassunta nel nome di progresso. E mi accorgo che molti, anche fra i compagni anarchici, restano legati a questa concezione lineare che ha conseguenze precise sia nella lotta sociale che nelle scelte dei mezzi da impiegare nella lotta stessa.
Ce ne sono stati tanti, dubbi e perplessità. Questo è vero. Ci si è chiesti, più volte: ma possiamo convivere insieme ai marxisti, per non dire altro, nell’ottica di un medesimo storicismo? Certo che no. Spostiamoci allora un pochino. E dove ci spostiamo? Su questo punto non abbiamo mai avuto le idee molto chiare.
Il discorso è semplice. C’è o non c’è, nella Storia, cioè nelle vicende degli uomini, una logica diversa dalle decisioni dei singoli individui? Le cose accadono perché uomini le vogliono, oppure, accanto a queste volontà, sommate insieme, ci sono altre forze che sviluppano conseguenze le quali hanno effetti sulle decisioni delle singole volontà?
L’anarchismo nella sua storia, ha ondeggiato un po’ in un senso, un po’ nell’altro. Da Bakunin e Kropotkin, fino a Malatesta, fino agli individualisti più esacerbati, ma il problema non si è chiarito, anche perché tutti i teorici anarchici sono sempre stati piuttosto restii a impantanarsi in discussioni filosofiche, almeno i teorici che avevano interessi anche pratici, mentre quegli altri, quelli che spesso lo hanno fatto, con mezzi non idonei, a dire il vero, avevano per nulla interessi all’azione.
Ne è derivato che i dubbi sono rimasti. E sono là, davanti a tutti i compagni, specialmente quando ci si interroga su problemi come quelli attinenti alla rivoluzione francese di due secoli fa.
L’invenzione del secolo decimo ottavo è stata grandiosa. L’idea di progresso è, difatti, molto utile. Essa consente di far muovere la gente con una speranza che altrimenti svanirebbe con facilità. Il “sol dell’avvenire” lascia intendere che si stia andando verso levante dove, con certezza, prima o poi, questo sole nascerà. Nessuno mette in conto la possibilità, pratica, del non sorgere del sole.
Il determinismo è una grande molla all’azione, fonda partiti e crea martiri, alimenta rivoluzioni e elite di dominio. Queste si alternano fra loro, cancellano e ricostruiscono fatti e idee, ma porgono al volgo sempre la medesima illusione, quella che mai nulla è perduto, che domani le cose devono andare meglio di oggi.
Così si giustificano le tecnologie del capitale, in nome di un progresso che domani sarà utilizzabile diversamente. Così si giustificano i sacrifici di oggi imposti dallo sfruttamento in nome di un trasferimento, domani, delle ricchezze di oggi a una società liberata. Così si giustificano le più odiose nefandezze, in nome della vittoria suprema di quella parte dell’umanità che impersonificherà la filosofia, secondo lo schema della Fenomenologia dello Spirito (mi dispiace, ma l’individuo “cosmico” qua non c’entra, Hegel la pensava diversamente sul “grande uomo”, burattino nelle mani della Storia).
E, infine, da un’idea del genere nascono le attese, le guerre guerreggiate e quelle di temporeggiamento, le crisi e le teorie economiche della crisi, le teorie dell’imperialismo e quelle del terzo-mondismo, ecc.
Si vede, quindi, che l’utilità dello storicismo è notevole. Ma essa è ancora più grande se si pensa al suo utilizzo da parte del capitale. Qui trova giustificazione morale l’accumulazione, la guerra, lo sfruttamento, per arrivare, colmo della raffinatezza, agli strumenti che la medesima filosofia ha fornito ai tentativi della destra vecchia e nuova di giustificare il genocidio e la superiorità di una razza sulle altre.
Non è questo il luogo per tratteggiare, sia pure per grandi linee, una ipotesi di riflessione non storicista. Fare i conti con la Storia è problema ben più ampio di quello che le mie forze mi consentono di affrontare. Vorrei quindi limitarmi ad alcune considerazioni brevissime.
È fuor di dubbio che nella realtà esistono fatti che si ripetono, fenomeni aggregativi che rimangono costanti, fatti e fenomeni ben conosciuti ma stranamente spiegati, in modo fantastico e illusorio. A esempio, se diversi individui si mettono insieme per fare un lavoro la somma in termini di lavoro ottenuto, di quello che viene fuori, è molto maggiore della somma del lavoro dei singoli individui, se questi avessero lavorato separatamente.
Questa legge, che è poi quella dell’organizzazione, è stata studiata a fondo da Proudhon, ma i suoi risultati sono poco conosciuti, ed è quella che illuminò il fondatore della teoria del capitalismo, Adam Smith il quale la illustrò partendo dall’esempio della fabbrica di spilli.
Che la coscienza di questa utilità aggiuntiva sia un fatto che la nostra civiltà ha ormai acquisito, e quindi trasformato in elemento intuitivo, è cosa talmente certa da far considerare una spinta verso l’aggregazione, in vista di fare un cosa, come un elemento spontaneo che tende a ripresentarsi davanti a situazioni abbastanza simili.
Ecco. Venendosi a modificare alcune condizioni sociali, per diverse cause, di natura economica, militare, geologica, ecc., si mette sempre in moto un meccanismo di autorganizzazione. Le rivoluzioni cominciano così, e si ripresentano puntualmente sempre così, con una spinta all’autorganizzazione.
La gente, dal basso, di fronte all’emergere di problemi che non trovano più una soluzione secondo le codificazioni precedenti, a un dato momento, si organizza in modo autonomo.
Secondo me, per una forza del genere non c’è bisogno di scomodare lo spirito oggettivo, per cui non si deve poi restare contrariati quando questa forza viene sprecata o recuperata per mano dei professionisti della politica. Si deve, caso mai, cercare di fare qualcosa per evitare questo recupero o, almeno, per limitarne i danni.
I fatti sono molteplici e le situazioni che si creano sono sempre nuove, ma hanno qualcosa di ripetitivo, di circolare. Alcuni elementi si ripresentano. Queste sono le forze della realtà, che si combinano in vario modo ma sono sempre presenti. Una forza contraria all’autorganizzazione potrebbe essere individuata nella paura della libertà, che spinge la gente a cercare una guida, un capo, una sigla, un’organizzazione preventiva, sotto cui mettersi per ricevere protezione, per sentirsi protetta. Questa paura è anch’essa una forza, se si vuole contraria alla prima, ed è sempre là, capace di ripresentarsi in continuazione.
E poi tutti gli altri sentimenti, più o meno negativi, più o meno positivi, che si associano e si pongono in relazione fra loro, o si contrastano: l’avarizia e la generosità, l’amore per il nuovo e il desiderio della tradizione, la viltà e il coraggio, l’odio e la tolleranza, e così via. Tutto ciò determina altre forze sociali, che si ripresentano in aggregazioni abbastanza costanti, sebbene sotto forme diverse.
Ma allora, sarà sempre così? Ci saranno sempre i padroni e ci saranno sempre gli anarchici a lottare contro i padroni? E così all’infinito?
No. Di una cosa siamo certi, che non esiste una garanzia esterna che possa fondare una certezza riguardante il fatto che tutta questa situazione di miseria e di sfruttamento un giorno finirà. Ma il fatto di non avere questa certezza esterna, non toglie che possiamo avere noi una certezza interna. E, in questa certezza, interna, una certezza della nostra coscienza, possiamo trovare la forza di agire senza bisogno di trovare la protesi del determinismo.
No. Forse le cose continueranno per sempre così. Cambieranno di poco. Ci saranno spostamenti piccoli, ma nella sostanza ci saranno sempre i dominati e i dominatori. E forse no. Forse sarà possibile la costruzione di una società libera, cioè di una società avente una qualità maggiore, più alta, di libertà. E forse no.
Ci potrà essere, quindi, un non ripresentarsi di alcuni eventi. Una rottura nel processo, o l’innesto di un processo diverso. Duecento anni, quanti ne intercorrono tra oggi e la rivoluzione francese, sono troppo pochi per discorrere di un vero e proprio non ripresentarsi di determinate forze sociali.
Dunque, mi sembra chiaro che i giacobini portarono una impronta autoritaria e accentratrice (per dir poco) nella grande rivoluzione. Per cui si cerca un paragone con i bolscevichi, e così via. Per quanto riguarda le altre situazioni rivoluzionarie, si pensa alla Spagna, al Messico, alle situazioni di lotta di liberazione nazionale, e a molti altri fatti che spesso chiamiamo impropriamente rivoluzioni.
Gente che oggi ha tutt’altri interessi che rivoluzionari, gente che mangia pacificamente al tavolo comune dello Stato, professori di ogni rango, dottori e giornalisti, piccoli e grossi professionisti, partecipi e oggetto, giudici e imputati della medesima situazione, tutti insieme, improvvisamente, si mettono a riflettere sull’idea di rivoluzione. Mi sembrano tanti avvoltoi con il loro cranio calvo chino sui cadaveri.
Per capire il filo macabro che lega quegli avvenimenti tutti insieme, e che li ha fatti identici e diversi nello stesso tempo, occorre avere l’animo sgombro e l’occhio agile. In caso contrario, dall’interno della propria classe di pasciuti controllori delle idee di regime, si mandano segnali di ripetizione fino alla noia. In attesa dell’evento di domani, quello definitivo, di inverazione, si tira a campare aspettando lo stipendio di fine mese. E voi, voi vorreste chiedere a questa gente cosa ne pensa delle concordanze o delle differenze tra giacobini e bolscevichi? Ma andiamo, siamo seri.
Vi voglio parlare delle brave persone. Ce ne sono dappertutto. Quegli avvoltoi di cui parlavo prima sono tutti brave persone. Non metterebbero – tranne rari casi – la mano nella tasca altrui e non scoperebbero la sorella. Gente del genere, piena di tutte le virtù, ce n’è da sempre. Ce n’erano anche durante la grande rivoluzione. Robespierre era uno di loro.
Si tratta di gente che cerca dapprima di porre un freno agli eccessi del popolaccio. In fondo ne ha paura, come ha paura di tutti gli eccessi che non siano ordinati dall’alto e posti sotto controllo.
Robespierre si adombrò parecchio per l’uccisione in modo orrendo della damigella di corte di Maria Antonietta, ma non batté ciglio per mandare alla ghigliottina centinaia di persone. Ma la ghigliottina è uno strumento pulito ed efficiente, e poi la gente vi finisce sotto (lui compreso) dopo un più o meno regolare processo.
Ecco delinearsi due forze contrastanti e ripresentarsi con costanza e lucidità in tutti gli eventi straordinari, intendendo come tali quelle situazioni in cui si rompono per motivi diversi le condizioni preesistenti di controllo, produzione, convivenza civile e formazione sociale.
Da un lato una forza informe, mostruosa, incontenibile, facile a crescere e a smorzarsi, che non si può frenare nemmeno con le fucilate. Una forza che ho chiamato una volta giustizia proletaria, ma che non è certo facile denominare e nemmeno capire. Men che meno, ovviamente, giustificare dall’alto delle virtù dell’onesto cittadino. È vano chiedersi se questa forma è utile o no alla rivoluzione, una domanda del genere ci fa ripiombare in pieno storicismo e il ragionamento che ne consegue diventa privo di senso. Siamo davanti a un evento distruttivo che ha un fondamento naturale e che non può essere, nel momento del suo sorgere, contrastato se non con l’impiego della più feroce e violenta delle repressioni.
Dall’altro lato, sta una forza anch’essa informe ma ben costruita nelle idee, fissa, strategicamente accorta. Una forza che crede nella virtù della conservazione, dei valori, dell’ordine. Una forza che forse potrebbe anche arrivare a mettere in discussione progetti di riforma, ma dopo avere restaurato l’ordine e dopo avere imposto la propria idea, la propria visione del mondo. Il bello è che questa seconda forza non ammetterebbe mai di essere contro l’oggettivo desiderio di rivincita che muove la prima forza, essa è contro il metodo impiegato, la mancanza di obiettivi chiari. Essa è contro la distruzione irragionevole. Vuole cambiare, trasformare, ma con calma e soprattutto senza eccessi.
I rivoluzionari hanno ragioni che la gente non capisce e le ragioni della gente non sono mai quelle dei rivoluzionari.
Se Turgot avesse dato ascolto alle istanze della provincia raccolte dal Parlamento, quasi certamente la rivoluzione francese avrebbe preso un’altra strada. Ma è vano discutere delle cause in tema di possibilità e variabilità. Esistono condizioni di rottura che non sono determinate in modo univoco. In questo non c’è una dominanza dei moventi economici. La tesi affermativa, quella dell’ortodossia marxista per intenderci, ammette uno storicismo troppo rigido, per quanto dialettico (ogni scusa è buona), per diventare accettabile. La rottura di domani, quella per cui gli anarchici lottano oggi, potrebbe avvenire per motivi tutt’altro che di natura economica.
Ma, se è vario il panorama delle cause di un evento molteplice come la rivoluzione, non è vario, anzi è piuttosto monotono il modello di ragionamento in base al quale cerchiamo di capire il funzionamento di quelle cause. Su questo punto, francamente, siamo tutti un po’ arretrati.
Fra i nostri sogni più ricorrenti c’è quello della crisi. Anche questo è un sogno storicista.
Nella linea del progresso, che lo spirito oggettivo percorre, ci sono delle fasi, cioè dei periodi in cui le cose si comportano in un modo e dei periodi in cui vanno in un altro modo. Qualcuno si è esercitato a individuare questi periodi anche nel campo economico (come se poi questo fosse un fatto separato) e li ha chiamati trend. Ma questo diverso battesimo non ha spostato il problema.
Lo studio di queste cosiddette crisi ha finito per sostituire lo studio delle cause del disagio sociale, con cui si possono se non proprio identificare tutte le cause dei movimenti rivoluzionari, almeno la maggior parte di esse. Ma non è detto che ci siano regole oggettive che determinano le crisi. Ogni tentativo in questa direzione è fallito, da quelle di eccesso di produzione a quelle di eccesso di offerta di lavoro.
Adesso sappiamo, con maggiore chiarezza, specialmente dopo la svolta del capitalismo anni Ottanta, che non si può parlare di crisi oggettive, che non esistono leggi capaci di dare indicazioni preventive sui fenomeni di aumento o diminuzione delle difficoltà in cui incorre la formazione produttiva capitalista nel suo insieme.
Ci sono maggiori o minori elementi che concorrono a garantire una ripartizione ineguale del profitto, in un dato posto, in un dato periodo di tempo. Spesso questi sistemi incontrano un aumento di difficoltà, anche imprevedibile. Il capitalismo ha studiato alcuni modelli e sta procedendo, con molta spregiudicatezza, a studiare anche alcuni rimedi. Adesso, anche i capitalisti non parlano più di crisi. E ne parleranno sempre di meno.
Ciò non toglie che i rivoluzionari stentino ad abbandonare l’ipotesi della crisi. Per questi ultimi la Grande Rivoluzione è stata il prodotto della crisi del vecchio mondo feudale. Come la rivoluzione russa è stata la conseguenza degli sconvolgimenti della grande guerra. Ragionando così, ci si aspetta molto da questi periodi di crisi e li si guarda con un certo interesse. Così non si sta tanto dietro le cose, in un’azione continua e organizzata, quanto si aspetta o, come accadeva all’inizio del Novecento, si desidera la massima distruzione possibile (allora si arrivò anche a desiderare la guerra) perché solo da questa poteva venire fuori la rivoluzione.
In fondo, adesso sappiamo che nessuno lavora al posto nostro. Il capitalismo si fa gli affari suoi. E li fa anche bene. Tanto bene che sta convincendo i tentativi cosiddetti diversi a ritornare su di una formazione produttiva più correlata, senza tanti contrasti fra opposti domini (opposti, si fa per dire), perché tanto lo scopo è uguale e non c’è motivo di accapigliarsi per questioni ideologiche, che oggi hanno sempre meno importanza.
La rivoluzione dal basso comprende quelle forze spontanee di rinnovamento morale e pratico che si mettono in moto non appena si verificano alcune di quelle condizioni che abbiamo visto prima, sconvolgimenti o semplici aumenti di difficoltà nella gestione del potere. Queste forze, è naturale, svolgono un’azione più o meno ampia in funzione della loro estensione, capacità di intervento, chiarezza di idee, radicalità di decisioni, e così via.
Come conseguenza si ha che la gente si muove, si organizza, discute, si incontra, sviluppa idee. Ma anche, e qui sta un grosso problema, distrugge, uccide, massacra. Scatena selvaggi attacchi contro tutto quello che, spesso a ragione e anche a torto, ricorda la sostanza e i simboli dell’oppressione passata. Spaventarsi o, peggio ancora, scandalizzarsi, di questa componente della rivoluzione dal basso, non produce altro che repressione cieca e reazione puntuale. Occorrerebbe capire.
Come si vede di già questo movimento dal basso è pienamente operante nella Grande Rivoluzione, in fondo, i suoi eccessi cruenti e stomacanti non sono che piccola cosa. C’è nella spontaneità di questi fatti una forma ineluttabile di giustizia proletaria che non tiene conto di responsabilità personali o soggettive, ma colpisce quello che arriva alla portata della sua mano, purché abbia i contrassegni visibili dell’antico potere. Spesso sotto questa mano implacabile e cieca, cadono persone che sono innocenti, donne, bambini, uomini illuminati. Ma non c’è modo di fermare una valanga che cade. Ed è veramente parziale e codino stare a recriminare su questi morti innocenti senza paragonarli, anche, a quei milioni di morti innocenti massacrati dalla fame e dal lavoro, dalla frusta del padrone e dalla sua cupidigia.
Quando, in passato, ho parlato a questo proposito di giustizia proletaria, mi riferivo proprio al meccanismo ineluttabile che si mette in moto in questi casi, meccanismo che ha fatto piangere e continuerà a far piangere, tanti cuori teneri e monocoli.
Ma la rivoluzione dal basso non è solo massacro, anzi è massacro in minima parte. È creazione, iniziativa, invenzione, fraternità, coraggio, uguaglianza, speranza, libertà. In breve tempo, spesso in pochi giorni, si aprono orizzonti collettivi all’azione che mai sarebbe stato possibile pensare prima. Si sviluppano idee che non sarebbero mai uscite dal laboratorio dei dotti.
È tutto questo che fa paura a molta gente. Ai vecchi gestori del potere, per il rischio che corrono personalmente e per il crollo improvviso del loro mondo. Ai nuovi futuri gestori, perché capiscono subito che le loro possibilità politiche diminuiscono man mano che cresce la spinta liberatoria dal basso.
Sono proprio questi nuovi uomini politici che si pongono il problema del controllo. Dapprima come necessità di limitare gli eccessi. Poi, come organizzazione di quella stessa spinta che minaccia di trasformarsi in caos. Poi, infine, come progetto di organizzazione produttiva.
Non si può dire che questa gente sia in malafede. Almeno non lo si può dire fin dall’inizio. Fra di loro ci sono esempi di altissima virtù. I rivoluzionari sono gente molto virtuosa. Ma vogliono imporre questo loro progetto e non possono farlo senza controllare la società.
Questo è accaduto nella rivoluzione francese e qui lo si vede, operante, forse per la prima volta nella storia in modo macroscopico ed efficace. I club nascono come strutture di dibattito collettivo, in sede di assemblea generale. Da questo processo emergono i leader, le avanguardie, i comitati di salute pubblica, i dittatori.
E il massacro c’è anche qui. Solo che qui è regolato da regole e sottoposto a controllo. In questo modo diventa meno stomacante, ma più efficiente. Non si sgozzano le persone, poche decine, ma si taglia loro la testa a migliaia. Si organizza la faccenda nel modo più razionale possibile. Il meccanismo finisce poi per mangiare anche se stesso, ma solo quando è in grado di produrre livelli di controllo altamente razionalizzanti.
In questa triste storia ci sono delle sfumature che vanno dalla destra alla sinistra, per usare una terminologia che solo in quelle occasioni trova il suo primo significato concreto. Così, la tensione etica iniziale, con tutti i suoi limiti, si allarga alle necessità pragmatiche e tutto tende alla ricostruzione di nuove forme di potere.
La funzione degli anarchici, in linea teorica, dovrebbe essere quella di fare avanzare per quanto possibile la rivoluzione dal basso, senza avere paura degli eccessi e senza per questo abbandonarsi a essi in modo inconsulto. I processi di autorganizzazione, spesso, hanno bisogno di una spinta, di un esempio, di un dibattito con parole appropriate e giuste. Non si può inventare sempre tutto di sana pianta.
E ci sono sempre uomini di cuore, coraggiosi, privi di interessi personali e anche di non troppo eccelse virtù che sono praticamente anarchici, che agiscono in questo senso. E ce ne furono anche nel corso della Grande Rivoluzione. Non avevano una tradizione alle spalle. Non avevano teoria nella testa. Ma avevano l’anarchia nel cuore e desideravano cose semplici come l’uguaglianza (vera), la fraternità, la libertà, non le chiacchiere giurisprudenziali di tanti altri. Per questo li chiamarono “Arrabbiati”, ma per gente come Varlet, Leclerq, Roux, si trattava di un’etichetta come un’altra. Il loro contributo fu notevole ma venne ben presto sommerso dall’ondata ordinatrice dei partiti vincenti, che si facevano la lotta in nome del predominio personale e delle personali idee. Mentre il popolo arretrava, quasi sorpreso della sua stessa audacia, e cominciava a fare i conti con la fredda macchina calcolatrice della virtù al potere.
E poi, e poi fu subito sera.
Per concludere queste poche chiacchiere vorrei aggiungere che non è stata mia intenzione suggerire la sostituzione di una metodologia (di utilizzo) storica a un’altra. Non mi sta bene lo storicismo, ma nemmeno (preso di peso) l’antistoricismo di Nietzsche o di Klages.
Naturalmente, non mi stanno bene le domande oziose, come sono soliti farsene gli storici di professione, gli stipendiati che lo Stato incarica di “pensare” e i rivoluzionari da scartoffie. Oggi tutte le discussioni sulle fasi rivoluzionare, il ruolo della borghesia, la rivoluzione industriale, l’Illuminismo, la Vandea, l’emigrazione dei nobili e così via, per quel che riguarda il fatto “Rivoluzione Francese”, devono essere riviste, in una chiave che sia libera dalle ipoteche ideologiche.
E questo grosso lavoro continuerà ancora per molti decenni, ben al di là della misera contingenza di un bicentenario.
[Pubblicato su “Anarchismo” n. 64, dicembre 1989, pp. 24-31 col titolo “La rivoluzione francese e l’attuale pasto degli avvoltoi”]
Carlo Rubbia
Il Nobel per la fisica Rubbia ha dichiarato [1987] che si possono costruire centrali nucleari “pulite” sostituendo al metodo della “fissione” quello della “fusione”.
Subito l’illustre luminare è stato smentito da appartenenti alla medesima confraternita e, a momenti, bacchettato sulle dita, perché, a quanto pare, la cosa non è vera, il pericolo ci sarebbe in quanto, in caso di incidente, anche le centrali a “fusione”, quelle che a detta di Rubbia sarebbero “pulite”, emetterebbero un qualcosa che si chiama “trizio”, altamente contaminante.
Ed è qui che ci è sorto un dubbio.
A voi la scelta. Sarebbe questo Rubbia un non molto intelligente operaio dell’industria della fisica applicata, oppure è un astuto battistrada del capitale multinazionale?
Come? qualcuno potrebbe risponderci: un premio Nobel su cui si avanza il dubbio di imbecillità. A rigor di esperienza – rispondiamo – la cosa non è del tutto incredibile. Per quanto riguarda la possibilità di capire la realtà, spesso gli specialisti sono fra la gente più stupida che ci sia, e ciò anche perché sono persi fra i loro problemi di settore, oltre al fatto che non ricevono – né si danno pena di procurarsi – una adeguata preparazione intellettuale. Spesso questi scienziati (parola grossa e, ormai, quasi priva di significato), sono grossolani ignoranti con una altissima specializzazione in un singolo settore dello scibile. In una materia come la fisica applicata, o la teorica, o la matematica, o la medicina, e simili, la cosa non è del tutto impossibile.
C’è poi l’altra eventualità. Questo faccione pacioso, nasconde forse l’arte diabolica di preparare la strada al potere di domani? Potrebbe anche essere. E allora saremmo davanti al caso – invero non numeroso – di scienziato capace di collaborare attivamente alla gestione del potere, di partecipare alle sue decisioni, di programmare (almeno in parte) le strategie; insomma, qualcosa di diverso dall’operaio intellettuale che è oggi la figura più comune nel mondo di coloro che impropriamente continuiamo a pensare come “uomini di scienza”.
Comunque stiano le cose, al di là del dilemma, un nostro nemico.
[Pubblicato su “Provocazione” n. 1, gennaio 1987, p. 8 col titolo “Un dubbio su Carlo Rubbia”]
Leonardo Sciascia
C’è una moda per tutto. Anche per la lotta contro la mafia.
Oggi tutti parlano di mafia e dei mezzi per sconfiggerla. Il coro degli oppositori è tanto vasto e armonico da sembrare una voce sola. Non c’è un cane che – a parole – difenda la mafia. Anche i democristiani, che per quarant’anni si sono arricchiti e hanno fatto le proprie fortune politiche proprio col sostegno degli uomini della mafia – da Scelba a Ciancimino – adesso sono tutti uniti per combattere questo male del secolo.
Ma, per noi che sappiamo come non sia ammissibile una separazione tra mafia e Stato e che combattere la mafia diventa impossibile se non si combatte nello stesso tempo lo Stato, tutta questa concordanza di amorosi sensi, sa di stonato e di precostituito.
Per la verità sapevano di stonato anche le denuncie che a suo tempo Sciascia, dall’alto del suo pulpito radicale, lanciava contro coloro che avevano fatto carriera grazie alla “lotta” contro la mafia. E la stonatura di Sciascia dipendeva non dal fatto che non sia vero che il sindaco di Palermo o il Procuratore della repubblica di Trapani possono realmente aver fatto carriera grazie alla loro posizione “ufficiale” contro la mafia, ma dal fatto che non basta dire il contrario del contrario per essere nel vero.
A prescindere dalle considerazioni che si potrebbero fare sul significato dell’essere nel “vero”, e limitandoci al problema dell’azione reale contro il potere, vogliamo sostenere che non basta “dire” qualcosa “contro” la mafia, e nemmeno basta dire qualcosa contro coloro che dicono qualcosa contro la mafia. Occorre fare qualcosa contro la mafia.
E ciò non viene fatto, né può essere fatto, da gente come sindaci o magistrati, i quali, nel migliore dei casi (cioè quando sono ingenui o illusi) possono solo farsi ammazzare senza battere ciglio. Il fare qualcosa spetta solo a quelle forze sociali che sono, da sempre, in grado di sconvolgere, con la propria azione, l’assetto su cui si basa la realtà capitalista nel suo insieme (e quindi anche quella parte di questa realtà che si chiama mafia).
Ora, queste forze sono latenti nel movimento complessivo degli sfruttati, cioè in quella classe – se si vuole molto varia e in continua trasformazione – che subisce il progetto di repressione, di reperimento del consenso e di estrazione del profitto, e ciò senza essere in grado di rendersene perfettamente conto. La potenzialità di questo soggetto sociale è enorme e, in questo senso, tutta l’attività dei rivoluzionari è diretta a svegliare questa potenzialità per condurla davanti alle possibilità concrete di un’azione trasformatrice dei rapporti sociali.
Ecco. In questo senso, cioè nel corso di una lotta per sollecitare il movimento complessivo degli sfruttati a prendere coscienza del proprio sfruttamento, si può inserire anche un discorso che sia realmente contro la mafia. In caso contrario, ogni dichiarazione democratica e progressista si equivale con tutte le altre dichiarazioni politiche dello stesso stampo: si tratta di manovre per addormentare la coscienza proletaria.
[Pubblicato su “Provocazione” n. 2, febbraio 1987, p. 3 col titolo “Sciascia e le false contrapposizioni alla mafia”]
Schema di discussione per un intervento nella scuola
Nell’affrontare il problema di come strutturare un intervento anarchico nella scuola abbiamo dapprima sviluppato un minimo di approfondimento analitico riguardo la situazione economica oggi per arrivare a capire meglio come si sono trasformate le funzioni della scuola nei riguardi di una situazione produttiva in forte movimento di crescita e di ristrutturazione. Da ciò abbiamo ricavato alcune ipotesi di un intervento operativo attraverso la costituzione di un organismo di massa. Ecco la traccia del nostro lavoro.
L’inflazione
Non è più – come in passato – una condizione anomala del sistema capitalistico, ma corrisponde a una delle condizioni del suo stesso sviluppo. I padroni hanno capito, dopo la seconda guerra mondiale, che un arresto dell’inflazione avrebbe potuto comportare rischi molto maggiori di un suo sviluppo coordinato. Altro genere di rischi possono però determinarsi per un suo eccessivo aumento. Da ciò tutta una serie di politiche economiche dirette a controllare l’inflazione dentro limiti accettabili.
Mentre in passato l’inflazione aveva origine solo da un aumento dell’emissione di carta moneta da parte dello Stato, adesso le sue cause sono di altro genere e si possono riassumere in due tipi:
a) Inflazione da domanda, quando i salari crescono e quindi cresce anche la richiesta di merce che i lavoratori vogliono comprare, mentre il settore produttivo resta indietro a seguito della riduzione degli investimenti (e ciò a causa del fatto che proprio la crescita dei salari mette paura agli imprenditori). I prezzi crescono allora perché la gente è disposta a pagare di più pur di avere la merce che desidera.
b) Inflazione da costi, determinata da un aumento del costo della mano d’opera e delle materie prime, che gli imprenditori trasferiscono sui prodotti e quindi sui prezzi di vendita. Si tratta, in pratica, dell’inflazione più comune.
c) Un’altra causa di inflazione sono gli eventi politici ed economici internazionali che possono agire dall’estero nell’economia di un paese capitalista a sviluppo avanzato come l’Italia, proprio per le sue intime interconnessioni a livello internazionale. Un esempio è stato ed è il caso del petrolio.
Le tre soluzioni proposte dal capitalismo
La prima è data dalla politica monetarista, sostenuta dai tecnocrati e dai conservatori, e si basa sull’ipotesi tradizionale che controllando la quantità di moneta in circolazione (quindi riducendo le spese statali in primo luogo) si ha una riduzione dell’inflazione dentro limiti accettabili.
La seconda è data dalla politica dei redditi, sostenuta dalla sinistra e si basa sia su di una più equa ridistribuzione del carico fiscale, sia su di un tentativo di ridurre la disoccupazione. Il primo aspetto dell’intervento consentirebbe di mettere nelle mani dello Stato più soldi e quindi di evitargli una maggiore emissione di carta moneta, il secondo aspetto consentirebbe di aumentare la domanda di merce e quindi spingere i capitalisti a produrre e a investire. Ciò dovrebbe fare controbilanciare le due spinte che agiscono sull’inflazione.
Questa situazione che è rimasta costante almeno fino al 1981, ha messo in luce critica la politica dell’occupazione basata sul sostegno della domanda (e quindi ha messo in crisi gli economisti neo-keynesiani). Ciò ha causato una limitata distribuzione dei redditi, ma principalmente ha causato una diminuzione delle potenzialità contrattuali dei sindacati stretti tra la morsa di sostenere le richieste dei lavoratori e diventare elementi portanti del processo inflazionistico, o di sostenere le richieste dei capitalisti e figurare come traditori degli interessi della classe produttiva.
La politica monetarista
È la tesi classica dei conservatori e dei tecnocrati. Si basa sul presupposto che un controllo della quantità di moneta in circolazione e della sua velocità di scambio, può contribuire a mantenere il livello di inflazione dentro limiti accettabili per lo sviluppo capitalista.
Ciò comporta necessariamente una disoccupazione al di sopra del livello naturale (che ora si è di molto allargato con l’entrata della scuola dell’obbligo). Ma si tratta di un sacrificio che si deve fare per impedire danni maggiori. I salariati devono rendersi conto dei benefici che si hanno da un rallentamento dell’aumento dei prezzi e che questi benefici vengono dopo un certo tempo e non subito.
La terza via
Battuta in questi ultimi anni, sostiene – sulla base delle analsi di Modigliani e Tarantelli – che non è possibile una netta separazione tra le due strade precedenti. Questi due economisti sostengono (per la verità il secondo non più, essendo stato ucciso) la necessità di sostegno della domanda e quindi dell’occupazione ma, nello stesso tempo, parlano della necessità di abbassare il livello dei salari reali. Modigliani ha recentemente affermato che la sola via di uscita, per evitare lo schiacciamento totale dei profitti che distrugge ogni incentivo agli investimenti è quella di ridurre l’eccessivo costo del lavoro. Quindi fermare i salari e licenziare. Il primo aspetto della ricetta consente un riequilibrio della produttività, il secondo consente una ristrutturazione più celere del settore industriale.
Le preoccupazioni che si avevano in precedenza su questa strada da seguire per le eventuali ripercussioni in termini di disordini sociali sono state dimostrate parzialmente infondate proprio da Modigliani e Tarantelli che hanno a lungo insistito sul fatto che i benefici in termini di stabilità politica che derivano da una prospettiva del genere consentono di evitare i disordini sociali in quanto la gente si sente meglio governata, vede che i prezzi ritardano la loro ascesa e tutti si illudono di ottenere benefici a breve termine in quanto si trovano a vivere in un clima di rilancio economico e istituzionale.
Questa strada viene seguita in questo momento.
[Gennaio 1987]
Sopra e sotto
Tre uomini sono morti nelle fogne di Napoli, morti intossicati dall’ossido di carbonio sprigionato dal generatore che si erano portati dietro per aprirsi una strada col martello pneumatico fino al caveau di una delle agenzie della Cassa di risparmio per le province lombarde. Una manifestazione di senza casa li ha obbligati a chiudere i tombini lasciati per prudenza aperti. Il gas ha fatto presto a ucciderli, prima dell’arrivo dei pompieri chiamati dal palo che solo con ritardo si deve essere accorto del pericolo.
Che strana cosa la vita, quando pone l’una accanto all’altra situazioni che di solito non siamo in grado nemmeno di cogliere. Una manifestazione di poveracci che scorre rumorosa e inutile, come tutte le manifestazioni, poveracci che poi fronteggiano in cagnesco i poliziotti che li controllano. E sotto i loro piedi tre uomini che agonizzano nell’impossibilità di uscire, che muoiono mentre fanno l’ultimo sforzo per tornare fuori dai tombini. I primi, in superficie, lavoratori del giorno, nel maldestro tentativo di strappare ai padroni poche briciole, un tetto, un aumento di stipendio, un qualche miglioramento; i secondi, nel sottosuolo, lavoratori della notte, mentre cercano di strappare il contenuto di una cassaforte, l’accumulo dello sfruttamento, il suo massimo significato in termini visibili: il denaro.
Chissà se quelli di sopra hanno poi avuto un pensiero di solidarietà per quei morti?
[Pubblicato su “Canenero” n. 15, 17 febbraio 1995, p. 3]
Sindone
La Sindone è falsa. Si tratta di un sudario del 1300 circa. Tutta la venerazione dei secoli passati, rinfocolata continuamente in modo interessato dalla Chiesa, è andata perduta. Poveri fedeli, gabbati. Fanno quasi pena, se non facessero schifo.
La vicenda [autunno 1988] sarebbe perfino comica se non celasse una profonda venatura di serietà. Essa ci fa subito ridere pensando a quali dolori di pancia avranno patito Papa e complici a denunciare l’imbroglio. Fa sempre male dire la verità quando questa risulta esattamente il contrario di quello che si è sempre sostenuto. E il Papa non fa eccezione. Il suo povero stomaco martoriato deve avere avuto una grossa strizza. La cosa ci fa ridere anche per questo.
Poi ci sono gli elementi seri di riflessione. Non quelli che la stampa ci ha messo sotto il naso, del genere che il sudario portato avanti e indietro sotto il naso dei fedeli era sempre una icona, una immagine di qualcosa che seppure diverso è pur diversamente sacro. Si tratta di stupidaggini. Gli elementi su cui riflettere sono legati alla nuova forza della Chiesa che guarda altrove, cercando di costruire le condizioni del suo futuro, sia pur circoscritto, dominio. E si accorge – lo fa da almeno vent’anni – di quanto queste condizioni siano legate a un rinnovamento laicista e critico delle proprie fondamenta, almeno di quelle più stupide e più legate a insostenibili tradizioni che se andavano bene quando non c’era il carbonio 14, adesso fanno troppe cattive figure.
Il fatto che questa gente, da sempre circospetta e guardinga, desiderosa meno di tutti del rinnovamento e delle modificazioni, perché questi sono quasi sempre forieri di riduzione degli imbrogli e quindi delle possibilità di continuazione del dominio, si sia decisa, adesso, a muoversi nella direzione dei cambiamenti anche negando, faccia a faccia, in collaborazione con la scienza, quello che prima affermava, significa che adesso si sente più forte.
È fondata questa sensazione di forza? Non lo sappiamo. In un momento in cui la fede nel razionalismo liberale e marxista sta crollando quasi dappertutto, certo, la Chiesa, come anche altri integralismi religiosi, può presentarsi come un orientamento salvifico o, almeno, come una possibilità di sostegno esterno alle diminuite forze dell’uomo. E il cattolicesimo con la sua ottusità oggettivante, con il suo tradizionale rifiuto di ogni razionalismo, può giocare un ruolo in questa prospettiva. Ma deve abbandonare quelle scorie troppo esteriori, quelle coglionerie da trivio che erano una volta mutuate da saltimbanchi e da maghi, per passare fra gli arnesi del mestiere di preti e papi. Tutta questa vecchia e rissosa collezione di ciarpami deve scomparire. Purché resti l’ultima e più sostanziosa realtà da difendere: il razionalismo che si cela nella forza occulta del verbo. Di questo imbroglio metafisico, tanto più pericoloso quanto meno facilmente coglibile, la Chiesa non si libererà mai.
Ecco perché la nostra immediata propensione al riso, anche sguaiato, rientra subito. Il futuro può riservarci sorprese del genere (a quando il rifiuto del sangue di San Gennaro?), ma il nocciolo reazionario e anti-libertario della Chiesa cattolica – come delle altre molteplici religioni – resterà sempre intatto.
[Pubblicato su “Provocazione” n. 17, novembre 1988, pp. 7-8 col titolo “Sindone e imbroglioni”]
Sperimentazioni e miliardi
Nel policlinico di Padova, ricercatori dell’università di medicina conducevano sperimentazioni con nuovi farmaci, usandoli su pazienti del tutto ignari.
La faccenda non impressiona molto. Infatti, non è che medicinali i quali abbiano passato tutto l’iter ministeriale e siano arrivati all’autorizzazione, per questo solo fatto siano immuni da rischi e da problemi. Il rapporto tra malattia e medicinali, con l’intermediarietà della figura del medico, è molto più complesso e non si esaurisce all’interno di traffici e di accordi sotterranei tra case farmaceutiche e ricercatori universitari o cliniche ospedaliere.
Resta comunque il fatto che regolarmente sperimentazioni clandestine vengono commissionate dalle case farmaceutiche agli ospedali e alle cliniche universitarie per accorciare i termini (e quindi i costi) della ricerca. Alcuni aspetti negativi dell’impiego di un medicinale, infatti, conosciuti per tempo possono essere molto utili, sia per modificare la formula che per meglio indirizzare le ricerche. Naturalmente, per queste operazioni non ufficiali le case pagano somme enormi e non stanno a sottilizzare sulla sorte di coloro su cui vengono sperimentati farmaci e combinazioni di farmaci, dei quali, spesso, non si conosce quasi nulla.
[Pubblicato su “Canenero” n. 11, 20 gennaio 1995, p. 2]
Joe Slovo
L’estraneo.
Joe Slovo, l’unico leader bianco dell’African National Congress, è morto di cancro al midollo osseo. Insieme a Mandela, uno dei grandi artefici della svolta democratica in Sudafrica, controllore e repressore di ogni movimento spontaneo diretto a rompere definitivamente col governo boero. Fedelissimo di Mosca, fino ad apparire disgustosamente accondiscendente nel corso dell’occupazione della Cecoslovacchia, solo da poco aveva preso prudenti distanze dal socialismo reale, pur mantenendo in vita, per il proprio paese, un progetto di sviluppo vetero-comunista. La consegna del Sudafrica nero in rivolta nelle mani della minoranza bianca sfruttatrice, in nome di un ideale di democrazia buono per tutte le stagioni, è stato l’ultimo capolavoro del vecchio dirigente comunista: la sua ultima capriola. La morte lo ha colto a mezz’aria.
I Sudafricani possono respirare.
[Pubblicato su “Canenero” n. 10, 13 gennaio 1995, p.11]
Studiare da spia
Il mestiere di spia è entrato nell’insegnamento universitario. In Francia l’ammiraglio Pierre Lacoste, ex funzionario della DGSE (servisi segreti francesi) è stato incaricato di tenere un corso all’università di Marne-la-Vallée, nella periferia parigina.
Il corso prenderà il titolo di “Cultura francese dell’informazione” e sarà inserito nel corso di laurea in relazioni internazionali. Il programma contiene studi su come informarsi e documentarsi, su come decidere quale informazione scegliere, sui metodi di ricerca delle informazioni, sul trattamento delle stesse e sulla loro diffusione tramite le autorità politiche. Infine un parte del corso è dedicata alla manipolazione dell’informazione e alle azioni clandestine.
[Pubblicato su “Canenero” n. 31, 16 giugno 1995, p. 5]
Stagno salato
Nell’Adriatico si sono di già inoltrate, prendendono diciamo così possesso militare, alcune fra le navi più potenti al mondo.
La portaerei americana “Theodore Roosevelt” è un’unità nucleare capace di portare 60 caccia bombarbieri con 30 aerei di appoggio, più 5000 uomini di equipaggio. Sarà appoggiata dalla portaelicotteri “Kearsarge” e dalla nave anfibia “Nashville” che oltre a trasportare un migliaio di marine è dotata degli Harrier aerei a decollo verticale.
La portaerei francese “Foch”, oltre a portare aerei ed elicotteri da combattimento, porta un numero non precisato di soldati. È assistita da due altre navi: L’“Ouragan” e “Le Foudre”.
La portaerei britannica “Illustrious” e la spagnola “Principe de Asturias”, completano il quadro di queste presenza tutt’altro che rassicurante.
[Pubblicato su “Canenero” n. 29, 2 giugno 1995, p. 7]
Statuetta
Il carabiniere che ha prelevato la statuetta della Madonna di Civitavecchia ha scritto nel suo verbale di constatazione: “Sulla superficie facciale della statuetta abbiamo riscontrato tracce di un liquido di colore rosso contenente cloruro di sodio...”.
In questa scena, divisa di carabiniere e statuetta costretta a traslocare, e poi nella successiva, carabiniere chino sulla macchina da scrivere, intento a redigere un verbale, c’è tutto il dramma moderno della lotta suprema tra razionalismo e irrazionalismo, tra scienza e religione. Non la religione dei preti e dei vescovi, ma quella più povera e meschina delle miserie e delle sofferenze.
Stranamente, una lunga trama razionalista attraversa la storia, e arriva fino al carabiniere di oggi e al suo cloruro di sodio. Parlando di una statua che suda e sanguina, Cicerone, nel suo De divinatione scriveva: “Sangue e sudore possono provenire solo da un corpo vivente. Mentre invece una qualche alterazione del colore causata dal contatto con la terra può produrre effetti simili al sangue, e l’umidità proveniente dall’esterno, come accade sugli intonaci dei muri nei giorni di scirocco, può rassomigliare a sudore”. Sembra di leggere l’analisi di uno smagato chimico dei nostri giorni, intento a redigere un referto di consulenza da inviare al magistrato inquirente.
Non riesco a convincermi di star bene in questa compagnia. Non sono del tutto tranquillo di essere dalla parte giusta. Riflettendo criticamente sull’argomento, ecco che mi vengo a trovare dalla stessa parte dei carabinieri, dei magistrati e perfino del mio odiatissimo Cicerone (“Fino a quando, Catilina, abuserai della nostra pazienza”, e tutto il resto, e a me Catilina è sempre piaciuto). Non riesco a star bene da questa parte. E nemmeno da quell’altra, in mezzo a sofferenze che capisco ma che non ammetto vengano piegate sull’altare dell’idolo, in attesa di una soluzione che non può venire mai da quel lato.
Quali parole trovare per porre il problema nel giusto modo?
Quali azioni?
[Pubblicato su “Canenero” n. 24, 21 aprile 1995, p. 8 col titolo “L’insolenza della ragione”]
Ugo Stille
Perfettamente normale.
Ugo Stille, giornalista, ex direttore del “Corriere della sera” è morto a New York per un attacco cardiaco. Un gentiluomo vecchio stampo, e proprio per questo, utile agli imbroglioni e ai corrotti. Di lui tutti parlano bene: colleghi, uomini politici, scienziati, attori, intellettuali, un coro di imbecilli all’unisono. Considerevole la sua funzione di servizio per gli uomini di potere che vedono in lui la “voce” autorevole in grado di recuperare i contrasti e di fornire, a livello internazionale, parlando dalla sede americana, una interpretazione dei fatti sempre adeguata agli interessi della classe dominante. Stille è l’uomo che accompagna il giornalismo italiano, e quindi indirettamente la stessa opinione pubblica italiana fondata sull’informazione, fino alle soglie del ricambio politico, battendosi fino all’ultimo perché la vecchia classe dirigente esca con il minor danno possibile dal passaggio delle consegne.
Il resto è solo cronaca.
[Pubblicato su “Canenero” n. 30, 9 giugno 1995, p.11]
Suicidio
Affrontare il problema del suicidio equivale ad affrontare uno dei punti essenziali della problematica umana, in quanto immediatamente esso conduce al problema della morte, del limite dell’esistenza, cosa questa che resta nello stesso tempo un punto di riferimento e qualcosa da cui cerchiamo di allontanarci per quanto possibile.
Problema della morte e problema della scelta di morire, sono ambedue estremamente complessi e di larga trattazione nella storia del pensiero umano.
Precisiamo che qui non ci occuperemo del problema esistenziale delle scelte, che pure presenta importanti elementi di riflessione, come non ci occuperemo neanche del problema del valore, in astratto, della vita. Non ci occuperemo, sotto un altro aspetto, nemmeno del problema della condanna religiosa del comportamento che sceglie il suicidio.
Ci sembra opportuno, invece, fare alcune riflessioni sulle condizioni obiettive che contribuiscono a produrre il fenomeno del suicidio. Motivi soggettivi e condizioni oggettive. Le due correnti motivazionali non ci appaiono subordinate l’una all’altra, ma si pongono su di un piano di importanza valutativa che possiamo considerare uguale. Da ciò consegue, malgrado l’aspetto di chiarezza esteriore, che non sempre è facile spartire queste due correnti motivazionali con un colpo secco. Ricerche cliniche, analisi statistiche, elaborazioni quantitative, indagini e riflessioni ideologiche necessitano di un chiarimento psicologico, necessitano di qualche approfondimento in merito al meccanismo decisionale, alla volontà di uccidersi. Quest’ultimo aspetto potrà essere bene illustrato, almeno ci pare, studiando situazioni specifiche che non devono per forza essere di tipo clinico.
Il suicidio non è un “atto eroico”, non è nemmeno, preso in se stesso, un atto che si può considerare come l’“estrema ribellione”. È però un’espressione della libertà umana e, se considerato nella sua obiettiva condizione di “possibilità”, può certamente contribuire a fare della vita un processo attivo capace di contrapporsi validamente all’oppressione e al dominio.
Quindi, se il suicidio non è, di per sé, fatto eccezionale, non ci si deve aspettare di trovare, nel suicida, un “diverso”, nel “bene” come nel “male”. Il suicidio è quindi un fenomeno che tocca il vicino di casa, l’uomo celebre, l’operaio, la casalinga, l’ammalato, il bambino, il vecchio e il giovane nel pieno delle sue forze e senza ombra di malattia. Il suicidio è uno dei tanti problemi della vita e, come tale, va considerato per quello che è.
Il fatto che il suicidio sia sempre stato condannato o considerato con sospetto, ci deve indurre alla prudenza e a valutare bene le possibilità di una ricerca che abbia pretese di “mantenersi distante”. Che il diritto consideri il suicidio come un crimine (almeno sotto certi aspetti), che la religione lo consideri peccato, che la società lo respinga, non sono elementi che possono essere separati dalla decisione del suicida di mettere fine alla propria esistenza.
Il suicidio è un fenomeno che si manifesta con notevole costanza (riscontrabile statisticamente) al verificarsi di alcune condizioni obiettive.
Secondo la scuola francese, facente capo a Durkheim, si hanno spostamenti nelle situazioni obiettive del singolo, da uno stato ipotetico di condizione non adatta all’evento suicidio, a uno stato specifico, in cui le probabilità che l’evento suicidio si verifichi aumentano notevolmente, quando si verifica un indebolimento delle strutture di difesa del gruppo sociale per cui ogni singolo si rinchiude progressivamente nella propria individualità.
Da ciò la conclusione di questa corrente di pensiero per un’alleanza dell’istituzione e della scienza sociologica al fine di garantire quelle condizioni di “prevenzione del suicidio” che possono ridurre questo fenomeno dentro limiti accettabili. La prova che questa situazione è anormale in se stessa è data da una curiosa scusante alla quale la legge ha fatto ricorso per impedire l’enormità dell’accomunare omicidio e suicidio. Invece di considerare il tentato suicida colpevole di tentato omicidio lo ha dichiarato pazzo. In questo caso, il ricorso alla formula “mentre l’equilibrio della sua mente era turbato” diventa obbligatorio. Per definizione si è deciso che il tentativo di suicidio può essere posto in atto soltanto da un individuo in non perfetto stato mentale, in quanto chiunque si trovi in perfetto equilibrio psichico, cioè sia considerabile “sano di mente”, non può attentare alla propria vita perché la cosa ripugna al primo bisogno dell’uomo, quello di vivere.
Si tratta di un ragionamento distorto, solito in questioni che rasentano l’ideologia istituzionale del potere e che viene costruito dalla scienza a uso e beneficio del mantenimento delle istituzioni.
In questo caso, il problema più importante era quello di impedire che il suicidio venisse accettato dalla comunità come un “fatto normale”, attuabile anche da persone “sane”, donde se ne potrebbe dedurre che nel caso del presentarsi delle condizioni obiettive favorevoli (rottura con il gruppo), il numero dei suicidi sarebbe aumentato di molto, trovando, un maggiore quantitativo di persone “del tutto normali” desiderose di togliersi la vita.
Su questa linea comincia S. Agostino che condanna severamente chi «per evitare le miserie del tempo, rischia di cadere nelle miserie dell’eternità, sovraccaricandosi del grave peccato del suicidio». (La città di Dio, cap. XXVI).
Dopo il Concilio di Arles (del 452 d.C.) la condanna della Chiesa diventa costante. Parimenti le leggi contro i suicidi diventano severissime. Nel 1270, Luigi IX stabilisce la confisca dei beni del suicida. Lo stesso, e di peggio, avviene contro il suo corpo. Nel 1601 le leggi inglesi fissano che il corpo del suicida venga trattato come quello di un omicida: «Trascinato da un cavallo al luogo della sua punizione e vergogna, dove messo sulla forca nessuno poteva prendere il suo corpo, se non dietro autorizzazione di un magistrato». (Cfr. A. Alvarez, Il dio selvaggio, tr. it., Milano 1975, p. 55).
Normalmente la sepoltura non può avvenire in terra consacrata, per cui i suicidi vengono sepolti sul ciglio della strada, a un crocevia.
Il codice francese del 1670 cataloga le pratiche più assurde a carico del corpo del suicida, mentre le proprietà vengono incamerate dalla Corona.
Sempre secondo le leggi inglesi, ancora nel 1961, un fallito suicida poteva essere imprigionato.
L’evoluzione della giurisprudenza, facendo seguito al progresso generale della condizione umana, legata, quest’ultima, alla realtà economica e sociale nel suo continuo svolgersi, riduce l’entità della pena e trasforma l’oggetto della condanna, passando dalla presunzione della colpevolezza, alla presunzione della pazzia, sorta di “colpevolezza involontaria”.
Il principio dell’“unità” sociale è quindi salvo. Questa trasformazione si va attuando parallelamente a una profonda modificazione dello scopo stesso della riflessione sui problemi della società.
La vecchia scuola statistica dà allora i suoi contributi, parlando di influenze cosmiche o naturali, di influenze etniche o demografiche, di influenze sociali, di influenze individuali e biopsicologiche. In questa corrente si deve subito sottolineare l’ingenua ed entusiasta tendenza dei positivisti fine secolo scorso (sull’argomento tiene banco Morselli con il suo: Il Suicidio. Saggio di statistica morale comparata, Milano 1879). La caratteristica povertà metodologica di questo sistema interpretativo dei dati raccolti dalla statistica, consentirà, qualche decennio dopo, la diffusione dello spiritualismo francese (Bergson) e del neo-hegelismo italiano (Gentile), il quale ultimo darà un grande sostegno al fascismo.
L’eclettismo di fondo, e una non sufficientemente corretta lettura e interpretazione dei testi, arrivarono a fare unire l’individualismo radicale di Spencer con il materialismo storico di Marx, in un impossibile pasticcio che non poteva avere che risultati negativi. Esempi di questo tipo: Ferri e Lombroso.
Il suicidio diventa quindi uno dei mille problemi che vengono ricondotti sotto l’ala interpretativa dell’evoluzionismo. Se da un lato questo sforzo metodologico positivo arriva a mettere da parte le pretese della religione e della morale, consente però dall’altro lato di pervenire in tempi brevi alla soluzione più avanzata e “moderna”, quella della pazzia. Il suicida è un pazzo che ha tagliato i ponti con il suo gruppo sociale, un debole che non ha sopportato una delusione.
In questo modo, il suicidio diventa un effetto della lotta per l’esistenza e si inserisce in quel cumulo di affermazioni caratteristiche dell’evoluzionismo spenceriano. Per questi pensatori si verifica una ben strana situazione. Come era già accaduto con i filosofi radicali inglesi della prima metà del secolo che stava allora per finire, essi erano progressisti ma, in sostanza, lavoravano solo a favore del determinismo. Partendo dall’evoluzionismo chiusero gli occhi davanti alla necessità della lotta sociale, unico mezzo per modificare la società, e arrivarono alla non modificabilità di quest’ultima se non sulla base dei tempi determinati a priori dell’evoluzione cosmica. Allo stesso modo, i loro predecessori inglesi (a esempio, Stuart Mill) lottarono per limitare lo sfruttamento dei bambini nelle industrie e nelle miniere, ma non per l’abolizione del lavoro infantile, se non al di sotto di un limite di età ben preciso, perché ciò avrebbe causato un danno considerevole all’economia inglese.
Nel secolo scorso si credeva ancora che il suicidio fosse un’abitudine nazionale degli Inglesi. Poi le rilevazioni statistiche diventarono più accurate e smentirono questa fantasiosa affermazione che risaliva a Montesquieu.
Appena qualche decennio fa gli Svedesi erano considerati gli eredi di questa fama. Adesso la percentuale di quel paese è in ribasso e la punta massima resta ferma a quella del 1910.
Su questi problemi, che a nostro avviso sono introduttivi alle tematiche sociali vere e proprie, l’ampio studio di Erwin Stengel (Suicide and Attempted Suicide, Harmondsworth 1969) è fondamentale. In questo lavoro si dimostra che la stasi degli Svedesi si deve attribuire alla loro neutralità in guerra. I Norvegesi e i Finlandesi occupano invece un livello molto più alto, ma il posto più elevato lo occupano in Europa centrale l’Ungheria (che ha la percentuale più significativa), l’Austria e la Cecoslovacchia. Alvarez ha notato che in una ipotetica mappa europea occidentale, la piccola Berlino Ovest [1988] occupa un posto elevato. La città, secondo lui, è un esempio di quelle condizioni di assenza delle norme di cui parlava Durkheim (anomia), trovandosi in una condizione di alienazione morale, culturale, spirituale, politica e geografica.
Osservando i dati statistici si arriva alla conclusione che i paesi industriali a capitalismo avanzato presentano cifre più elevate sia per i suicidi che per i tentativi di suicidio, mentre i paesi arretrati presentano cifre inferiori. Si è interpretato questo fenomeno come un freno che l’ideologia religiosa, molto potente nei paesi più arretrati, costituisce nei confronti dello stimolo a togliersi la vita e, in senso inverso, come un impulso all’inconsistenza del valore della vita, nei paesi più progrediti, immediata conseguenza dell’alienazione e della civiltà dei consumi. Ma la realtà potrebbe essere molto meno complessa, potrebbe cioè derivare dal fatto che i paesi più progrediti hanno anche sistemi di rilevazione statistica molto più raffinati per cui individuano dati che sfuggono agli altri paesi.
Un altro problema che potrebbe essere condizionato dalla codificazione valutativa a priori, ancora imperfetta, è quello del rapporto tra suicidio e classe sociale. È stato fatto notare da Peter Sainsbury che nei distretti operai più miseri, la percentuale di suicidi è più bassa di quella dei quartieri medi, con i loro formicai e i loro grandi alveari. Si è concluso che il cerchio di solitudine si può spezzare – come ha affermato Alvarez – più facilmente nelle zone povere dove si possono creare dei centri comunitari che non nelle zone ricche con i loro miniappartamenti e i loro grandi alberghi. Da qui l’appello dei sociologi “progressisti” per spingere la società (che poi, nel loro linguaggio si confonde con lo Stato e basta) a interessarsi di più dei malati, degli instabili, degli estranei, dei diversi e di chi si lascia andare alla deriva.
Ma, in questo modo, non si esce dal problema. Le attitudini preventive e correttive della sociologia sono, come quelle della pedagogia, attitudini autoritarie di sostegno all’istituzione in carica. Suggerire, come fa Alvarez, la necessità di creare dei “centri comunitari”, equivale ad affermare la necessità di costruire dei pre-manicomi, dove la gente “forzata” a ritrovare gli altri, finirà per trovare un nuovo modo per giustificare a se stessa la necessità di fuggire dalla vita.
In effetti, è qui che si racchiude uno dei punti nevralgici del problema del suicidio. Se le condizioni di base, che pure determinano la condizione “ineluttabile”, come sappiamo, al verificarsi di un certo numero di fenomeni di ben prevedibile caratteristica, sono pur sempre riconducibili a cause che non possono essere influenzate se non in minima parte dalla buona volontà dei riformatori, in quanto cozzanti con interessi precisi dei gestori del potere; allora la reazione del singolo individuo si dissocerà radicalmente da queste “condizioni” di fondo, reagendo in forma positiva. Si tratta di un impegno personale, un ritrovare se stessi e la propria autonomia nella lotta quotidiana per la vita, anche attraverso l’esperienza limite del suicidio.
Il progressivismo imperante, figlio diretto per quanto non certo legittimo del più classico positivismo, pone a fondamento delle proprie riflessioni il fatto che le società più avanzate hanno un più alto numero di suicidi.
Di già Enrico Morselli, alla fine del’Ottocento, riprendendo le medesime parole di Comte, affermava che lo sviluppo umano procede verso un progressivo perfezionamento, sia per le società, che passano da società giovani dove prevalgono reati di sangue e di violenza, a società mature dove questi reati tendono a scomparire. Queste affermazioni oggi fanno ridere, alla luce delle nostre presenti esperienze, ma da queste esperienze si possono solo ricavare considerazioni che, per quanto ovvie, stentano a entrare nelle riflessioni dei cosiddetti dotti.
Su questa linea Émile Durkheim affermava: «Il suicidio non appare che con la civiltà. Per lo meno, il solo tipo di suicidio che possiamo osservare nelle società inferiori allo stato cronico presenta caratteri molto particolari che fanno di esso un tipo speciale, il cui valore sintomatico non è il medesimo. E un atto non di disperazione, ma di abnegazione». (La divisione del lavoro sociale, tr. it., Milano 1962, p. 248). Questo autore estende le sue considerazioni anche a livello delle singole classi, affermando che “le professioni liberali sono le più colpite, e l’agricoltura è la più risparmiata”.
Non ci sembra qui il caso di contestare queste affermazioni – come è stato fatto – sulla base delle tecniche di rilevazione dei dati, di certo discutibili all’epoca di Durkheim, per cui si può anche ammettere che si tratti di dati che mantengono una loro significatività anche oggi. Quello che non è condivisibile è il contenuto, i concetti fondamentali di “normalità” e di “felicità”, concetti che reggono tutto il discorso di Durkheim e degli altri studiosi della medesima tendenza ed epoca. La “normalità” è considerata da Durkheim come una specie di “media”, per cui sono normali i fatti che rientrano nelle forme più generali teoriche conosciute a priori, sono “patologici” i fatti che non ci rientrano. In questo senso egli parla di motivazioni “altruistiche”, che basate sulla estrema solidarietà meccanica con gli altri appartenenti al gruppo, finiscono per privare di importanza la vita individuale. Poi parla di motivazioni egoistiche che esaltano il valore dell’individuo e lo sottraggono a sentimenti collettivi come quelli di Dio, società, patria, ecc. Infine Durkheim parla di periodi in cui prevalgono i fattori “anomici” (assenza di norme), cioè periodi in cui si verificano rapidi e profondi sconvolgimenti all’interno della società. A esempio, egli dice, in periodi di estrema prosperità o di estrema povertà, la frequenza dei casi di suicidio aumenta. In entrambi i casi la relazione tra i mezzi e i fini è rovesciata, con la povertà improvvisa vengono meno i mezzi per i fini abituali, con la prosperità improvvisa i fini vengono attuati senza i soliti mezzi. Nel primo caso c’è una frustrazione diretta e immediata, nel secondo caso all’appetito viene tolto ogni freno e la situazione precipita verso la frustrazione. Fattore comune è l’assenza di una chiara definizione dei fini.
Si tratta di considerazioni non prive di interesse. I periodi di alleggerimento delle norme sociali di fondo, che sono le scale dei valori e i codici di comportamento (quindi non si devono confondere né con le mode, né con le leggi scritte e codificate), periodi che corrispondono sia a momenti di preparazione degli eventi rivoluzionari, come a momenti di ristrutturazione dei processi repressivi e di controllo, sono quelli in cui la cosiddetta “coscienza collettiva” subisce profonde modificazioni. Ora questa coscienza collettiva, di cui parla anche Durkheim, non è altro che un modello medio di “reazione adeguata” di fronte alle situazioni sociali di fatto, che poi sarebbe qualcosa di molto simile alle condizioni dei processi di produzione. Che poi Durkheim veda questi periodi di “anomia” come “disastrosi”, in quanto l’individuo, in essi, può trovare molto difficilmente un freno alle libertà, questo è un altro argomento. Egli scrive: «[...] un essere liberato da ogni freno, un despota più assoluto di quanti appaiono nella storia dei singoli, un despota che non può essere controllato da nessun potere esterno [...]. Quando i nostri desideri sono sottratti a ogni influenza moderatrice, quando niente li limita, diventano essi stessi tirannici, ed il loro primo schiavo è proprio il soggetto che li prova». (Il suicidio, tr. it., Torino 1969, p. 237).
Dietro queste preoccupazioni c’è l’interesse di una classe che si prepara a sferrare gli attacchi più decisivi contro la classe avversa, quella dei proletari che si stanno affacciando sulla scena del mondo con progetti e realizzazioni. Durkheim, e con lui il positivismo e l’evoluzionismo, furono incapaci di collocare l’uomo in una prospettiva storicamente reale basata sullo scontro di classe. Quando tentarono questo sforzo caddero nell’idealismo. I punti fondamentali della tesi evoluzionista e positivista erano: a) ammissione della tendenza evolutiva del progresso delle forme organiche; b) lotta per la vita: la lotta viene riconosciuta, non potendosi negare come fatto storico, sebbene in alcune versioni (Kropotkin) venga limitata all’interno della specie (classi e gruppi in contrasto tra loro); c) successiva correzione del principio darwiniano, attuata dallo stesso Darwin e dai suoi successori, con maggiore accentuazione data al concetto di solidarietà e di “coscienza collettiva”; sviluppo del concetto di socialità come derivato dall’esistenza dell’istinto di solidarietà, cosa che modifica profondamente l’interpretazione della dinamica evolutiva della specie. Tutto ciò finì per essere usato dai sociologi, in servizio permanente, per affermare, in favore del potere in carica, la necessità della socialità per definire lo stesso concetto di etica, donde la deduzione necessaria che lo Stato (non sempre separabile dalla società nel senso astratto) può diventare il tenutario del concetto di etica. Da ciò alla creazione dello Stato etico di Gentile e del fascismo, il passo non poteva essere difficoltoso.
Certo, non sono mancati gli anarchici, come Kropotkin, che hanno sviluppato l’evoluzionismo in senso antiautoritario, ma si tratta di una minoranza messa subito al margine della “scienza sociale”. L’evoluzionismo di stampo deterministico portava al conservatorismo e all’immobilismo. Spencer, malgrado i suoi scritti come L’uomo contro lo Stato, ci appare nella sua giusta veste di reazionario. Per lui lo sviluppo dell’umanità è lento ma inevitabile, allo stesso modo dello sviluppo del bambino: come non è possibile accelerare i termini di quest’ultimo sviluppo, così non è possibile fare per il primo. Da ciò la considerazione negativa in cui Spencer teneva le rivendicazioni della classe operaia, nelle quali vedeva il germe rivoluzionario del tentativo di sovvertire quel corso predeterminato degli eventi in cui fermamente credeva.
Ma, in effetti, l’uomo è un evento sociale e storico. Come fenomeno biologico esso non ci dice molto in merito ai suoi destini e alle sue possibilità. Solo nella realtà complessa della vita di tutti i giorni, anche gli elementi biologici possono trovare completa estrinsecazione facendo vedere la reale costruzione umana. In questa prospettiva diventa più comprensibile il problema del suicidio.
Occorre stabilire una distinzione fondamentale: quella tra cause e pseudocause. Le cause sono quelle che concorrono a determinare le condizioni che rendono possibile il suicidio o che influiscono in modo preciso sull’aumento o sulla diminuzione dei suicidi. Le pseudocause sono quelle cause che non agiscono direttamente sul fenomeno, ma che sono a loro volta effetti di cause ben diverse che nulla, o quasi nulla, hanno a che vedere col fenomeno del suicidio in particolare, potendo, al più, avere rapporti con l’andamento della società e con l’organizzazione di potere in senso stretto.
Questo ragionamento consente di individuare alcune cause che possono essere considerate come “vere”, procedimento analitico che sarà discutibile quanto si vuole, ma anche consente un ottimo orientamento pratico nell’azione.
La realtà moderna agisce sugli individui condizionandoli fortemente, magnificandoli, plasmandoli secondo gli interessi della classe dominante. Oggi, il dominio del capitale è del tutto indiscusso. Sia a Occidente (capitalismo concorrenziale), sia a Oriente (capitalismo di Stato [1988], per altro in forte processo di recupero), non abbiamo che questa prospettiva, di giorno in giorno più massiccia, una prospettiva che grava sull’uomo. Ma, a differenza del passato, oggi il capitalismo è considerato come una struttura economica storicamente prodotta, cioè che può cambiare, non essendo per nulla connaturata – come si credeva una volta – al vivere in società. La vecchia concezione partiva dal presupposto che “capitale” fossero tutte le cose possedute dall’uomo, dall’arco e dalle frecce del selvaggio nostro progenitore, alla macchina dell’industria moderna. Questa concezione fu sviluppata in forma chiarissima da Böhm-Bawerk, che considerava capitale “tutto ciò che è prodotto per servire alla produzione ulteriore”. Oggi, il “capitale” non è più considerato un insieme di cose, ma un rapporto sociale, non lo strumento di produzione come tale, ma la proprietà privata di esso, e non soltanto questa (infatti, anche in economia di tipo non capitalistico, a esempio, nell’economia medievale, si aveva proprietà privata dei mezzi di produzione), ma questa proprietà in quanto trova sviluppo e accrescimento attraverso l’impiego di salariati. Così, il capitale o “capitalismo” diventa un fenomeno storico, nato nel tempo e destinato a modificarsi o a morire.
In questa prospettiva, accettata non solo dai marxisti ortodossi, che risalgono per questo alle analisi contenute nel Capitale, ma anche dagli economisti “ufficiali” più importanti (Keynes, Schumpeter, Galbraith, Modigliani, ecc.), grande importanza assume la lotta di classe e l’azione dei singoli all’interno della prospettiva storica. La vecchia concezione, di cui parliamo, a esempio di un Durkheim, di una “coscienza collettiva”, come di un qualcosa nei confronti del quale il suicida rompe i legami, venendosi a trovare fuori del gruppo, nella “solitudine”, va rivista alla luce di questi concetti.
Ci si trova fuori della società in quanto è la società a collocarci in una zona alienata tramite il suo meccanismo produttivo e repressivo, una zona in cui ci utilizza come strumenti di produzione e di consumo. Oggi, la società dei consumi ha imposto al produttore un duplice ruolo: produrre, staccandosi dalla cosa prodotta, e consumare, staccandosi dal vero bisogno della cosa che consuma. Questo duplice processo alienante non manca di dare i suoi veri frutti come elemento produttore delle condizioni migliori per il suicidio.
Siamo così alla radice delle cause di molti fenomeni che spesso le scienze sperimentali e morali ricercano separatamente andandosi a perdere nel mare senza fondo delle supposizioni e delle misurazioni. Ma, nello stesso tempo, bisogna essere attenti. Non basta l’alienazione per risolvere ogni problema della vita moderna. L’alienazione non può diventare un primo motore capace di produrre ogni male, e quindi anche il suicidio. Certo, in una società in cui non esiste questa divisione in classi, in cui non esiste il problema della divisione del lavoro, in cui è possibile costruire l’uguaglianza delle fortune nello sviluppo diseguale e armonico degli individui, i suicidi sarebbero di gran lunga minori, e avrebbero soltanto motivazioni estetiche e di natura personale.
L’“esclusione” è senza dubbio privazione di qualcosa di concreto e, nelle condizioni di oggi, nella maggioranza dei casi, questa privazione è di qualcosa di primario ed essenziale, generalmente di qualcosa che ha attinenza con la miseria e la degradazione. Ma non si può affermare in assoluto che questo spieghi la totalità dei casi che si concludono con suicidio o tentativo di suicidio. La privazione può, a parità di conseguenze, se non addirittura con conseguenze peggiori e più violentemente sentite dal singolo, essere avvertita anche in condizioni di “inclusione” oggettiva, che però si traducono in condizioni di “esclusione” soggettiva (psicologica). Comunque, in qualsiasi modo si vedano le cose, non è certo l’angolazione riflessiva che modifica la realtà. Le cause “vere”, di cui dicevamo sopra, sono di tipo sociale e generale, e ciò anche quando si scende nelle condizioni personali dell’individuo, in quella realtà che spesso viene parcellizzata e spacciata come fatto “patologico”.
La “preoccupazione” è una delle caratteristiche “moderne” dell’individuo. Si tratta di uno stato psichico che finisce per diventare la trasposizione soggettiva della realtà dell’uomo come soggetto ridotto al rango di oggetto. La preoccupazione è il perdersi dell’uomo nel complesso dei rapporti che gli si presentano a livello pratico e utilitario.
Il singolo cessa così di essere soggetto pensante, capace di intuizioni, e diventa soggetto capace solo di vivere nella prassi, nel mondo degli affanni, dei mezzi, dei fini, dei progetti, degli ostacoli e dei successi.
La preoccupazione costante lo avvolge e finisce per isolarlo all’interno stesso della società in cui vive. L’individuo è certo ciò che si crede, più ciò che gli altri credono che egli sia, più ancora un elemento supplementare, aggiuntivo: la “preoccupazione” di giocare un ruolo obiettivo, sovraindividuale, del quale, però, non si rende conto necessariamente. Questo ruolo supplementare, è il solo sostanziale, è il ruolo che consente la costante riproduzione dell’uomo attraverso il proprio lavoro.
Il fare è l’attività specifica ed essenziale di quest’uomo storico, per come noi lo conosciamo, con tutti i suoi limiti oggettivi e con i limiti altrettanto oggettivi della nostra capacità di conoscerlo. Creazione e produzione di oggetti: il modo in cui l’uomo si mette in pratica. Questa attività specifica è propria dell’uomo in quanto soltanto lui può prospettarsela in anticipo, può cioè programmare quello che farà, il modo in cui tradurrà in pratica i suoi pensieri. Nel fare, giustamente, l’individuo potrebbe realizzare le condizioni per arrivare a ciò che vuole trasformare nel mondo. Solo che non esistono le condizioni adatte perché questa semplice affermazione si traduca in pratica reale. Cosa diventa questo processo di oggettivazione nel sistema economico e sociale capitalista?
Il sistema capitalista è basato sulla proprietà privata dei mezzi di produzione: alcuni possiedono questi mezzi e sono i capitalisti. Chi deve produrre è obbligato a utilizzare necessariamente questi mezzi, quindi da produttore libero si trasforma in operaio, cioè in un creatore che mette la propria forza lavoro al servizio di un altro uomo, il capitalista. Da ciò l’alienazione. È la proprietà privata e il capitalista che trasformano l’oggettivazione in alienazione: l’oggetto prodotto è diventato in questo modo completamente estraneo al suo produttore. Quest’ultimo scompare in quanto produttore e rimane soltanto come operaio, cioè il fare per lui non è più che un mezzo per assicurare la propria sopravvivenza in quanto essere fisico. Il fare manca così la propria prospettiva (la creazione di qualcosa di veramente nuovo), prospettiva che avrebbe potuto essere quella di manifestare la libera e integra personalità dell’individuo. Negare il fare è l’unica condizione possibile, in una situazione come quella attuale, dove non c’è altro modo per salvare la realtà umana residua.
Ma, in una realtà capitalista che tende verso una riduzione del lavoro, anche in termini quantitativi, e ciò in funzione delle sue prospettive, a breve e a medio termine, non si possono non verificare tutti i fenomeni relativi alla mancanza, improvvisa e traumatica, del supporto medesimo dell’alienazione. Ogni ostacolo, ogni catena, ogni impedimento sono sempre da rimuovere, purché l’azione diretta alla rimozione sia prodotta autonomamente dal soggetto, il quale nel processo di rimovimento produce una lotta e una carica di energia che concorrono, insieme e mescolate, a rendere per nulla traumatica la rimozione stessa. Invece, al contrario, se la rimozione dell’ostacolo è ottriata dal potere, se essa è una gentile concessione per volontà del sovrano che gestisce la baracca, il risultato non può essere molto diverso dallo sbandamento e dall’insorgere della “preoccupazione”.
Il suicidio, in questo modo, viene inserito in un processo di profonda modificazione istituzionale. Le condizioni generali del quadro societario si modificano. In tutto ciò l’individuo, tra contraccolpi e preoccupazioni, può, sia pure con uno sforzo, individuare un progetto al di là del cosiddetto crollo dei valori. L’alienazione, specie quella per intervenuta modificazione delle condizioni del processo alienante attuata dal potere, non deve necessariamente condurre all’istituzione totale o al suicidio, può portare alla lotta e alla vita.
E, certamente, anche il semplice avere le idee più chiare in merito al problema del suicidio stesso, può facilitare il compito. In questo senso la possibilità del suicidio, chiarita in tutti i suoi aspetti, anche quelli tecnici e non solo quelli metafisici, può diventare strumento di lotta contro il nemico di classe.
[Pubblicato su “Anarchismo” n. 62, dicembre 1988, pp. 18-27 col titolo “Il problema del suicidio tra tabù e processo di liberazione”]
Teste rapate
Cosa c’è dentro le teste rapate? Non molto, questo è vero. Le tesi dell’estrema destra attuale, che si richiama al nazionalsocialismo in maniera dichiarata, più che essere confuse sono proprio inesistenti. Non per nulla esse si possono facilmente riassumere nei tre elementi del coraggio, della violenza e della lotta contro il diverso. Questa condizione di povertà individuale porta molti osservatori del fenomeno, per alcuni aspetti ricco di folclore, a concludere superficialmente per una pericolosità limitata, circoscritta appunto a qualche scontro di piazza e a qualche raid punitivo, tutto facilmente controllabile dalle forze repressive dello Stato.
Noi pensiamo che non si possano accettare analisi così affrettate e conclusioni così insufficienti. E ciò almeno per due ordini di motivi. Prima di tutto, il discorso sulla violenza e sul coraggio non è così semplice, come pure non lo è quello sul razzismo. Si tratta di argomenti che oggi più che in passato necessitano di approfondimenti decisivi. E poi c’è da segnalare un secondo ordine di motivi, quello dell’eredità reazionaria che è sempre dietro l’angolo e che gli organizzatori delle attuali teste vuote potrebbero recuperare agevolmente in un futuro più o meno prossimo.
Vediamo questi aspetti uno alla volta.
Il crollo delle certezze del passato si può riassumere nella sconfitta del modello di progresso lineare. Una visione reazionaria, fabbricata in cucina, vi sostituisce il modello del disastro lineare. L’improvvisazione è grossolana, ma dentro certi limiti funziona. Nell’attesa della catastrofe, pochi eletti, coraggiosi e forti, si possono radunare in una tribù identificabile anche sulla base di contrassegni esteriori. Le prove di coraggio e l’esercizio della violenza servono qui a identificare i soci e a camuffare la reale paura collettiva di chi si aggrega a un gruppo di teppisti solo per farsi coraggio e per cercare emozioni forti che da solo non saprebbe affrontare. Non è un caso che questi gruppi privilegino l’attacco improvviso a individui isolati o indifesi, declinando lo scontro quando la forze in campo appaiono pari.
Queste pratiche mimano il coraggio effettivo e la violenza liberatoria, cioè gli strumenti che l’oppresso trova per affrontare la scontro con l’oppressore. D’altro canto, in un’epoca in cui le tradizioni culturali dell’Occidente stanno tramontando, e con loro quel liberalismo gestionario e centralizzato che le aveva rese possibili in tutte le varianti sociali ed economiche, la polverizzazione dei vecchi schemi di classe rende difficilmente individuabili il vero coraggio e la violenza da non condannare. Mancando un modello operativamente attivo, o essendosi quest’ultimo ridotto ai suoi minimi termini, assurge all’attenzione l’atteggiamento spavaldo e stupido di questi ragazzi dalle teste pelate.
Allo stesso modo, contro una pratica razzista e dichiarata, posta in atto da pochi imbecilli, non è possibile identificare una pratica internazionalista capace di indicare metodi e idee per un intervento a fianco delle lotte che si stanno conducendo in tutto il mondo. Anzi, l’unica cosa che viene fuori, come contrapposizione fittizia è un antirazzismo ideologico, sostenuto a parole soltanto per differenziazione di partito o di bandiera, per pratica politica e per tradizione, quasi mai per convincimento. Antirazzismo che nella sostanza, osservando i mille aspetti della diversità che vanno dal colore della pelle al sesso, è razzismo solo a malapena coperto da una vernice democratica che vuole darsi il belletto d’una intelligenza che non possiede.
Ma il fascismo non è stato soltanto olio di ricino e manganello, come una superficiale analisi marxista ha voluto farci credere. È stato anche analisi e approfondimento culturale, sulla cui base si sono innestati malintesi e malumori di un’epoca di transizione, forse non tanto lontana da alcune caratteristiche di fondo che si possono leggere anche in quella presente. Se i crani rasati non hanno idee, quelle antiche idee reazionarie non sono del tutto morte e vengono utilizzate da altri schieramenti politici o guardate con una nascente, o ritrovata, simpatia da fasce consistenti di intellettuali, filosofi, economisti, uomini di pensiero e di governo. Questo considerevole pericolo non è tenuto da conto in tutti i suoi aspetti, anzi, al contrario, si ritiene di potere stare tranquilli perché questi ragazzi, così violenti, fondano le loro istanze su niente di concreto, su simboli e gagliardetti che ormai dicono poco. E invece il pericolo c’è.
D’altro canto, l’equivoco imposto e gestito dai marxisti, di una identificazione tra cultura e cultura di sinistra, aveva nei decenni passati eliminato dal territorio universitario la cultura dichiaratamente di destra e reso difficile il recupero di scrittori e filosofi come Nietzsche, Heidegger, Pound, Céline, Cioran e tanti altri. La pretesa di non considerare cultura l’insieme delle tesi di destra, pur nella difficile identificazione di tale identità politica, si andò poi allentando con il declinare dell’egemonia marxista nei luoghi della produzione culturale accademica. Considerando come cultura le analisi complessive di natura generale e metodologica fino a pervenire alle ricerche specifiche e settoriali, non c’è motivo per accettare una simile discriminazione.
Quindi, dietro queste marginali manifestazioni di folclore e di reale stupidità, c’è un patrimonio culturale pronto ad agire che può alimentare forze tutt’altro che stupide e folcloristiche, forze capaci di trovare i giusti legami all’interno del sempre più frammentato schieramento politico attuale, specialmente in una situazione come quella italiana, per arrivare a incidere sulle decisioni del potere. La paura di un presente incerto può spingere larghe fasce di esclusi verso sistemi di pensiero capaci di dare sicurezza e ordine, o almeno di prometterli. Non dimentichiamo che i grandi movimenti di destra del passato sono stati movimenti a larghissima base popolare. Al loro interno il consenso era reperito prima di tutto in forza dell’enorme impatto psicologico causato dalla paura della fame e del disordine sociale. Solo dopo interveniva la repressione organizzata, e quasi sempre quest’ultima colpiva i riottosi e tutti coloro che cercavano altri modi per rispondere alle condizioni oggettivamente disastrose del sistema sociale.
Di più, la cultura di destra, dichiarata o strisciante, ha un contenuto fortemente unitario e coerente. Essa s’indirizza verso i principi di autorità, di ordine, di gerarchia, di subordinazione dell’individuo alla nazione, rivalutando i concetti di tradizione, di aristocrazia, di nobiltà. Singolarmente presi questi luoghi comuni possono far sorridere di sufficienza, ma nel loro insieme cementano un movimento di recupero che si pone in termini di omogeneità di fronte alla frammentazione e all’incertezza dei resti di quella che fu l’egemone cultura di sinistra. Il marxismo è andato in pensione, il liberalismo lo seguirà a ruota. La democrazia, come sistema di potere politico, abbisogna di un nuovo fondamento teorico e organizzativo. Niente lascia prevedere che questo problema venga risolto in tempi brevi. I sanguinosi sussulti che disegnano un’incerta mappa in varie zone del mondo, non sembrano indirizzati a risolversi nel segno della stabilità. Manca un coefficiente comune sufficientemente saldo, capace di indicare idee portanti in grado di promuovere una vera solidarietà fra gli esclusi, un reale internazionalismo, una risposta concreta ai tentativi maldestri di ristrutturazione e di reintegrazione del potere sulle profonde trasformazioni in corso.
La ragione ha svelato i suoi limiti organizzativi e le sue recondite intenzioni di dominio. Qualsiasi modello conoscitivo è rimasto infettato da un razionalismo che aveva il solo scopo di produrre verniciature per massacri e ruberie. Perso l’atteggiamento ideologizzante indiretto, mantiene il controllo di un altro atteggiamento, quello tecnico e diretto. La scienza, e il suo braccio tecnologico armato, organizzano il mondo e non forniscono giustificazioni plausibili ai costi che impongono all’uomo. La destra non le ha mai avute, ha sempre giustificato la tecnica e tutte le sue conseguenze. C’è un’ampia produzione teorica reazionaria, in senso dichiarato, che discute delle conseguenze e delle possibilità di sviluppo nel campo sociale delle scoperte scientifiche e delle applicazioni tecniche.
In questa traballante situazione sostiamo spesso incapaci di decidere cosa fare davanti ai poco simpatici skin, mentre una radicata estetica della discrezione non ci fa venire in mente niente di meglio di un sorriso sprezzante.
Che sia troppo poco?
[Pubblicato su “Anarchismo” n. 68, aprile 1992, pp. 7-9 col titolo “Cosa c’è dentro le teste rapate?”]
Tolleranza
Il razzisti e i naziskin picchiano e sprangano a tutto spiano. Negli ultimi giorni [gennaio 1995] si sono scatenati. A Latina un ragazzo polacco è stato aggredito e accoltellato. A Bari alcuni ragazzi usciti da una discoteca sono stati assaliti da fascisti e picchiati perché non hanno voluto gridare “Viva il duce”. A Torvajanica continuano i raid contro tutti coloro che lontanamente somigliano a un “marocchino”: la morte di Sara Folino, la ragazza investita da una macchina a bordo della quale sembra ci fossero alcuni extracomunitari, è all’origine della serie di atti d’intimidazione. “Giustizieri” in azione a Tor San Lorenzo, dove feriscono un nero con una fucilata. A Roma, un indiano, di professione lavavetri, è stato ricoverato all’ospedale a seguito di una coltellata ricevuta da tre teste rasate.
L’elenco non è completo e, forse, non necessita di essere completato. Gli aggressori si stanno moltiplicando, assistiti da una indifferenza e da un’attesa che torna utile solo a loro e alle ideologie di sopraffazione che sostengono. Hanno trovato in Italia una spinta indiretta, ma non per questo meno pregnante, nei recenti successi elettorali della destra [1994], ma più ancora hanno avuto coperture involontarie da tutte quelle componenti ideologiche perdenti che scoprono adesso di essere tolleranti, di aspirare a una democratica convivenza, al dialogo con tutte le parti in gioco.
Perfino i fascisti dichiarati, naturalmente non quelli nostalgici che pretendono stupidamente di sposare manganello e perbenismo, si dicono democratici e sostenitori delle minoranze, purché queste si comportino bene, lavorino e accettino un ruolo subordinato e marginale. Altrimenti, entrano in campo i picchiatori dichiarati, quelli che del bastone fanno una divisa, un metodo e uno stile di vita.
È ovvio che non possiamo continuare a discutere. Aspettare che il fenomeno dilaghi oltre misura è non solo pericoloso, ma stupido. A Berlino, un giovane aggredito da tre skinhead si è difeso uccidendone uno a coltellate e ferendo gli altri due. La tolleranza è un’ubbia come quella del buon governo. Non esiste possibilità alcuna di combattere la violenza dello Stato e dei suoi aggressori senza o in divisa, se non ricorrendo alla violenza delle nostre risposte. Baloccarsi in distinzioni ipotetiche, significa aspettare di essere attaccati, per poi difendersi, col risultato di restare senza sapere cosa fare, a disposizione delle velleità aggressive del primo bullo di quartiere.
Rispondere vuol dire comprendere il problema. Non considerare questi fatti come accadimenti accidentali, spesso determinati dal cattivo carattere del singolo, o di piccoli gruppi marginali e isolati. Il fenomeno ha consistenza quantitativa e qualitativa considerevole, è munito di progetto e di uomini adeguati a realizzarlo. Si propone come strumento attivo, disponibile a un semplice cenno della prima cosca di potere che voglia utilizzarlo in una prospettiva squadristica. In quanto tale, esso non percorre i sentieri del passato, non accetta le ideologie superate di una destra nostalgica e inebetita dai ricordi mal digeriti. Al contrario, naviga in acque culturali non sempre limpide, comunque sufficientemente alte per fornire giustificazione a miti sempre nuovi e fiorenti: quello della forza in primo luogo.
La tolleranza, anche questa volta come in altre occasioni, potrebbe renderci un cattivo servizio.
[Pubblicato su “Canenero” n. 10, 13 gennaio 1995, p. 2 col titolo “Morire di tolleranza”]
Totalità
Esistono diversi significati di totalità in quanto somma delle parti e un significato di totalità in quanto qualcosa di più della semplice somma delle parti.
Il concetto di “somma” è molto discutibile e presenta spesso delle ambiguità. Nella forma più elementare, cioè nella forma dell’aritmetica, esso viene indicato come concetto necessariamente vero. A esempio le due aree parziali in cui una diagonale divide un quadrato si dicono che sommate insieme diano l’area del quadrato. Questo enunciato viene, di regola, considerato “vero”. Ne I princìpi della matematica, (tr. it, Milano 1963, p. 648), B. Russell scrive: «Siano tre particelle A, B, C. Diciamo che B e C causano entrambe delle accelerazioni in A, e componiamo queste due accelerazioni con la legge del parallelogramma. Però questa composizione non è veramente un’addizione, poiché le componenti non sono parti della risultante; la risultante è un nuovo termine, altrettanto semplice quanto le sue componenti, e non è affatto la loro somma. Gli effetti attribuiti a B e a C non si producono dunque mai, ma si produce un terzo termine diverso tanto dall’uno quanto dall’altro. Possiamo dire che questo terzo termine è prodotto dalle due particelle B e C insieme, prese come un tutto. Ma possiamo scoprire l’effetto che esse producono come un tutto, soltanto supponendo che ciascuna produca un effetto separato: se non si facesse tale ipotesi, sarebbe impossibile ottenere le due accelerazioni la cui risultante è l’accelerazione effettiva. Sembra pertanto che si raggiunga un’antinomia: il tutto non ha altro effetto, salvo quello che risulta dagli effetti delle parti ma gli effetti delle parti sono non esistenti».
Questa tesi di Russell sembra volere provare che solo le parti spaziali di un tutto spaziale possono essere “sommate” insieme; mentre le forze non lo possono dando origine all’antinomia suddetta. E Nagel precisa che il problema di Russell risulta posto in modo errato: «Tutta questa argomentazione però mostra che per componente di una forza (o di un’accelerazione) noi non intendiamo niente di analogo a quello che intendiamo per componente o parte di una lunghezza – le componenti delle forze non sono parti spaziali delle forze. Questo non giustifica la tesi che l’addizione di forze “non è veramente un’addizione” a meno che la parola “addizione” venga in realtà usata così restrittivamente che nessuna operazione risulti così designata se non implica una giustapposizione di parti spaziali (o eventualmente temporali) del tutto che vien chiamato la loro somma». (E. Nagel, La struttura della scienza, tr. it., Milano 1968, p. 397).
La sorte del concetto filosofico di “somma”, equivalente a quello di “totalità” subisce spesso di questi errori di prospettiva, errori determinati dalla particolare posizione teorica di fondo di chi li commette. Su questo argomento scrive K. Kosik: «[...] i concetti centrali della filosofia, in cui vengono svelati gli aspetti essenziali della realtà, hanno uno strano destino. Essi non rimangono mai monopolio spirituale di quella sola filosofia che per prima se ne è servita e li ha motivati, ma diventano gradualmente proprietà comune. La diffusione o l’accettazione dei concetti, o il processo mediante il quale un concetto ottiene notorietà universale, segnano al tempo stesso la sua metamorfosi. Anche la categoria della totalità nel ventesimo secolo ha raggiunto un’ampia risonanza e notorietà, ma allo stesso tempo essa è continuamente esposta al pericolo di essere intesa unilateralmente o di trasformarsi addirittura nel suo opposto». (Dialettica del concreto, tr. it., Milano 1965, pp. 43-44).
I più noti significati di totalità in quanto somma delle parti sono: a) di tipo spaziale: singole porzioni di spazio, anche non contigue, in questo caso vengono sommate in una totalità: a esempio gli Stati europei costituenti la Comunità Europea; b) di tipo connesso con l’estensione spaziale: a esempio le singole cariche elettriche delle parti di un corpo costituiscono una somma di cariche elettriche; c) di tipo temporale: singole unità di tempo in cui è possibile suddividere un evento possono essere sommate nella totalità temporale dell’evento stesso; d) di tipo aggregativo: a esempio tutti gli iscritti a un sindacato in un dato momento; e) di tipo progressivo: l’insieme di singoli processi si svolge come totalità in un processo unico che riproduce le caratteristiche dei processi componenti; f) di tipo intrinseco: la totalità delle proprietà di un oggetto caratterizzano l’oggetto stesso, a esempio la moneta è malleabile, duttile, resistente, coniabile; g) di tipo sistematico: le singole parti della totalità stanno in una relazione dinamica tra di loro: a esempio due gas in un recipiente; h) di tipo organico: le singole parti stanno in relazione con la totalità come parti designate che svolgono una funzione specifica: a es. gli organi del corpo umano.
Come si è detto l’esempio biologico è fuorviante. Infatti le relazioni organiche tra le parti e il tutto sono assai simili a quelle di fenomeni non biologici come a esempio la produzione. Ogni singolo mezzo di produzione entra nell’equazione produttiva e vi svolge una funzione specifica. Scrive su questo argomento F. Jakubowski: «Il tutto non è la somma delle parti, ma le parti trovano il loro significato nella loro relazione al tutto, tramite la loro integrazione nella totalità. La categoria della totalità non sopprime tuttavia i momenti particolari, non diventa una unità indifferenziata nella quale i fenomeni concreti spariscono». (Le sovrastrutture ideologiche nella concezione materialistica della storia, tr. it., Milano 1975, p. 132).
Quello che abbiamo redatto è un elenco di significati che potrebbe continuare ma che interrompiamo perché ciò che interessa approfondire qui è il significato di totalità come qualcosa di più della semplice somma delle parti.
In questo senso con il concetto di totalità si indica una struttura di relazioni sia fra oggetti specifici che fra eventi, una struttura che subisce modificazioni a seguito delle modificazioni degli oggetti o degli eventi che la compongono e che essa stessa è motivo di modificazioni in questi oggetti o in questi eventi. Il fenomeno è studiato molto bene in alcuni problemi della fisica quantistica e atomica. Tra l’altro la teoria della complementarità di Bohr si pone il problema della totalità significativa. Ecco come viene trattato questo argomento dal fondatore stesso della meccanica quantistica, M. Planck: «Le due ipotesi sulla luce stanno oggi l’una di fronte all’altra come due combattenti di pari forza. Entrambe hanno un’arma ben affilata e un punto vulnerabile. Quale sarà l’esito del combattimento? Possiamo essere certi che non assisteremo al trionfo esclusivo di nessuna delle due ipotesi. La decisione non può consistere che nel contemplare da un punto di vista più alto e comprensivo ciò che v’è di giusto e ciò che v’è di unilaterale in ciascuna delle due ipotesi.
«Per trovare questo punto di vista dovremo, avvicinandoci meglio alla sorgente delle nostre esperienze, rivolgere la nostra attenzione ai processi che si verificano quando misuriamo i fenomeni ottici e trarre nel cerchio dei nostri esami anche gli strumenti di misura. È un passo di enorme importanza dottrinale, che può essere definito l’introduzione del concetto di totalità in fisica. Esso significa che per comprendere completamente le leggi di un fenomeno ottico non basta osservare i processi fisici nei luoghi dove la luce origina e si propaga, ma bisogna anche esaminare i caratteri del processo di misurazione, perché gli strumenti ottici di misura non sono soltanto ricevitori passivi che si limitano a registrare i raggi che li colpiscono, ma prendono parte attiva al processo di misurazione ed esplicano sul suo risultato un’influenza che forma un tutto unico col sistema fisico osservato». (La conoscenza del mondo fisico, tr. it., Torino 1943, p. 281).
A esempio, una melodia è il prodotto della totalità dei singoli suoni di singole note, ma essa, in quanto melodia, è qualcosa di più della semplice somma dei singoli suoni delle singole note. Non c’è dubbio che se non è possibile dire con esattezza cosa sia una specifica melodia in quanto somma delle singole note che la compongono, è sempre possibile specificare cosa sia il qualcosa in più, e come questo qualcosa sia identificabile, possa comunicare un contenuto, possa essere analizzato, rapportato, paragonato, valutato, ricordato, ecc.
Criticando questa tesi E. Nagel scrive: «È evidente che l’enunciato è informativo solo se esiste una cosa come la somma delle singole note di una melodia. Infatti si può decidere che l’enunciato è vero o falso solo se è possibile confrontare una tale somma con quel tutto che è la melodia. La maggior parte delle persone inclini ad asserire un tale enunciato, non precisano però che cosa vuol essere quella somma; si ha così una base per supporre che o essi non hanno chiaro quello che intendono dire o non intendono dire alcunché». (La struttura della scienza, op. cit., p. 398). Il fatto è che questa tesi non intende affermare che non esistono melodie musicali, come non potrebbe affermare che non esistono piatti preparati con le regole dell’arte culinaria solo perché ognuno di essi avrà un sapore che non potrà essere considerato la somma dei sapori dei singoli componenti che sono stati usati nella sua preparazione. Quello che Nagel vuole affermare è che qui si fa un uso errato del significato aritmetico della “somma”, con la qual cosa implicitamente prova che esistono significati diversi, tra cui il significato di totalità di cui ci occupiamo.
Ma il qualcosa in più riesce importante stabilire come abbia delle proprietà sue che non possono essere ricercate nelle singole note, e nemmeno in raggruppamenti parziali di note che pure possono essere identificati come sottoinsiemi o sottocomponenti della totalità. I teorici della “Psicologia della forma” hanno affrontato questo argomento, con particolare attenzione Kohler che sviluppa l’esempio del conduttore elettrico. Così Nagel illustra l’esempio di Kohler: «Consideriamo un conduttore elettrico ben isolato di forma arbitraria, per esempio, avente la forma di elissoide; e supponiamo di portare successivamente su di esso delle cariche elettriche. Le cariche si distribuiranno immediatamente da se stesse sopra la superficie del conduttore in modo tale che il potenziale elettrico risulterà il medesimo sopra tutta la superficie. La densità della carica (per es. la quantità di carica per unità di superficie) non sarà però in generale uniforme in tutti i punti della superficie. Così nel conduttore elissoidale la densità della carica sarà massima nei punti di curvatura massima e sarà minima nei punti di curvatura minima. In breve la distribuzione delle cariche mostrerà uno schema, od organizzazione, caratteristico – schema che dipende dalla forma del conduttore ma è indipendente dagli speciali materiali della sua costruzione o dalla quantità totale di carica immessa in esso.
«Non è possibile però costruire questo schema di distribuzione pezzo per pezzo, per esempio, portando delle cariche prima su una parte del conduttore poi su un’altra in modo che lo schema complessivo emerga solo dopo che tutte le cariche siano state disposte sul conduttore. Infatti quando viene immessa una carica su di una porzione della superficie, questa non si fermerà lì ma si distribuirà da sé nel modo indicato; e di conseguenza la densità di carica in un punto non è indipendente dalle densità negli altri punti. Similmente non è possibile rimuovere alcuna parte della carica da una porzione della superficie senza alterare le densità di carica negli altri punti. Per conseguenza sebbene la carica totale su un conduttore sia la somma di cariche parziali e separabili la configurazione delle densità di carica non può essere considerata come composta da parti indipendenti». (Ib., p. 402).
Un esempio chiarirà meglio: pur essendo la massa di un corpo uguale alla totalità delle masse delle sue parti separate, il corpo ha proprietà sue che non sono la totalità delle proprietà delle singole parti. Ciò si spiega col fatto che la totalità come sistema organizzato di più parti in relazione fra di loro si presenta come un tutto dinamico avente sue proprietà. Sarebbe un esempio banale ricordare il corpo umano, e anche un esempio fuorviante. Ragionando sul concetto di associazione come appare nel campo sociale, i positivisti ne ricavavano una probabile estensione anche al campo naturale e biologico, che avevano cura di mantenere separato. I loro sviluppi analogici caso mai prevedevano un impiego delle regole del metodo scientifico anche in campo sociale perché quelle regole erano considerate sufficientemente fondate e quindi vere. Scrive E. Durkheim: «[...] nelle cellule [le] molecole sono associate, e proprio questa associazione è la causa dei nuovi fenomeni che caratterizzano la vita (nei confronti della materia bruta), e di cui non è possibile trovare neppure il germe in nessuno degli elementi associati. Un tutto non è identico alla somma delle sue parti, ma è qualcosa d’altro, le cui proprietà differiscono da quelle che presentano le parti dalle quali è composto. L’associazione non è – come si è talvolta ritenuto – un fenomeno per se stesso infecondo, che consisterebbe semplicemente nel porre in rapporti esteriori certi fatti acquisiti e certe proprietà costituite. Al contrario, essa costituisce la fonte di tutte le novità che si sono successivamente prodotte nel corso dell’evoluzione generale delle cose [...]. In virtù di questo principio, la società non è una semplice somma di individui; al contrario, il sistema formato dalla loro associazione rappresenta una realtà specifica dotata di caratteri propri». (Le regole del metodo sociologico, tr. it., Milano 1963, pp. 100-101).
Il limite di questa interpretazione della totalità è dato dal fatto che essa coglie sì il qualcosa che emerge come di più nella somma di singoli elementi, ma identifica questo qualcosa come elemento a se stante e non come elemento collegato alla totalità stessa, anzi come elemento prodotto dal processo di autocreazione della totalità. Per i positivisti la società è sempre una cosa derivata dall’azione degli individui che, a un certo momento si solidifica e finisce per vivere una vita propria, di genere diverso della vita tipica degli individui che l’hanno determinata. La società diventa appunto un organismo vivente con caratteristiche simili alla vita biologica e si differenzia dalle strutture inorganiche come le cellule della vita si differenziano dalle cellule della materia inanimata.
Un altro esempio è quello della cultura come sistema armoniosamente e interamente organico all’interno del quale i diversi elementi sono posti in una rete di interrelazioni sistematiche non facilmente coglibili ma non per questo negabili. L’analisi tipica di questo modo di considerare la cultura è quella che P. A. Sorokin conduce nell’opera La dinamica sociale e culturale (tr. it., Torino 1975, p. 97) dove la cultura viene considerata come «un tutto integrato, in cui nessuna parte essenziale è accidentale e ciascuna è organicamente connessa al resto [...]». E più avanti, lo stesso autore: «Ogni agglomerazione culturale può essere collocata teoricamente su un continuum che va dagli aggregati meramente spaziali, che non sono integrati nel senso proprio della parola, sino a quelli che sono integrati logicamente in modo completo». (Ib., p. 119).
Un altro esempio è dato dal processo di produzione che rende possibili risultati che non sarebbero raggiungibili con la semplice somma delle singole operazioni in cui si può suddividere il processo. A esempio cento operai possono produrre insieme molto di più di quanto non produrrebbero isolatamente. L’esempio classico è quello illustrato da A. Smith per la fabbricadegli spilli: «Un operaio non addestrato a questa manifattura (che la divisione del lavoro ha fatto un mestiere speciale), e che non conosca l’uso delle macchine che vi s’impiegano (l’invenzione delle quali è stata probabilmente originata dalla stessa divisione del lavoro) potrà a malapena, applicandosi al massimo, fabbricare un solo spillo al giorno, e certamente non ne potrà fabbricare venti. Ma nel modo in cui si esegue ora tale fabbricazione, non soltanto essa è un mestiere speciale, ma si divide in molti rami, la maggior parte dei quali è analogamente un mestiere speciale. Un uomo tira il filo del metallo, un altro lo tende, un terzo lo taglia, un quarto lo appunta, un quinto lo arrota all’estremità in cui deve farsi la testa [...]. Ho visto una piccola fabbrica di questo genere che occupava dieci uomini [...]. Quelle dieci persone potevano dunque fabbricare assieme oltre quarantottomila spilli al giorno. Si può dunque ritenere che ciascuno di loro, facendo una decima parte di quarantottomila spilli, ne fabbricasse quattromilaottocento al giorno». (Ricerche sopra la natura e le cause della ricchezza delle nazioni, tr. it., Torino 1958, pp. 9-10).
Ma il capitale non ha avuto problemi a impadronirsi non soltanto del prodotto delle singole parti dello strumento produttivo “mano d’opera”, ma anche del prodotto di quel qualcosa in più che emerge dalla somma delle singole parti. La legittimità logica per fare questo è venuta al capitale dal fatto che il qualcosa in più non è altro che una produzione della capacità di autocreazione della totalità e non qualcosa di separato dalle singole parti che entrano nella somma. In caso contrario l’espropriazione del valore prodotto sarebbe avvenuta con due operazioni separate: una relativa all’espropriazione del valore prodotto dalle singole parti, e una relativa all’espropriazione del valore prodotto dalla somma delle singole parti. Il capitalismo stesso nasce e si sviluppa sulla possibilità di sfruttare quel qualcosa in più.
Questo significato del concetto di totalità come qualcosa in più della semplice somma è il più produttivo di conseguenze dal punto di vista dell’analisi sociale. La posizione che consideriamo definibile come posizione dal punto di vista della totalità considera la realtà (e quindi la totalità stessa) come un tutto strutturato in corso di svolgimento fondato su di un meccanismo di autocreazione. Si tratta di una posizione che nega validità all’insieme dei fatti in quanto tale, cioè non considera la realtà come la totalità dei fatti. Questa differenziazione è importante per capire il concetto di attingibilità che svilupperemo più avanti quando parleremo della totalità come anarchia. Chi considera la totalità come “totalità di tutti i fatti”, afferma giustamente che “tutti i fatti” non sono mai interamente conoscibili, quindi svaluta il concetto di totalità e lo considera una inutile questione metafisica. Ma in effetti quando parliamo di totalità non possiamo intendere la totalità dei fatti ma un insieme di azioni e di fatti (insieme strutturato) che rende possibile la comprensione di ogni singolo fatto, azione, evento, ecc. I fatti (e l’agire coatto e gli eventi, ma non l’azione vera e propria) possono venire elencati, ma restano estranei alla comprensione, cioè alla conoscenza, finché non vengono inseriti in una totalità strutturata che riesce a strapparli a una loro fissità immobile, rendendoli dinamici, produttivi di modificazione, vivi. Su questo argomento scrive K. Kosik: «Il concreto e cioè la totalità non sono pertanto tutti i fatti, il complesso dei fatti, il raggruppamento di tutti gli aspetti, delle cose e dei rapporti, giacché in tale raggruppamento manca ancora l’essenziale: la totalità e la concretezza. Senza la comprensione del fatto che la realtà è totalità concreta, la quale diventa struttura significativa per ogni fatto o complesso di fatti, la conoscenza della realtà concreta resta soltanto una mistica o l’inconoscibile cosa in sé». (Dialettica del concreto, op. cit., p. 46).
Come pensare la totalità? Per chi si pone a riflettere su di un determinato fenomeno sociale diventa indispensabile che riesca a porsi dal punto di vista della totalità. Questo porsi dal punto di vista della totalità è compito specifico dell’individuo, è la sua dichiarazione di guerra metodologica contro la realtà che gli si nega. Ma da sola, in quanto semplice dichiarazione, non è sufficiente. Occorre che il singolo abbia veramente l’intenzione di impegnarsi totalmente, che non mantenga, dentro di sé, le riserve mentali tipiche della doppia morale gesuitica. La persistenza di un mondo lacerato e di una coscienza lacerata determinano la trasformazione del punto di vista della totalità in banale esercitazione metafisica, spesso in utile appagamento della propria falsa coscienza, ma nulla di più. Scrive L. Sebag, autore lacerato tra marxismo e strutturalismo, morto suicida a trentun anni: «Pensare il Tutto è sempre oltre la portata dell’analisi scientifica; e ciò per due motivi fondamentali: da una parte, perché ogni “unità” quale che sia la sua natura, può essere compresa solo se integrata in un sistema più vasto di cui essa diviene un elemento, in quanto tale sistema richiede esso stesso d’esser trattato nel medesimo modo; il tutto autentico non sarà allora nient’altro che l’ultimo sistema che include in sé tutti i sotto-sistemi, e che non può esser pensato sino in fondo; dall’altra, perché oggetto scientifico e attività scientifica sono omogenei l’uno all’altra, e perché tale attività, anche quando combina e ricostituisce, è sempre analitica, giacché lavora su variabili che ha in precedenza isolato [...]. La validità del metodo impiegato non dipende, dunque, in primo luogo, dai risultati che esso consente di ottenere, ma dalle condizioni d’esistenza che sono quelle dell’uomo che è in rapporto con la totalità.
«“Pensare il Tutto” è in realtà una formula priva di senso, se l’uomo è incapace di prendere su di sé la verità di questo tutto, se la società esplode in frammenti disparati ed eterogenei, in mondi contraddittori il cui senso si rivela solo parzialmente ai suoi membri». (Marxismo e strutturalismo, tr. it., Milano 1972, p. 54).
Chi riflette quindi dal punto di vista della totalità deve evitare di cadere nel settorialismo metodologico che lo porta a isolare il fenomeno per coglierne tutti i dettagli. Spesso questo modo di procedere si veste degli abiti allettanti del paternalismo socialdemocratico, e suggerisce la modesta ma costruttiva funzione dell’acquisizione progressiva della verità. Il settorialismo metodologico procede dalle premesse di una massima modestia e circospezione a pretese conclusive di grande arroganza. Per questo modo di vedere il mondo il punto di partenza di ogni indagine è sempre il problema. Non sempre questo problema può dirsi risolvibile, ma sempre, se le osservazioni e le interpretazioni sono state sottoposte a un corretto metodo di controllo, i risultati saranno positivi (tesi socialdemocratica del neopositivismo sociale). Una delle esposizioni più chiare è quella fornita da Karl Popper riguardo il metodo delle scienze sociali e riassunta dall’autore in sei punti: «a) Il metodo delle scienze sociali, come anche quello delle scienze naturali, consiste nella sperimentazione di tentativi di soluzione per i suoi problemi – i problemi da cui prende le mosse. Si propongono e criticano soluzioni. Se un tentativo di soluzione non è accessibile alla critica oggettiva, viene scartato appunto per questo come non scientifico, anche se, forse, solo provvisoriamente. b) Se esso è accessibile a una critica oggettiva, cerchiamo di confutarlo; poiché ogni critica consiste di tentativi di confutazione. c) Se un tentativo di soluzione è confutato dalla nostra critica, proviamo con un altro. d) Se resiste alla nostra critica, lo accettiamo provvisoriamente; lo accettiamo soprattutto come degno di essere ulteriormente discusso o criticato. e) Il metodo della scienza è dunque quello del tentativo (o idea) di soluzione, che viene controllato dalla critica più severa. È una prosecuzione critica del procedimento per tentativi ed errori (“trial and error”). f) La cosiddetta oggettività della scienza consiste nell’oggettività del metodo critico; ma ciò significa, anzitutto, che nessuna teoria si può sottrarre alla critica, e anche che gli strumenti logici della critica (la categoria della contraddizione logica) sono oggettivi». (La logica delle scienze sociali, in AA.VV., Dialettica e positivismo in sociologia, tr. it., Torino 1972, pp. 107-108).
Niente di più sbagliato, si tratta dell’altra faccia della medaglia della tirannia ideologica di chi vuole imporci tutta in una volta una verità di Stato. Che la cattiva totalità dell’empirismo metodologico cominci con poco per pretendere tutto, è fatto che tutti comprendono. Applicando la regola socialdemocratica del “cerca l’errore e correggilo”, si ha la costruzione della migliore dittatura oppressiva dal punto di vista funzionale. Tutti sono convinti di vivere in un regime di libertà e solo alcuni si accorgono di quanto incida su tutti l’oppressione del permissivismo socialdemocratico. Partendo dal presupposto che l’errore può sempre essere cercato e corretto si pretende una conoscenza praticamente assoluta delle possibilità operative dell’uomo, quando, al contrario, il punto di vista della totalità, proprio perché parte subito dal complesso, si avvicina al semplice non con la mentalità quantitativa di chi si vuole mettere il mondo in tasca, ma con la mentalità qualitativa di chi vuole comprendere il mondo (e il parziale racchiude di già “tutto il mondo”) per trasformarlo. In questo senso scrive J. Habermas (che però cade poi nell’equivoco del meccanismo dialettico): «Nel quadro di una teoria empiristica rigorosa il concetto di sistema può solo indicare, formalmente, la connessione interdipendente di funzioni che sono a loro volta interpretate a esempio come rapporti fra variabili del comportamento sociale. Lo stesso concetto di sistema resta altrettanto estraneo al campo di esperienza analizzato quanto lo sono le proposizioni teoretiche che lo spiegano. Le prescrizioni per i procedimenti analitico-empirici contengono, accanto alle regole logico-formali per la costruzione di un complesso deduttivo di proposizioni ipotetiche (e cioè di un calcolo empiricamente utilizzabile), solo ed esclusivamente l’istanza di scegliere le assunzioni fondamentali semplificate in modo che esse consentano la deduzione di ipotesi nomologiche che abbiano empiricamente un senso [...]. Le teorie [per l’empirismo] sono schemi ordinatori che costruiamo liberamente entro una cornice sintatticamente vincolante. Mostrano di poter essere utilizzate per un certo particolare campo di oggetti, quando la molteplicità reale si accorda con esse. Perciò la teoria analitica della scienza può ben insistere sul programma della scienza unificata: una coincidenza fattuale delle leggi ipotetiche dedotte con uniformità empiriche è per principio accidentale, e resta come tale estranea alla teoria. Ogni riflessione che non si limiti a questo è considerata illegittima». (Epistemologia analitica e dialettica, in AA.VV., Dialettica e positivismo in sociologia, op. cit., pp. 154-155).
La conoscenza è sempre lotta contro la realtà perché questa si pieghi agli strumenti di indagine e piegandosi dispieghi i suoi segreti. Ma ciò non sarà possibile partendo da una visione provinciale. Pensando la realtà dal punto di vista della totalità le cose si trasformano profondamente. Ci si innalza così a un livello diverso della semplice analisi scientifica. L’analisi scientifica diventa in questo modo non un semplice “rispecchiamento” dei fatti ma una loro decodificazione. Nel disvelamento della realtà si ha un processo di impadronimento teorico che trova il suo corrispettivo in un processo di trasformazione pratica. Abbiamo pertanto che un singolo fatto (o fare coatto o evento) può contenere da un minimo di realtà corrispondente al fatto bruto che resta chiuso in se stesso e quindi inesplicato; a un massimo di realtà, cioè un quantitativo di realtà maggiore del semplice fatto (o fare che si trasforma in azione o evento) e ciò a seguito del processo di decodificazione. Il metodo scientifico risiede quindi proprio nella decodificazione della realtà attraverso la totalità; la rappresentazione della realtà attraverso il metodo empirico non può considerarsi che un vero e proprio metodo prescientifico o comunque come metodo scientifico di prima approssimazione: prepara i dati bruti ma non vi fa entrare dentro la realtà, li imbalsama e li fa tacere. Solo il punto di vista della totalità obbliga i fatti a parlare e a dirci quanta realtà la nostra decodificazione è stata capace di disvelare attraverso di loro.
Ora la raccolta bruta dei fatti può dare l’illusione della completezza, in quanto mira a costruire una elencazione, una classificazione, un miraggio tassonomico che si traduce in una cattiva totalità. Infatti questo metodo di analisi prescientifica non possiede un metro valutativo in grado di dare ordine ai fatti nel senso della loro essenzialità, per questo metro, al limite tutti i fatti sono uguali: tra il fare coatto e l’agire questo metodo non riesce a vedere la differenza. Ma la stessa esistenza della realtà dipende dalla possibilità o meno di mettere da parte i fatti non essenziali, pena il restare soffocati, pena la trasformazione dell’azione in banale fare coatto.
Pensiamo a un avvenimento storico: poniamo i giorni della Comune di Parigi. In così breve lasso di tempo furono accumulati un numero incredibile di fatti, come, per altro, ogni giorno se ne accumulano in tutto il mondo. A volerli elencare tutti non si concluderebbe mai nulla: in nome di una cattiva totalità si pretenderebbe sempre di andare alla ricerca della totalità uccidendo qualsiasi conclusione e qualsiasi utilità della ricerca stessa, non considerando il fatto di per sé evidente che simile proposizione è impossibile in partenza. Già il fatto stesso di circoscrivere i fatti alla città di Parigi subito dopo il conflitto franco-prussiano è un’operazione di separazione finalizzata a dare un senso alla propria ricerca. Ma occorre fare di più. Ogni singolo fatto non può essere lasciato a se stesso, ma deve contenere la sua realtà, e questa realtà non è fissata in partenza, in quanto non è una caratteristica ineliminabile del fatto, ma viene inserita nel fatto, viene fatta entrare nel fatto, ponendosi dal punto di vista della totalità. Ogni singolo fatto diventa pertanto la Comune di Parigi, non un fatto della Comune di Parigi, ma la Comune di Parigi nella sua totalità, e non la totalità della Comune di Parigi come fatto separato dagli altri fatti contemporanei, ma la Comune di Parigi nel senso che ha per coloro che lottano oggi, e non solo per una parte di loro ma per tutti in tutte le manifestazioni della loro vita.
Ogni fenomeno viene così inserito in un sistema più vasto di cui è semplice elemento, ma questo sistema più vasto sarà a sua volta semplice elemento di un ulteriore sistema più vasto in cui risulta inserito. La totalità non sarà altro allora che l’ultimo sistema, quello più vasto possibile, che raccoglie tutti gli altri sottosistemi.
Certo che posta in questi termini la formula: pensare la totalità diventa un banale rinvio all’infinito, una “cattiva totalità”. Sulla cattiva totalità T. Perlini ha scritto: «[...] la totalità (cattiva) si pone come il prodotto di una razionalità che si è alienata dall’uomo a tal punto che l’uomo stesso viene da essa espulso come irrazionalità irrilevante. Ciò comporta una formalizzazione dei rapporti umani. La formalizzazione riduce ogni aspetto del reale a mero dato manipolabile. Dai termini rapportati fra di loro viene espunto ciò che concretamente li caratterizza, che è loro specifico. Il dato viene privato del suo substrato materiale. Ne deriva una esasperata dicotomia, una vera e propria scissione di forma e materia [...]. Le progettazioni dei singoli soggetti non trovano più un limite nelle progettazioni altrui, non si danno più contraddizioni tra diverse finalità, tra sforzi fra di loro contrastanti di totalizzazione, non si dà nemmeno più il subire la storia da parte di chi è impedito (a farla) da altri che pretendono di avere il diritto di farla per lui [...]. Non più: ora il progettare viene reso irrilevante da una forza trascendente. La storia, non la fa più nessuno: essa è il risultato (indiretto e, in definitiva, causale) di un insieme di volontà che fra di loro non si riconoscono [...]». (Utopia e prospettiva in György Lukács, Bari 1968, p. 357).
Invece l’importanza del modo di pensare il tutto risiede nel dare una dimensione finita al particolare. È così che il punto di vista della totalità consente la decodificazione, il disvelamento. Ciò che trattiene l’empirista dal procedere in questo, tra le altre cose, è la paura, profondamente radicata, che la realtà nascosta sia disordinata, negatrice di quell’ordine che le sue classificazioni vogliono a qualsiasi costo salvare. Fuori dal mondo della ripetitività l’empirista entra in crisi. Scrive T. W. Adorno: «La totalità non è una categoria affermativa, ma critica. La critica dialettica cerca di aiutare a salvare o a produrre ciò che non appartiene alla totalità, che le si oppone, oppure, come potenziale di un’individuazione che non esiste ancora, si sta solo formando. L’interpretazione dei fatti guida alla totalità, senza che questa sia essa stessa un fatto. Non vi è nessun fatto sociale che non abbia il suo posto e il suo significato in quella totalità. Essa è preordinata a tutti i singoli soggetti, poiché questi anche in se stessi ubbidiscono alla sua pressione, e rappresentano la totalità nella loro stessa costituzione monadologica, anzi, soprattutto in essa. In questo senso la totalità è l’essere supremamente reale». (Introduzione a AA.VV., Dialettica e positivismo in sociologia, op. cit., p. 21).
E ciò senza chiudere il “tutto” in un confine settoriale che con la scusa di delimitarlo lo smarrisce nell’infinito concreto del ripetitivo e del sempre uguale. Questa chiusura è identificata da J. Habermas: «L’empirismo, come la critica tradizionale della conoscenza in genere, fa il tentativo di giustificare la validità del sapere rigoroso facendo ricorso alle fonti del sapere stesso. Tuttavia alle fonti del sapere, al puro pensiero e alla tradizione così come all’esperienza sensibile, manca l’autorità. Nessuna di queste forme può pretendere di avere evidenza immediata e validità originaria, né, quindi, forza di legittimazione. Le fonti del sapere sono sempre già intorbidate, l’accesso alle origini ci è precluso. È perciò che il problema dell’origine della conoscenza deve essere sostituito da quello della sua validità. La richiesta di verificare le asserzioni scientifiche è autoritaria, perché fa dipendere la validità delle asserzioni dalla falsa autorità dei sensi». (Sul razionalismo dimezzato dei positivisti, in AA.VV., Dialettica e positivismo in sociologia, op. cit., pp. 233-234).
Il vero infinito negativo non è il ricorso alla totalità, ma il ricorso alla parzialità che è un modo per uccidere la specificità e la personalità nella produzione in serie e nella standardizzazione del pensiero. Un’interpretazione fuorviante del concetto di totalità è quella che viene sviluppata dalla sociologia della conoscenza. La totalità viene rivissuta come semplice generalizzazione, mentre la parzialità che si contrappone viene data come formalizzazione. Scrive Karl Mannheim: «Generalizzazione e formalizzazione sono, a nostro avviso, un legittimo procedimento “tecnicistico” del pensiero, e in quanto tale utile anche nella sociologia, perché si possono usare per superare e dominare la molteplicità». (Sociologia della conoscenza, tr. it., Bari 1974, p. 181).
Possiamo pensare la totalità come un processo dal settoriale al totale, senza per questo annegare tutto nell’infinitamente piccolo o nell’infinitamente grande. Se nella decodificazione del fatto (e quindi nella trasformazione del fare coatto in azione) facciamo penetrare la realtà all’interno del fatto stesso, per cui diciamo che lo consideriamo dal punto di vista della totalità, non per questo lo anneghiamo in un processo all’infinito (cattivo processo). Ciò è possibile perché la totalità si può cogliere contemporaneamente alla decodificazione del fatto perché essa non si pone come un semplice fatto più grande dentro cui annegare il fatto più piccolo. Noi stessi, il fatto e la totalità riconfermiamo un’origine comune, un senso comune, un comune processo. Il significato decodificato del fatto non è più specifico del fatto nel suo isolamento, ma appartiene a noi, al fatto e alla totalità: il futuro punto di vista della totalità, dopo la decodificazione del più semplice dei fatti non sarà mai più lo stesso, proprio perché diversamente attingibile a seguito della decodificazione che si è verificata, la quale, in questo senso, diventa decodificazione della totalità nel momento in cui è decodificazione del fatto singolo.
Nel suo tentativo di ridare fondamento al negativo, mantenendo però il meccanismo dialettico che minaccia di diventare asfissiante sotto la dittatura del positivo, Adorno scriveva: «L’individuo diventa soggetto nella misura in cui si oggettiva per mezzo della sua coscienza individuale, nell’unità di se stesso e delle proprie esperienze: a quanto pare gli animali non possono avere né l’una né l’altra. Poiché è in sé universale, e per quanto lo è, l’esperienza individuale raggiunge anche l’universale. Perfino nella riflessione gnoseologica l’universalità logica e l’unità della coscienza individuale si condizionano reciprocamente. Ciò non riguarda però solo il lato soggettivo-formale dell’individualità. La coscienza individuale riceve ogni contenuto dal suo portatore, per la sua autoconservazione, e si riproduce con essa. La coscienza individuale riesce a liberarsene, ad ampliarsi tramite autoriflessione. A ciò la spinge il tormento per cui ogni universalità ha la tendenza ad acquistare il predominio nell’esperienza individuale». (Dialettica negativa, tr. it. Torino 1970, pp. 40-41).
La realtà è la totalità. La realtà è totalità di ciò che esiste. Fare una distinzione tra realtà oggettiva e realtà soggettiva non ha senso dal punto di vista della totalità; non perché la realtà in quanto totalità è nello stesso tempo oggettiva e soggettiva; ma perché quando essa è realtà soggettiva lo è in termini di totalità, quindi comprendendo anche l’aspetto oggettivo; e quando essa è realtà oggettiva lo è in termini di totalità, quindi comprendendo anche l’aspetto soggettivo.
La cattiva totalità pur presentando la realtà come l’insieme dei fatti, quindi come una totalità, la pone come un oggetto accanto agli altri oggetti, oggetto verso cui si indirizzano gli sforzi della classificazione. La vera totalità, al contrario, coglie la realtà nel suo aspetto complessivo, cioè dal punto di vista della totalità, quindi non come un oggetto accanto agli altri oggetti, ma come uno svolgimento in cui ogni momento comprende l’oggetto sotto la forma del soggetto e il soggetto sotto la forma dell’oggetto. Se mi rivolgo verso la realtà devo presupporre non solo la mia soggettività, ma anche ciò che la realtà significa per la mia soggettività; e se mi rivolgo a me stesso devo considerarmi non solo per ciò che la mia soggettività significa per me, ma per ciò che l’oggettività della realtà significa per me attraverso la mia soggettività.
Noi conosciamo la realtà solo come parzialità, ma nella parzialità dobbiamo ricomporre non l’immagine ma la vera e propria totalità, perché in caso contrario la parzialità reale ci sfugge, ritrovandoci nelle mani solo il simbolo commercializzato della parzialità, così come ce lo impone il potere. Tra i dialettici migliori questa preoccupazione è molto evidente. In Adorno assume livelli veramente tragici e lirici. Egli scrive: «Chi si piega alla disciplina dialettica deve certamente pagare un amaro tributo in termini di molteplicità qualitativa dell’esperienza. L’impoverimento dell’esperienza a opera della dialettica, di cui si scandalizzano le opinioni ragionevoli e sensate, si rivela tuttavia nel mondo amministrato adeguato alla sua astratta monotonia. Ciò che vi è di doloroso nella dialettica è il dolore su quel mondo, elevato a concetto. A esso deve piegarsi la conoscenza se non vuole degradare la concretezza ancora una volta a ideologia, come comincia veramente a diventare». (Ib., p. 6).
Esistono due cattive totalità: la totalità metodologica e la totalità dialettica.
I borghesi liberali e socialdemocratici si sono perfettamente resi conto dell’equazione totalità = realtà. La tesi positivista è bene approfondita da Durkheim: «La vita è nel tutto, non nelle parti [...]. È possibile [...] spiegare i fenomeni che si producono nel tutto in base alle proprietà caratteristiche del tutto, il complesso in base al complesso, i fatti sociali in base alla società, i fatti vitali e mentali in base alle combinazioni sui generis da cui risultano: questo è il solo cammino che la scienza possa seguire. Ciò non vuol dire che tra questi diversi stadi del reale vi sia soluzione di continuità. Il tutto si forma soltanto in virtù del raggruppamento delle parti, e questo raggruppamento non avviene in un istante, per un repentino miracolo; c’è una serie infinita di intermediari tra lo stato di isolamento puro e lo stato di associazione caratterizzata. Ma l’associazione, a misura che si costituisce, dà origine a fenomeni che non derivano direttamente dalla natura degli elementi associati; e questa parziale indipendenza è tanto più accentuata quanto più numerosi e più fortemente sintetizzati sono questi elementi. In ciò risiede senza dubbio l’origine, la duttilità, della flessibilità e della contingenza che le forme superiori del reale manifestano nei confronti delle forme inferiori, pur avendo le loro radici in seno a esse». (E. Durkheim, Sociologia e filosofia, tr. it., Milano 1963, p. 160).
Partendo da queste considerazioni i pensatori socialdemocratici ne hanno dedotto che la loro interpretazione della realtà doveva pur salvare il principio empirico della parcellizzazione, senza cui non sarebbe più stato possibile applicare il metodo dell’errore e dell’aggiustamento, ma non doveva cadere nell’equivoco dell’aritmetizzazione della realtà. Così un positivista moderno, il popperiano H. Albert: «La metodologia delle scienze reali teoriche mira anzitutto a cogliere leggi, connessioni regolari, a formulare ipotesi informative sulla struttura della realtà e quindi di ciò che effettivamente accade. I controlli empirici e, in connessione con essi, le prognosi, vengono fatti per provare se le connessioni sono tali quali le supponiamo –, dove il nostro “sapere precedente” può essere certamente messo in questione. Svolge qui una parte importante l’idea che noi abbiamo la possibilità di imparare dai nostri errori, esponendo le teorie al rischio di fallire alla prova dei fatti. Gli interventi nell’accadere reale possono servire a produrre situazioni che rendono questo rischio relativamente grande. I successi tecnici che si realizzano in connessione con la ricerca possono essere spiegati col fatto che ci si è parzialmente avvicinati alle connessioni reali». (Il mito della ragione totale, in AA.VV., Dialettica e positivismo in sociologia, op. cit., pp. 197-198).
La soluzione è stata offerta dalla logica del modello. La totalità viene vista come una esigenza metodologica di interpretazione della realtà. Ogni fenomeno viene rapportato a una totalità più ampia possibile di altri fenomeni, e viene anche preso in considerazione il fatto che possono esistere effetti simili al qualcosa in più non strettamente prevedibile nella parcellizzazione, ma niente di più.
Questo modo di procedere è quello tipico della sociologia della conoscenza. Così riassume questa posizione Mannheim: «Il problema di una sociologia della conoscenza nacque quindi dalla collaborazione di quattro fattori: a) dall’auto-relativizzazione del pensiero e della conoscenza; b) dall’emergere di un nuovo sistema di relazione, cioè quello della sfera sociale, partendo dal quale e rispetto al quale il pensiero poteva essere relativizzato; c) dal nascere di una nuova forma di relativizzazione effettuatasi con l’apparizione della “coscienza che smaschera” e d) dall’aspirazione alla totalità di una tale relativizzazione per cui non un pensiero, non una “idea”, ma un intero sistema di pensiero fu messo in relazione con l’essere sociale che lo sostiene». (Sociologia della conoscenza, op. cit., p. 164).
Il ragionamento relativo al rapporto tra il particolare e la totalità viene presentato come un modello della realtà. Scrive Kosik: «Le correnti idealistiche del ventesimo secolo liquidarono la tridimensionalità della totalità come principio metodologico riducendola essenzialmente a una sola dimensione, al rapporto della parte con l’intero, e soprattutto disgiunsero radicalmente la totalità come esigenza metodologica e principio epistemologico della conoscenza della realtà dalla concezione materialistica della realtà come totalità concreta. Per una simile disgiunzione la totalità come principio metodologico ha perso la sua motivazione e coerenza, il che ha immediatamente condotto alla sua interpretazione idealistica e all’impoverimento del suo contenuto». (Dialettica del concreto, op. cit., pp. 44-45).
Il modello in questione può sempre essere modificato, migliorato, perfezionato. La cosa appare perfettamente ragionevole e si adatta alla logica socialdemocratica di fondo. In generale, per quanto concerne la posizione degli empiristi riguardo il problema della società e dello scontro di classe, c’è da dire che essi sono tutti allineati su una linea socialdemocratica. La società che loro vogliono costruire è quella della discussione e del dialogo, una società in cui sia possibile dibattere i problemi liberamente, ma dentro certi limiti, una società in cui sia bandito il dogmatico e il totalitarismo, ma purché si abbia sempre un centro di coordinazione e di guida al comando. I liberali avevano sostenuto che le stesse regole della logica imponevano una società organizzata dal centro, pianificata e autoritaria. Gli empiristi, al contrario, hanno dimostrato l’illogicità di queste affermazioni, in quanto una società autoritaria si basa su di un concetto superato di scienza. Per loro anche la democrazia non può considerarsi un bene in assoluto, ma deve considerarsi come un male minore. Sotto il profilo logico la democrazia, come ogni altra teoria della sovranità, è vittima del paradosso derivante dall’impossibilità di una libera accettazione da parte di tutti i sudditi. Anche il concetto di Stato per loro rientra nella categoria del “male minore”. Partendo dal concetto del governo (e dello Stato) come “male necessario”, Popper sviluppa la tesi dei controlli e dei freni all’attività del governo; tesi che poi sarebbe il corrispettivo dell’ipotesi metodologica delle prove e dell’individuazione degli errori. Egli scrive: «La mia concezione è che ogni teoria della sovranità trascura di affrontare una più fondamentale questione – la questione, cioè, di sapere se non dobbiamo sforzarci di realizzare il controllo istituzionale dei governanti bilanciando i loro poteri mediante la contrapposizione di altri poteri. Questa teoria dei freni e dei contrappesi può almeno pretendere un’attenta considerazione». (La società aperta e i suoi nemici, vol. I, tr. it., Roma 1974, p. 176). E altrove, con maggiore puntualità: «Ciò che importa, per essere precisi, non è tanto chi governa, ma in che modo coloro che governano possono essere influenzati e controllati». (H. Marcuse, K. Popper, Rivoluzione o riforme? Interviste, tr. it., Roma 1977, p. 40). Si tratta di una pericolosissima posizione tecnocratica. Il governo ai più preparati. La peggiore delle tirannie. Alla domanda “Chi deve governare?”, gli empiristi logici, nemici dichiarati della totalità, assertori del metodo “sbaglia e correggiti”, rispondono: Non bisogna chiedersi chi deve governare, ma: «Come possiamo organizzare le istituzioni politiche in modo da impedire che i governanti cattivi o incompetenti non facciano troppo danno?». (K. Popper, La società aperta e i suoi nemici, op. cit., vol. I, p. 174).
Coloro che hanno paura del metodo che si pone dal punto di vista della totalità, e che in nome di un malinteso programma realistico affermano la necessità di partire dal singolo dato, dal controllo del fatto, dalla certezza di quanto accade sotto i nostri occhi; coloro che hanno paura di ogni analisi diretta alla decodificazione della realtà e che preferiscono affidarsi al dato bruto come viene fornito dalle nostre immediate capacità di rilevamento; facciano attenzione a quanta strategia di dominio si nasconde dietro la proposta saggiamente riformista degli empiristi. La loro richiesta si presenta in forma quanto mai innocente: in fondo è la sola che consenta di correggere gli errori dei governanti, errori che vengono collocati sullo stesso piano degli errori individuali che si fanno nella ricerca scientifica. Da questo i riformisti dell’empirismo positivista deducono la legge dell’unità del metodo. Sono proprio loro, insieme ai marxisti, l’ultima barriera di combattimento del capitale.
Considerando la totalità come dialettica, i marxisti inseriscono all’interno del meccanismo dialettico il concetto di totalità. Scrive Marx nella famosa Introduzione del ’57: «La più semplice categoria economica, come per es. il valore di scambio, presuppone la popolazione, una popolazione che produce entro rapporti determinati, e anche un certo genere di sistema familiare o comunitario o politico ecc. Esso non può esistere altro che come relazione astratta, unilaterale di una totalità vivente e concreta già data. Come categoria, al contrario, il valore di scambio mena un’esistenza antidiluviana. Per la coscienza – e la coscienza filosofica è così fatta, che per essa il pensiero pensante è l’uomo reale, e quindi il mondo pensato è, in quanto tale, la sola realtà – il motivo delle categorie si presenta quindi come l’effettivo atto di produzione (che ahimé, riceve soltanto un impulso dal di fuori) il cui risultato è il mondo; e ciò è esatto nella misura in cui – ma qui abbiamo di nuovo una tautologia – la totalità concreta, come totalità del pensiero, come un concreto del pensiero, è di fatto un prodotto del pensare, del concepire; ma mai del concetto che genera se stesso e pensa al di fuori e al di sopra dell’intuizione e della rappresentazione, bensì dell’elaborazione in concetti dell’intuizione e della rappresentazione. La totalità come essa si presenta nella mente quale totalità del pensiero, è un prodotto della mente che pensa, la quale si appropria il mondo nella sola maniera che gli è possibile, maniera che è diversa dalla maniera artistica, religiosa e pratico-spirituale di appropriarsi il mondo». (Introduzione del ’57, tr. it, Verona 1974, pp. 100-102).
Qui le componenti deterministiche del meccanismo della dialettica si ripresentano anche nella loro concezione di totalità, infatti in caso contrario non sarebbe stato possibile il suddetto inserimento. Così Engels: «L’unità del mondo non consiste nel suo essere, sebbene il suo essere sia un presupposto della sua unità, poiché esso deve anzitutto pur essere, prima di poter essere uno». (Antidühring, tr. it., Roma 1956, p. 52). Ma più che altro qui Engels vuole fondare la materialità del mondo e non tanto la sua totalità. Infatti per i marxisti in genere, e per Engels in particolare, che riduce all’ortodossia più cruda i fondamenti metodologici della dialettica, non importa illustrare il punto di vista della totalità, quanto il punto di vista del movimento del reale, che, esso stesso, è una totalità, ma nel senso dialettico. Per Engels, infatti, «[...] il movimento è il modo di esistere della materia. Mai e in nessun luogo c’è stata o può esserci materia senza movimento». (Ib., p. 70). Che poi sarebbe un grosso cedimento al meccanicismo settecentesco di d’Holbach.
La totalità, per i marxisti, non solo determina l’oggetto (inserendolo all’interno di un sistema o di un sistema di sistemi) ma determina anche il soggetto della conoscenza. Ma questo soggetto non è mai l’individuo ma è la classe, infatti perché si abbia la totalità dell’oggetto il soggetto che la pone deve essere esso stesso una totalità (la classe, in questo modo, è una totalità). Il teorico più conseguente della totalità nel senso marxista è Lukács, per lui «[...] la categoria della totalità, il dominio determinante ed onnilaterale dell’intero sulle parti è l’essenza del metodo che Marx ha assunto da Hegel riformulandolo in modo originale e ponendolo alla base di una scienza interamente nuova». (Storia e coscienza di classe, tr. it., Milano 1971, p. 35). E più avanti: «Il metodo dialettico in Marx tende alla conoscenza della società come totalità. Mentre la scienza borghese attribuisce con ingenuo realismo una “realtà effettiva” oppure in modo “critico” un’autonomia a quelle astrazioni – utili e necessarie dal punto di vista metodologico delle scienze particolari – che sorgono da un lato dalla delimitazione materiale degli oggetti della ricerca, dall’altro, dalla divisione scientifica del lavoro e della specializzazione, il marxismo sopprime e supera queste delimitazioni, in quanto le eleva e le riduce a momenti dialettici. L’isolamento astrattivo degli elementi, sia di un intero campo di ricerca sia dei particolari complessi problematici o dei concetti all’interno di un campo di ricerca è certamente inevitabile. Ma il fatto decisivo è se si intende questo isolamento solo come mezzo per la conoscenza dell’intero, cosicché esso resta sempre integrato nel corretto contesto complessivo che presuppone e richiede, oppure se si pensa che la conoscenza astratta del campo parziale isolato mantenga la propria “autonomia”, resti fine a se stessa. Perciò, per il marxismo non vi è in ultima analisi una scienza autonoma del diritto, dell’economia, della storia, ecc., ma soltanto una scienza unica ed unitaria – storico-dialettica – dello sviluppo della società come totalità». (Ib., pp. 36-37).
Questo per quanto riguarda l’oggetto della conoscenza. Come si vede si tratta di parole chiare. Il marxismo riduce il concetto di totalità all’unità del metodo (come del resto fa anche l’empirismo), all’unità della scienza (divisione tra natura e società superata nella storia), all’unità della realtà intesa come movimento dialettico. Riguardo il soggetto lo stesso Lukács scrive: «La totalità dell’oggetto può essere posta soltanto se il soggetto che la pone è esso stesso una totalità; se dunque, per pensare se stesso, il soggetto è costretto a pensare l’oggetto come una totalità. Nella società moderna soltanto le classi rappresentano questo punto di vista della totalità come soggetto». (Ib., p. 37). Appare qui, ancora una volta con chiarezza, come l’individuo trovi la propria fine nella totalità della classe, e come questa totalità non sia mai quella dell’individuo nella classe, ma della classe al di sopra dell’individuo. Il meccanismo dialettico consentirà questo passaggio per altra via, quella del partito, ma la soluzione sarà peggiore del male.
Il punto di partenza non è pertanto il semplice ma il complesso. Il semplice viene ricavato partendo dal complesso e questo viene ottenuto come sintesi dialettica di generico e di specifico. L’insieme del semplice e del complesso dà vita a un intero strutturato, non chiuso, ma aperto e dinamico. Si tratta dei tentativi di spezzare il cerchio dialettico, se non proprio definitivamente almeno in modo da consentire una dinamicità creativa che non venga sacrificata eccessivamente dal determiniamo. Ponendosi questo problema scrive Kosik: «La dialettica non può intendere la totalità come un intero già fatto e formalizzato che determina le parti (ed è proprio ciò che intende nella gran parte dei casi) giacché alla determinazione stessa della totalità appartengono la genesi e lo sviluppo della totalità, il che da un punto di vista metodologico comporta l’indagine di come nasca la totalità e quali siano le interne sorgenti del suo sviluppo e movimento». (Dialettica del concreto, op. cit., p. 63). Ma in questo modo viene saltato sia l’Engels della Dialettica della natura, sia gli sviluppi di Lenin, almeno quelli di Materialismo e empiriocriticismo, per accogliere più o meno soltanto il Marx dei Grundrisse e quello della Introduzione del ’57, che se resta tra il Marx più digeribile non per questo può considerarsi l’interprete più indicato dei pericoli del meccanismo dialettico.
A nostro avviso qui si colloca una delle raffinatezze dell’analisi marxista, e quindi una delle sue maggiori pericolosità. Lungi dal mostrare l’ottusità ortodossa dei sostenitori della volgarizzazione engelsiana, i dialettica dinamici sostengono appunto il carattere di apertura del metodo. Scrive Perlini in questo senso: «La creazione della totalità, tesa a far di sé una struttura significativa, è anche un processo nel quale si crea realmente il contenuto oggettivo ed il significato di tutte le parti che compongono il tutto, in una reciproca connessione. Tale organicità si esplica in un processo; il sistema organico ha uno sviluppo. Ogni sistema organico (a esempio il sistema sociale borghese indagato da Marx) è una totalità con presupposti che mira a totalizzare se stessa sviluppandosi, sottomettendo a sé gli elementi di cui ha bisogno per qualificarsi come totalità. È una totalità che diviene, una potenzialità mirante ad attuare se stessa come totalità Storica. Per Marx lo sviluppo verso la totalità storica è un momento del processo di questa stessa totalità che mira a porsi come sistema organico». (Utopia e prospettiva in Gyorgy Lukács, op. cit., p. 28).
Ma si tratta di una indicazione che per salvare la dinamicità del metodo rinchiude il concetto di totalità all’interno del banale significato di struttura. La totalità viene ad assumere l’aspetto di paniere che si va a poco a poco riempendo. Mentre dovrebbe essere che man mano che si scoprono i contenuti del paniere si crea il paniere stesso e i contenuti, a seguito della contemporanea creazione del paniere, finiscono per non essere più gli stessi.
In fondo il punto di vista della totalità è dato dallo svolgimento autocreativo della realtà, cioè da un processo in cui il contenuto della realtà emerge assieme al suo significato totale.
Pensando la totalità come anarchia, la realtà appare come una totalità concreta in corso di svolgimento autocreativo. Come sistema di sistemi o come sistema totale, la realtà non ha regole e si può definire nel modo più attendibile come spontaneità assoluta, come assenza di predeterminazione, di finalità e di causalità. Ma nell’ordine di sotto-sistemi più facilmente attingibili e più significanti per noi, la realtà ha una caratteristica costante: è lacerata dal conflitto di classe. Le interrelazioni che si sviluppano sono tutte condizionate da questo conflitto e, a loro volta, condizionano il conflitto stesso. Il condizionamento non è mai univoco, cioè non è possibile dire che l’azione di un individuo è il prodotto predeterminato del conflitto sociale, ma non è possibile nemmeno dire che la sua azione è il prodotto predeterminato della sua volontà. La interrelazione tra le due componenti produce l’azione che, a sua volta, ha conseguenze sia sulle azioni future che sul conflitto di classe, ecc.
Nel dar conto di un fatto, di un fenomeno, di un evento, di un’azione, di una struttura sociale, ecc., dobbiamo metterci sempre dal punto di vista della totalità, dobbiamo cioè pensare la totalità, non per suggerire un modello interpretativo della realtà, e neppure perché la struttura della totalità è dialettica e quindi anche il nostro metodo deve essere dialettico (cioè totale); ma solo perché nel nostro dar conto interveniamo nella realtà e la modifichiamo, non possiamo metterla tra parentesi e osservarla sotto il microscopio: noi agiamo, e con il nostro agire modifichiamo la realtà, per cui per dar conto della realtà dobbiamo dar conto anche di questa modificazione. Di più essendo che anche la realtà ci modifica nel mentre che noi diamo conto, ecco che dobbiamo anche dar conto di questa modificazione che abbiamo subito nel mentre che stavamo dando conto e così via.
Nel fatto che la realtà (nella sua totalità) ci modifica mentre agiamo su di essa, è da individuare l’aspetto autocreativo della totalità, infatti la modificazione che nasce in noi non è la conseguenza dell’azione modificativa della realtà (conseguenza da porsi come causa ed effetto), ma è una autocreazione della totalità della realtà in quanto essa modificandoci modifica la totalità della realtà nel suo complesso. E allo stesso modo, quando con il nostro agire modifichiamo la totalità della realtà si tratta di una autocreazione della totalità e non di una nostra azione specifica, che magari non avremmo voluto fare per non cambiare la realtà che volevamo “osservare”, in quanto la modificazione verificatasi nella totalità è realmente una modificazione della totalità per il semplice fatto che comprende anche una modificazione per noi.
La totalità significa pertanto tutta la realtà non soltanto la realtà raggiungibile o ipotizzabile nell’arco di quei sistemi di raccordo che abbiamo definito più facilmente attingibili. Una mia azione, che come abbiamo detto determina modificazioni autocreative nella totalità della realtà, non si deve considerare limitata ai sistemi suddetti che oggi io posso ipotizzare o raggiungere col pensiero o con l’azione stessa, ma si deve considerare anche in rapporto con quello che io oggi non posso nemmeno pensare ma che non per questo non può considerarsi facente partedella totalità.
Tutta la realtà significa anche i sentimenti. L’amore è il sentimento che ci dà il senso più pieno della totalità. L’amore è la parte più assurda e più evidente della totalità. In quanto parte della totalità non ha modo di potersi cogliere che come totalità esso stesso; in quanto parte più assurda diventa facilmente attingibile a coloro che involontariamente parcellizzano la realtà, per paura della totalità. In quanto parte assurda e facilmente attingibile in modo parcellizzato scompare nel momento che si solidifica in un fatto, in una dimensione precisa, in una continuità spaziale o temporale, nella stessa immaginazione, nella creazione fittizia dell’arte, nel sogno, nell’utopia.
In fondo, il punto di vista della totalità è un atto di amore: dell’oggetto, ma principalmente di noi stessi. La dedizione assoluta all’oggetto del nostro amore è riconferma assoluta di noi stessi nell’atto totale dell’amore, nell’atto di amore. Il sacrificio come atto parcellizzato della dedizione non è altro che negazione dell’amore e riconferma dell’odio distruttivo per tutto ciò che ci impegna e ci confronta, per tutto ciò che ci fa migliori e più completi, per la stessa strada verso la totalità. Il sacrificio, anche verso l’oggetto amato, è negazione della totalità e quindi dell’amore. La dedizione, che non è parcellizzazione del dare, ma è totalità di noi stessi e dell’oggetto nel dare, è riconferma dell’apertura dell’atto di amore attraverso la totalità tra noi e l’oggetto d’amore.
La cattiva totalità è totalità senza amore, totalità vuota, totalità astratta. Essa è sempre perplessa e indecisa, ha sempre bisogno del dato di fatto, dell’esperienza, dell’approvazione degli altri, del giudizio del mondo, della novità. La cattiva totalità ha paura del confronto diretto, dell’iniziativa, dell’invenzione che si ripete, della creatività che si ripresenta. Preferisce la monotonia del sempre nuovo, l’idiozia della moda, dell’irrefrenabile meccanismo che sconvolge la superficie della realtà come il vento la sabbia del deserto. Ma tutto ciò: la superficialità del parziale che si veste di sempre nuovo, e la profondità del totale che nasconde con pudore la sua creatività sotto la ripetizione, non possono essere colte dalla cattiva totalità. Non è nemmeno vero che l’inseguimento affannoso dei simboli dell’amore possa sostituire l’amore nella sua realtà totale. Il femminismo (come maschilismo rovesciato) e la fallocrazia sono due grossi esempi di cattiva totalità.
Da parte sua l’amore ha come caratteristica connaturata il punto di vista della totalità. L’innamoramento non è un processo, non è scindibile in momenti separati (tanto meno dialettici: non credo che un marxista si sia mai innamorato, come non credo che esista un innamorato marxista), non può dirsi neonato o adulto. L’amore è la condizione essenziale dell’oltrepassamento della parzialità, per questo è totalità in grado di dare certezza alla realtà.
La perfetta coincidenza di realtà e totalità si realizza nell’amore, anche se poi l’attingibilità della struttura totale del reale procede per gradi di sempre maggiore estensione, in rapporto alla quantità di totalità che riusciamo a fare entrare nel fatto, nell’agire, nell’evento. Ma questa è limitatezza soggettiva che non modifica la dimensione totale dell’amore. Noi possiamo negarla, dibatterci terrorizzati di fronte a essa, mettere la testa sotto la sabbia, perseguire inutilmente i simboli di sempre e il culto della parcellizzazione; ma la folgorazione dell’amore non per questo è meno totale: in questo senso, dal punto di vista della totalità non può aversi né qualcosa di più né qualcosa di meno.
E, in fondo, noi lo sappiamo. Sappiamo perfettamente che quello che siamo non ha più senso al di là di quello che anche per un attimo abbiamo sentito realmente (cioè totalmente) di essere. In questo senso, la rivoluzione è amore.
Da quanto detto si possono trarre alcune conclusioni provvisorie che riteniamo importanti: a) il conflitto di classe è una caratteristica della totalità della realtà anche se non può definirsi la caratteristica principale. Appare pertanto che nei limiti dell’attuale significatività del livello del conflitto di classe questo qualifichi la realtà nella sua totalità; b) le nostre azioni non possono essere mai messe tra parentesi, nel senso che con la volontà possiamo trasformare la valenza sociale di un’azione. La dottrina della riserva mentale non è realizzabile; c) non possiamo agire in un modo e pensare in un altro; d) la vita per essere vissuta realmente richiede una coerenza totale; e) il rivoluzionario è un uomo coerente.
[Pubblicato su “Pantagruel” n. 2, maggio 1981, pp. 79-96 col titolo “Chiarimenti sul concetto di totalità”]
Tribunali
Negli ultimi mesi [1991] è apparsa su diversi giornali anarchici una interessante posizione di rigetto e irrigidimento nei riguardi dei processi penali che la repressione periodicamente imbastisce contro alcuni compagni anarchici.
Questa posizione, che a quanto pare trova un ampio consenso fra tutti quei compagni anarchici che in un modo o nell’altro si richiamano all’anarchismo rivoluzionario, mi sembra meriti un migliore approfondimento, anche perché nella foga delle dichiarazioni o nello slancio retorico delle analisi, spesso si corre il rischio di dire qualcosa sopra il rigo, lasciando intendere, forse, quello che non si pensava o non si riteneva potesse invece dedursi da alcune affermazioni di principio.
La partecipazione a un processo in quanto imputato non è, a mio modestissimo avviso, accettazione del meccanismo giudiziario, né tanto meno riconoscimento dell’autorità dello Stato per come si esplica nell’esercizio della giustizia con relative procedure, condanne, carcere e tutto il resto. Non lo è, almeno così mi sembra, perché in caso contrario io per primo sarei senz’altro da considerare un ingranaggio del meccanismo, dopo tanti anni di frequentazione in qualità d’imputato, di inquisito, di perquisito, di incriminato, di condannato, e tutto il resto, dopo decine e decine di processi in tutta l’Italia, nessuno più di me meriterebbe la medaglia della frequentazione di pessimi posti.
Solo che a me non è sembrato di avere stretto col potere chissà quali intenti segreti e compromessi, come non mi è saltata mai in mente la piuttosto balzana idea che farsi “identificare” o “interrogare”, sia farsi “edipizzare” dal magistrato. Devo confessare, come mi accade a volte, di non avere capito il senso di questo “edipizzare”, ma mi sembra si riferisca a qualcosa di sconcio o di sconsigliabile per ogni corretto rivoluzionario.
Ebbene, devo ammettere di non essere stato corretto negli ultimi vent’anni, se ho soggiaciuto, facendo buon viso a cattivo gioco, a diverse incarcerazioni, decine di perquisizioni, più di cento interrogatori di ogni genere, per non parlare delle tantissime volte in cui sono stato fermato e come un ingenuo ho confessato candidamente le mie generalità, collaborando, questo è vero, con il potere. Certamente è poco importante dire qui che quando, insieme a Pippo Stasi, sono stato arrestato a Bergamo, nel febbraio del 1989, nel corso di una rapina, in questura, per motivi ben precisi e non per essere più rivoluzionari della rivoluzione, ci siamo rifiutati (ma solo per alcune ore) di dare le nostre generalità, e devo ammettere che l’esperienza non è stata piacevole, in quanto per tutto il tempo siamo stati sistematicamente picchiati, come è uso e costume inveterato delle questure di tutto il mondo e di tutte le epoche.
Ora, io non pongo il problema della tortura nel senso che per evitarla basta semplicemente dire il proprio nome e cognome (certamente in quel caso saremmo stati picchiati lo stesso), dico che, escludendo i nostri personalissimi e buoni motivi, non mi pare che a suggerire il contrario ce ne siano di natura generale, validi cioè in quanto motivi “di principio” in tutti i tempi e in tutti i luoghi. Di regola, quando vengo arrestato, o fermato, rispondo ordinatamente e con calma alle domande che mi vengono rivolte, valutando attentamente quello che voglio e posso dire, e scartando quello che non voglio e non posso dire. Fin da questi primi momenti di impatto, la mia lunghissima (mi sia consentito) esperienza mi suggerisce di impostare di già quelle che saranno le linee difensive da seguire, senza stare a porre considerazioni di principio assolutamente gratuite, salvo che non sia l’inquirente stesso a porle facendo domande precise, anch’esse di natura generale, cui è ovvio non ci si può rifiutare di rispondere, in quanto concernenti la propria identità di anarchici e di rivoluzionari.
Non credo nemmeno che la scelta di fronteggiare il meccanismo repressivo sul suo medesimo terreno, cioè quello tecnico e giuridico, delle leggi e del diritto, sia un’accettazione della validità di questo meccanismo, un avallare il diritto dei padroni, in base al quale mi si inquisisce, tortura, condanna, incarcera, ecc., non lo credo in quanto penso che un rivoluzionario debba lottare su tutti i terreni in cui le vicende alterne dello scontro lo possono, in un determinato momento, collocare. Se si trova in un’aula di tribunale, ovviamente dalla parte dell’imputato e non da quella del giudice, deve fare di tutto per difendere se stesso, non tanto per un rispetto alla propria persona, o peggio ancora per paura o timore delle conseguenze, quanto per avere quella libertà di manovra che gli consentirà di portare avanti il proprio progetto. Infatti, tutti i tentativi che lo Stato cerca di realizzare, processi in primo luogo, sono proprio diretti a rintuzzare o sventare in anticipo le attività che il rivoluzionario compie, le analisi che sviluppa, le relazioni che allaccia, i progetti che realizza, gli strumenti che mette in campo di cui si è preventivamente impadronito. Arrestando, processando, torturando, imprigionando, lo Stato cerca di spezzare l’insieme delle attività del rivoluzionario, non soltanto la sua persona fisica, e lo fa sottraendo quest’ultima, per quanto gli è possibile, a quell’attività.
La difesa, con ogni mezzo, in tutti i campi, con la coerenza e la correttezza che solo il rivoluzionario stesso può scegliere e decidere di imporre al nemico, è quindi un obbligo che egli ha non tanto verso se stesso, perché sarebbe facile abbandonarsi al più esclusivo dei rifiuti, al superbo, e bello, atteggiamento del distacco e della noncuranza, ma verso il proprio progetto, verso gli altri compagni che con lui stanno sviluppandolo, verso gli sfruttati e gli oppressi che dal progetto potranno (oppure non potranno, questo è un altro problema), ricavarne beneficio di liberazione.
La gloria delle barricate è sempre la prima cosa a cui pensa il rivoluzionario, nei suoi sogni di distruzione di ogni ordine fondato sull’inganno delle regole e dei codici, delle leggi e dei regolamenti. E sulle barricate egli si augura di morire, fin dal primo giorno, come accadde al fortunatissimo Ascaso, che non dovette affrontare e vivere tutte le tristezze dell’attività rivoluzionaria per trovare, come lo sfortunatissimo Durruti, la morte sul finire della lotta. Ma questo è un desiderio che possiamo rimettere sul grembo del destino, non spettando a noi calcolare la traiettoria della pallottola che potrebbe ucciderci per risolvere, al posto nostro, tutti i problemi (e i compromessi) di una lotta rivoluzionaria, i quali ci stomacano talmente da respingerci indietro verso sdegnose, e forse anche comode (o no?), posizioni di rifiuto.
E qui mi pare importante un’altra considerazione, che in tempi ormai da considerare remoti, sollevò molte più polemiche di quanto sarebbe stato necessario. A me sembra che la teorizzazione della necessità di un rifiuto di avere qualsiasi rapporto con il sistema giudiziario in quanto imputati, quindi rifiuto non solo dei processi, ma anche dei primissimi interrogatori, sia logica solo nell’ottica di un’organizzazione specifica la quale imponga ai propri militanti, nell’eventualità di un loro arresto, di dichiararsi “prigionieri politici”, in quanto sarebbe veramente contraddittoria la posizione difensivista di un individuo che intende al contrario proporre un cambiamento futuro in modo da realizzare condizioni in cui al posto del giudice, possibilmente sullo stesso scanno, ci sarà seduto proprio lui a giudicare le stesse persone che oggi vogliono giudicarlo. Poiché noi anarchici non ci poniamo problemi del genere, e neanche progetti del genere, non ci dichiariamo “prigionieri politici”, ma individui liberi che rivendicano personalmente, in quanto tali, le azioni che fanno e quindi non vedo perché non si possa portare avanti una gestione del processo con tutte quelle caratteristiche che di volta in volta le condizioni dello scontro suggeriscono.
Mi è sempre parso indispensabile, nelle moltissime occasioni in cui mi sono trovato ad affrontare “frequentazioni” con il meccanismo repressivo, rivendicare, salvaguardandola, la mia identità di anarchico, lasciando poi agli inquirenti fare il loro mestiere. Mi è anche parso sempre indispensabile fronteggiarli, nei limiti del possibile, sul piano del ragionamento, per ricavare quegli spazi difensivi che potevano avvantaggiarmi, facendo in modo di non dare mai nessun vantaggio a loro, se non quello della mossa iniziale, quello indiscutibile e irreversibile del mio essere anarchico e rivoluzionario. Ma, al di là di questo, nient’altro. Negare sempre, anche l’evidenza, scriveva tanti anni fa Victor Serge, e mi sembra un ottimo consiglio.
[Pubblicato su “Anarchismo” n. 67, maggio 1991, pp. 43-45 col titolo “Qualche considerazione d’un frequentatore di tribunali”]
Mamma! arrivano i Turchi
Le sacre sponde d’Italia sono minacciate, a Oriente. Il governo manda l’esercito e la marina per difenderci delle invasioni degli stranieri: Macedoni, Albanesi, Bosniaci, Kurdi, e giù di lì, una calca immane e disgustosa minaccia di annerire le candide (si fa per dire) spiagge dell’Adriatico. La gente nostra può però dormire tranquilla, l’occhio vigile della marina e dell’esercito non dorme.
Era tempo che non si risciacquavano le intenzioni patriottiche di quei ruderi insignificanti e costosi che vestono la divisa. Era tempo che qualcuno usasse le maniere forti, e non è un caso che i fascisti in Puglia siano particolarmente agguerriti, se non altro dal punto di vista elettorale.
È la prima volta dalla fine della seconda guerra mondiale che l’esercito e la marina vengono utilizzati in funzione di pattugliamento massiccio delle coste italiane, ed è un fatto significativo. Si tratta di operazione di polizia, ma svolta da una struttura che, passo passo, sospinta dai venti che potrebbero indirizzarsi verso mai sopite musiche retoriche, potrebbe andare, come si dice, alla radice del problema. Se, difatti, è impossibile frenare l’esodo delle immigrazioni clandestine (ormai organizzate attraverso una fitta rete di mezzi celeri di trasporto), dopo i primi fallimenti, e dopo le prime scariche di mitraglia per fermare gli inarrestabili gommoni zeppi di poveracci allo sbando, cosa resterà da fare per le nostre gloriose bandiere? La risposta è semplice, come dicevo, affrontare il problema alla radice, recarsi proprio nei paesi da cui muove il flusso migratorio e impedirlo.
Per carità, si tratterà, ne sono certo, di un semplice prolungamento dell’attuale operazione di polizia, nulla di aggressivo o provvisto di intenzioni conquistatrici, ma da cosa nasce cosa, come tutti sappiamo, e un passo ora, un altro dopo, chissà che a qualche generale di casa nostra, obbligato da cinquant’anni a giocare ai soldatini di piombo, non venga qualche idea brillante in capo.
Per carità, tutto deve muoversi nell’ambito della legalità democratica. Oggi le navi bordeggiano lungo la costa, domani trasporteranno specialisti in repressioni e torture nelle terre d’oltremare, solo per dare una mano d’aiuto alla polizia locale, null’altro, forse qualche piccola cosetta in più, ma niente di eccezionale.
Insomma, signori antimilitaristi, smettiamola con i vostri sofismi, le faccende troppo vicine ai sacri interessi della Patria devono pur trovare qualcuno che li sbrighi. Non vi pare?
E sono certo che qualcuno troveranno.
La Somalia si avvicina.
[Pubblicato su “Canenero” n. 25, 5 maggio 1995, p. 2]
Utopia
Alcuni di noi hanno vissuto momenti simili. Improvvisamente sorge dietro il grigiore di monotonie quotidiane il lampo incredibile di un concetto propulsore. Il desiderio di essere di già al di là del baratro, abbondantemente al di là.
L’hanno vissuto e regolarmente dimenticato. Una piccola minoranza di questi sperimentati frequentatori di assemblee e cortei, ha continuato a praticare, nel chiuso di se stessa, la liturgia dell’incredibile, convincendosi che la proposta utopica dovesse, per forza, venire dai rifacitori di teorie, tanto bravi a scalare montagne nel chiuso della propria stanza.
Gli altri, nemmeno a parlarne. I più non avevano nemmeno sentore di cosa si stesse sognando. Confondevano tranquillamente possibilismo e radicalismo in un miscuglio indigesto che è stato definito come “radicalismo democratico”.
Ma l’utopia propulsiva, quella che costituisce la linfa vitale che scorre nelle vene del movimento reale, non si trova nei libri e nemmeno nelle tesi d’avanguardia del filosofo d’elite che, come un bravo turnista, timbra il cartellino della fabbrica delle idee preconfezionate.
In un desiderio collettivo nascosto, ma non per questo meno cocente, si alimenta crescendo questo flusso dai mille aspetti. Poi, improvvisamente, te lo ritrovi all’angolo della strada. La sua formulazione non è travolgente, spesso è timida e incerta, non ricorda il lampo della strada per Damasco. Ma, per chi sa leggere tra le pieghe del movimento reale, essa, e soltanto essa, è il punto di forza di un fenomeno che si estende per mille rigagnoli e minaccia di perdere la propria unità e identità in modelli da gazzettiere frettoloso.
Qua e là, anche in banali manifestazioni di piazza, appare la parola d’ordine tradizionale delle grandi rivoluzioni, quella che eravamo ormai rassegnati a vedere definitivamente annacquata nei discorsi parlamentari: l’uguaglianza.
Per un piccolo sentiero nella foresta, il movimento reale ritrova se stesso nell’indicazione di un grande obiettivo utopico, contrassegnato dal superamento del diritto nella realtà piena del fatto.
Mi si potrebbe far notare che una rondine non fa primavera. Giusto. Un cartello, mille cartelli sono solo parole urlate al vento e da questo, spesso, portate via in fretta. Ma le parole non nascono nel chiuso delle biblioteche. Quando corrispondono a uno stato d’animo di migliaia di persone, quando, improvvisamente, irrompono in quella coscienza collettiva che costituisce il fondamento del movimento reale, allora, e soltanto allora, abbandonano la loro simbolica attitudine a costituire la semplice buccia della realtà, per diventare sostanza di un progetto latente ma non per questo meno poderosamente operativo.
Oggi il macabro spettacolo dei diritti, e dell’uguaglianza dei diritti, soffoca ogni desiderio che sospinga lo sguardo al di là della barriera del di già costituito. Lo stesso rifiuto del politico, da parte del movimento studentesco attuale [1987], è solo un filtro attraverso cui viene bloccata la profonda istanza utopica del liberarsi definitivo e immediato. Fuori i mestatori di ogni genere, dentro la libertà. Giusto. Ma quando questa libertà non è corposamente modellata di contenuti, quando diventa una buccia di parole bene o male costruite, allora non è altro che un nuovo modo di sigillare l’ideologia.
Certo, il dibattersi del prigioniero – nel ghetto, nelle prigioni, nelle fabbriche, nelle scuole, nella discriminazione razziale e sessuale – è diretto solo ad abbattere la prima barriera, il muro, il nemico immediato, il colore della pelle, la differenza del sesso che si ripercuotono in dolorose discriminazioni sociali. Ma ciò, pur essendo comprensibile, non corrisponde ancora a una lotta rivoluzionaria per l’uguaglianza di tutti, nella differenza di ciascuno, nell’esaltazione massima di questa differenza. Bene che vada, quella lotta sarà ripresa e trasformata in ulteriore condizionamento, perché sarà sempre una lotta per “uguali diritti” a prescindere da situazioni di fatto che uguali non possono essere, finché esisterà un terreno della discriminazione politica e quindi sociale.
Mi pare importante sottolineare in queste righe che l’affermazione comparsa nelle strade parigine [autunno 1986] indica un serio tentativo di superare la trappola che gli ideologi hanno costruito per tempo, camuffandola opportunamente, suggerendo per vie traverse agli studenti di fare attenzione agli elementi estranei, ai politici, ai provocatori, ecc. È una vecchia favola che i gestori del potere mettono sempre in circolazione al momento opportuno perché sono sicuri di controllare, indirettamente, attraverso i canali di reperimento del consenso e di condizionamento dell’informazione. Si tratta della tecnica di potere che mette in guardia contro i pericoli relativi a una parte di se stessa proprio per distogliere l’attenzione da quello che un’altra parte sta portando a termine.
Ora, contrapponendo a queste trame sotterranee una genuina posizione rivoluzionaria, il movimento reale riscopre la potenzialità dirompente dell’utopia. Fa di ciò che non può essere recuperato lo strumento di critica radicale del processo di recupero. Non a caso, difatti, questa posizione è apparsa nello stesso momento in cui scadono d’importanza le rivendicazioni economiche in senso stretto. In questo campo, tipico del sindacalismo di ogni pelo, l’uguaglianza è vista come condizione finale della spartizione del valore prodotto, al di là della divisione endemica tra capitalisti e proletari. Ma, siamo certi, una società che passasse, più o meno violentemente, dal capitalismo al socialismo post-rivoluzionario attraverso la porta stretta del sindacalismo, sarebbe, per forza di cose, la grigia parodia di una società liberata. Il pesante meccanismo auto-regolatore sindacalista si trasferirebbe di peso nella società, con i suoi ideali del buon lavoratore e del cattivo fannullone.
Perché, si potrebbe chiedere, si è così sicuri del contenuto rivoluzionario di un concetto che, dopo tutto, viaggia con alterne fortune nel tessuto rivoluzionario mondiale da almeno duecento anni? La risposta è semplice. Il valore propulsivo di un concetto non può capirsi, nel campo sociale, se ci si limita all’esame delle condizioni date. Non esiste, difatti, un rapporto causale tra condizioni sociali e concetto utopico. Quest’ultimo viaggia nel movimento reale profondamente in contrasto con i limiti strutturali che lo condizionano ma non lo causano. Nel movimento fittizio, al contrario, lo stesso concetto viaggia comodamente. Qui, nella rarefazione del castello dei fantasmi, perduta tutta la sua pregnante significatività, il concetto utopico è un semplice prodotto dell’ideologia, come tanti altri.
Sarebbe certo interessante una ricerca sulle cause dell’utopia, o, per meglio dire, del desiderio utopico, ma credo che darebbe ben scarsi risultati se ci si limitasse solo nel campo delle condizioni sociali e storiche in cui il concetto improvvisamente viene a emergere.
Per questo motivo non ci si può basare su queste ultime condizioni per fissare i limiti di una presunta operatività del concetto utopico. Questo può andare ben oltre quelle condizioni, diventare esso stesso causa di nuove condizioni sociali, diventare, in altri termini, elemento operativo di modificazione sociale.
Ora, l’uguaglianza è un concetto contraddittorio che esiste in ognuno di noi. Da un lato, ci sentiamo profondamente diversi dagli altri e teniamo a difendere e a far crescere questa diversità. L’uniformarsi e l’accettare ordini e imposizioni è visto come qualcosa di indegno, anche se dalle necessità del momento ci si vede spesso costretti a fare buon viso a cattivo gioco. Ma questa radicale differenza viene vista da tutti come un valore da inserire in una sostanziale uguaglianza tra tutti. Uguaglianza di condizioni, di possibilità, di libertà, di valore, di spazio sociale, ecc. Il tutto nella più profonda differenziazione di desideri, sentimenti, scopi, interessi, culture, aspetti fisici, ecc.
Ma questo concetto non è percepibile storicamente che attraverso tutti i tentativi realizzati per trasformare l’uomo in animale da branco. Per essere uguale all’altro doveva diventare pecora, senza contare che ciò lo faceva profondamente differente dal pastore che guida il branco e tosa le pecore. La democrazia è stata sempre vista (ed è vista anche oggi) come uguaglianza di diritti, non come uguaglianza di condizioni. In questo modo, a parità ipotetica di diritti ha sempre corrisposto una disparità reale di condizioni. E le differenze fra gli uomini, anziché essere quelle della loro individualità, sono state sempre quelle derivanti dalle diverse condizioni di fondo, attraverso cui si facevano avanti a fatica le diversità dell’individualità, costrette a lottare per non morire soffocate dalle diversità artificiali imposte dal dominio.
Quando un’idea come questa irrompe nel movimento reale e riesce a spezzare i condizionamenti attraverso cui appare come camuffata, si possono verificare incredibili eventi. L’appiattimento del presente non giustifica una conclusione negativa. In pratica tutto è possibile. Se i rivoluzionari sono anche prima della rivoluzione, la maggior parte di loro nascono proprio nel corso della rivoluzione. La forza di un concetto utopico si moltiplica all’infinito proprio nel momento in cui esso viene posto, purché emerga all’interno del movimento reale e non sia baloccamento ideologico all’interno del movimento fittizio.
La proposta, di fatto, dell’uguaglianza trasforma radicalmente la superficiale esistenza di un’uguaglianza di diritto.
Se gli sfruttati fanno propria l’utopia egualitaria, proprio dal momento che ne inalberano la bandiera, questa cessa di essere utopia e, nello stesso tempo, fa cessare di essere realtà quella uguaglianza di diritto che non era altro che la base dello sfruttamento in funzione delle condizioni di classe. Cessando di essere utopia, l’idea rivoluzionaria si trasforma in fatti che sconvolgono l’assetto sociale ben al di là di quanto fosse prevedibile alla luce di un’analisi della situazione politica. Il potere ha sacralizzato l’uguaglianza imponendole lo stimma del diritto. In questo modo ha trasformato la pulsione utopica che proviene dal sotterraneo lavoro di secoli all’interno del movimento reale, in un ulteriore mezzo di sfruttamento e di recupero. La lotta per il diritto si venne così a sostituire alla lotta per la vera uguaglianza.
L’uguaglianza è una sfida alla società di oggi, corrisponde alla decisione utopica di fare in modo diverso da come il concetto generale impone. Ma questo concetto – introiettato dai più – è il fondamento stesso della repressione, è la morte per uniformità, per inedia, per asfissia. Proprio l’uguaglianza, che nella storia ha fatto tremare tanti cuori tiepidi per le sorti dell’individuo, è la strada più esplosiva per salvaguardare le differenze e le caratteristiche di ogni uomo, al di là delle condizioni sociali che lo incatenano alla mediocrità di una illusoria differenza. Così, l’uguaglianza è una sfida all’ordine che solo il movimento reale può lanciare in faccia alla società.
[Pubblicato su “Provocazione” n. 1, gennaio 1987, p. 6 col titolo “L’utopia propulsiva”]
Vandea
Nel clima generale di restaurazione e di risistemazione – a uso delle future generazioni – di tutta la storia recente e meno recente, si inserisce anche l’operazione fatta dalla Chiesa cattolica di rivalutare la Vandea (certamente, non in chiave rivoluzionaria) e di criticare la rivoluzione francese, portatrice di disastri, distruttrice di regni, e seminatrice di disordini.
Ciò è stato fatto [1987] dal cardinale francese Poupard, originario, appunto, della Vandea e diretto discendente dal capo carismatico dei contadini “antirivoluzionari” dell’epoca, un certo Cathelineau. Nelle università, intanto, si sta riabilitando il nazismo, il fascismo e si stanno accomunando, acriticamente, le responsabilità storiche di tutti, per venire fuori con nuove tesi che cercano di far passare per decisioni politiche operazioni di sterminio e genocidio.
Comunque la cosa non sarebbe stata interessante se la Chiesa cattolica, in armonia con il suo costante modo di pensare, non avesse descritto, per mano di questo cardinale, l’insurrezione vandeana con accenni reali, molto di più di quanto non hanno fatto moltissimi storici di sinistra. Solo che ha tralasciato di far vedere che la Vandea non insorse perché i contadini erano reazionari e non per questo si mise a innalzare i labari della madonna o accettò di farsi guidare dai nobili, ma, al contrario, tutto ciò accadde perché la rivoluzione aveva, fin dalle sue prime battute, tradito le speranze degli strati più poveri i quali, non solo videro peggiorare la propria situazione, ma si videro obbligati (con la forza) a fare una guerra che non potevano né capire, né accettare.
In questo senso, quindi, cioè nel senso di una non sufficiente posizione rivoluzionaria del potere centrale giacobino, i contadini vandeani insorsero contro i simboli di un nuovo potere che prendeva velocemente gli aspetti peggiori del vecchio e non dava se non poche cose in cambio, la maggior parte delle quali erano semplici concetti astratti: uguaglianza, libertà, fraternità.
Lo stesso accadrà poi con i patrioti spagnoli che morirono fucilati dai soldati dell’esercito francese che pure portavano scritto sulle proprie bandiere le suddette parole di progresso e di rivoluzione. Ed è per questo che gli spagnoli morirono gridando “Abbasso la libertà”!
E sarà lo stesso con i briganti meridionali che dichiararono guerra ai piemontesi e trovarono un alleato nel Borbone e si misero nelle mani degli specialisti della guerriglia sanfedista spagnola.
Ma sulla reale motivazione rivoluzionaria che spinge i miserabili, i poveri, le classi più sfruttate a insorgere ben al di là di quanto i simboli dello spettacolo politico cercano di spacciare per vero e reale, la Chiesa cattolica ha, fortunatamente, ben poco da dire.
* * *
A seguito dalle superficiali dichiarazioni del Presidente della Camera dei deputati [1994] Irene Pivetti, è cominciata una sorta di riscoperta della Vandea, l’insurrezione contadina iniziata nel marzo 1793 e finita quasi del tutto nell’ottobre dello stesso anno, in pratica con una resa dei poteri rivoluzionari in carica a Parigi.
Oggi si parla, la maggior parte a sproposito, di questo vasto fenomeno, essenzialmente sanculotto e contadino, di rifiuto di un nuovo ordinamento che minacciava di agire peggio del vecchio, sottolineando solo l’azione del clero legittimista. E anche questo tentativo di esaltare soltanto gli aspetti religiosi della Vandea, mettendo in secondo piano il rifiuto antimilitarista di accettare la coscrizione obbligatoria e il rigetto di una nuova autorità centrale venuta a cancellare per decreto la religione cattolica in zone di antica tradizione di vivissima fede, corrisponde allo spirito del tempo in cui viviamo.
Gli orrori della guerra civile in Vandea restarono leggendari, da una parte e dall’altra. Il Comitato centrale giacobino non riuscì mai a ristabilire il proprio potere nella regione, ma anche gli insorti non ebbero mai un piano concreto per allargare il proprio progetto insurrezionale contro Parigi. Alla fine, furono proprio gli insorti a firmare una sorta di accordo con il quale riuscirono a ottenere garanzie di riduzione della leva e delle tasse, mentre la borghesia locale e i preti (il cui simbolo crociato tanto astutamente viene oggi sbandierato ai quattro venti) traevano i più larghi benefici finanziari in termini di acquisto delle terre sottratte ai nobili. L’unico insegnamento che si può trarre dai fatti di Vandea, ancora oggi vivi nel ricordo popolare dei Francesi, è che nessun integralismo, né religioso né anticlericale, può mai essere consigliabile per l’uomo.
[Primo pezzo pubblicato su “Provocazione” n. 3, marzo 1987, p. 8 col titolo “Il Vaticano e la Vandea”; secondo pezzo pubblicato su “Canenero” n. 2, 4 novembre 1994, p. 7 col titolo “La riscoperta della Vandea”]
Vecchia guardia
Seduto sulla sua poltrona dorata, il vecchio avvocato non demorde. Ha mandato allo scoperto il cavaliere con macchia e paura, per tirare subito i remi in barca non appena le acque si sono fatte burrascose. Adesso, aspetta gli eventi. Il suo fido esecutore di ordini gli ha fatto sapere che le cose non vanno male. Gli operai della Fiat non sono più quelli di una volta. Ascoltano ora i prudenti indirizzi dei vari rappresentanti sindacali, che sollecitano alla collaborazione di classe, all’unità padroni-salariato.
Agnelli sa che la sua non è una vittoria, che non potrà mai vincere questa partita, che altre se ne giocheranno in futuro, su altri territori, forse differenti dalla fabbrica, e sa anche che quelle partite non gli appartengono fin d’ora, troppo vicino alla morte è la sua miserabile vicenda terrena. Ma sa anche di rappresentare il simbolo del padrone-dominatore, del signore delle ferriere che non ha paura di quattro cani balbettanti dietro i cancelli. Sa di potere contare sui pastori che questi cani comandano, e sa anche che dietro i cani, solo apparentemente rabbiosi, si cela tremante una vasta distesa di pellicce candide che nascondono cuori di pecore belanti l’accondiscendimento e la pazienza.
Quello che non sa è che fra queste pecore cominciano a intravedersi le pellicce fulve di pochi lupi. Pochi per adesso, o pochi per sempre?
[Pubblicato su “Canenero” n. 10, 13 gennaio 1995, p. 7]
Alta velocità
Parlando diversi anni fa dei “Sistemi esperti”, facevo riferimento ai rischi di un abbassamento linguistico e culturale causato dalla tecnologia telematica avanzata. Poiché adesso mi si ripresenta l’occasione, voglio invece affrontare l’argomento complementare, che in quella sede, anche per motivi di spazio, non venne approfondito. Questo secondo aspetto è legato alla velocità.
Ma perché l’uomo vuole essere sempre più veloce?
La sua lotta con lo spazio, sulle prime, sembra una lotta per abbattere confini troppo ristretti per le ambizioni di questo straordinario animale. Poi si scopre che i confini non si abbattono aumentando la velocità, ma semplicemente si spostano. E spostandosi si rassodano, diventano più consistenti. I mille rivoli attraverso cui filtravano una volta i contenuti umani di una vita ancora densa di significati, sia pure dentro restrizioni e angosce non minori di quelle di oggi, si inaridiscono con la velocità. Non c’è più tempo per riflettere, non c’è tempo di prendere le distanze, siamo tutti uno a ridosso dell’altro, in una corsa a chi arriva primo a un traguardo che viene continuamente spostato in avanti.
Tutto questo, fuori di noi, al di là della nostra coscienza. Dentro quest’ultima i meccanismi della ragione e dell’intelletto, assistiti dal controllo della volontà, sembravano fino a poco tempo fa capaci di resistere all’assalto della velocità. Fino a ieri sembrava possibile fermarsi sul limitare di questa soglia, accettare tempi propri e non imposti dall’esterno. Oggi non è più così. Ancora più veloce. La maggior parte delle nuove tecniche pedagogiche infantili è basata sull’accelerazione delle capacità del bambino di affrontare e risolvere problemi binari, cioè che presentano una soluzione positiva e una negativa, tipo lucetta accesa/spenta. I videogiochi si basano su questo principio e di certo favoriscono la velocità decisionale dell’operatore, se quest’ultimo è idiotizzato fin da piccolo, con l’assistenza e la complicità dei genitori, a loro volta idioti che fungono da collegamento tra l’industria produttiva e il disgraziato che ne subisce le conseguenze. Il prodotto che viene fuori è un nevrotico che soltanto con grandi difficoltà potrà gestirsi i suoi tic e le sue fissazioni.
All’aumento della velocità che possiamo definire esterna, quella che ha praticamente abolito lo spazio sostituendolo col tempo reale, cioè con l’eterno presente, corrisponde una velocità che possiamo chiamare interna, legata ai tempi di reazione agli stimoli esterni. Questi tempi devono per forza avvicinarsi all’ideale astratto del tempo reale (velocità della luce), per consentire un utilizzo ottimale del mezzo telematico.
Tutto ciò, per raggiungere livelli di perfezionamento adeguati a quelle che sono le speranze di sviluppo degli strumenti, (specialmente di questi strumenti che operano in parallelo e che vengono definiti “sistemi esperti”, speranze che non sono lontane dall’ipotesi, per il momento soltanto fantascientifica, di una gestione totale dell’esistente), deve richiamare all’ordine ogni tendenza “diversa” che si presenta nell’individuo e nella società.
Facciamo un solo esempio, i lettori possono ricavarne altri a piacimento. Prendiamo il concetto di spreco. La critica di questo concetto si basava, in passato, su di una ipotesi di natura economica e sociale. Il risparmio, la giusta dose di utilizzo delle risorse disponibili, il rapporto tra risparmio e investimenti, la crescita dell’economia, il benessere collettivo e tutte le altre favole con cui ci hanno assordato gli orecchi fino a poco tempo fa. Oggi la musica è cambiata. La condanna dello spreco è pronunciata in termini di algoritmo matematico, di soluzione ottimale fra diverse soluzioni possibili, di problema gestionario, come se ogni individuo fosse un’azienda agente in un libero (e ipotetico) mercato. Mentre prima il risparmio era una virtù sociale, oggi è una soluzione matematica che possiamo delegare alla macchina, solo che per fare nostra la decisione (suggerita) dalla macchina, dobbiamo abbassarci al suo livello, dobbiamo cioè costruirci desideri adeguati, pensieri e progetti in linea con la possibile soluzione matematica che ci verrà prospettata. Problemi del genere, fino a qualche anno fa insolubili per l’architettura telematica lineare, adesso sono accessibili attraverso le strutture parallele che forniscono soluzioni in tempo reale. Non solo lo spazio si è accorciato, non solo la velocità è cresciuta, non solo la nostra coscienza è stata costretta ad accelerare i suoi tempi di reazione ai fenomeni esterni, ma anche le categorie morali fondamentali, che gli ultimi duemila anni ci avevano costruito, sono in corso di veloce cambiamento.
Non ci rammarichiamo (e come potremmo?) del crollo dei valori, ma indichiamo soltanto i segnali di pericolo che da questo crollo si manifestano. Le cause che stanno determinando questo crollo (non ancora definitivo) sono esse stesse produttrici di altri valori, adeguati perfettamente alle mutate condizioni di risposta della coscienza individuale. Questi nuovi valori saranno ancora più refrattari dei primi a possibili critiche provenienti dall’esterno, le quali verranno viste come provenienti da un altro pianeta. Allo stesso modo oggi viene guardato con sospetto chi si ostina a non usare il computer e preferisce la vecchia macchina per scrivere.
Pensate a quello che potrebbe accadere in futuro.
[Pubblicato su “Anarchismo” n. 74, settembre 1994, pp. 26-27 col titolo “Macchine più esperte uomini più idioti”]
Viaggio
Tutti abbiamo bisogno di raggiungere uno scopo. Ci affanniamo per questo e ci diamo continuamente obiettivi da raggiungere.
Quello che sta lontano da noi ci angustia, quando non ci preoccupa nel senso pieno del termine, quindi vogliamo raggiungerlo, se non altro allo scopo di possederlo, e quindi di controllarlo. Ogni viaggio è un modo di fuggire alle proprie paure.
Ma non esiste un obiettivo innocente, una stazione di arrivo che non comprenda in sé qualcosa di spaventoso, di concluso e quindi di mortale. Lo scopo non è mai privo di conseguenze, senza che ciò possa indicare una differenza esatta con quello che siamo, una specie di sostituzione reciproca, come accade poniamo con la parola. Nell’obiettivo c’è la persistenza necessaria di tutte le possibilità, contraddizione dell’irripetibile che si ripete proprio perché si trasforma sempre. Più andiamo veloci verso la destinazione, più sfuggiamo alle nostre possibilità di capire, più si affievolisce la cognizione che abbiamo del nostro destino. Ciò causa un intestardirsi della coscienza nella sua ripetitività, difesa e tana contro la paura.
In questo eterno pulsare si dà tutta la realtà, non un singolo viaggio. Nell’apparente ripetizione si delinea per intero la struttura dell’esistente, mentre nell’impossibilità di una ripetizione identica a se stessa, si delinea per intero la tragedia di una corsa che non ha mai fine, restando comunque priva di senso.
Possiamo parlare del viaggio, ma per capirlo dobbiamo esserci dentro, essere nello spostamento verso qualcosa di diverso, dove il contenuto di questo spostamento è il rischio stesso, non una riflessione sul movimento. Ma parlare della velocità, come dello spazio o del tempo, contrassegna sempre una distanza, un’incolmabile distanza, il campo di percorrenza dell’itinerario, il territorio del dire che farà da velo al territorio da percorrere, velo che non può nascondere tutto, prima o poi la paura dell’ignoto viene fuori, e non saranno certo le parole a superare questo abisso.
La spaventosità del punto di arrivo la nascondiamo in molti modi. A esempio banalizzandola, trasferendola nell’oggettività da quattro soldi della vita quotidiana, del di già conosciuto. Non c’è viaggio nuovo che non ci affascini e non ci faccia paura, viaggio all’interno del quale il tempo non si allunghi in maniera incredibile, per poi riaccorciarsi quando quell’itinerario è di già sperimentato.
Per un attimo, come i fuochi d’artificio, ogni incertezza sfuma nella sua massima estensione. Ma non esiste certezza pensabile, né sincronia deliberata di meccanismo che possa resistere a lungo. Ogni riproduzione meccanica, rumorosa e utile, ogni cartolina pubblicitaria di luoghi e stazioni d’arrivo, sacrifica se stessa all’imprendibile attimo dove somiglia dolorosamente alla stazione di partenza, ogni durata appare per quella che è, un’illusione senza gusto. Lo spazio nasconde un segreto che svela solo nell’angoscia del movimento, nel disperato tentativo di capire il perché di quello che viene dopo, senza legame e senza ragione con quello che è di già accaduto prima. Questo segreto è dato dal suo carattere istantaneo. Non è possibile parcellizzarlo. I chilometri sono un’illusione della tecnica che il brivido della coscienza continua a rifiutare. Perciò corriamo, su mezzi sempre più veloci, su treni e auto e aerei, verso la nostra distruzione. Perciò non ne possiamo fare a meno.
Proponendo la distruzione di quello che la tecnologia dell’alta velocità ci mette davanti – oggi il treno, domani un altro mostro dello stesso genere – non ci illudiamo di acquietare con questo i nostri sogni o le nostre paure. Non vogliamo rendere la realtà più facile, non vogliamo conservare le cose nella loro stesura precedente, nella prospettiva di future utilizzazioni “buone”, non persuadiamo nessuno, né raccogliamo proseliti.
Sappiamo che la fuga dalla solitudine è anche la nostra fuga. Non ci atteggiamo a portabandiera di teorie quietiste che non ci interessano. Vogliamo solo entrare nella nostra fuga, essere noi la nostra velocità, decidere noi i tempi e i modi in cui realizzarla, anche nella più stupida delle maniere, anche correndo in motocicletta, quando il vento ci fa uscire a forza le lacrime dagli occhi e sai che un piccolo scatto del polso potrebbe costarti la vita.
Ciò comporta di per sé una distanza dalle mode, una igiene culturale che non è necessariamente contrapposizione di principio, che suonerebbe meglio come snobismo. Il conformismo è una malattia dietro l’angolo. da cui non è facile sfuggire solo con la forza di non mettersi d’accordo. L’avere torto può essere una sorta di prova indiretta che ci si trova su di un sentiero interessante. Ma come scoprire questo sentiero? Dove trovare la forza di avere torto?
Nelle nostre scelte degli obiettivi da raggiungere, delle stazioni d’arrivo, c’è sempre qualcosa di contraddittorio e di non molto chiaro che si nasconde dietro una pretesa evidenza. Siamo sollecitati da qualcosa che ci manca. Questa mancanza la riconfermiamo puntualmente nel movimento dell’accumulo, nel complesso groviglio delle iniziative che prendiamo, le quali restano in gran parte inespletate. Più restiamo in queste frenetiche vicende del fare accumulativo, più immaginiamo e progettiamo (spesso senza neanche avere idea dei mezzi necessari per realizzare quello che ci proponiamo), più quelle possibilità ci sfuggono; più ci avviciniamo all’accumulo, più mettiamo carne sul fuoco, più ci sfugge il senso della possibilità “altra” del meccanismo stesso. In questo movimento ci concediamo all’improbabile rielaborazione della nostra vita, alle visite inaspettate, all’avventura e al caso codificati, alle soluzioni impreviste ma ortodosse. Ci permettiamo desideri che immaginano la scomparsa della distanza, che costituiscono avvicinamenti, anzi producono accelerazione del passaggio tra lontananza e riaccostamento.
È importante capire che ogni viaggio può avere un senso vitale per noi solo se, attraverso l’inquietudine, non siamo più in condizione di prevedere il desiderio della destinazione, solo cioè se riusciamo a non desiderare nei suoi dettagli quello verso cui stiamo andando incontro. Questi dettagli infatti, fissando condizioni di sicurezza, impediscono il rischio e disegnano un itinerario turistico conosciuto in partenza. Per spezzarli dobbiamo volere e amare il nostro destino, essere fuori della paura.
Sono molte le maniere di muoversi. Ci si può muovere per paura, e anche per temerarietà. Mai per sincerità. Nel viaggio c’è sempre un tentativo di nascondimento. Difatti si può rimettere continuamente tutto in gioco solo non rivelandosi a se stessi, immediatamente, per quello che si pensa di essere. Il bilico tra i due versanti consente un gioco di astuzie praticamente infinito. Nessun movimento della coscienza è asettico. Non avviene mai sulla base di una ipotesi da verificare. Non c’è mai una condizione che possa garantire una pacifica e distaccata visione del mondo.
Il luogo del viaggio dovrebbe essere quello della scoperta, l’itinerario uno dei momenti in cui ci si trova al cospetto di se stessi. Si potrebbero così cogliere, non disvelare ma cogliere, il senso degli opposti contrasti, il rapporto reale che esiste tra la destinazione e il suo raggiungimento. Nel viaggio potremmo trovare il primo segno della verità che traluce dietro la simulazione. Ma, per far questo dobbiamo rompere l’accordo di non belligeranza con noi stessi, dobbiamo metterci a rischio. Ogni accordo è semplicemente simulato, non produce chiarezza, mette tutto a tacere, sigilla l’archivio. Ma quando il sigillo viene apposto, concordando tutte le contraddizioni, la verità è di già morta da un pezzo. L’itinerario è quindi crescita delle meraviglie, aumento dei meccanismi di copertura, non semplificazione, non distinta ricerca delle componenti. Ogni viaggio è trasferimento in blocco al di là della trama che da sempre si continua a tessere, ed è anche ricerca della morte, guardare verso il territorio che non si conosce, ma che ci ha per tante volte visto ospiti coraggiosi e coinvolti.
Si potrebbe, come Apollinaire al cospetto della prima automobile a Parigi, gridare: plus vite, nom de Dieu, plus vite, più presto, perdio, più presto. Il gioco senza fine, quando ha inizio, risulta troppo pesante se a giocarlo si è in più di uno. Ora, il giusto valore dell’impossibile può essere considerato solo da chi ha deciso di possederlo, anche a costo della propria messa a repentaglio, oltre la singola, miserabile, possibilità di vita. Molti pensano che tutto ciò corrisponda esattamente alla debolezza generalizzata, specchio fedele di un profondo cambiamento delle strutture sociali. Debolezza che non è poi molto difficile definire come crisi o come decadimento e altri consimili concetti. Non sono d’accordo. Se la critica negativa della razionalità costituisce una debolezza, è bene accettarla se tutti i risultati della forza della ragione sono quelli che abbiamo sotto gli occhi. Ma la verità è che non si può parlare, se non a torto, in termini di debolezza o di forza del pensiero. Sono solo luoghi comuni di recente invenzione.
Anche nel rischio del viaggio cerchiamo di trovare i rassicuranti elementi del di già dato, vogliamo fare nostra la destinazione, questo è vero, per cui ci qualifichiamo surrettiziamente, ma non vogliamo perderci, come quando partiamo per un viaggio turistico organizzato e lasciamo accuratamente in cassaforte pellicce e ori. Mettiamo qualcosa a repentaglio, ma solo qualcosa, giochiamo una piccola percentuale di quello che possediamo. Ci riserviamo sempre un entroterra di sicurezza. Ecco perché sosteniamo la conoscenza sulla base del metodo dell’a poco a poco. Siamo bottegai e non vogliamo ammetterlo. Sulla soglia della bottega, quando mettiamo fuori il naso, guardiamo sospettosi il cielo e scorgiamo sempre segni di futuri rivolgimenti e, a volte, ci rincuoriamo e sogniamo a occhi aperti. Poi corriamo subito a rifare l’inventario per paura di avere perso qualcosa. In questo modo, non possiamo pretendere nulla dalla vita, né possiamo darci una prospettiva di trasformazione. Deludiamo gli altri, che prima o poi scoprono il nostro maldestro gioco delle tre carte, e deludiamo noi stessi che, comunque, non potevamo mai sognare di illudere. Così perdiamo ogni contatto reale col mondo che ci circonda, e viviamo contagiati dalla nebbia. Invece di giocare veniamo giocati. La paura rileva sempre la nostra ripugnanza di fronte all’imprevisto e alla diversità.
In definitiva possiamo scappare dalla realtà in due modi, o rallentando la nostra vita, rinchiudendoci nei ritmi del di già conosciuto, o accelerando tutto al massimo, trasferendoci in una crescita esponenziale che volendo abolire la distanza la riconferma nella sua espressione più terribile, quella del carcere, in primo luogo del carcere delle idee.
I due aspetti sono complementari. Non si sfugge a essi né inseguendo record di velocità, né sognando passeggiate con la carrozza a cavalli.
Appendice sugli effetti negativi dell’installazione di una linea ferroviaria ad alta velocità
Rumore. L’aumento di rumore è incontestabile. I tecnici favorevoli parlano della possibilità di installare dei sistemi che rompono le onde sonore. Ma si tratta di palliativi. La propagazione di queste onde è fenomeno complesso che non si elimina in questo modo. Il rumore non dipende solo dalla velocità ma anche dalla lunghezza del treno.
I fastidi riguardano diversi aspetti: la conversazione è ostacolata, si hanno sensazioni, di panico, di aggressività, cambiamenti di comportamento, insonnia, stress.
Danni alla campagna. Si hanno perdite nella superficie coltivabile. Ciò comporta modificazioni nel mercato fondiario. Ci saranno delle speculazioni a causa delle strutture di supporto della linea ferroviaria vicine alle stazioni intermedie.
Altri danni saranno causati alla struttura idraulica del terreno circostante, mentre altri danni verranno dai depositi di materiali di riporto. Ciò potrà determinare erosioni, inondazioni o eccessiva secchezza dei terreni.
Danni verranno a causa dei disboscamenti.
Speculazioni ci saranno a causa delle indennità e delle differenze tra indennità di valore reale del fondo, indennità di reimpiego e sovvenzioni alle attività agricole in difficoltà.
Aumenti di prezzi ci saranno sul mercato fondiario, specialmente per i piccoli fondi.
Il paesaggio come valore in se stesso verrà definitivamente distrutto. Su questo punto, trattandosi di un valore a forte carattere soggettivo, la polemica raggiunge i suoi massimi livelli. La tesi dei recuperatori è quella che il paesaggio può essere modificato dall’uomo e quindi anche migliorato e perfino creato: tesi delittuosa.
I sindaci dei paesi interessati all’inizio cercheranno di impostare duramente la lotta, poi si accorderanno sulla base di piccole riduzioni di nocività secondo i luoghi, e poi accetteranno i grossi contributi che impiegheranno per migliorare le condizioni del proprio paese, potranno pretendere una sistemazione viaria e una ristrutturazione dello spazio comunale: non più di questo. Alla fine accetteranno il passaggio del treno.
I Cantieri. Gli inconvenienti dei cantieri saranno: rumori, vibrazioni, polvere, sporcizia nelle facciate delle case, crolli parziali, fessure nelle abitazioni determinate dalle mine.
Aumento del traffico a livelli considerevoli e non abituali per i singoli posti, quindi difficoltà di traffico e aumento degli incidenti stradali.
Degradazione delle strade comunali e provinciali.
In contropartita i sostenitori parlano di un aumento delle possibilità di lavoro (eterno argomento), di un aumento delle attività commerciali, aumento della frequenza nelle scuole locali, incasso comunale delle tasse pagate dalle Ferrovie.
L’industria. Sarà la grande sostenitrice dell’operazione Alta Velocità in quanto farà i migliori guadagni con le commesse industriali relative. Almeno la sola linea in questione dovrebbe garantire alle industrie pesanti italiane un aumento del 20 per cento di produzione per i futuri quattro anni.
Volendo considerare la cosa da questo ristretto punto di vista, non è neanche positiva per gli interessi industriali in quanto li disequilibra, danneggia le catene di produzione e i progetti futuri produttivi, irrigidisce i progetti economici e pone le industrie davanti alla necessità futura di una ristrutturazione non sempre realizzabile, finite le commesse relative alla costruzione del treno.
Aspetti politici
Sono tutti fondati sulle coperture ideologiche: maggior numero di posti di lavoro, miglioramento d’immagine, democratizzazione della grande velocità nei trasporti, soddisfacimento di presunti bisogni delle masse.
Non sarà facile smontare questa ipotesi, in quanto anche gente che non è mai salita su di un treno e che ha sempre avuto a disposizione solo la bicicletta, si sente gratificata dalla possibilità di potere salire, quando che sia, su di un treno italiano che va a trecento chilometri all’ora.
I politici faranno leva su ciò. L’argomento critico qui fa poca presa sulla gente.
Aspetti economici
Le ferrovie come struttura produttiva di servizi in Italia sono arretrate e devono raggiungere la dimensione e il livello produttivo dello standard europeo.
In particolare è il servizio trasporto merci che è disastroso per l’economia nazionale, coprendo appena il 10 per cento della totalità dei trasporti, essendo il resto servito dal trasporto su gomma.
Il mercato che si apre alla grande velocità è quindi di almeno un altro 25 per cento delle merci da trasportare, con costi di gestione relativamente bassi, di certo molto più bassi di quelli dei Tir. In questo modo il settore viaggiatori potrebbe essere appena un’aggiunta complementare all’intero progetto economico.
Ma da questo punto di vista non si deve trascurare l’importanza che questo trasporto potrà avere per garantire una più veloce mobilità del lavoro, faccenda questa che interessa moltissimo alla ristrutturazione industriale italiana dei prossimi dieci anni.
[1995]
Violenza e stupidità
Dopo il film “Full Metal Jacket”, messo in onda da Canale 5, un mare di chiacchiere ci ha sommerso tutti riguardo lo spettacolo della violenza in TV. Alle 20,40 i bambini sono davanti ai televisori e far loro vedere uno spettacolo di violenza militare è grave fatto antipedagogico. Occorre pertanto che qualcuno intervenga, che lo Stato regoli, che i controllori della morale pubblica controllino, che gli educatori educhino, che i poliziotti arrestino, che i giudici condannino, e tutto il resto.
Ma il film di cui si parla, non è soltanto violento nelle sequenze e nella storia, è anche stupido. La violenza dell’ordine militare costituito è sempre stupida, e in questo senso torna anche utile come elemento pedagogico, per preparare i bambini alla stupidità del loro comportamento di adulti. Stranamente, la stupidità trasforma in oggetto fisicamente reale, qualsiasi fantasia, anche quella inverosimile dei film, per cui quanto più un film è stupido (e lo stesso si può dire anche per i libri), tanto più è utile dal punto di vista pedagogico.
Per far vedere, da un punto di vista non spettacolare, la stupidità della macchina militare (ricorrendo, per ipotesi, al film) occorrerebbe un prodotto intelligente, cosa che non è facile. E in questo caso sarebbe antipedagogico farlo vedere, perché educherebbe alla ribellione e all’indipendenza del pensiero, con relativa negazione della figura del “maestro”, cosa che tutti i pedagogisti (libertari compresi) negano e combattono.
Per lo stesso motivo è strana la decisione della Baviera di fare una denuncia legale per impedire la pubblicazione del Mein Kampf di Hitler in Svezia, visto che questo libro, eminentemente stupido, potrebbe utilmente dissuadere da qualsiasi rivolta e abituare all’ordine e all’obbedienza (le chiacchiere sull’antisemitismo si potrebbero facilmente spiegare in nota come personali stravaganze dell’autore), quindi avere un considerevole valore pedagogico.
Ma, come spesso gli accade, il potere non sa valutare bene i mezzi che ha disposizione. Fortunatamente.
[Pubblicato su “Canenero” n. 13, 3 febbraio 1995, p. 2]
Davide Visani
Una vita senza significato.
Davide Visani, funzionario comunista per tutta la vita, attuale coordinatore della segreteria del Pds e deputato progressita, è morto a Bologna. Passa tutta la vita nelle gerarchie del partito, arrivando prima al posto di segretario regionale dell’Emilia Romagna e poi di coordinatore della segretaria nazionale. È l’organizzatore vero e proprio della “svolta” organizzativa della vecchia struttura. A cercare a fondo nella sua biografia non si trova altro. Un piccolo uomo in nero, tutto casa e partito. Esemplare di una miriade di piccoli uomini in nero che incontriamo dappertutto, sempre pronti a servire gli ideali dell’ordine e del controllo. Il mondo dell’orrore non esisterebbe senza questi esemplari. La morte, ogni tanto, ne porta via uno.
Sempre troppo poco.
[Pubblicato su “Canenero” n. 18, 10 marzo 1995, p.11]
Bruno Visentini
Un aristocratico del dominio.
Bruno Visentini, uno dei maggiori finanzieri italiani della vecchia scuola, è morto a Roma per complicazioni polmonari. La sua figura non aveva mezze tinte. Teorico duro della finanza del dominio, economista fra i più reazionari, vicepresidente dell’Iri e della Confindustria, presidente dell’Olivetti, conclude la sua carriera come senatore della repubblica nel gruppo progressista. Sostenitore della morale di dominio, scelta che solo i grandi capitalisti possono permettersi, non ama che mezze figure gli taglino la strada. Per questo motivo sferza con l’acrimonia degli intellettuali vecchio stampo gentaglia come De Michelis o Formica, e non risparmia neanche nullità garantiste come Guido Carli o Giorgio La Malfa. Ministro delle finanze fra i peggiori, applica due pesi e due misure quando va a dirigere l’Olivetti. Insomma un uomo d’altri tempi, con la cultura d’altri tempi, con la passione per Wagner e per la letteratura tedesca, ma con l’occhio al portafoglio suo e degli altri. Se ci fosse dato scegliere i nemici, è uno come lui che sceglieremmo, se non altro per la sua aristocrazia di pensiero che gli impediva di camuffare da allodola le sue penne di falco. La morte lo ha tolto di mezzo.
Il suo ghigno sarcastico non saranno molti a rimpiangerlo.
[Pubblicato su “Canenero” n. 16, 24 febbraio 1995, p.11]
Volontariato
Il fatto che in un clima di generale disincanto e di ripristino dei valori assoluti della concorrenza e dell’efficientismo capitalista, ci siano persone che ancora ripresentano i valori della solidarietà e dell’eguaglianza, non può che essere un aspetto positivo. Ed è proprio questo aspetto, utopico nel senso migliore del termine, che attira molti giovani verso un impegno che, se da un lato li fa stare meglio, proiettandoli verso una progettualità “altra”, da un altro lato, li rende involontariamente complici di un progetto complessivo del potere che conta “anche” su di loro per completarsi in tutti i suoi aspetti.
Chiariamo questo concetto.
Le comunità, le cooperative, le botteghe commerciali, i gruppi alternativi che si dedicano al settore della solidarietà e della cooperazione sociale, sono gli elementi principali con cui l’intero sistema economico e politico ammortizza l’ingiustizia sociale proprio in quelle fasce e in quei settori dove essa permane maggiore e rischia di esplodere.
È proprio questo settore che ha arginato lo sbando di una generazione passata di “rivoluzionari” che, avendo perso il partito-papà e smarrito l’ideologia-mamma, si erano ritrovati senza guida e senza idee. E il volontariato li ha ricondotti con i piedi per terra, impedendo loro di vedere al di là del proprio naso, e quindi nullificando quegli incidenti di percorso che avrebbero potuto spingerli verso una pratica di trasformazione sociale del tutto nuova e questa volta veramente rivoluzionaria.
È proprio questo settore che sta gestendo le situazioni a rischio più estreme, facendo da tappabuchi e intervenendo specificamente nei momenti in cui le contraddizioni esplodono più violente e irrecuperabili con i classici metodi repressivi dello Stato. E la coscienza di questa funzione istituzionale il settore del volontariato l’esprime chiedendo finanziamenti precisi attraverso una legge quadro sull’associazionismo: utopisti sì, ma fessi perché?
È proprio questo settore che individualmente fornisce un prodotto molto importante: il senso di fare qualcosa. Così tutti coloro che si sentono male a causa del fatto che ingiustizie vergognose dilagano per il mondo, dove metà della popolazione muore di fame, comprando nei negozi “alternativi”, che acquistano i prodotti all’origine pagandoli a un giusto prezzo (?), si sentono a posto con la propria coscienza.
È proprio questo settore che ha diffuso l’idea, di per sé nefasta, del chiamarsi fuori, del considerarsi assolto da un impegno distruttivo diretto, proprio a causa del semplice fatto di individuare un settore economico esente da inquinamento capitalista. Così ci si illude che investendo il proprio denaro nelle banche “alternative” non lo si indirizzi verso speculazioni di morte, così ci si illude che comprando nei negozi “alternativi” si boicotti la produzione capitalista mondiale e si alimenti un canale esente da responsabilità e da genocidi.
A chi possiede una sia pur minima idea di come funziona l’economia a livello complessivo, sarà chiaro il fatto che acquistando nel cosiddetto Terzo mondo prodotti a prezzi superiori, quindi non concorrenziali, non si blocca affatto la vendita degli stessi prodotti alle grandi multinazionali, ma anzi la si favorisce, perché i produttori, avendo a disposizione un minimo di guadagno in più (che resta per altro trascurabile considerando l’entità della domanda alternativa), possono contrattare meglio, in una posizione di maggiore pressione, con le grandi multinazionali, ottenendo prezzi più alti, prezzi che queste ultime potranno sempre offrire avendo grandissimi margini di profitto e non trattandosi, dopo tutto, che di piccoli aumenti. Per un altro lato, questa politica di maggiori introiti, sia da parte degli acquirenti alternativi, sia da parte di quelli multinazionali, non può non dare vita a una classe di arricchiti locali i quali finiranno per produrre, inevitabilmente, non migliori condizioni per tutti nelle aree in discussione, ma solo per un numero ristretto di nuovi ricchi.
Questa valutazione non è dettata dalla logica del tanto peggio tanto meglio, ma da due considerazioni: primo, non si può parlare di solidarietà e di uguaglianza all’interno del medesimo sistema capitalista, secondo, non si aiuta il Terzo mondo aumentandone i profitti. La prima considerazione si basa sul fatto che il sistema capitalista a livello mondiale è un tutto chiuso che non ammette logiche diverse al proprio interno, se non in fase recuperativa e integratrice degli scompensi marginali. La seconda considerazione si basa sul fatto che una nazione, un paese che ha un reddito pro-capite bassissimo, non l’aumenta (se non dal punto di vista statistico) con il semplice accrescersi delle entrate dovute alle esportazioni. Infatti ci sarà sempre una classe di privilegiati, gestori del potere economico e politico locale, che guadagnerà di più e terrà il resto della popolazione nelle stesse condizioni miserabili di prima.
Per questi motivi, e per altri dei quali avremo occasione di parlare in seguito, il volontariato costituisce oggi uno degli sbocchi più importanti per le scorie d’ingiustizia sociale che il capitalismo produce a livello mondiale.
[Pubblicato su “Canenero” n. 2, 4 novembre 1994, p. 5 col titolo “Aspetti involontari del volontariato”]
Eugene Wigner
Tutte le carte in regola.
Eugene Wigner, premio Nobel per la fisica, è morto a Princeton colpito dal morbo di Alzheimer. Si può dire che in lui si riassumevano tutte le peggiori condizioni dell’uomo come tecnico e come intellettuale. Ungherese, figlio di ricchissima famiglia, frequenta grandi università tedesche e ha professori di fama mondiale, fra i quali Heisenberg e Hilbert. Oltre a essere fisico teorico è anche ingegnere chimico, per cui viene chiamato da Fermi a collaborare alla risoluzione dei problemi tecnici che renderanno possibile la costruzione della bomba atomica. Anzi, lui è uno dei firmatari della lettera che Einsten scrive a Roosevelt per fargli presente la possibilità di costruire la bomba. Ma Wigner non ferma qui le sue responsabilità. Sulla scia di altri matematici e fisici ungheresi, come Von Neumann, Szilard e il tragico Teller, quest’ultimo autore della bomba all’idrogeno, collabora costantemente con il governo americano per la produzione dei reattori atomici e per la risoluzione dei problemi di ingegnieristica legati all’industria militare. Negli ultimi anni il suo viscerale anti-comunismo e i suoi tragicomici sentimenti patriottici l’avevano portato ad aderire ufficialmente alla setta del reverendo Moon, una specie di santone molto conosciuto per la predicazione religioso-millenaristica, ma anche per i suoi buoni affari con gli ambienti dell’estrema destra americana.
Tutto qui, e non ci sembra poco.
[Pubblicato su “Canenero” n. 12, 27 gennaio 1995, p. 11]
Harold Wilson
I pericoli dell’onestà.
Harold Wilson, primo ministro laburista inglese degli anni Sessanta e Settanta, è morto di cancro a Londra. Fin da giovane si distingue per le sue abilità di politico e per la sua specchiata onestà. Da tutti gli scandali dell’epoca, famoso quello che coinvolge il ministro Profumo e quindi distrugge il governo McMillan, egli viene fuori sempre pulito, costando caro agli Inglesi che in questo modo non si accorgono dei guai e delle avventatezze che continua a commettere nelle varie occasioni di politica interna e internazionale. Dalla crisi della sterlina alla ribellione della Rhodesia, dalle condizioni di fame in cui si viene a trovare una gran parte dei lavoratori (svenduti senza mezzi termini) ai gravissimi guai combinati nell’Ulster. Wilson è il campione di tutti questi disastri costati sacrifici e guai ancora oggi non del tutto superati. Da ultimo, pur restando lontano dal giro dei miliardi che continua ad arricchire i politici emergenti, come a esempio la Thatcher, ha il gigionismo tipico dei poveri di spirito: accetta il titolo di lord e muore quindi come lord Wilson of Rievaulx. L’imbecillità riesce difficilmente a nascondersi: prima o poi le spunta fuori la coda. Mai fidarsi dei virtuosi.
[Pubblicato su “Canenero” n. 29, 2 giugno 1995, p.11]
George Woodcock
Una vita da storico.
George Woodcock è morto a Vancouver all’età di 82 anni. Molti anarchici hanno avuto occasione di gustare la lettura della sua Storia dell’anarchia, tradotta in italiano per le edizioni Feltrinelli. Un libro disgustoso. E anche lui era un individuo disgustoso. Un professore di storia vanitoso, bugiardo e pettegolo, oltre che opportunista e incapace di distinguere una tesi anarchica da un mazzo di cavoli. Ma una cosa aveva di buono: era un uomo preparato nel suo campo e i suoi libri, almeno quelli in inglese, erano del tutto esenti da errori di ortografia. A questo proposito, non sapendo che altro dire in merito al carro funebre su cui facciamo fuoco, ecco una barzelletta ebrea che potrebbe essere di conforto a coloro che ci hanno rimproverato di “parlare male dei morti”. Diffusasi la notizia della morte di Hitler, qualcuno chiede al Rabbi: “Che cosa di buono puoi dire di lui?”. Il Rabbi ci pensa su un poco e poi, ricordandosi dell’obbligo di non parlare male dei morti, dice: “Bene, nel Mein Kampf non c’erano errori d’ortografia”.
[Pubblicato su “Canenero” n. 21, 31 marzo 1995, p. 11]
Questo sito, oltre a informare i compagni sulle pubblicazioni delle Edizioni Anarchismo, archivia in formato elettronico, quando possibile, i testi delle varie collane.
L’accesso ai testi è totalmente libero e gratuito, le donazioni sono ben accette e servono a finanziare le attività della casa editrice.
