Prima edizione: La Fiaccola, Ragusa 1975
Seconda edizione: Anarchismo, Catania 1981
Terza edizione: Anarchismo, Trieste dicembre 2013
Le Annotazioni di Amfissa sono state pubblicate in traduzione greca in opuscolo col titolo Καταστροή του κεφαλαίου και γενικευμένη αντοδιαχείρηση s. l. 2012.
Alfredo M. Bonanno
Autogestione e anarchismo
Terza edizione riveduta e corretta con l’aggiunta delle Annotazioni di Amfissa
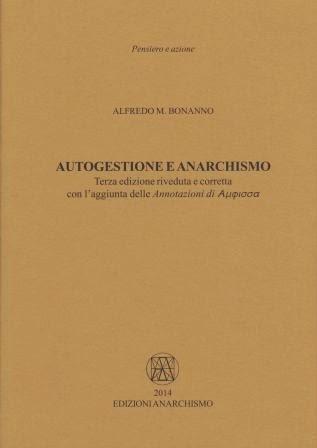
Introduzione alla terza edizione
Nota editoriale indispensabile
Introduzione alla seconda edizione
Nota introduttiva alla prima edizione
Autogestione della rivoluzione
Autonomia della classe lavoratrice
Superamento della divisione del lavoro
Sviluppo della capacità creativa
Autogestione ed espropriazione rivoluzionaria
Superamento dell’anarchismo idealista
Le basi di un anarchismo materialista
Lotta di classe e autogestione
Il problema della scelta dei mezzi e del condizionamento dei fini
Scelta dei mezzi e crescita del movimento operaio
Coabitazione col potere e autogestione
Alternativa all’ideologia della produzione
Autogestione e scelte economiche
L’azione della minoranza anarchica
Sull’organizzazione autonoma del proletariato
Autogestione e dominio reale del capitale
Dibattito sull’autogestione con “Tribune Anarchiste Communiste”
Intervento di “Tribune Anarchiste Communiste”
GEPI. Un esempio di destrutturazione del capitale
Verso il dominio reale del capitale
Autogestione, dominio reale e pace sociale
Aspetti tecnici dell’autogestione realizzata alla LIP
Bollettino n. 1 dell’11 giugno 1973
Bollettino n. 2 del 19 luglio 1973
Bollettino n. 3 del 27 luglio 1973
Bollettino n. 4 del 2 agosto 1973
A mia figlia Tatiana
* * * * *
“I magni si mettano d’accordo con se medesimi, poiché in pari tempo predicano la dignità del lavoro e, più esplicitamente, la redenzione da esso”.
(T. Landolfi, Rien va)
Introduzione alla terza edizione
I clamori dell’attenzione di chi pensa sempre di stare sulla cresta dell’onda si sono spenti sul problema autogestionario. Non se ne parla. I reduci sono tornati ai vecchi baloccamenti e si limitano a raccontare le passate glorie, infiocchettando il racconto con qualche esagerazione che tanto non guasta. I fronzoli si sa è meglio che siano sovrabbondanti.
Andando al nocciolo delle cose il problema dell’autogestione, prima o poi, si ripresenterà. Macchiato sanguinosamente dalla protervia dei padroni, che considerano questa via come una sorta di tesoretto di riserva, oppure esaltato dal movimento insurrezionale del futuro che, pagando ancora una volta col proprio sangue, finirà per riscoprire quello che il passato ci ha messo sotto gli occhi, sotto i nostri occhi miopi.
Mi viene voglia di tagliare qui l’argomento, che troppo stanco sono di pestare acqua nello stesso mortaio e troppo stanchi dovrebbero essere i miei pochi lettori di guardare il mio tramestio indaffarato. Eppure i sogni sono sempre qui, compagni insofferenti di viaggio, si agitano e sbuffano e vogliono dire la loro e non accettano di essere messi da parte.
Ancora una volta tocca alla parola, alla mia parola, e tocca pure al problema dei miei rapporti con la parola, con quello che con la parola riesco a dire (o a non dire).
La memoria, le tecniche della memoria, aumentano la capacità di sentirmi padrone di me stesso, anche ora che sono avanti con gli anni questo convincimento, se si preferisce, questa illusione, non mi abbandona. L’esperienza della LIP in Francia, ad esempio, un momento, uno dei miei migliori momenti, andato perduto per sempre, è qui, accanto a me che scrivo queste righe, adesso, ed è arrivato attraverso una fessura del tempo troppo sottile per farci passare un supporto fisico differente dalla memoria.
Per evitare che questo miracolo fuoriesca e vada perduto lo devo vestire con le parole, e qui la confezione è un procedimento d’amore, quindi una commistione di coraggio e avventatezza, di eccesso e di coinvolgimento.
La parola ha così un tempo nuovo da proporre, e lo coordina con un luogo nuovo che dall’assenza si sposta sul futuro, in un avvento possibile che dal passato riceve il legame della rammemorazione. Ogni ritorno su queste progressioni nuove ha una base tautologica che concresce su se stessa, fondamento di novità e reiterazione, aspettativa e disinganno, falsità e corteggio globale di modulazioni sempre differenti.
Questa vita interna alla parola approfondisce gli intrecci e i ritmi li modula in una maniera più ampia, regolando con le proprie pulsazioni sia il riferimento all’esperienza diversa, ora assente, sia l’orizzonte dell’attesa, ora presente, senza che il destino possa non corrispondere al gioco delle possibilità. Più questo intreccio si arricchisce di volute che appaiono perfino chiuse in se stesse, prive di sbocchi, false e depistanti, e più l’infallibile risposta del destino si approssima a realizzarsi. La parola mi dice che l’attesa è vicina a vedere compiersi la possibilità del tempo nuovo.
Datazione di testi, collocazione di date tra parentesi quadre, è come aggirarsi nei viali dei cimiteri. Eppure non è soltanto così. C’è in tutto questo una nuova sfida. La chiarezza è la degna comare dell’imbroglio. Le parole hanno una profondità che non lascia tracce alla superficie, esse appaiono così disseccate in una sorta di insipidezza che le colloca nella formalina dei vocabolari, cimiteri, questi sì, del di già detto. Eppure, non appena si solleva un primissimo strato sotto appare l’insolita veste dell’arbitrario, il fiorire tracotante e irregolare di una originalità che niente potrà mai regolare definitivamente. Ciò perché non c’è mai stato, nel battere il ferro quando era caldo, un interesse altro, un tentativo di ricavare qualcosa di utile, qui per me, qualcosa che mi salvaguardasse la vecchiaia, non c’è mai stata una riserva mentale, un calcolo del più e del meno, un bilancio patrimoniale. Leggere e ascoltare, oggi, gli ordinati oratori dei cosiddetti critici mi fa venire il voltastomaco se penso alla virulenza e alla forza di Lutero, di Savonarola, di Segneri. La chiarezza qui non è di casa, l’attacco a fondo sta a fianco della frase cortese che prepara una stoccata ancora più grave. Gli enigmi e le ridondanze propongono scossoni alla coscienza e la sottopongono a un viaggio disagevole. Ma la vita è un viaggio che sgomenta e che non tutti sono in grado di affrontare.
Trattandosi di problemi economici sono tentato di fare appello alle mie competenze, pergamene di laurea, antichi ricordi di tomi sfogliati e digeriti, la mia amata matematica, i miei sogni metalinguistici, i calcoli con infinite variabili quantitative sempre pronti in apposite cartelline colorate. Poi il disgusto. Nessuna oggettivazione è possibile, bene, ma quali sono i sacrifici che impone qualsiasi processo assolutamente altro, a cominciare dal silenzio?
No, non sono d’accordo. Il silenzio è pieno di parole, di minacciosi riferimenti a mancanze, paure, incertezze, sospensioni di responsabilità e tutte le ombre delle lunghe notti passate a guardare i pochi metri quadrati dell’isolamento carcerario. La rinuncia alla condizione immediata del mondo, la possibilità limite di un non ritorno, la desolazione eterna della cosa, la morte, è ancora contro di loro che combatto.
Se mi impregno della qualità, e perdo per sempre il contatto con il mondo da me creato, posso andare avanti all’infinito, chiuso nella mia ormai incomprensibile corazza. Ma non sono un privilegiato e nel mio petto non batte un cuore di coniglio.
La tensione anarchica è l’espressione più chiara del nulla, non conosco qualcosa che renda meglio questo universo sconosciuto. Le parole la violentano nel tentativo di riempire quel nulla. Ogni tentativo del genere è un modo di salvarsi la vita. L’indifferenza non è una modulazione accessibile del fare, lo costituisce ma come elemento oggettuale, quindi accidentale ed estraneo. Per un altro verso, l’impegno del fare è falso, non è coinvolgimento ma accidente. Se forzo la mia volontà non avvicino l’indifferenza, al contrario l’allontano. La strada più accettabile è sempre quella più lunga e tortuosa. Abbandono e indifferenza non sono la stessa relazione. Il demone alberga nei posti più strani.
Niente lunghe elencazioni esplicative. Documenti che propongo, quasi certamente per l’ultima volta, in un luogo fisico, un libro, pagine di un libro, dove troveranno la loro fine corsa, almeno per quel che mi riguarda. Eppure non sento odore di crisantemi.
A lungo andare, il percorso della parola riesce a delineare sullo sfondo indicazioni improvvise, capaci di fare esplodere l’assenza, non sono semplici ampliamenti della memoria, ma luci e riflessi che riecheggiano, in modulazioni e movimenti contraddittori e spazi impensabili, il dire di fondo, il muoversi costante e creativo della parola rammemorante. Il tempo, allungandosi, getta ombre che coprono le possibilità di comprensione, fatti sfumano e si confondono, richiedono nuova linfa interpretativa. Non sempre è possibile evitare riflessi che ingannano anche l’orecchio e l’occhio più esercitati. Uno scarto, a volte consistente, a volte quasi minimo, tale da perdersi nell’interstizio del ricordo giacendo incompreso. Questo scarto è cambiamento profondo pure non essendo cambiamento radicale, è frattura nella traccia del dire.
Non ho cercato di metterci una medicazione, la cattiva coscienza è uno dei camminamenti di disturbo della ferrea custodia del controllo, e forse in molti casi non è neanche volontaria, ma a volte compare improvvisamente la considerevole consistenza di un vagito, un fremito di ali, un calore di sole cocente sulla faccia coperta da un velo leggero, un presente che non vuole ammettere il passato che si difende dichiarando ostracismo e fissando vendette.
La volontà di attaccare, di sgominare il nemico, torna a dominare e il suono si fa ancora più prossimo. La stessa incomprensione è desiderio, qualcosa che venero perché preservato da quella condizione degradante che chiamo chiarezza a portata di mano. Libero in questo modo il mondo dalla sua sufficienza ovattata e lo pongo nuovamente in una dimensione che esclude la limitazione, che cancella tutto quello che limita. Profano, con le mie scarpe infangate e da allora mai pulite, tutto ciò che propone sacralità e limitatezza non profanabile. Predispongo l’illusione che trova modo di collocarsi al posto della certezza che mortifica.
La lotta, e la pietà che pretende gestire la conoscenza, non si sposano facilmente. La parola è un’arma che viene a volte gestita con pietà, in modo maldestro e sciocco. Danzare con le parole, farle apparire leggere e diafane, quando possono anche essere pesanti e mortali, vuole dire accreditare loro una funzione che esercitano solo per conto dell’imbroglio, di chi gestisce il potere. Certe sfumature possono starci nelle parole e così venire raccolte, ma non si tratta di fervore dissacratorio, solo trascurabili raffinatezze. Volere essere inumani con le parole non è difficile, alla fine si tratta di strillare di più, ma è faccenda per spiriti deboli, addentrarsi invece nella loro possibile oscurità è altra questione, qui si sollevano di colpo vertiginose profondità che nessuno aveva mai sospettato, senza con questo indicare la strada per arrivare fino in fondo. La rigidezza e il completamento non sono stimoli per l’uso del dire, nel senso in cui l’intendo io, sono solo appesantimenti e titubanze.
Andiamo insieme, ancora più oltre.
Trieste, 15 maggio 2008
Alfredo M. Bonanno
Nota editoriale indispensabile
La prima edizione di questo libro venne preparata a Parigi agli inizi del 1975 per conto delle Edizioni Spartacus. René Lefeuvre mi aveva infatti suggerito l’idea di mettere insieme il materiale da me pubblicato su riviste e giornali e di fare un libro adatto alla situazione francese e allo stato delle ricerche sul problema dell’autogestione in quel paese che, come si sa, era ed è molto più avanzato di quanto non sia in Italia. La traduzione del dattiloscritto, fatta da Frank Mintz, non piacque all’editore che decise di non pubblicare il libro fin quando non si disponesse di una nuova traduzione che, fatta successivamente da Isabella de Caria, non mi sembra sia stata a tutt’oggi pubblicata.
Nel settembre del 1975 si presentò una favorevole occasione di stampare il libro in italiano con le Edizioni La Fiaccola di Franco Leggio, anche per le condizioni vantaggiose fatte dal tipografo. Non essendoci il tempo di aggiustare il dattiloscritto, adattandolo meglio alla situazione italiana, si preferì stamparlo per come stava.
Per la seconda edizione italiana ho riscritto le parti che avevano, nel frattempo, trovato collocazione in libri usciti in Italia. Ho lasciato, con l’indicazione della fonte, le parti che erano state pubblicate, sempre in Italia, su giornali, ciclostilati, riviste e come introduzioni.
Infine il libro è stato aggiornato con un approfondimento degli aspetti più recenti e più interessanti del problema dell’autogestione dal punto di vista rivoluzionario.
La terza edizione presenta, oltre a qualche aggiunta di poca importanza, il saggio su “La lotta della LIP”, che ritengo particolarmente significativo, e le Annotazioni di Amfissa
Introduzione alla seconda edizione
Non è possibile considerare il problema dell’autogestione come qualcosa di esclusivamente tecnico, legato soltanto alla realtà di fabbrica o alla situazione produttiva delle campagne. Per questo motivo non è facile stendere un’analisi che possa risultare accettabile per lunghi periodi, proprio perché non solo si modificano le situazioni produttive, ma si modificano le strategie rivoluzionarie a seguito degli accorgimenti adottati dal capitale per realizzare lo sfruttamento.
L’autogestione non è quindi solo il problema di come fare funzionare la società futura, una volta che la presente venga distrutta dall’evento rivoluzionario. Autogestione è anche, e principalmente, autogestione dell’insieme delle lotte, processo che si struttura in forma autorganizzata all’interno del movimento degli sfruttati.
Quindi il problema non è più solo di che cosa fare dopo, ma anche di che cosa fare adesso.
Le analisi sull’autogestione, così fondate, dovrebbero contribuire a dare chiarimenti teorici e tecnici, sia sul possibile funzionamento di una società autogestita, sia sulle possibilità di autorganizzazione delle lotte oggi, davanti a un nemico che ha appreso una formula di attacco che comincia con la destrutturazione dei modelli produttivi del passato. È chiaro che davanti a questi nuovi processi repressivi non ci si può presentare con le forme aggregative del passato, di tipo sindacale, facilmente nientificabili in un’ottica che tende di già ad atomizzare i luoghi di produzione.
La separazione tra lavoro e lavoratore, tra prodotto e produttore, e il rapporto alienante che ne deriva, trova riflesso immediato nel rapporto tra cosa e consumo, atto supremo del produttore nella sua veste di consumatore, sacrificio della merce e ripristino della sacralità del capitale nel pieno del suo flusso mercantile.
Tutto ciò sta finendo di distruggere le illusioni di ricostruire l’identità dell’uomo attraverso il re-impadronimento di quanto sfuggiva nel processo alienante della produzione. Il meccanismo dialettico era troppo semplicistico, o troppo scoperto. Il capitale sta costruendo a grande velocità modelli alternativi di “tempo libero” che dovrebbero, nei suoi deliri onirici a fondamento elettronico, sostituire le manifestazioni di rigetto da alienazione. Comunque il bisogno intrinseco di questa scappatoia, intrinseco alla massa produttrice/consumatrice, è tanto forte che da se stessa, quest’ultima, sta da tempo provvedendovi, anche attraverso l’utilizzo dei “paradisi artificiali”, del “misticismo”, della “fuga a Oriente”, e così via.
Certo, la danza più avanzata la conduce, nella fase del recupero, sempre il capitale. Sono i suoi teorici a indicare le strade maestre della produzione destrutturata, dell’isola della calma all’interno del viaggio infernale del lavoro. Il movimento rivoluzionario, per quanto faccia, spesso non è che ben povera cosa, in merito a iniziative del genere.
Dalla sua ha solo una forza: una grande forza, quella che gli viene dai processi autorganizzativi che si sviluppano al suo interno, anche all’interno della ricerca della vita, della gioia, anche all’interno del rigetto della dimensione produttivistica, del sacrificio, della morale cristiana, del modo borghese di valorizzare.
Ricordiamo quante riflessioni e quante preoccupazioni c’era costato il grosso problema della produzione autogestita in una situazione di assenza del mercato: la necessità di arrivare a quantificare il suo valore in un momento in cui, abolendosi la merce-denaro, tutto sembrava affondare nelle nebbie del baratto.
Adesso, le esperienze di questi ultimi anni ci fanno sollecitare interventi più originali del tradizionale rinvio al computo del tempo di produzione. Perché la rivoluzione non dovrebbe essere anche l’uccisione del tempo? Gli operai rivoluzionari della Comune di Parigi non sparavano forse sugli orologi? Perché non pensare possibile un modello di contabilizzazione che non tenga conto né del denaro (abolito) né del tempo (abolito anch’esso)? Cosa ci impedisce ciò se non la nostra antica ottusità?
Cosa fare adesso? Cosa fare dopo? Ecco, appunto! Autogestire la distruzione della morte, e il regno della morte, da sempre, è stato il regno della sacralizzazione del lavoro.
Catania, giugno 1979
Alfredo M. Bonanno
[Pubblicato su “Anarchismo” n. 26-27, 1979, pp. 72-73, col titolo “Cosa fare adesso. Cosa fare dopo”]
Nota introduttiva alla prima edizione
Problema di domani questo dell’autogestione, ma problema che può assumere la doppia prospettiva dello sfruttamento più razionale o della liberazione totale. Oggi, in una realtà pre-gestionaria, possiamo solo accennare per sommi capi alle condizioni che permettendo la liberazione impediscono l’utilizzazione repressiva dello stesso concetto di autogestione.
Il potere ha oggi la caratteristica di utilizzare in senso repressivo e mistificante le stesse parole d’ordine della lotta di classe. Ciò è particolarmente vero per quanto riguarda l’autogestione.
Il lavoro che presentiamo trova origine da ricerche condotte negli ultimi anni intorno al problema dell’autogestione e alle condizioni necessarie della sua interpretazione rivoluzionaria.
O l’autogestione è autogestione della rivoluzione e della produzione o non è autogestione. Nel caso venisse limitata solo all’autogestione della produzione, nella persistenza di un potere centrale, il lavoratore autogestirebbe solo la propria miseria e il proprio sfruttamento.
L’anarchismo si riconosce nella strategia autogestionaria solo se questa è rettamente intesa nella sua visione globale di autonomia della lotta rivoluzionaria e autonomia dell’organizzazione della produzione. In questo senso la fecondità delle ricerche sulle forme produttive libertarie e sulle possibilità di una rivoluzione sociale anarchica, è enorme e ancora quasi tutta da scoprire.
Catania, settembre 1975
Alfredo M. Bonanno
* * * * *
“Il dogmatismo che la filosofia della scienza ci porta a combattere non riguarda solo il campo delle religioni, ma pressoché tutti gli istituti più rispettabili sui quali si regge la nostra società: dall’istituto della famiglia a quelli dell’economia e della vita societaria”.
(L. Geymonat e G. Giorello, Le ragioni della scienza)
Il concetto di autogestione
Autogestione della produzione
Il problema dell’autogestione è di moda. Molto più negli altri paesi, un poco meno in Italia, dovunque si parla di questa “nuova” forma di organizzare la produzione. Alcuni si dicono favorevoli all’autogestione, senza sapere bene di cosa si tratta, altri la combattono, restando nella stessa ignoranza. I partiti politici di sinistra strappano, qua e là, qualche parola d’ordine, guardando con un occhio la Jugoslavia e con un altro l’Algeria. I sindacati scadenzano per un prossimo futuro questa parola di lotta, sperando di portare le cose per le lunghe, salvando capra e cavoli, la propria poltrona e la faccia davanti ai lavoratori.
Anche fra i movimenti di sinistra, non richiamati nell’area dei partiti tradizionali, la conoscenza dell’autogestione è superficiale e confusa. Resterebbe il movimento anarchico che, per motivi che vedremo più avanti, avrebbe dovuto per tempo sviluppare questo problema: ma non riteniamo che lo abbia fatto.
Resta da dire che il principio autogestionario non può essere separato da una critica della realtà nei suoi aspetti centralizzatori; per cui non basta dire che cosa bisogna intendere per “autogestione”, ma occorre anche indicare i pericoli di una impostazione economicista e le degenerazioni visibili nei tentativi di realizzazione già compiuti.
Partendo dall’uomo, il “fatto” autogestionario riveste una luce e una qualificazione tecnica diverse; partendo dalla necessità produttivistica e dall’efficienza neocapitalista, esso scade in una ulteriore forma di sfruttamento, più sottile e più pericolosa.
Non possiamo considerare l’autogestione come faccenda puramente tecnica, da codificarsi e incanalarsi dentro precise direttive, sia pure decise dalla base, ma con caratteristiche di natura tecnico-organizzativa soltanto. Ciò significherebbe ridurre l’autogestione al problema di come fare funzionare la società futura, una volta che la presente venga distrutta dall’evento rivoluzionario. È ovvio che questa concezione deve essere corretta. Autogestione è anche, e diremo primariamente, autogestione delle lotte che porteranno la classe degli sfruttati a distruggere il potere dei padroni. In altre parole, non possiamo sperare di costruire una società futura autogestita partendo da un’organizzazione piramidale della lotta costruita da un partito o da una casta dirigente a carattere professionale.
Il problema non è soltanto cosa fare dopo, ma è, principalmente, che fare ora, perché, dopo, non ci si trovi davanti a strutture che renderanno inutili gli sforzi dei lavoratori.
Da una ricerca sull’autogestione ci si deve aspettare: chiarimenti teorici e tecnici sulla possibilità di funzionamento di una società autogestita, ma anche chiarimenti sulla possibilità di autogestire le lotte oggi, di fronte a un nemico che ci attacca e finisce per strumentalizzare le nostre stesse parole d’ordine.
Il potere potrebbe oggi, in una situazione di sfruttamento capitalista, inglobare l’idea di autogestione per trasformarla in uno sfruttamento più raffinato del lavoratore. È questo l’esempio che ci viene dai paesi dove l’autogestione è stata applicata, o si è cercato di applicarla, in presenza di un potere centralizzato a struttura burocratica. Si è visto che il lavoratore, caduto nel tranello, in questo modo, se gestisce qualcosa gestisce solo la propria miseria.
Quindi, prima autogestione delle lotte, dopo, distrutto il potere padronale, autogestione del lavoro e della società.
Il pericolo maggiore, in questo senso, potrebbe venire dalla collaborazione che i sindacati prestano ai padroni. Attraverso di essa si potrebbero realizzare processi produttivi autogestiti, situazione di programmazione centralizzata, per cui si avrebbe un acceleramento dell’alienazione, uno sfruttamento gestito dallo stesso lavoratore, tutto mascherato sotto il simbolo dell’autogestione e della costruzione, progressiva, della società di domani.
È in questo senso che ci si deve chiedere: va bene l’autogestione, ma con quali scopi e per conto di chi? Se gli scopi sono quelli del produttivismo, se un ansimante sistema economico trova la soluzione delle proprie crisi ricorrenti nello spingere i lavoratori verso la falsa prospettiva di una partecipazione alla direzione dell’impresa, allora, questa autogestione non fa per noi. Allo stesso modo, se l’autogestione deve essere organizzata dall’alto per conto di un partito o di un gruppo di persone che si arrogano il diritto di utilizzarla per “costruire il socialismo”, anche questa non fa per noi.
[Per questo paragrafo vedere: Introduzione a “Noir et Rouge”, Lo Stato, la Rivoluzione, l’Autogestione, Ragusa 1974, pp. 7-20]
Autogestione della lotta
L’autogestione della lotta e l’autogestione dell’economia presuppongono l’organizzazione rivoluzionaria della lotta, voluta e determinata dalla base, e l’insieme delle imprese di produzione nelle mani dei lavoratori. I partiti e i sindacati sostengono che per arrivare a questo si deve passare attraverso la fase sperimentale e provvisoria costituita dalla lotta rivendicativa, come pure dalla fase autogestionaria orchestrata dai padroni e dai loro intermediari. Per noi quello che conta è che queste proposte vengano viste bene dalla base per quello che sono: strumenti di affermazione di un potere nascente che intende sostituirsi al vecchio potere del capitale. Contro di esse non esiste altro che la lotta e la preparazione delle masse all’autogestione.
Qui il discorso si trasporta sul piano organizzativo del movimento rivoluzionario che propone il discorso autogestionario. Se alla base della proposta c’è una intenzione centralizzante essa suona stonata. È in questo senso che risultano poco credibili le proposte marxiste di costruire una società futura, in forma autogestionaria, con la presenza di uno Stato – pure proletario – che si assuma l’onere di centralizzare ogni forma di iniziativa popolare, nel campo delle lotte come in quello dell’organizzazione tecnica delle imprese produttive. In questo modo, le migliori intenzioni abortiscono nello stalinismo, insito in ogni discorso che fa della sopravvivenza della struttura il primo scopo della struttura stessa.
La prova più valida della frattura che esiste oggi tra i compiti tradizionali delle organizzazioni dei lavoratori (fra i quali figurava lo sciopero generale come anticamera della rivoluzione sociale), e quelli ai quali in effetti queste organizzazioni oggi si dedicano, è data dal fatto che lo sciopero, smarrendo il suo iniziale significato di lotta diretta, proveniente dalla base, si è trasformato in strumento di compromessi politici ed economici, operati sulla pelle dei lavoratori. E, come è naturale, cadendo lo sciopero cade il concetto stesso di strada verso la rivoluzione sociale, passante attraverso le organizzazioni dei lavoratori. Con questo fallimento cadono pure i concetti di “libertà nel lavoro” e di autogestione.
È in questo senso che diciamo che l’autogestione che viene proposta dai politici è vuota di contenuto: una formula astratta che quando è stata attuata in certe situazioni storiche, a parte lo spirito di sacrificio e l’iniziativa dei lavoratori, si è sempre conclusa con un fallimento.
Autogestione della rivoluzione
La nostra prospettiva rivoluzionaria parte da una considerazione fondamentale: le rivoluzioni le fanno le masse e le fanno perché si trovano in una certa situazione di sfruttamento, di alienazione, di disumana progressiva eliminazione di ogni aspetto positivo della vita. Il lavoro rivoluzionario resta quindi sempre un fatto complessivo, collettivo, della massa nel suo momento di stimolo coscienziale di classe, mai un fatto ristretto ad alcuni individui.
Oggi non è più possibile cadere nell’illusione di un vago populismo o di un operaismo di maniera. Tanto meno si può fare credito a una prospettiva di universale pacificazione. L’analisi degli interessi delle classi contrastanti e delle loro contraddizioni è tanto chiara da non lasciare dubbi, come poteva accadere ai rivoluzionari del 1848. Se proprio la storia deve insegnarci qualcosa, ci insegna che le rivoluzioni vere, quelle che determinano il progresso, sono attuate con un movimento delle masse, un movimento che trova radice nella loro situazione di sfruttamento, nella modificazione e nel deterioramento di quelle che furono le condizioni economico-sociali e culturali precedenti.
L’uomo, nella società dei consumi, si trova in una situazione di autosfruttamento. Tutto lo spinge verso un vicolo cieco, come l’operaio che fa lo straordinario per pagarsi la macchina che poi non può usare perché lavora per acquistarla. Tutto agisce sull’individuo spingendolo verso una forma di autosfruttamento: il suo posto nella società dipende spesso dal modo in cui può vestirsi, dalla casa che abita e dall’automobile che possiede.
Mutate le condizioni esterne della gestione del potere, questa forma di autosfruttamento persiste e prende il nome di autogestione della produzione in regime centralizzato.
In effetti, il concetto di autogestione parte dal fondamentale concetto di autonomia e di responsabilizzazione degli individui. Solo ottenendo un minimo di autonomia il singolo può svegliare le proprie forze vitali che lo spingeranno verso orizzonti più ampi di responsabilizzazione: qui comincia la storia dell’autogestione.
La caduta progressiva delle abitudini e dei modi di essere voluti dalla tradizione, il disfacimento dei valori del passato che reggevano i pilastri fondamentali dello sfruttamento, lo smascheramento lento ma progressivo delle forze che si celavano dietro i tradizionali concetti di patria, di onore, di famiglia, di purezza, ecc., tutto questo, in un insieme organico, getta le basi dell’autogestione.
E, in questa dimensione, si colloca il progetto rivoluzionario, come progetto altamente autogestito, anche se non ciecamente affidato alla “buona volontà” degli uomini o all’“armonia” delle leggi di natura.
Il progetto rivoluzionario deve essere fondato sull’autogestione, ma quest’ultima non appartiene alle condizioni essenziali che rendono possibile l’avvenimento rivoluzionario. Quest’ultimo può verificarsi anche in assenza, o di fronte a una scarsa crescita della coscienza autogestionaria, e allora essere destinato a un fallimento più o meno precoce, a un aborto in senso autoritario. Ogni illusione, più o meno in buona fede, come quella della dittatura del proletariato e dell’estinzione progressiva dello Stato, non regge al progredire degli avvenimenti.
È per questo che gli anarchici parlano di autogestione della rivoluzione, preparando il terreno a uno scontro che potrebbe risultare rovinoso per le masse se il concetto di libera scelta e di determinazione della base non trovasse sufficiente spazio.
Come abbiamo visto, il potere, nelle condizioni attuali, sfrutta tutte le possibilità che si aprono davanti a esso per sopravvivere alle difficoltà ricorrenti della gestione capitalista dell’economia. Fra queste soluzioni è stata prevista e studiata anche quella autogestionaria, sotto forma di cogestione, prima, e di autogestione, poi. Il discorso sarebbe adatto come continuazione del consumismo: si assisterebbe a un re-investimento notevole e a un aumento della produzione, impensabili oggi.
Lo sciopero diventerebbe illogico (l’operaio non potrebbe, infatti, scioperare contro se stesso, una volta che viene a essere considerato padrone della fabbrica). Persistendo la direzione centralizzata dei settori della produzione e l’impostazione capitalista dell’economia di mercato, il sistema continuerebbe a reggersi, fino alle prossime difficoltà, poniamo per altri venti anni.
Sfuggire a questa nuova forma di autosfruttamento non è facile. Per prima cosa, bisognerebbe uscire da una vieta logica sindacale, riformista e interclassista, che intende, come avviene di fatto, schierarsi con i padroni per garantire la sopravvivenza del sistema capitalista.
Il discorso più recente è quello di consentire un’integrazione tra agricoltura e industria per garantire, nei paesi sviluppati che soffrono di scompensi di produzione e monetari, il superamento dei momenti di maggiore pericolo. La logica riformista non può che condurre a queste conclusioni. Volendo a tutti i costi salvare la barca, non ci si accorge più quando è il momento di abbandonarla perché troppo vecchia e non adatta a navigare, e si continua ottusamente a tappare i buchi mentre l’acqua arriva ormai al collo.
In una critica che la Confédération française démocratique du travail faceva a se stessa si legge: «Bisogna rifiutare la concezione puramente piramidale dell’organizzazione dei poteri, sia che si presentino sotto forma di una piramide gerarchizzata, sia sotto forma di consigli operai o sotto forma di centralismo democratico. L’esperienza mostra, in effetti, che questo modo di esercitare il potere, fondato su di una concezione rigida e gerarchizzata della delega, mette in moto rapidamente un processo di burocratizzazione e di tecnocratizzazione». (Aa.Vv., La C.F.D.T. et l’autogestion, Paris 1973, p. 48).
Non sappiamo quanto questa affermazione consista solo di parole, ma in effetti si tratta di una critica molto veritiera. È alternativa che non può essere perseguita dal sindacato in quanto organismo fondato sui presupposti centralizzati che oggi lo caratterizzano. Allo stesso modo, non siamo d’accordo a insistere sulle formule del passato: cooperative, consigli di fabbrica, comitati di base, comitati di settore, ecc., così come sono state sperimentate in situazioni storiche passate e in altre condizioni dei rapporti di produzione.
I pericoli di un ragionamento del genere sono evidenti. Il lavoratore non è portato a fare lunghissimi calcoli di lotta, egli preferisce vedere le cose nella loro realtà immediata, economicamente determinata, che lo colpisce con la divisione del prodotto realizzato e con lo sfruttamento che ne consegue. Gli si può fare un discorso più ampio e completo di rigenerazione sociale, gli si può parlare di una prospettiva rivoluzionaria che intenda partire dall’uomo per costruire una società diversa, ma il primo discorso non deve essere abbandonato. Ciò non significa, però, che questo deve essere considerato un discorso che da solo può dare frutti notevoli. Dalle società cooperative di oggi non potrà uscire che un più razionale sfruttamento, nessuna educazione alla collaborazione. Da un eventuale futuro spostamento dell’asse capitalistico, da un’economia di consumi signorili a un’economia di consumi sociali, non potrà uscire fuori che un ulteriore sfruttamento. Non avrebbe alcun senso il gran da fare che oggi si dà il capitalismo intorno al problema ecologico, se non lo si guardasse attraverso la lente di questo tipo futuro di modificazione economica. In altre parole, schiavi si è con il mare inquinato e schiavi si resta con il mare pulito. È per questo che gli sforzi dei riformisti e di tutti coloro che hanno interesse a frenare le lotte di emancipazione dei lavoratori, sono diretti, di fronte al problema dell’autogestione, a circoscrivere questa forma organizzativa all’interno del fatto economico.
Autogestione della produzione, soltanto della produzione. Dal che ne consegue che non potendosi avere un’autogestione della produzione soltanto, si dovrà organizzare un’autogestione controllata dallo Stato. In altre parole, essendo illogico pensare che gli operai delle industrie e i contadini delle campagne, possano autogestire la produzione senza avere notizia di tutti gli altri settori e problemi della comunità, la tesi autoritaria e riformista risulta evidente: occorre una coordinazione centrale, un punto di riferimento cui fare capo, che possa prevedere i piani di produzione e coordinare la vita complessiva della comunità. Ovviamente, questo punto centrale avrà altre incombenze, quali quelle militari, di polizia, legislative, ecc., ritornando alla dimensione classica dello Stato, però sotto le nuove spoglie dell’autodeterminazione dei lavoratori.
Pertanto, dovendosi anche dopo la rivoluzione continuare a servirsi di un centro organizzatore, tanto vale non distruggere per nulla la macchina dello Stato, ma lasciarla intatta per poi utilizzarla nella sua piena efficienza. Conclusione: stacco netto tra concetto di autogestione e concetto di rivoluzione.
Molti compagni cadono spesso in un curioso errore. Vedendo come l’idea dell’autogestione venga sfruttata a livello padronale e a livello riformista, vedendo che anche i partiti dell’area parlamentare e i sindacati parlano di autogestione, vedendo che anche qualche grosso industriale comincia a parlate di cogestione per aprirsi la strada all’autogestione; concludono che tanto vale andare alla ricerca di nuove soluzioni lasciando perdere l’autogestione e ogni tentativo di studiarla e di esaminarne i difetti e i pregi.
Il concetto di autogestione, per noi, e molto importante, perché rappresenta una caratteristica “complessiva” che non viene rilevata dai traditori dei lavoratori. Riguarda sia il problema delle lotte per l’emancipazione (lotte rivendicatrici e rivoluzionarie), sia le forme dell’organizzazione della società futura. Considerare l’autogestione soltanto come un problema di natura economica è questione di ignoranza o di malafede.
Il concetto di autogestione nel senso statale si restringe solo all’aspetto economico. Il concetto anarchico di autogestione si allarga alla presa di coscienza dei lavoratori, alla maturità della classe sfruttata, per arrivare alla costruzione della società futura sempre mediante il socialismo.
L’esame dei problemi dell’autogestione fornisce quindi chiarimenti, sia sulla società del futuro, sulle possibilità di prevederne le realizzazioni e i difetti; sia sulle lotte di oggi, sulle possibilità di svilupparle al di fuori della gerarchia pseudorivoluzionaria.
Autonomia e autogestione
Autonomia dell’individuo
Dalla possibilità di scelta che l’uomo possiede, pur nella varietà degli ostacoli che condizionano e specificano questa stessa possibilità, deriva immediatamente che l’uomo ha la responsabilità di essere libero.
Non si tratta di una vana affermazione metafisica, che non avrebbe significato fuori delle pagine del personalismo di cui si maschera un certo pensiero cattolico; ma si indica qui la reale attività dell’uomo che è quella di agire, di modificare il mondo esterno e di essere da questo e dall’attività degli altri, a sua volta, modificato.
La presa di coscienza delle proprie responsabilità non indica necessariamente l’acquisizione di una dimensione di vita proiettata verso la rivoluzione, ciò richiede un ulteriore passo in avanti, una determinazione di progetto e strategia che può non essere ancora stata fatta nella prima ipotesi. Ma questa presa di coscienza indica il riconoscimento del valore morale della libertà, con tutto ciò che ne consegue.
Nasce una progressiva costruzione dell’“autonomia” dell’individuo, basata su leggi che egli stesso “sperimenta” senza che da esse si senta obbligato in un senso che gli risulti estraneo. Spesso l’azione di quest’uomo risulta essere identica a quella di tanti altri uomini. Egli, infatti, decide di fare quello che fanno gli altri. Non ci sarà nessun salto metodologico quando deciderà di fare in modo diverso dagli altri: la fonte delle sue scelte è sempre la propria responsabilità di fronte alla libertà.
Chi accetta gli ordini di un altro senza criticarli in modo responsabilizzante, non è autonomo ma non per questo cessa di essere responsabile di ciò che compie ubbidendo agli ordini ricevuti.
Molte azioni umane vengono apparentemente sottratte a questa possibilità di responsabilizzazione. Se seguiamo le prescrizioni del dottore, se adottiamo i disegni e i calcoli di un architetto, senza procedere a una loro verifica personale e immediata, è perché non ne possediamo, il più delle volte, la competenza tecnica. Deleghiamo, quindi, la nostra autonomia nelle mani del medico e dell’architetto, che vengono così a prendere, al nostro posto, decisioni che vorremmo fossero nostre. L’unico mezzo per limitare i danni conseguenti a queste necessità imposte dall’attuale divisione del lavoro, necessità che non possono ovviamente essere cancellate con un semplice atto di buona volontà rivoluzionaria, è che questa nostra delega sia sempre revocabile in funzione degli atti compiuti e dei provvedimenti adottati dal nostro delegato.
Non esistono “ordini” possibili per un individuo che sia “autonomo”, le decisioni degli altri per lui non potranno mai prendere la forma di “ordini”. Da ciò la più assoluta incompatibilità tra autonomia e autorità nella dimensione dell’individuo.
Col termine autorità abbiamo definito la possibilità di comandare ad altri un comportamento attivo o passivo (Cfr. A. M. Bonanno, Astensionismo elettorale anarchico, Ragusa 1974, p. 5 e sgg., questo opuscolo è la rielaborazione dell’Introduzione a Malatesta-Merlino, Anarchismo e democrazia, Ragusa 1974). L’autorità presuppone l’esistenza di un potere che rende possibile la stessa attività di comando. Spesso non è facile, a nostro avviso, distinguere tra potere e autorità. In linea generale il potere è l’insieme dei mezzi che qualcuno ha a disposizione per esercitare un’autorità, cioè una possibilità di imporre norme di comportamento.
La distinzione impostata dalla filosofia politica parte dal presupposto che altro è il potere che il ladro esercita su di me brandendo un’arma, per cui gli riconosco una “autorità” consegnandogli il portafoglio per paura di un male maggiore, e altro è il potere esercitato dallo Stato su di me quando mi impone di pagare le tasse o di fare il servizio militare, ecc. La differenza consisterebbe nel fatto che io riconosco al secondo il diritto di fare quello che fa, cosa che non riconosco al primo. Nel riconoscere questo diritto, continuano i filosofi politici, io riconosco la legittimità dell’autorità statale e quindi opero una distinzione tra potere (la forza della minaccia del ladro) e diritto (l’autorità che riconosco allo Stato).
Secondo noi la distinzione tra potere e autorità è di tipo metodologico. L’autorità è una prospettiva di azione posseduta da qualcuno, il potere è l’insieme dei mezzi che rendono concretamente attuabile quella prospettiva di azione che, in caso contrario, resterebbe puramente teorica.
Questa tesi, così com’è sopra sviluppata, ripete sostanzialmente, con alcune varianti formali, quella esposta nella prima edizione del presente lavoro, essa è stata criticata da M. La Torre nell’articolo “Discutendo di democrazia”, in “Volontà”, aprile-giugno 1980, n. 2, p. 34. La posizione di La Torre tende a dimostrare che il potere e l’autorità non qualificano un soggetto in quanto tale, ma solo in quanto questo soggetto li esercita. Come dire che non esiste una istituzione concreta che eserciti l’autorità che possa definirsi autorità essa stessa, e potere, una volta che possieda i mezzi adatti; ma che sarebbe da fare una distinzione tra istituzione che l’autorità esercita e realizza in fatti concreti e concetto di autorità da quella istituzione personificato. Quindi, conclude La Torre: «È tale attività che può essere qualificata come forza potere autorità...». (Ib., p. 34). E l’istituzione? In qualsiasi modo si voglia affrontare questo problema, ci sembra che così facendo si corra il rischio di aprire la strada a una possibile (e sicuramente involontaria) legittimazione dell’istituzione, riservando la critica all’attività (autoritaria) dell’istituzione stessa, che potrebbe (e perché no!) cambiare.
In questo modo insistevamo (cfr., A. M. Bonanno, Astensionismo elettorale anarchico, op. cit., p. 6): «Trasportando il nostro semplice ragionamento nel campo della scienza politica si ha che lo Stato non è più quell’organizzazione alla quale viene “riconosciuta” un’autorità suprema all’interno di un territorio da coloro sui quali questa autorità viene esercitata; ma quell’organizzazione che possiede i mezzi adatti (il potere adatto) per esercitare la più forte autorità in un dato territorio su coloro che, onde evitare un male più grande, finiscono per riconoscerla».
Questa definizione non vuole per altro disconoscere o minimizzare la difficoltà del problema dello Stato e del potere, né il ruolo del consenso e della mistificazione ideologica, argomenti che saranno meglio approfonditi in altri lavori.
Veniamo adesso a un’altra “autorità”, quella elaborata dagli organismi associativi di base, che viene fuori dalle discussioni delle assemblee.
Trovandomi davanti a un problema nuovo, posso ricevere dall’esterno due modelli di “comunicazione”: uno di tipo autoritario, che mi dice quello che devo fare; un altro di tipo rivoluzionario, che mi fornisce la condizione migliore perché venga a contatto col problema, i chiarimenti in merito sia al problema che alle conseguenze delle mie probabili decisioni. Di più: questa comunicazione rivoluzionaria, per restare veramente tale, deve adottare lo stesso procedimento non solo in merito alla risoluzione del problema, ma anche alla scelta del problema stesso.
Pur conoscendosi dei limiti a questa metodologia (presenza del compagno più informato, ecc.) la sua caratteristica è sempre quella di non possedere i mezzi per diventare la prassi d’intervento di istituzioni autoritarie.
Un’istituzione, infatti, che riuscisse a fare propria questa metodologia “persuasiva” e riuscisse, nello stesso tempo, attraverso profonde mistificazioni ideologiche, a darsi sufficienti mezzi di potere, sarebbe una istituzione autoritaria di rara efficienza repressiva.
Comunque, nella realtà, l’uomo non si trova mai di fronte al modello autoritario in senso assoluto, e nemmeno al modello rivoluzionario puro. Anche l’autorità più dispotica avanza delle ragioni per obbedire alle proprie ingiunzioni come pure delle ragioni per combatterle. Sta proprio in questo punto di estrema delicatezza la difficoltà del problema politico e della lotta rivoluzionaria. Procedendo dal regime autoritario verso quello socialdemocratico le ragioni per combattere l’autorità e distruggerla si fanno meno chiare ed evidenti.
È questa difficoltà che segna il conflitto autonomia-autorità nella vita associata. La maggior parte degli individui considera la “comunità” come qualcosa di estraneo, confondendola con lo Stato e con il suo insieme di processi di imposizione e burocratizzazione. L’etica della sopravvivenza concretizza alcune prescrizioni, alcuni precetti di natura generale, mentre l’ubbidienza a mille forme concrete che emanano dall’autorità trasforma tutto in coercizione e conservazione.
È la realtà delle lotte che dà significato all’autonomia morale, da cui deriva che questa è legata alla presa di coscienza di alcuni fatti precisi, alla documentazione, allo sviluppo di facoltà critiche, al mantenimento di precisi contatti ambientali. Il potere si basa invece sull’ignoranza e sull’apatia dell’individuo e delle masse.
La soluzione apparentemente più facile è quella fornita dalla democrazia. Ci si illude di essere autonomi dandosi un governo che non sia sul popolo o per il popolo, ma un governo fatto dal popolo. La finzione giuridica che sia il popolo stesso a dare gli ordini provenienti dal governo, determina la legittimazione degli ordini stessi. La negazione più radicale dell’autonomia viene considerata come riaffermazione, nella dimensione collettiva, della primaria autonomia del singolo.
In astratto la soluzione democratica dovrebbe basarsi sulla cosiddetta democrazia diretta: ogni individuo dà il proprio assenso o dissenso su ciascun provvedimento. Ma in realtà, a prescindere dagli aspetti tecnici che rendono scarsamente applicabile su ampia scala la democrazia diretta, c’è da dire che anche superandoli (tramite l’impiego della moderna elettronica, come è stato suggerito), niente potrebbe correggere i processi mistificatori delle ideologie e della disinformazione agenti sulle decisioni dei singoli. In aggiunta si avrebbe il fatto decisivo che se anche il singolo riuscisse a intervenire in modo cosciente nella decisione che fissa il provvedimento, non avrebbe mezzi idonei per intervenire per quanto concerne la sua applicazione: qui sarebbe sempre uno speciale organismo ad agire, investito, per questo stesso motivo, da un preciso potere decisionale, del tutto autonomo dalla decisione del singolo che aveva reso possibile il provvedimento.
La democrazia rappresentativa, prospettando una soluzione più efficientista del problema, parte direttamente dal concetto di delega. Quando qualcuno si trova impossibilitato a prendere una certa decisione o a fare qualcosa può delegare un altro al suo posto. In sostanza il principio stesso della delega nasce come strumento per allargare l’autonomia del singolo, consentendogli di fare cose che altrimenti gli sarebbero impossibili. Ma si tratta di un principio molto rudimentale che oggi potrebbe tecnicamente identificarsi nella procura speciale. La realtà è che la forma della procura classica è inutilizzabile nella prospettiva del mandato parlamentare. Che cosa guida la scelta di un candidato al Parlamento? Certamente non precise indicazioni riguardo le leggi future che il parlamentare concorrerà a determinare, che nemmeno lui conosce e che non sono conosciute da chi va a votare. La sola indicazione resta il programma politico del partito e del candidato, con tutte le conseguenze relative determinate dalla genericità e dalla confusione di simili dichiarazioni programmatiche.
È quindi chiaro che la democrazia parlamentare non può garantire l’autonomia del singolo. Le decisioni prese dal Parlamento in nome della nazione diverranno coattive per tutti gli individui i quali saranno in questo modo privati della loro autonomia.
Per questi motivi struttura parlamentare e autogestione sono in contrasto tra di loro. La prima utilizza forme di pseudo-democrazia che travisano l’autonomia della base, la seconda parte da questa autonomia per ogni futura costruzione. Una società autogestita che lasciasse intatto il sistema della delega parlamentare sarebbe diretta verso il fallimento e la dittatura.
Tutte queste riflessioni sull’autonomia dell’individuo, in quanto tale e in quanto elemento di una comunità sociale, ci portano direttamente davanti al problema della classe e della contrapposizione di classe.
Non è vero che parlare di “autonomia dell’individuo” precluda la possibilità di un discorso di classe, in quanto non è vero che l’individuo sia una creazione della fantasia filosofica dei reazionari. L’individuo è una realtà concreta dalla quale non si può prescindere nel dar vita al discorso di classe, se non si vuole trasformare il progetto rivoluzionario di liberazione in un progetto autoritario. La fine più sbrigativa dell’individuo è nel partito e nel centralismo, strutture mentali e concrete che lo soffocano in nome di un preteso interesse superiore.
Al contrario, illuminando le condizioni che garantiscono l’autonomia del singolo, risulta molto semplice dedurre il passaggio alle condizioni che garantiscono l’autonomia della classe degli sfruttati. Infatti, la responsabilizzazione verso le proprie azioni e le proprie idee è condizione essenziale per la costruzione di una prospettiva concreta nel conflitto di classe, una prospettiva che provenga dalla base e che risulti diretta verso un socialismo antiautoritario. La negazione della validità del sistema rappresentativo, l’esame dei limiti della delega, sono condizioni indispensabili al lavoro costruttivo che si è detto. Lungi dall’essere elementi di una torre d’avorio, dove il privilegiato finisce per rinchiudersi, queste condizioni dell’autonomia del singolo sono le basi essenziali dell’autonomia della classe degli sfruttati.
Autonomia della classe lavoratrice
Di fronte al proletariato in lotta la strada è sbarrata. I partiti riformisti, i sindacati e i padroni si sono coalizzati per impedire ogni crescita dei livelli di lotta e ogni conquista che apra la strada alla trasformazione rivoluzionaria dei rapporti di produzione.
L’alternativa proletaria è una sola: costruire il comunismo direttamente, passando sopra le costruzioni burocratiche controrivoluzionarie. Per fare questo si devono immediatamente individuare analiticamente e si devono praticamente realizzare quegli elementi minimi dell’autonomia di base che sono i nuclei produttivi.
Questi nuclei, a nostro avviso, non devono essere confusi con l’azienda, con la fabbrica, con l’officina; ma il loro concetto deve allargarsi alla visione globale della fabbrica, del quartiere, della scuola e della campagna.
In questa globalità deve essere reinterpretata la visione dell’autonomia della classe lavoratrice in rapporto all’autonomia del singolo individuo, elemento di raffronto costante e di correzione delle eventuali tendenze a costruire la prima a scapito della seconda.
Se una volta la possibilità rivoluzionaria poteva essere confusa col semplice fatto dell’espropriazione dei mezzi di produzione (su cui perdura oggi l’equivoco marxista), adesso sappiamo con certezza che gli stessi borghesi sono disposti a trasformare il loro titolo di proprietà purchè venga garantita, sotto altra specie, la continuazione dello sfruttamento. Il passaggio “dolce” al socialismo di Stato è la prospettiva più diffusa negli ambienti “progressisti” della borghesia.
Contro un simile fallimento la classe dei lavoratori deve costruire i mezzi adatti alla lotta e alla riconquista della prospettiva rivoluzionaria.
L’individuazione analitica della “classe” lavoratrice potrebbe essere faccenda assai complessa. Di solito i compagni amano rifarsi alle analisi marxiste, anche a quelle più sofisticate, per uscirsene con tutta la gloria possibile con affermazioni che intendono limitare “l’uso di Marx” allo stretto indispensabile (in genere identificato con l’analisi economica e col materialismo storico), per costruire le vere prospettive libertarie dell’autonomia dei lavoratori e delle loro lotte.
Francamente non mi sono mai potuto decidere a tanto. Forse perché sono avverso alla metafisica e tanta parte delle analisi marxiste, anche in economia e in metodologia storica, puzzano di metafisica.
Come gli stessi padri fondatori hanno ammesso, i temi della problematica della classe non sono loro “invenzione”. Essi, in particolare Marx, si sono limitati a mettere in rapporto l’esistenza delle classi con certe precise fasi storiche dello sviluppo della produzione, donde, con un notevole salto logico, hanno concluso per l’ineluttabilità della dittatura del proletariato e conseguente mitologia della transizione alla società senza classi.
Ho sentito spesso esaltare il “realismo” di Marx, individuandolo nel suo rifiuto di qualsiasi “lamento” sulla “immoralità” della società e nella sua analisi che i “fatti” dello sfruttamento e le “vicende” della lotta di classe sono un necessario processo verso la liberazione della società, un processo salutare ed evolutivo. Non ci vedo nulla di scientifico in tutto ciò, Marx non poteva seguire i suoi predecessori, come Saint-Simon, Fourier, Owen o Sismondi, per due buoni motivi: credeva nella rivoluzione (a suo modo) e aveva studiato Hegel (rimastogli sullo stomaco malgrado tutte le critiche giovanili). Così riusciva a fondere nel suo cervello “sistematico” il realismo del propagandista e del giornalista politico e l’ottimismo del metafisico che identifica razionale e reale.
Quello che sbalordisce di più è che i compagni anarchici, spesso, non si accorgono di sottoscrivere in pieno un programma che affonda le sue radici nel medioevo del misticismo protestante tedesco (vedere Hegel e i suoi debiti), un medioevo filosofico che insiste ancora oggi su una pretesa differenza tra “classe in sé e classe per sé”. Il passaggio sarebbe la presa di coscienza, il punto di partenza, la determinazione oggettiva ottenuta dalla distribuzione della proprietà privata. Qualche volta la presa di coscienza viene fatta coincidere con l’organizzazione di classe.
A parte le premesse metafisiche, qui l’unico dato concreto è la storia. Per la prima volta, con grande chiarezza e spiegamento di forze analitiche, Marx riesce a liberare il ragionamento sull’uomo da ogni idealizzazione di tipo religioso, biologico, evolutivo, ecc. Resta l’uomo nella storia: un fatto non trascurabile che, comunque, viene sprecato gravemente per la pretesa “razionalizzante” di racchiudere questa vicenda nel ristretto ambito “romanzesco” della fenomenologia dello spirito (sia pure capovolta). In questo modo, dal processo dialettico, ritmato in una struttura ben fissata, emerge la giustificazione della storia dell’uomo. La storia viene portata alla ragione attraverso un processo metafisico, allo stesso modo in cui altri storici, con intendimenti altrettanto necessitanti di un “punto di appoggio”, la riportavano sotto il dominio di Dio o dell’evoluzione della specie. Una volta “razionalizzata” la storia, la ragione storica cessa di essere “ragione assoluta” (ad esempio, come lo era per i teorici della vecchia democrazia), e diventa “ragione dialettica”. La razionalità viene fatta consistere nell’involucro in cui viene avvolta una vecchia paccottiglia, smerciata così per merce di nuova fabbricazione. Ma vecchia o nuova che sia, codesta merce è sempre un prodotto delle officine “Metafisica & Co.”, stabilimento di fama mondiale, fornitore di tutte le “Real Case” del mondo.
Certo, la vecchia “ragione assoluta” aveva veramente perduto credito. Reinterpretare il mondo col suo metro sarebbe stata un’operazione facilmente screditabile, come lo fu quella tentata dagli ingenui materialisti della prima metà dell’Ottocento, romantici innamorati della materia e delle sue “sensazioni” metafisiche, incapaci di strappare la vicenda dell’uomo alla sua assoluta periodicità: sfruttamento-ribellione, e ancora sfruttamento e ancora ribellione. Nell’altro versante, stessa situazione: ottusità della storia e ottusità degli interpreti idealisti. Questa marcia dello spirito non voleva mettersi in moto in forma progressiva: lo sfruttamento continuava a ricostruirsi dopo la rivolta, il sangue dei lavoratori bagnava le strade e tutto ritornava esattamente come prima.
Eppure, malgrado tanta povertà di mezzi, tanto inquinamento nelle poche idee di base, Marx seppe lo stesso uscire dall’inutile produzione del suo tempo, unificando ottimismo e realismo in una ricostruzione veramente notevole, sebbene mancante di molte parti e necessitante di fondamentali trasformazioni. Una delle parti più deficienti è, appunto, la problematica della “classe”: non per nulla il manoscritto inedito del Capitale si arresta proprio lì.
A noi anarchici i conti dovrebbero tornare molto facilmente. Ogni ragionamento di tipo “cosa in sé” non ci dovrebbe interessare. Che possa essere la “classe in sé” non ci pare problema importante, anzi non ci pare affatto un problema. In che modo questa “classe in sé” possa diventare “classe per sé”, ci appare poi uno scherzo di pessimo gusto. Lasciamo questi “scherzi tipografici” ai professori di filosofia e ragioniamo più semplicemente, attenendoci ai fatti.
Non sappiamo e non vogliamo sapere se esista una classe in sé, quello che ci interessa è sapere che esiste un potere. Questo fatto macroscopico, che attraversa tutta la storia, non si può negare. In questo senso la storia può dirsi contrassegnata dal potere e dalle sue trasformazioni per persistere in quanto tale. Ma un ragionamento del genere comincerebbe a puzzare di metafisica in quanto ci porterebbe alla domanda: è il potere a determinare la storia o qualcosa nella storia rende possibile il potere in questo o in quel modo? Mettiamo da parte ragionamenti simili: la storia può dirsi contrassegnata da tante vicende: il potere, la religione, la produzione, il sesso, la lotta degli sfruttati. E, in effetti, sarebbe possibile costruire altrettanti svolgimenti storici per ognuna di queste vicende, potendosi quindi avere una storia in base al potere, una in base alla religione, una in base alla produzione, una in base al sesso, una in base alla lotta degli sfruttati.
Ciò prova, almeno ci pare, che un modello esterno è sempre ricostruibile, sia esso quello dialettico (modello metafisico), quello idealistico (modello religioso), quello materialistico (modello economico), quello genetico-comportamentale (modello sessuale), quello descrittivo (modello empirico); ma prova anche che un lavoro del genere sarebbe del tutto inutile.
Per gli anarchici la storia è tutto ciò insieme e tante altre cose ancora. Mettimoci pure gli aspetti irrazionali e metafisici: anch’essi storia, sebbene di volta in volta isolabili e condannabili, ma non per questo eliminabili. Agendo diversamente cadremmo in alternative insolubili, come quella tra idea e azione: se sia l’idea a determinare l’azione o questa a determinare la prima. In pratica di tutto ciò non ce ne importa nulla: lasciamo simile lavoro ai professori. Guardiamo la realtà.
Questa esortazione ci pone davanti un ultimo ostacolo metafisico. Dobbiamo chiederci che cosa sia la realtà? Non è una domanda oziosa. Il marxismo ha avuto tanto credito proprio perché ha saputo camuffare la risposta a questa domanda in un rinvio all’infinito. La realtà non si differenzia dalla storia. Non ci interessa identificare la storia con una struttura giustificativa a priori, come non ci interessa farlo per la realtà. La realtà è nello stesso tempo: potere, religione, produzione, sesso, lotta e tante cose ancora che non ricordiamo e che non sappiamo. Quello che conta non è identificarla con l’idea di realtà nel suo insieme (che poi sarebbe il problema metafisico della “cosa in sé”), ma identificare gli elementi salienti, i parametri essenziali, utili per costruire un programma d’azione.
Facciamo un esempio partendo dalle lotte degli sfruttati, reperibili con costanza nella storia. Esaminiamo la sorte comune di queste lotte: essere riassorbite dal potere. Questo riassorbimento, che è costato milioni di morti e sofferenze incredibili, non ha ucciso la volontà di lotta.
Abbiamo così due elementi: la lotta e la volontà di lotta. Vediamo adesso di chiederci il perché questa lotta abbia costantemente avuto un esito negativo, e i significati di questo esito costante. Un motivo che ci spiega il primo punto è dato dalla presenza di una minoranza “guida” di queste lotte, minoranza che se da un lato si pone come “testa” del movimento degli sfruttati, dall’altro assume la veste di elite ascendente, cioè minoranza diretta a impadronirsi del potere per sfruttarlo in proprio sostituendosi alla elite in carica. Un altro motivo ci spiega ancora più profondamente il primo punto: la persistente “religiosità” delle masse sfruttate, donde il loro “bisogno” di una guida, di un gruppo o di una persona capace di “materializzare” il desiderio di vendetta. Questo secondo motivo, su cui torneremo più avanti, ci apre adesso la strada al secondo punto: quale significato dare al costante esito negativo di queste lotte? La conclusione ci riallaccia al discorso sull’autonomia dell’individuo. Solo la volontà di liberazione, frutto e ragione della lotta, può determinare l’eliminazione del sentimento di religiosità, nelle lotte dei lavoratori.
Se l’individuazione della classe degli sfruttati è nebulosa, e non può non essere tale una volta che abbiamo lasciato espressamente la storia nella nebulosità (cioè la stessa realtà, come si è visto), come corrispettivo abbiamo la possibilità di utilizzare elementi pluralistici nella nostra analisi che ci sarebbero restati fuori nel caso della scelta di un sistema preciso (ad esempio, dialettica, religione, economia, metafisica, ecc.). Se la costruzione del modello analitico è più difficile, più ricco dovrebbe essere il risultato. Non lavoriamo né alla costruzione di un partito, né alla difesa di uno stato di cose prestabilito.
Una conclusione di prima approssimazione sarebbe quella che legherebbe la classe lavoratrice alla progressiva eliminazione del sentimento di religiosità che fonda la necessità della “guida”. Ogni tentativo di “fare da sé” costituisce per noi un sintomo di questa volontarizzazione del processo oggettivo che viene fuori dallo sfruttamento. La lotta, presa in se stessa, come fenomeno di una massa amorfa, o più o meno sensibilizzata sotto l’insegna di una Chiesa o di un partito, non è sufficiente a indicare una classe. Il processo produttivo, preso in se stesso, come ripartizione precisa della proprietà dei mezzi di produzione, escludente una parte del genere umano, non è sufficiente a indicare una classe.
I marxisti possono pure parlare di “coscienza” di classe, il termine non ci turba. Non per questo, però, dobbiamo farci coinvolgere nelle loro beghe filosofiche. Il fatto che determina l’autonomia dell’individuo è la sua responsabilizzazione di fronte alle scelte della vita: anche questa responsabilizzazione può prendere il nome di “coscienza”. Sarebbe preferibile definirla come “volontà”. Volontà di fare da sé, volontà di intervenire in prima persona, volontà di rompere il cerchio magico della religiosità, volontà di capovolgere la tradizione, volontà di costruire la propria autonomia. E, in questo senso, l’autonomia del singolo e l’autonomia della classe dei lavoratori trovano il proprio punto d’incontro.
[Per questo paragrafo vedere: “L’alternativa proletaria: L’autonomia dei nuclei produttivi di base”, in “Anarchismo” n. 3, 1975, pp. 143-153. Questo scritto è stato pubblicato in opuscolo col titolo: L’alternativa anarchica. L’autonomia dei nuclei produttivi di base, Torino 1976, pagine 12. La traduzione inglese si trova in Workers’ Autonomy, ed. Bratach Dubh, London 1979, pp. 3-17]
La lotta per l’autogestione
Conquista dell’autonomia
Il maturarsi di livelli diversi nelle lotte dei lavoratori è cosa ormai accettata da tutti. Non solo, ma i partiti dei lavoratori, pressati da ogni lato, si sono preoccupati da tempo di codificare nel loro repertorio queste lotte, studiando la maniera di farle entrare, il più rapidamente possibile, nell’arco della legalità.
Una volta, poniamo al tempo di Sorel, la teorizzazione dello sciopero generale, anticamera della rivoluzione, sembrava faccenda talmente pericolosa da essere oggetto della più precisa attenzione degli organismi di polizia; oggi, a distanza di settant’anni [1974], gli scioperi generali si susseguono l’uno dopo l’altro senza che nessuno batta ciglio.
Una volta, la formazione segreta dei consigli di fabbrica, sul modello di quelli tedeschi del periodo spartachista, era un fatto talmente grave da fare accorrere da ogni parte, in santa alleanza, tutti gli organismi repressivi del potere; oggi, sono elemento contrattuale di largo impiego.
Una volta, l’occupazione delle fabbriche e delle campagne significava l’estremo insulto alla proprietà privata, la vigilia della rivoluzione; oggi, le occupazioni sono spesso sollecitate dagli stessi padroni che ci guadagnano sopra con oscure operazioni di sottopotere.
Una volta, il concetto di autogestione della produzione si trovava esclusivamente nei libri dei teorici dell’anarchismo, oggi, tutti i partiti della sinistra, tutti i sindacati e molti paesi capitalisti o pseudosocialisti, parlano e applicano l’autogestione.
Evoluzione delle forme di lotta? Più precisamente si dovrebbe parlare di “inglobazione” delle forme di lotta.
Come è ormai accertato, il potere rigido esiste solo in teoria. Tutti gli Stati moderni sono caratterizzati, fra l’altro, dall’adozione di un tipo di potere che viene denominato “flessibile o morbido”, cioè capace di adattarsi alle varie forme di lotta della base dei lavoratori, raggiungendo lo scopo finale di smussare gli aspetti più pericolosi e di inserirne gli altri nel quadro degli interessi economici generali.
È proprio questa politica che caratterizza gli “Stati moderni”, molto più intelligenti delle ottuse dittature del passato. Anche Stati dichiaratamente fascisti, come la Spagna [scritto prima della caduta del franchismo e dell’avvento della cosiddetta “democrazia”], fanno sforzi enormi per liberarsi delle frange di estrema destra e costruire sistemi di potere modellati su “gestioni morbide”.
Da ciò un processo continuo di modificazione delle forme della resistenza collettiva. La base stessa dei lavoratori elabora queste forme di lotta di nuovo tipo. Un esempio recente è quello della continuazione della produzione in forma autogestionaria con un’organizzazione clandestina.
La realtà delle cose è che le forme di lotta si evolvono non perché qualcuno ne parla in astratto o ne teorizza i termini essenziali, ma perché le masse si trovano sempre davanti a un potere che annulla sistematicamente gli effetti positivi delle forme di lotta precedenti e quindi si vedono costrette a escogitarne di nuove.
La conquista dell’autonomia costituisce, però, non tanto un avanzamento del livello della lotta, quanto uno scatto qualitativo ben preciso. Uno scatto di tale importanza da rimettere in discussione la congiura antioperaia attuata da tutte le forze repressive. Non si tratta di una scelta strategica limitata ai mezzi da impiegare nella lotta, ma si tratta di un riesame della situazione di classe nel suo insieme, si tratta di una rielaborazione del rapporto con i cosiddetti rappresentanti dei lavoratori e con le forze dei padroni e dei loro servitori.
Superamento della divisione del lavoro
La critica del sistema capitalista ci fa comprendere alcuni fatti fondamentali riguardanti l’essenza del lavoro in una società caratterizzata dalla separazione tra capitale e lavoro. In una società come la nostra, il lavoro è l’attività specifica dell’uomo, cioè l’attività che lo fa creatore di oggetti. Ma questa attività risulta distorta, impedita, donde il concetto di alienazione. A parte la problematica intrinseca al concetto di lavoro ci interessa comprendere come il sistema capitalista, fondato sulla proprietà privata dei mezzi di produzione, non consenta l’utilizzazione di questi mezzi in modo creativo da parte del singolo, in quanto appartengono a una classe ben precisa: quella dei capitalisti. Negandosi, quindi, come uomo creatore, il lavoratore diventa operaio, cioè creatore che mette la sua forza al servizio di un altro uomo, il capitalista, che la sfrutta.
Ciò che sfugge al lavoratore, nella dimensione capitalista, è il dominio della produzione, degli oggetti che escono dalle sue mani. In questo modo egli entra nel campo del lavoro forzato, un lavoro terribile ed estraneo.
Pur essendo discutibile che sia il lavoro a determinare l’essenza dell’uomo, la qual cosa, come al solito, ci sembra un rigiro metafisico, ci appare chiaro che il sottrarre il prodotto al produttore è la base della estraneazione tra lavoratore e produzione. Da qui la necessità di ricostituire la sua capacità creativa, ricollegando la sua spontaneità di produttore con la libera disponibilità della cosa prodotta. E siccome questo non può avvenire che nei posti stessi di lavoro, come fatto rivoluzionario non può essere che “rivoluzione nel lavoro”, cioè organizzazione autogestionaria della rivoluzione e contemporanea organizzazione autogestionaria di quegli embrioni di società futura che sono, appunto, i nuclei produttivi di base, fondati sull’autonomia delle lotte.
È sorto il dubbio legittimo se, nella situazione attuale di gestione capitalista socialdemocratica, sia possibile vedere dietro l’alienazione del lavoratore una possibilità di realizzazione creativa rivoluzionaria. Certo, sotto l’azione dello sfruttamento il lavoratore realizza progetti di lotta, ma spesso questi non sono suoi in quanto vengono suggeriti od imposti da forze che strumentalizzano la forza di liberazione che viene dalla base. Lo stesso discorso può farsi per la capacità creativa riguardo il lavoro. Il lavoratore, pur sotto lo sfruttamento, cioè pur trovandosi in una situazione di alienazione, non perde la propria capacità operativa di realizzare oggetti attraverso un certo progetto di produzione.
I marxisti sostengono che, in tutti e due i casi, il lavoratore acquista progressivamente capacità rivoluzionarie e tecniche che non potrebbe altrimenti avere essendo il capitalismo l’organizzazione migliore per accelerare lo sviluppo del processo di liberazione.
Questa affermazione ha certi aspetti di verità, ma non deve essere interpretata nel senso di una pacifica attesa dell’esplosione del sistema e dell’utilizzazione di queste capacità non più a favore del padrone (o del partito) ma a favore della classe operaia vittoriosa. Purtroppo la struttura del capitalismo non è di tipo rigido, non ricorda per nulla quella delle economie feudali e meno ancora quella delle economie schiaviste. Proprio in forza dello stesso progetto di sviluppo che lo caratterizza, il capitalismo si evolve incessantemente. Oggi nei paesi a economia avanzata siamo davanti a una struttura assai diversa di quella che è possibile osservare nei paesi sottosviluppati in preda a una gestione dittatoriale di tipo fascista. L’assetto socialdemocratico del mondo occidentale, volendo limitarci a questo modello di capitalismo senza parlare del capitalismo di Stato di tipo sovietico o cinese, è basato su di una progressiva partecipazione del lavoratore al consumo signorile. Questa prospettiva, se determina alcune condizioni di crisi tipiche del consumismo, consente la sopravvivenza, a medio termine, del capitalismo.
Come effetto collaterale, ma non secondario, determina una modificazione della reazione del lavoratore di fronte al processo di alienazione. Per prima cosa, lo sviluppo della struttura industriale moderna ha accentuato il processo di divisione del lavoro arrivando a estremi non pensabili cento anni fa, cioè ha accelerato il processo di sfruttamento, ha consentito una maggiore forza di contrattazione al capitale ed ha determinato una difficoltà supplementare nell’impadronimento della tecnica di realizzazione dei progetti di lavoro. In secondo luogo, ha sclerotizzato il processo di formazione della coscienza di classe, cosa alimentata – sia pure indirettamente – dalle mire politiche dei partiti guida dedicati alla dimensione rivendicativa finalizzata a se stessa.
Resta da esaminare la situazione nuova che emerge dal conflitto tra spontaneità creatrice (che in definitiva consente la realizzazione del progetto lavorativo anche in regime di sfruttamento) e influsso negativo determinato dal processo consumistico, influsso che ha conseguenze precise sulla capacità di lotta, sulla capacità organizzativa e, in una parola, sulla capacità del progetto rivoluzionario.
Ma, se la dimensione lavorativa è la base del progetto rivoluzionario, essa deve essere curata costantemente sia nei dettagli realizzativi come nella tendenza alla spontaneità. Ed è proprio qui che emergono le contraddizioni all’interno delle burocrazie sindacali e riformiste. Il lavoratore salva da solo il progetto rivoluzionario e produttivo, supera la struttura burocratica, minaccia di farla saltare: da qui il disperato recupero dei sindacati di fronte alla lotta autogestita dei lavoratori.
Conquista dell’informazione
Tradizionalmente le lotte rivendicative condotte dai lavoratori si sono concentrate nella pressione sugli organi statali allo scopo di vedere riconosciuto il diritto al lavoro. Spesso queste lotte sono state pilotate dalle organizzazioni sindacali in armonia con gli interessi dei padroni, anche senza volere arrivare alla realtà estrema di sindacati apertamente finanziati e voluti da quest’ultimi. È stata la logica stessa del capitale, col suo dio supremo: “la produzione”, a influenzare la strategia sindacale fino a farla coincidere con una specie di “sviluppo parallelo”. È logico che questo sviluppo troverà un limite, pagato in prima persona dai lavoratori, nelle leggi dello sfruttamento e dell’accumulazione che reggono l’economia capitalista.
Dopo le esperienze negative (per loro) del maggio 1968, i sindacati si sono accorti che la base poteva reagire autonomamente, senza intervento “dall’alto” e che se quella volta si era riusciti a riprendere in mano la situazione, non era detto che la cosa sarebbe sempre stata possibile.
Occorreva esaminare bene il fenomeno. Per prima cosa scrollarsi di dosso tutti i preconcetti negativi che circolavano nelle alte sfere sindacali verso lo “spontaneismo operaio” e verso “quel pazzo avvenimento che fu il Maggio francese”, occorreva rivalutarlo a posteriori proprio quando il suo “collocarsi in una prospettiva storica” impediva una vera e propria pericolosa influenza sulle masse lavoratrici.
È quello che è stato fatto. I sindacati non arricciano più il naso davanti a quel ricordo, al contrario ne usano i riferimenti come se fosse cosa loro. Hanno capito che una delle molle che possono sempre fare ripresentare un “maggio ’68” è la conoscenza dei lavoratori di certi fenomeni, di certi fatti – anche piccolissimi – di certe decisioni di vertice che vengono sempre prese in loro nome e alle loro spalle. Da qui tutta una teoria sul “diritto all’informazione”. Ovviamente all’informazione che deve essere fornita dal padrone e filtrata dall’organizzazione sindacale.
Quando diciamo “filtrata” non intendiamo dire necessariamente distorta o falsata, ma spesso semplicemente differita nel tempo, fornita quando il “clima” si è raffreddato, diluita, interpretata.
Ecco perché esiste la necessità della “conquista” dell’informazione, per preparare quelle lotte risolutive che condurranno all’autogestione dell’economia da parte dei lavoratori non come mezzo di pacifica evoluzione verso il socialismo, ma come conclusione violenta, rivoluzionaria, di tutta una prospettiva sociale.
Attualmente i lavoratori ricevono notizie sulla loro ditta o industria, sul settore economico in cui operano, sull’economia nazionale correlata con quel settore e anche sui rapporti internazionali. I sindacati si danno da fare per mettere insieme queste notizie, anche negli incontri internazionali organizzati dalle confederazioni si parla di questo e si scambia la relativa documentazione. Ma si tratta di informazioni assai parziali che cadono sul lavoratore lasciandolo freddo. Anche il modo stesso in cui sono redatte e lo strumento di divulgazione che viene usato per farle pervenire alla base (giornale confederale o circolari), non sono certo ideali per un assorbimento da parte del lavoratore.
È sintomatico che l’informazione data dalla direzione ai comitati di fabbrica è sempre pessimistica, mentre la stessa informazione data ai soci (relazione al bilancio annuale), è spesso ottimistica. È impressionante, ad esempio, il tono pessimistico usato in un rapporto passato ai rappresentanti sindacali di una grande banca italiana che poi, a livello di bilancio annuale, presenta miliardi di utile per gestione.
Infine, quando nel corso di importanti scioperi l’informazione è data all’opinione pubblica, essa è diretta a provare che l’industria è ben condotta, che il suo benessere risulta da sforzi molteplici che risalgono molto indietro negli anni, che adesso stanno dando i primi frutti, che il mercato internazionale è quasi conquistato e che solo lo sciopero minaccia di distruggere tutto; sciopero, per altro, fatto da gente che ha avuto tutti i miglioramenti e tutti i vantaggi sociali possibili.
Per essere precisi occorre dire che spesso l’informazione fornita ai rappresentanti sindacali, invece di essere pessimistica è ottimistica ma sotto condizione; cioè viene precisato che l’industria va bene, solo che occorre una maggiore collaborazione per evitare che il benessere presente si capovolga in disastro.
La prova che questo modo di concepire l’informazione non riesce a interessare i lavoratori e non fa vedere bene ciò che informazione significa come strumento di lotta, è data dal fatto che si è lottato per avere pagate le ore d’assemblea all’interno della fabbrica. La fatica del lavoro, lo scarso interesse per quello che si diceva, la sfiducia nella possibilità di fare qualcosa, facevano disertare quasi totalmente le assemblee dopo le ore di lavoro.
In pratica solo in questi ultimi anni ci si va accorgendo della grandissima importanza che l’informazione assume nella lotta di classe.
I primi ad accorgersi di questo fatto sono stati proprio i padroni, elaborando tutta una sezione speciale della tecnologia allo scopo di costruire un sistema perfetto d’informazione. Non solo dal punto di vista “passivo”, cioè codificazione e catalogazione di tutte le varianti sociali; ma anche dal punto di vista “attivo”, creazione e sollecitazione di un certo tipo di variante, quella più utile al potere padronale.
Dal momento in cui la televisione ha iniziato il suo sviluppo commerciale, i padroni si sono accorti di come poteva essere utilizzata come strumento di condizionamento e di controllo, sempre più perfezionato ed efficace, via via nel tempo. Su questa strada il fatto lavorativo stesso potrebbe essere, in futuro, profondamente modificato, fino a rendere il rapporto di classe estremamente nebuloso, con conseguenze catastrofiche per la logica della lotta rivoluzionaria.
La fusione del telefono e della televisione, con tutte le incredibili possibilità che questo “impero” dell’informazione darebbe a un potere centrale, viene vista ormai come un programma preciso da parte degli Stati moderni più avanzati, con in testa gli Stati Uniti. Le possibilità dell’elettronica fornendo calcolatori di potenza e capacità nemmeno immaginabili appena dieci anni fa, lasciano supporre meno fantascientifica di quanto sembri a prima vista, una possibilità di assoluto potere sulle masse.
Per quanto li riguarda, gli intellettuali, questa classe di servitori del sistema, sembrano uscire da una fase di “crisi di coscienza”, per disporsi a quest’ultima contrattazione col potere. I migliori servitori di domani potrebbero essere proprio i più arrabbiati contestatori di ieri, educati alla fumosa manipolazione dei concetti chiave di una pseudo-rivoluzione che avrebbero voluto fare nel chiuso delle loro stanze.
Eppure, esistono possibilità notevoli d’impadronirsi e autogestire un certo tipo d’informazione. Tutto consiste nel rendersi conto dell’esistenza di queste possibilità. In questo si hanno le medesime difficoltà di ordine generale che molti incontrano davanti al concetto di “autogestione”. Il problema è sempre quello: in che modo possiamo fare da soli? Che senso ha contrapporre il nostro misero volantino all’azione pesantemente integratrice della grossa casa editrice o del giornale che tira trecentomila copie al giorno?
Eppure un senso esiste. Lo vediamo nell’accanimento con cui la polizia perseguita i nostri “miseri” volantini, mentre lascia passare inosservati i nostri libri, anche quando contengono le stesse tesi e le stesse frasi dei volantini. Un motivo ci deve essere. Ed è costituito dal fatto che il potere conosce perfettamente la grande pericolosità del volantino, del numero unico, del giornale locale, insomma di quei piccoli strumenti che creano un livello d’informazione diretto a correggere l’azione integratrice del sistema.
Accanto a questa tecnica attiva d’informazione, che secondo noi non è ancora veramente riuscita a cogliere la dimensione autogestionaria, ma si è posta semplicemente come informazione alternativa gestita da gruppi specializzati; andrebbe sviluppata l’informazione nei posti di lavoro, nelle scuole, dovunque si svolge il contrasto di classe; ciò garantirebbe il possesso di quegli strumenti che fanno decidere lo scontro.
Comprendere bene l’importanza dell’autogestione dell’informazione significa comprendere i motivi per cui oggi, in un sistema padronale centralizzato, o domani, in un sistema socialista centralizzato, l’autogestione finisca per essere una pantomima recitata soltanto a beneficio della classe al potere. Infatti, in queste realtà, i lavoratori non hanno la possibilità di elaborare un’informazione di base, non sono padroni dell’informazione; questa arriva loro attraverso i “filtri” della burocrazia, condizionata, preventivamente, a seconda degli interessi che questa, direttamente o indirettamente, intende raggiungere.
[Per la stesura dei primi tre paragrafi di questo capitolo sono state utilizzate le mie introduzioni ai seguenti tre ciclostilati: La lotta della “LIP” e la conquista dell’informazione. Documenti, Catania 1974; Autogestione. Teorie. Interpretazioni. Realizzazioni, Catania 1974; P. Archinov, Problemi costruttivi della Rivoluzione sociale, Catania 1974]
Sviluppo della capacità creativa
Il capitalismo ha determinato, nel corso della sua storia, un certo sviluppo complessivo delle forze produttive di cui l’uomo dispone. Non ci interessa qui l’annosa questione sulla presunta “necessità” storica del capitalismo come inevitabile fase successiva all’organizzazione feudale e postfeudale della produzione, quanto invece il problema se, in effetti, questo progresso delle forze produttive è stato massimo e “necessario”.
Il problema non è trascurabile. In effetti questo sviluppo, questo accrescersi del potenziale tecnologico, questo perfezionarsi delle capacità lavorative, c’è stato ma non può essere considerato una fase “necessaria” dell’assoluto sviluppo della storia. Questo schema sa troppo di hegeliano per essere accettato di peso in un’analisi moderna che vuole essere libera dalle pesanti ipoteche dell’imperialismo culturale marxista. Se accettassimo la tesi della fase intermedia e del massimo sviluppo dovremmo ammettere, deterministicamente parlando, l’avvento indispensabile, in un futuro più o meno prossimo, della fase comunista nell’organizzazione della produzione, per cui scadrebbe l’importanza della spinta rivoluzionaria. Non dobbiamo dimenticare che anche quando i comunisti autoritari (esempio, Lenin o Gramsci) hanno criticato l’ipotesi del determinismo marxista considerandola una versione “volgare” del materialismo dialettica, hanno suggerito che questa ipotesi restava valida e utilizzabile “nei momenti di crisi e di deflusso” del movimento operaio. Ancora una volta la visione tattica finiva per deformare la sostanza del problema. Anche l’attesa messianica del determinismo poteva essere utile in momenti di “stanca” perché dava agli uomini una fede nella società comunista di domani che “comunque” doveva venire e alla quale si poteva guardare con speranza dal fondo della buia notte presente. Tutta roba che non ci interessa.
Il concetto di necessità è spurio in filosofia e presenta caratteristiche troppo precise per passare inosservato. Lo schematismo filosofico tedesco, in genere, contiene il termine “necessità” costantemente posto in relazione ad altri termini da giocolieri: “essere”, “ente”, “sostanza”, ecc., per cui, questi ultimi, ricevono da quello non solo una luce qualsiasi, ma la possibilità logica di pretendere un significato. È un gioco che lo stesso Marx denunciò non accorgendosi di esserci dentro fino al collo, con tutta la buona volontà manifestata nelle tesi programmati che su Feuerbach.
Lo sviluppo capitalista è un dato di fatto, l’attuale livello di sviluppo delle forze produttive è un altro dato di fatto, come il livello della lotta di classe e quindi della fondamentale contraddizione che mina il sistema capitalistico e che lavora alla sua distruzione. Che questo sistema, come tutte le organizzazioni, abbia la pretesa di non voler morire e di cercare con tutti i mezzi (fascisti compresi) di sopravvivere, è un discorso che non è estraneo a quello della crescita, della persistenza o della diminuzione della capacità creativa operaia. Se fosse possibile l’ipotesi “necessaria” di partenza, avremo che questa capacità di “fare progetti” dei lavoratori sarebbe costantemente in aumento, quindi potremmo prescindere dallo stato attuale della contraddizione del sistema, dalla lotta di classe, dal livello di sviluppo delle forze produttive e affermare che essa è oggi quella che è, che domani sarà un poco migliore di oggi e così via, per trovarcela bella e pronta al momento dello sbocco rivoluzionario. In effetti il problema è molto diverso. La capacità creativa può essere utilizzata dal sistema capitalista come uno strumento nel gioco delle vicende della sua sopravvivenza, e allora essa viene a essere coinvolta in una lotta che le risulta estranea. Sarebbe questo il caso di una forte diminuzione dell’orario di lavoro, di un processo di automazione sempre più ampio, di un impiego di più grandi fonti di energia, di una utilizzazione a livello globale delle fonti di informazione, di una centralizzazione del tempo libero e di tutti i problemi connessi. Annunci di programmi così ampi sono, ad esempio, i frequenti “slittamenti” che vengono concessi nelle pubbliche amministrazioni, consentendo ai burocrati di andare in pensione molto tempo prima del termine fissato per legge, allo scopo di diminuire la massa di questi lavoratori, la pressione della disoccupazione e così via. In effetti, il loro sostanziale ruolo produttivo era stato talmente ridotto, preventivamente, che la messa in pensione non determina alcun vero e proprio spostamento all’interno dell’organizzazione burocratica stessa.
Come abbiamo detto, il problema è di portata amplissima. Le organizzazioni sindacali se lo sono posto, ma soltanto come correttivo di fronte a situazioni specifiche di fallimento sul piano rivendicativo, non nella sua reale portata di problema del futuro, di problema che potrebbe condizionare la gestione produttiva postrivoluzionaria, un domani che le manovre padronali riuscissero veramente a “ridurre” la presente capacità creativa del lavoratore.
Qui, a nostro avviso, s’inserisce un nuovo aspetto del concetto rivoluzionario dell’autogestione. Impadronirsi oggi della capacità di fare progetti, significa garantirsi contro questa probabile azione futura dei padroni. Studiare i mezzi per una produzione gestita dalla base, significa capovolgere i programmi padronali, specie nel caso che questi dovessero passare proprio attraverso la falsa “autogestione centralizzata”; farlo in tutte le occasioni possibili, anche nel corso delle vicende stesse della lotta di classe e non come ultimo espediente, ma come costante punto di riferimento, può essere la strada per la soluzione del problema.
[Cfr. la citata Introduzione a “Noir et Rouge”, Lo Stato, la Rivoluzione, l’Autogestione, pp. 16-19]
La rivista “Noir et rouge”
Nasce nel marzo 1956 ed è sostenuta dai G.A.A.R. (Groupes Anarchistes d’Action Révolutionnaire) costituiti nel novembre dell’anno prima e che raggruppano elementi diversi provenienti dalla Federazione comunista libertaria e da una deludente esperienza più trotskysta che libertaria, quella della partecipazione alle elezioni legislative del 1956.
Questi gruppi, i G.A.A.R., sono all’epoca impegnati nella lotta contro la guerra di Algeria. Poi si ha il tentativo di formare una organizzazione specifica anarco-comunista, tentativo che fallisce e molti elementi escono dai G.A.A.R. per costituire l’Union des Groupes Anarchistes Communistes (U.G.A.C.), mentre i restanti danno vita al gruppo “Noir et Rouge” allo scopo di continuare la rivista.
La formazione di questo nuovo gruppo avviene intorno al 1961. Si deve attendere fino alla Pentecoste del 1967 perché una grossa scissione al Congresso della F.A. (Fédération Anarchiste) si riconnetta al gruppo “Noir e Rouge” che si trasforma in Gruppo-non-gruppo. L’entrata di nuovi compagni, specie studenti parigini e anche della provincia, richiama l’attenzione sul concetto di gruppo, cercando di studiare, se possibile, una nuova forma di organizzazione. L’applicazione pratica di queste idee si tenta nel Movimento 22 marzo. Il maggio 1968 vede il Gruppo-non-gruppo lanciato in differenti attività, per cui solo alla fine del 1968 si ricostituisce quando gli avvenimenti esteriori lo permettono e riprende la rivista per un periodo di due anni.
Come gruppo, i compagni facenti riferimento a “Noir e Rouge”, non avevano un’organizzazione precisa e una stessa attività precisa, organizzata, a parte, nel periodo del Maggio francese, dove addirittura divennero famosi come “la banda à Cohn-Bendit”. È per questo che dopo, anche sotto la spinta dei nuovi aderenti, il gruppo cerca di darsi nuove strutture, più decentralizzate, più diversificate, fino ad “esplodere” come gruppo e come rivista. L’ultimo numero della rivista (n. 46) denuncia questa situazione e tenta una sincera autocritica dell’attività del gruppo e della rivista stessa, arrivando a una totale demistificazione.
L’importanza di questa pubblicazione è da ricercarsi, maggiormente, negli argomenti e nelle ricerche affrontati: razzismo, lotta di classe, lotta anticlericale, massoneria, individualismo, famiglia, collettivizzazione in Israele, in Spagna, in Jugoslavia, critica del marxismo, materialismo, critica dell’URSS, problema della divisione del lavoro, critica delle scienze umane. Dopo il maggio 1968 si intensifica l’influenza dei situazionisti e del libro: De la misére en milieu étudiant. Lo sforzo di approfondire l’opposizione tra anarchismo e marxismo si va esaurendo, l’interesse della rivista si sposta sul problema dei consigli, su Pannekoek e su altro.
Comunque, come scrive la rivista proprio nell’ultimo numero: «L’anarchismo, pur essendo in molti a pensare che costituisca un freno allo sviluppo delle nostre attività nel momento presente, deve restare una costante delle ricerche di “N. R.”, e la sua stessa critica dovrà tendere a rivalorizzarlo». Nel n. 28 del 1964 aveva scritto: «Un anarchismo – noi cerchiamo – che si definisca non soltanto come una concezione umanitaria, individualista, filosofica ed etica, ma anche organizzativa, sociale, economica, collettivista e proletaria».
[Cfr. “Noir et Rouge”, Lo Stato, la Rivoluzione, l’Autogestione, op. cit., pp. 8-9]
Autogestione ed espropriazione rivoluzionaria
La prospettiva autogestionaria, come abbiamo visto, non si pone come un lontano miraggio del quale si può soltanto teorizzare, ma presenta caratteristiche precise e modalità determinate. Tra i diversi problemi che solleva, nella fase dell’organizzazione rivoluzionaria, esiste quello della giustificazione etica e politica dell’espropriazione.
Non può esserci dubbio che il fatto autogestionario, sia come organizzazione dell’evento rivoluzionario, sia come organizzazione della produzione e della distribuzione in forma diversa da quella capitalista, è un fatto espropriativo. Il padrone e i suoi servitori devono essere messi da parte, il diritto di proprietà del primo e i pretesi diritti di rappresentanza dei secondi, devono essere cancellati e distrutti.
Ciò solleva il problema dell’espropriazione.
L’atto di “espropriazione” è quello con cui le masse derubate rientrano in possesso di tutto quello che è stato loro sottratto con l’inganno e con la forza. L’espropriazione toglie la proprietà a coloro che la detengono senza prevedere alcun indennizzo.
Espropriazione non significa furto. Chi ruba, nel senso comune che questa parola ha nella realtà del capitale, trasferisce la proprietà di qualcosa senza con ciò compiere un atto rivoluzionario. L’espropriazione, al contrario, trasferisce il bene dalla proprietà del singolo alla libera disponibilità della collettività espropriante col risultato di fare ritornare alla collettività il bene che le era stato rubato in precedenza e di abolire una sovrastruttura giuridica (il diritto di proprietà) che rendeva legale quella sottrazione.
I rivoluzionari però non possono aspettare con le mani in mano che sia tutto il popolo in armi a espropriare gli sfruttatori. Nel frattempo l’azione di attacco contro la proprietà deve essere generalizzata per quanto possibile, sia a livello di comportamento illegale individuale, sia a livello di attacco organizzato. Non sarà certamente l’espropriazione in atto, ma sarà lotta e preparazione alla lotta, attacco al capitale e rifiuto della subordinazione della quotidianità alla logica dei padroni.
In passato molti compagni manifestavano una ritrosia notevole a considerare questo problema dell’espropriazione parziale, non riuscendo a superare la sacralizzazione della proprietà altrui e la condanna borghese del furto. Oggi le cose sono notevolmente cambiate e spesso si casca nell’eccesso opposto, finendo per considerare l’esproprio proletario un’attività fine a se stessa, una specie di sport o di droga. La soluzione migliore sarebbe sempre quella di un giusto uso dello strumento.
L’espropriazione isolata può essere di terre, di denaro, di beni strumentali o di consumo.
L’espropriazione della terra, quando si presenta come fenomeno isolato, deve realizzarsi fino in fondo con tutti i mezzi possibili. L’arrivo della repressione pur essendo un fatto scontato avrà conseguenze diverse a seconda di quanto tempo è durata l’espropriazione e della sua capacità di estensione nello spazio.
L’espropriazione di beni strumentali (a esempio, un’industria) potrà costituire un punto di riferimento solo a condizioni che si sia in grado di autogestire la produzione per un minimo ragionevole di tempo e ciò perché l’esperimento possa assumere aspetti significativi anche per gli altri lavoratori e per le future lotte.
L’espropriazione di denaro verrà contrastata dal potere attraverso un attacco contro le realizzazioni rivoluzionarie e comunitarie che col denaro espropriato si sono potute sviluppare.
Anarchismo e autogestione
Superamento dell’anarchismo idealista
Intendiamo con il termine di “anarchismo idealista” l’insieme di tutte quelle tendenze che mettono in secondo piano la lotta sociale e l’intervento diretto nel conflitto economico, dando la preferenza all’evoluzione progressiva e indeterminata dell’uomo, inteso, in se stesso, come fenomeno compiuto e non considerato in relazione a una certa situazione storica.
Per queste tendenze l’uomo è un dato “assoluto”, dotato di caratteristiche costanti che sono soltanto distorte dalla pressione del potere, per cui, una volta rimossa questa pressione, con l’educazione e la lotta, egli troverà la strada per raggiungere le mete della perfezione.
Possiamo distinguere tre correnti in questo cosiddetto “anarchismo idealista”: a) l’anarchismo liberale, b) l’anarchismo evoluzionista, c) le tendenze naturiste, vegetariane, esperantiste, cristiane, pedagogiche, ecc.
L’anarchismo a tendenza liberale ha causato non poca confusione. Anche oggi, con una certa malafede, molti liberali utilizzano scritti di teorici anarchici spacciandoli a sostegno della propria tesi.
Abbiamo avuto in Italia l’esempio di alcune opere di Francesco Saverio Merlino edite con introduzione da un esponente della vecchia congrega liberale (a cura di Vittorio Frosini, Il socialismo senza Marx, Bologna 1974).
Per certi aspetti la responsabilità è stata anche di alcuni anarchici che non hanno voluto operare con chiarezza una scissione netta tra libertarismo e liberalismo. Così scriveva al liberale Piero Gobetti il nostro Berneri: «Non pensi caro Gobetti, che potrebbe essere utile, su “Rivoluzione liberale”, una serie di studi sul liberalismo economico nel socialismo? Credo colmerebbe una grande lacuna e leverebbe di mezzo molti e vecchi equivoci. Credo ne risulterebbe, fra le tante cose interessanti, questa verità storica: essere stati gli anarchici in seno all’Internazionale, i liberali del socialismo. Storicamente, cioè nella loro funzione di critica e di opposizione al comunismo autoritario e centralizzatore, lo sono tutt’ora». (Lettera del 24 aprile 1923).
Ma in pratica, Berneri aveva idee molto diverse. Sosteneva un vigoroso potenziamento dell’anarchismo, strappandolo dalle solite formulazioni tradizionali per impegnarlo di più nella lotta di tutti i giorni e vedeva chiaramente come il materialismo storico fosse indispensabile per l’interpretazione della storia e la costruzione di una norma d’azione. «Che Marx sia stato il sistematore, quindi il potenziatore, del materialismo storico, non è una buona ragione per passare sotto il nome di marxismo ciò che appartiene ormai alla moderna filosofia della storia che, comprendendolo e correggendolo, lo supera». (“Pensiero e Volontà”, 1° aprile 1924).
Furono gli epigoni, i lettori interessati dei suoi scritti, che svilupparono una latente interpretazione liberale e idealista, facendo di Berneri l’autore più importante di un anarchismo di tipo umanitarista. A nostro avviso, a parte passi come quelli della lettera a Gobetti, e altri scritti poco felici come l’Operaiolatria, la cosa non risponde a verità e offre la possibilità, agli uomini politici liberali, di sfruttare i nostri argomenti per la loro polemica contro il marxismo, fatta a nome dei padroni.
Nessun grosso teorico anarchico, direttamente impegnato nelle lotte sociali, fu un umanitarista. Tutti si resero conto, sia pure con diverse sfumature, della necessità della lotta e delle condizioni specifiche che questa necessità comportava. Ciò non toglie che molti compagni predichino la fratellanza universale, l’unione di tutti gli uomini in nome di un umanitarismo che se è lodevolissimo come desiderio dell’uomo di vedere scomparire per sempre dalla faccia della terra ogni manifestazione di violenza e di guerra, non per questo cessa di essere assurdo e inutile.
L’anarchismo evoluzionista possiamo identificarlo con la grande figura di Kropotkin. Egli riprende la teoria di Darwin ma ne trasforma radicalmente l’impostazione: i punti essenziali sono:
-
Ammissione della tendenza evolutiva del progresso delle forme organiche.
-
Lotta per la vita. È il centro della polemica di Kropotkin. La lotta viene riconosciuta, non potendosi negare come fatto storico. È invece negata all’interno della specie, in quanto limitata alle classi o ai gruppi in contrasto tra loro.
-
Da questa correzione del principio di Darwin, correzione cui era giunto, dal canto suo, lo stesso scienziato inglese, nelle sue opere successive, viene spontaneo il concetto di “mutuo appoggio”.
-
Il concetto di “socialità”, che rende possibile l’impiego dell’altro concetto di “mutuo appoggio”, nell’interpretazione della dinamica evolutiva della specie.
Ma fu l’incontro con Spencer che l’obbligò a ristrutturare il suo pensiero per criticare quello del sociologo inglese che, malgrado l’aspetto libertario, concludeva per la necessità del governo.
L’immobilismo di Spencer, che spesso lo fa apparire un reazionario, non poteva riscuotere le simpatie di Kropotkin. La tesi evoluzionista, rendeva consequenziale questo immobilismo: lo sviluppo dell’umanità è lento ma inevitabile, allo stesso modo dello sviluppo del bambino: come non è possibile accelerare i termini di quest’ultimo sviluppo, così non è possibile farlo per primo. Da ciò la considerazione negativa in cui Spencer teneva le rivendicazioni della classe operaia, nelle quali vedeva il tentativo di sovvertire quel corso predeterminato degli eventi in cui credeva.
I punti principali della critica di Kropotkin sono: a) riduzione in Spencer dell’evoluzione alla sola lotta per la vita, b) errore di partenza che considera l’uomo primitivo non vivente in società ma isolato, c) manipolazione filosofico-metafisica, d) ripresentazione dello strutturalismo di Comte.
Per Kropotkin, l’istinto della “socialità” domina lo sviluppo etico dell’uomo. La scoperta di un istinto identico a questo negli animali superiori, conduce alla soluzione del problema dell’origine dei moventi etici.
Da qui l’esclusione di ogni ingerenza religiosa.
La morale deve trovare il proprio fondamento in questo mondo. Non potendolo trovare nella semplice legge dell’evoluzione, intesa nel senso di lotta per la vita o di sopravvivenza del più forte, lo trova in quello della società, cioè di “mutuo appoggio”. Questa legge è ugualmente necessaria come la legge che regola l’istinto di conservazione.
Il momento successivo dello sviluppo etico è quello della riflessione speculativa. Kropotkin non parla della filosofia accademica ma delle riflessioni morali che l’uomo ha sviluppato nel corso dei tempi. Da una parte queste riflessioni determinano regole di condotta, dall’altra queste regole trovano conferma nell’affinarsi dell’istinto primordiale di socialità.
Ecco come Malatesta parla di questa posizione kropotkiniana: «Secondo il suo sistema, la volontà (potenza creatrice di cui noi non possiamo comprendere la natura e la sorgente, come del resto non comprendiamo la natura e la sorgente della “materia” e di tutti gli altri “primi principi”) la volontà, dico, che contribuisce poco o molto a determinare la condotta degli individui e delle società, non esiste, non è che un’illusione... Naturalmente, logicamente, se la volontà non ha alcuna potenza, se tutto è necessario e non può essere diversamente, le idee di libertà, di giustizia, di responsabilità non hanno nessun significato, non corrispondono a niente di reale». (“Studi sociali”, 15 aprile 1931).
Questo non significa che Kropotkin non fosse per la rivoluzione, significa solo che la considerava un momento dello svolgimento generale del processo evolutivo. Malatesta, invece, considerava l’intervento rivoluzionario, l’azione insurrezionale di preparazione, la lotta e l’organizzazione della lotta, atti dovuti alla volontà dell’uomo.
L’azione rivoluzionaria, violenta se necessario, è l’aspetto conclusivo del volontarismo malatestiano. Ma questa azione non deve essere isolata o, peggio, condotta dall’esterno, sulla testa del popolo. In questo senso la considerazione e lo studio delle condizioni oggettive che determinano le modificazioni strutturali dell’uomo, non ultime le condizioni stesse dell’evoluzione, non devono essere considerate come da gettare via, ma tenute presenti nella stessa prospettiva dell’organizzazione diretta della lotta.
Le tendenze naturiste, vegetariane, esperantiste, cristiane, pedagogiche, di liberazione sessuale, ecc., sebbene nel loro complesso rispondano a bisogni essenziali di liberazione dell’uomo, si pongono in posizione subordinata al problema centrale della lotta di classe. Non attaccando direttamente le strutture portanti della società capitalista, limitandosi (nella maggior parte dei casi) a una resistenza “passiva” o “alternativa”, dimostrano di non avere compreso l’essenza del potere moderno che è basato sulla tecnica morbida dell’inglobazione. Qualche volta questi movimenti superano le limitatezze del lavoro specifico di tipo educazionista e passano all’organizzazione di classe e all’attacco al potere; in questo caso, pur restando immutato il nome, è cambiata la loro sostanza e, quindi, la nostra critica non ha più ragione d’essere.
È lo stesso problema dell’individualismo anarchico. L’istanza primaria è essenziale: bisogna salvare l’individuo dal pericolo della massificazione e dallo stesso pericolo di una libertà costruita su di lui, in nome di valori che finiscono per risultargli estranei. Ma questa tutela indispensabile, può raggiungersi per un’altra strada, cioè non attraverso la negazione dell’altro, ma attraverso la collaborazione con l’altro in un germe organizzativo che trovi la giusta dimensione e i giusti rapporti per non degenerare in una costruzione centralizzata. E questo libro è proprio un contributo alla risoluzione di questo problema. Neghiamo che il problema sia insolubile. Al contrario, affermiamo che partendo dalla base, mettendo da parte ogni struttura di partito o di sindacato, gestendo la lotta rivoluzionaria e la costruzione della nuova società, dal basso; si può risolvere il problema dell’apparente contrasto tra individualismo e comunismo anarchico.
Le basi di un anarchismo materialista
Il termine “idea”, usato tanto spesso dagli anarchici, ha due significati nella storia della filosofia. Poiché esso è stato coniato dai filosofi, è giusto che cerchiamo di chiarire questi significati, per superare una grave confusione che spesso troviamo fra i compagni. Il primo significato è quello di Platone: l’idea è il modello delle cose esistenti (esempio, il cavallo e l’idea di cavallo), e su di questa affermazione il filosofo greco costruiva tutta una mitologia che qui non ci interessa. Il secondo significato è quello di Cartesio: l’idea è un concetto, una teoria, una tesi, un modo di interpretare una realtà.
È evidente che il senso moderno in cui viene quasi sempre usato il termine “idea” è quello di Cartesio. Ma quando facciamo riferimento all’idealismo le cose non sono più chiare. Quando diciamo che l’anarchismo, in certe sue manifestazioni è stato ed è idealista, e che dovrebbe smettere simili fanciullaggini per diventare materialista, intendiamo dire che dovrebbe smettere di considerare la realtà un prodotto dell’idea. Qui sta, infatti, l’equivoco.
Gli idealisti (Hegel e tanti altri) considerano la realtà come una proiezione dell’idea (in senso platonico) e molti nostri compagni, cadendo nello stesso errore, considerano la realtà rivoluzionaria come qualche cosa che viene determinata esclusivamente dalla nostra idea. In questo modo anche il volontarismo finisce per idealizzarsi, e pericolosamente. Si può spiegare in questo modo la presenza di teorie estranee agli interessi del movimento operaio in generale e allo stesso movimento anarchico in particolare, e che vengono propugnate, nella più assoluta buona fede, dai compagni che non hanno una chiara visione del problema.
Consideriamo, al contrario, il termine “idea” nel senso di Cartesio. In questo modo l’“idea anarchica” è una tesi, una teoria, un’interpretazione del mondo. Essa non produce niente sulla realtà, se non siamo noi, con le nostre azioni, a determinare, le condizioni adatte e se la realtà, in se stessa, non presenta caratteristiche precise non dipendenti soltanto dalla nostra volontà.
La volontà non ha qualità particolari, non ha capacità miracolose, non può risolvere situazioni irrisolvibili, non può determinare accadimenti che non corrispondano a certe situazioni già esistenti nella realtà; può soltanto accelerare questi processi, indirizzarli in un senso o nell’altro; in una parola, può contribuire a determinare il corso della storia.
Gli anarchici insistono per costruire un’organizzazione della società che parta dal basso e che garantisca la libertà di tutti dal bisogno e una uguale distribuzione dei beni. Questo loro insistere è un’azione volontaria e cosciente che trova di fronte una realtà sociale molto differente, a volte refrattaria a questa soluzione. Compito degli anarchici è quello di agire su questa realtà per indirizzarla verso le prospettive libertarie.
Ma nella realtà agiscono forze di composizione e indirizzo molto contrastanti. Vi sono le forze della reazione, padroni e loro servitori, che sostengono lo sfruttamento; vi sono le masse sfruttate che lottano a volte in modo scomposto e scarsamente cosciente, per affrancarsi; vi sono le minoranze autoritarie e rivoluzionarie che cercano di guidare queste masse non verso l’abolizione del potere ma verso la costruzione di un nuovo potere. Su questa realtà, che chiamiamo lotta di classe, bisogna agire concretamente, senza idealizzare né la nostra “idea” in se stessa, né l’atto stesso dell’azione. Queste due idealizzazioni ci impedirebbero una visione esatta della realtà.
La lotta di classe è un fatto innegabile. Essa può essere interpretata con gli intendimenti metodologici marxisti e risultare deformata in funzione dei fini che questa brava gente vuole raggiungere. Può essere interpretata in senso libertario, non forzandola al sostegno di tesi discusse a tavolino da filosofi in vena di astruserie.
Il particolare punto di angolazione dato dai marxisti al ruolo giocato dal movente economico, la dipendenza assoluta tra la struttura e quello che essi considerano sovrastruttura, la scarsa considerazione del problema etico, la strumentalizzazione dialettica, il meccanismo filosofico rigidamente legato a una concezione ormai del tutto sorpassata di “visione del mondo”; sono problemi che non reggerebbero molto tempo se sottoposti a una critica aperta e franca degli stessi marxisti, una volta che costoro uscissero dallo schema imposto dal partito. In altri termini, se scomparisse il rapporto autoritario che lega il fenomeno marxista, in breve, scomparirebbe il marxismo così com’è per riemergere come una fra le tante teorie che possono essere prese in considerazione per analizzare le condizioni di lotta del proletariato e le possibilità di una futura società socialista.
Il caso di Lukács è chiarissimo. Non appena si permette di sviluppare un’interpretazione che esce dalle direttive del partito è costretto all’autocritica e, per sopravvivere, deve rinunziare e dichiarare errata la sua tesi. Korsch, che non lo fa, viene gettato fuori dal partito e gli è impedita qualsiasi attività. In questo modo il discorso diventa assurdo e allucinante.
Ogni discorso aperto con i marxisti, specie sul piano del materialismo storico, è bloccato non tanto dalle loro tesi quanto dal partito, che le santifica e le rende inavvicinabili. Finché resteranno in questo stato di cose, non sarà possibile non solo parlare di apertura, ma anche di utilizzare quelle tesi per le nostre analisi. Al contrario, sarà necessario riprendere tutti gli spunti analitici che ci sono stati tolti, esaminare in che modo sono stati mistificati e riportarli alla loro originalità.
Per rendere concreto il nostro discorso riportiamo due esempi. Il primo ci viene dato dal concetto di dialettica. Nel senso marxista la dialettica non è un modello che ci consente di esaminare un possibile sviluppo della realtà, ma spesso è la realtà stessa nella sua intrinseca composizione. Quest’ultima tesi è molto valida per stabilire le condizioni di dominio del partito perché sarà sempre possibile fissare un modulo preciso e spacciarlo come realtà. Al contrario, un modello di lavoro può sempre essere messo in dubbio, può essere criticato da chiunque e, su questa impostazione, un partito si troverebbe subito in difficoltà.
Il secondo esempio lo troviamo nel concetto di classe. Come abbiamo visto Marx è molto nebuloso. Per aversi una classe occorre la coscienza di classe, chi non la possiede non si può dire che appartenga a una certa classe anche se certe condizioni (ad esempio, economiche) porterebbero a una conclusione di appartenenza. Questo problema aprirebbe la strada a tutta una serie di considerazioni in merito al rapporto avanguardia-classe, nel senso che la crescita della seconda dovrebbe portare alla scomparsa progressiva della prima: ma le scadenze potrebbero essere più immediate, la necessità ancora una volta presentarsi alla porta: da ciò una conclusione rigidamente centralista, quello che conta è l’avanguardia, il processo rivoluzionario farà il resto. Si sfugge, in questo modo, al problema, lasciandolo aperto. Ma, in effetti, la rivoluzione la faranno gli sfruttati, la loro classe non è rigidamente determinabile a priori, e, materialisticamente, non è nemmeno necessario che lo sia: le condizioni di fondo dello sfruttamento, condizioni economiche ed etiche, fanno in modo che la separazione esista e si mantenga. Ma i marxisti non possono essere d’accordo con queste affermazioni. Per loro solo il proletariato industriale è una classe rivoluzionaria; se poi sono altre classi, quelle dei contadini, a fare la rivoluzione: non cambia, la loro tesi resta la stessa. Su questi argomenti non è possibile alcuna apertura.
Ma questi problemi della dialettica e della metodologia filosofica, delle classi e degli sfruttati, e tanti altri, non sono problemi “marxisti”, sono problemi di tutti e devono essere affrontati dagli anarchici. Al di là delle parole, l’esperienza è indispensabile.
La conclusione di questo discorso è la necessità di liberare il materialismo dall’ipoteca dialettica dei marxisti senza ridurlo all’astrazione biologica o meccanica, senza cioè tagliarlo fuori dalla sua sede storica. L’uomo è un evento storico. Come fenomeno biologico esso non ci dice nulla in merito ai suoi destini e alle sue possibilità. Solo nella storia si estrinseca e si costruisce in quanto uomo.
Peraltro, l’affermazione della storicità dell’uomo non è affatto un riconoscimento della sua inevitabile struttura dialettica. Il materialismo storico non è una “combinazione” marxista, almeno nei termini in cui è possibile tenerlo in piedi come materialismo senza essere costretti a ridurlo a un idealismo figlio di Hegel, tanto ampio che Gentile e Marx possono pure starci insieme.
L’uso della ragione, per cui è possibile parlare di materialismo, può essere in senso dogmatico (assolutista) e in senso critico (non dialettico). In quest’ultimo senso, che è poi quello che ci interessa, possiamo dirci razionalisti, non dialettici, critici, pluralisti, volontaristi; in quest’ultimo senso la volontà (irrazionale) coglie il momento positivo della ragione (razionale) e determina la forma storica (materiale), senza esservi costretta da un modello prefissato (dialettico). Al contrario dei dogmatici dialettici (marxisti), dobbiamo cogliere l’aspetto fecondo del pensiero nella sua azione sul reale, nella sua effettiva realizzazione come trasformazione degli schemi, ma questo è possibile solo se partiamo da una posizione sgombra di preconcetti e modelli precostituiti (materialismo dialettico).
Quanto sia grave questo problema ognuno può vedere riflettendo su come molti compagni anarchici risultino condizionati dalle tesi marxiste, anche nella scelta degli autori da leggere. Ad esempio, Sorel è messo al bando su condanna della chiesa marxista, lo stesso dicasi per Stirner e per tutti gli altri pensatori che hanno inteso darci una visione volontaristica della realtà. Quello che non è ammissibile, per degli anarchici, è la condanna in blocco, il rifiuto in assoluto, per principio, specie quando questa condanna viene da parte marxista. Se non si fosse contrapposto storicamente in modo così netto a Marx, in seno alla Prima Internazionale, la stessa sorte sarebbe toccata, probabilmente, anche a Bakunin.
[Per la redazione dell’ultima parte del presente paragrafo cfr. “Crisi economica e possibilità rivoluzionarie”, in “Anarchismo” n. 1, 1975, pp. 3-10]
La storia e l’uomo
La storia è vicenda degli uomini, delle loro lotte e dei loro sforzi per liberarsi. Il fenomeno più appariscente della storia è l’esercizio del potere: le vicende degli Stati diventano spesso centrali e finiscono per sommergere le vicende degli uomini.
«La potenza è in se stessa un male [...]. Non sta in quiete, ma è spinta da avido desiderio e per questo è irrealizzabile; crea un’infelicità che non può mancare di rendere infelici gli altri. Con essa, ineluttabilmente si cade nelle mani o di ambiziose dinastie desiderose di mantenersi al potere, o di singoli “grandi uomini”, e roba del genere, cioè di forze cui non importa nulla del progresso della civiltà». (J. Burckhardt, Weltgeschichtliche Betrachtungen, nella Jacob Burckhardt-Gesamtausgabe, a cura di A. Oeri e E. Durr, ns. tr., Stuttgart, Berlin und Leipzig 1929, vol. VII, p. 25).
È una interpretazione molto aderente alla realtà, sebbene necessita di notevoli correzioni. Questo storico insiste sulla “potenza”, entità centrale non meglio identificata, la quale estrinseca la sua forza che, da notarsi con attenzione, è sempre malefica.
«Certo lo Stato avrà fatto di tutto, presso gli Assiri, i Babilonesi, i Persiani, e altrove, per impedire l’avvento dell’individualità, che considerava, come sempre, un gravissimo male. Ed è sempre stato così dappertutto; ora in un punto, ora in un altro, l’individualità voleva emergere ma dovette soccombere di fronte alla barriera degli ordinamenti civili e religiosi, all’organizzazione delle caste, ecc., senza poter lasciar traccia di sé». (J. Burckhardt, op. cit., p. 42).
Qui si delinea un contrasto, una lotta. Ma non è la lotta di classe. In pratica, per quanto affascinante, questa tesi dello storico svizzero è falsa o, almeno, parziale. La lotta dell’individuo avviene all’interno di una dimensione collettiva, di una solidarietà di fondo; l’altra lotta, quella individuale, quella dei grandi spiriti della libertà, serve alla prima da punto di riferimento, ma non costituisce un segno dei tempi o una crescita obiettiva del processo di liberazione.
Ci pare che la caratteristica centrale della storia sia la lotta dell’uomo all’interno di strutture precarie modificate nel tempo in funzione delle necessità, ma tutte caratterizzate dal segno della solidarietà. Questa lotta emerge sollecitata da necessità obiettive: la fame, la miseria, le pestilenze, le angherie dei signori e dei preti, lo sfruttamento; emerge in rivolte più o meno organizzate, accordi di mutuo soccorso, strutture elementari di resistenza.
Essa si contrappone al potere in forma diretta accettando la guida delle elite rivoluzionarie che si apprestano ad attaccare il potere per soppiantarlo e che, proprio per questo, hanno bisogno delle masse.
Abbiamo, pertanto, una lotta a livello ufficiale, costantemente registrata dalla storia, che vede un continuo sostituirsi delle elite al potere; e, non registrata, una lotta della base, costantemente recuperata dall’elite in fase ascendente.
La domanda essenziale è la seguente: perché le istanze di liberazione della base sono state tutte le volte consegnate nelle mani dei futuri padroni? Perché tutte le lotte sono state recuperate?
La risposta ci pare chiara. In effetti, non c’è stato mai un recupero “totale” delle lotte, ma sempre si sono verificate delle “differenze”. L’insieme di queste differenze è quello che di solito definiamo “progresso”. Esse non possono disporsi in linea orizzontale, cioè non si può parlare di un processo rettilineo, comunque, per grandi fasi, questo processo c’è stato ed è riportabile sempre alle lotte degli sfruttati. Quello che è stato recuperato interamente è il senso di religiosità della lotta, legato in modo indissolubile alla situazione di miseria e di sofferenza della base. È il dolore che ha caratterizzato le lotte storiche e che è stato recuperato per intero attraverso il meccanismo della guida rivoluzionaria, e, con questo dolore, il senso di religiosità che si accompagna, il senso di “riscatto” e di “vendetta”.
Possiamo vedere nella storia, da un lato un progresso materiale dei popoli, dovuto alle loro lotte; dall’altro, la costanza del bisogno religioso che scaturisce dalla situazione di sfruttamento e di sofferenza in cui sono rimasti. A un cambiamento oggettivo dello sfruttamento e della sofferenza corrisponde un cambiamento di religiosità. Diversa la sofferenza dei popoli antichi, diversa la loro religiosità; diversa la sofferenza del proletariato moderno, diversa la sua religiosità.
Non dobbiamo però confondere religiosità con religione. La religione comporta un sentimento di religiosità nel popolo che non deriva dai miti assurdi della religione stessa, ma dalla situazione di sofferenza in cui il popolo si trova. Abolito lo sfruttamento, scompare la religione. In questo senso con religiosità del proletariato moderno intendiamo il bisogno che esso ha di avere una guida, un punto di riferimento; il bisogno del partito.
È questo bisogno che è stato recuperato costantemente nella storia, perché costantemente la sofferenza è stata ricostituita, sebbene sotto forme diverse e sotto diverse intensità.
Non è molto importante fissare un momento iniziale di questo decorso storico. Siamo più o meno certi che dalla proprietà comunitaria della terra si passò, in epoca storica, alla proprietà individuale, coincidendo il fenomeno con il passaggio dal matriarcato al patriarcato e con il sorgere della famiglia e del principio ereditario; ma quello che più conta è che la storia, dal momento in cui è possibile avere testimonianze ragionevoli, registra la presenza di maggioranze in stato di gravissimo disagio. Sono esse che danno il segno allo sviluppo storico, in altri termini, la storia tutta è storia degli sfruttati.
La situazione di sfruttamento viene determinata da una precisa distribuzione dei mezzi di produzione. La classe che gode della proprietà di questi mezzi finisce per sfruttare tutti coloro che ne sono esclusi. Ma questo fenomeno, da solo, non è sufficiente per determinare lo stimolo alla lotta, all’insurrezione. Occorre anche la volontà di alcuni, di una piccola minoranza, per spingere gli altri alla rivolta, per chiarire agli altri i perché della rivolta e gli scopi.
La storia non ci ha sempre registrato questi uomini e questi gruppi di uomini che spinsero alla lotta e alla ribellione gli sfruttati, ma la loro esistenza possiamo dedurla sia dalla presenza costante di queste minoranze in epoca storica, sia dal fatto che una massa di individui sfruttati non reagisce tutta allo stesso modo, vi sono quelli più sensibili, più rapidi a cogliere il limite di sopportazione dell’autorità, e quelli meno sensibili. È l’eterna differenza tra gli uomini, che crea le basi possibili all’esercizio attivo della volontà.
Spesso questi uomini sono stati inglobati dall’élite in ascesa, altre volte sono stati uccisi perché si erano rifiutati.
Contro il residuo senso di “religiosità” l’anarchismo deve lottare cercando di spingere gli sfruttati alla lotta liberatrice in prima persona, spiegando loro che quel desiderio della “vendetta” ha origine nelle oscure notti bibliche della religione del passato e che oggi deve essere visto nella sua obiettiva luce: un residuo irrazionale che viene sfruttato dalle elite in ascesa per ricacciare ancora una volta le masse nel baratro della disperazione.
Il determinismo dialettico
Il conflitto tradizionale, che ha segnato la storia dei movimenti rivoluzionari, è stato quello sorto attorno alla necessità di delimitare il campo d’azione dell’autorità. Che la nuova “autorità” sorga a contrapporsi alla vecchia è faccenda comunemente accettata come intrinseca componente del corso delle cose, almeno una volta data per certa la sostanza dialettica della realtà.
Tutti problemi di sostanza che sono anche di metodo. Se per metodo intendiamo quello dialettico, sostanza e metodo si identificano, onde appare sostanza il metodo stesso.
Il determinismo dialettico è prodotto di un’epoca storica ben precisa e risente di tutte le premesse scientifiche e metodologie tipiche dell’Ottocento. Il concetto di equilibrio dinamico che presuppone è preso dalla meccanica dell’epoca, ritenuta la scienza esatta per eccellenza, visto i grandi risultati che aveva dato nelle sue applicazioni all’astronomia. Se l’assunto di partenza è preso da Hegel (e sarebbe necessario studiare i limiti di questo prestito), l’idea generale di equilibrio dinamico è chiaramente un mito dell’epoca, che ritroviamo esattamente uguale in economia e in sociologia.
Non vogliamo trattare delle elaborazioni che il determinismo dialettico ha subito a opera dei revisori del patrimonio marxista, finendo per distaccarsi dall’impostazione più rigida che sarebbe quella di Engels. È interessante parlare qui di un tentativo di elaborazione fatto da alcuni compagni anarchici (R. Ambrosoli, N. Berti, A. Bertolo, P. Finzi, L. Lanza, Un’analisi nuova per la strategia di sempre, Cesena 1973). Il problema affrontato è quello della lotta di classe, ma ne viene fuori una strana interpretazione a causa di alcune confusioni in merito alla dialettica.
Tralasciando la presenza di Pareto, notevole critico del marxismo ma troppo inquinato di parzialità viscerale, e le reminiscenze di Kropotkin e Archinov, il discorso avanzato da questi compagni è abbastanza nuovo e interessante. Purtroppo lo schema tripartito sostituendo quello bipartito non fa modificare di molto il problema della dialettica. In fondo non esiste un passaggio netto tra livelli di contraddizione, anzi questi ultimi si possono suddividere in spazi infiniti, parimenti contraddittori, che stravolgono il misero meccanismo dialettico pur salvandone apparentemente lo schema. Un tentativo del genere è stato anche fatto da Mao nei suoi scritti sulla contraddizione.
Se il concetto di lotta di classe presenta dei pericoli (come li presenta) non è perché risulta legato, nella maggior parte delle interpretazioni, allo schema bipolare della dialettica, ma perché dietro quello schema si trova il meccanicismo deterministico che nega le capacità creative della volontà di ribellarsi. La dialettica può essere presentata in molti modi, fino a diventare non più un metodo di comprensione della realtà ma la realtà stessa. In quest’ultima versione essa appare ridicolmente limitata e presenta meno pericoli, però questi pericoli sono pronti a emergere nuovamente non appena si manifestano le conseguenze controrivoluzionarie del presupposto deterministico. Il fantasma cacciato dalla porta rientra dalla finestra.
Pertanto, ci pare che il centro del problema non sia tanto la scelta tra un modello binario e uno a tre variabili. La sola cosa da fare è sviluppare un’analisi delle forze che agiscono nella realtà sociale, anche utilizzando il meccanismo dialettico, ma soltanto a condizione di denunciare la pretesa marxista di suggerirlo come fondamento della realtà, e a condizione (ancora più significativa) che venga privato del presupposto deterministico. La lotta di classe non contiene nulla che possa fare pensare a una emancipazione finale “necessaria”. Solo l’azione rivoluzionaria, voluta e concretizzata dall’uomo, può realizzare il progetto della società futura.
Il volontarismo anarchico
È molto superficiale l’affermazione che la volontà rientri esclusivamente nell’ambito dell’irrazionale e vada riguardata con ogni possibile circospezione. Ci rendiamo conto che attraverso l’affermazione della volontà possono essere contrabbandate merci di diversa qualità (ad esempio, la volontà di potenza, ecc.), ma la questione va approfondita in un altro senso.
Se definiamo come “irrazionale” la volontà, dobbiamo sapere con esattezza cos’è il razionale. Non possiamo concordare con Hegel che il razionale è tutto ciò che esiste, cosa quest’ultima che farebbe diventare razionale la volontà ma non ci consentirebbe di distinguere più nulla: razionali sarebbero le azioni del despota che tiranneggia e quelle del rivoluzionario che lotta per la libertà,
Ma possiamo distinguere tra la razionalità nel senso di “ragion d’essere” e la razionalità nel senso di “ciò che ogni individuo, in una precisa situazione di classe, deve fare in base alla propria coscienza morale”. Il primo senso del termine “razionalità” è un senso statico, valido per ricercare motivi e connessioni nella realtà, il secondo è un senso dinamico indispensabile per l’azione pratica.
Questa che suggeriamo potrebbe essere una strada per superare l’apparente separazione tra ragione e volontà, tra razionale e volontario, tra determinismo e volontarismo.
Fissiamo in questo modo un rapporto preciso tra volontà e moralità, ambedue determinate storicamente dalla situazione di classe. La volontà determina quindi un’azione che trova un limite nella moralità dell’individuo, che non è un’entità astratta, ma qualche cosa che nasce dalla modificazione dell’evento storico della lotta di classe, per cui finisce per trovare la sua giusta collocazione nella realtà concreta dove, appunto, questo evento è in corso di svolgimento. In questo modo si è provveduto a una “razionalizzazione dell’irrazionale”, con un procedimento non diverso da quello che viene impiegato, poniamo, nella giustificazione della violenza. La violenza, se considerata in se stessa, come fatto primigenio, è un evento irrazionale, ma se considerata in funzione di una limitazione morale (violenza di fronte all’attacco costante dello Stato) diventa evento razionale perché trasformato dall’altro evento razionale – più ampio e generale – che è la lotta di classe.
Nel 1897 Malatesta scriveva: “Nessuno si scusi col desiderio di più grandi cose: nessuno nasconda la propria ignavia col dire che non scende in piazza se non per mandare il mondo a soqquadro. Il poco e meglio che niente!”. Nella grande chiarezza di queste parole, si può cogliere l’insegnamento più alto del volontarismo anarchico: la modestia e la costanza dell’azione. È in questa dimensione che la volontà trova la sua giustificazione e la sua ragione d’essere. Oggi, è proprio il volontarismo malatestiano uno degli elementi più importanti dell’anarchismo, uno degli elementi verso cui fare riferimento nell’interpretazione delle lotte degli sfruttati.
In Malatesta è chiara la necessità del fatto educativo e propagandistico ma anche la necessità del fatto insurrezionale, cercato con insistenza, studiato e alimentato con fede e passione, attuato anche quando non si può parlare di “rivoluzione anarchica”, come i puri vorrebbero che fosse.
Tutto ciò è presente in Malatesta, quello stesso Malatesta che viene preso a bandiera dal movimento anarchico.
La controparte
I partiti dei lavoratori
Sfruttando quella che abbiamo definito “religiosità residua” degli sfruttati, i partiti dei lavoratori si sono autodefiniti “guida” rivoluzionaria e si dispongono come elite ascendente nei paesi dove non hanno conquistato il potere.
Partendo dall’ipotesi autoritaria, anche se con sfumature diverse, i risultati non possono essere che sempre quelli, anche se l’organizzazione diretta allo sfruttamento è modificata. Abbiamo l’esempio della rivoluzione russa. Se il marxismo trionfante modifica le strutture, fa rimanere in piedi lo sfruttamento e la divisione in classi. Se consente un certo tipo di riuscita rivoluzionaria, ben presto la rivoluzione nel suo naturale sviluppo logico (come rivoluzione sociale e non soltanto come rivoluzione economica) finisce per rinculare. Se la morale borghese e il modo di pensare tipico di questa classe sono per un certo periodo sospesi, ben presto ristabiliscono il loro sciovinismo, abbrutendo ogni residuo rivoluzionario. Se il vecchio ordine economico cade, un altro ne prende il posto, parimenti fondato sullo sfruttamento, sul dogmatismo teorico, sulla religione del sistema.
Il giacobinismo vendicatore può diventare – in mani sapienti – uno strumento ben accetto alle masse; ma la sostanza autoritaria non si cancella facilmente. In questo modo la rivoluzione non è più l’eliminazione dei privilegi dalla classe dominante, ma la sostituzione della vecchia classe con una nuova, altrettanto orgogliosa, altrettanto famelica.
La nostra è un’esortazione a soppesare le due soluzioni: quella dell’anarchismo e quella del marxismo. La soluzione fornita dal marxismo non è affatto una soluzione, nel senso che comunemente viene dato a questo termine, cioè quello di rimozione definitiva del problema; è soltanto uno spostamento del problema stesso, una pseudosoluzione.
L’anarchismo potrà avere le sue limitazioni, i suoi aspetti meno allettanti per chi è abituato ad avere il palato facile a causa delle letture dei soloni dell’autoritarismo rivoluzionario; ma ha un grande pregio, intende partire dall’uomo costruendo per lui la società futura postrivoluzionaria, intende quindi realizzare una rivoluzione che sia liberazione dell’uomo e non semplice trasferimento di poteri, intende preparare le possibilità per concretizzare questo piano anche se è cosciente delle difficoltà cui va incontro. Spesse volte la strada più breve finisce in un vicolo cieco.
Essendo l’uomo il punto di partenza non è consentito riflettere sugli eventuali metodi di organizzazione di una perfetta gerarchia di partito. In quelle sottili discussioni, in quelle ingenue (ma non sempre) attese di una dissoluzione dello Stato, in quelle accorte costruzioni di potere, l’uomo è estraneo, viene schedato, valutato, pesato, misurato e poi indirizzato, ancora una volta, verso i campi di concentramento, verso il lavoro forzato, verso lo sterminio. E il socialismo non può costruirsi sui cadaveri dei lavoratori assassinati.
Il militante di base del partito potrà ancora essere in buona fede, ma i quadri burocratici non lo sono di certo. È questa elite di potere che raccoglie i sostegni della base, mettendo avanti lo scudo ideologico, per convogliare le forze rivoluzionarie nel mare dell’oblio.
La reazione, in modo particolare negli Stati moderni, non è soltanto la bieca figura del fascista, ma anche la simpatica figura del riformista che, coprendosi con le parole del solito vocabolario rivoluzionario, sostiene lo sfruttamento in modo molto più efficiente di quanto non faccia il fascista nell’ottusità della sua opposizione.
Quella che sembrava una vana polemica, fatta in nome di un’autonomia e di una libertà del singolo, quello che veniva considerato fatto individualistico e quindi da condannarsi davanti alle necessità delle masse, emerge qui, nella riflessione di classe, in forma macroscopica. La negazione della presa di coscienza, della difesa dell’autonomia, e il rifiuto della responsabilizzazione del singolo, abbinati alla pratica della delega del potere e delle decisioni, al rifiuto di ogni sforzo per comprendere la realtà politica, conducono all’impossibilità dell’emancipazione, al fallimento di tutti i tentativi rivoluzionari, alla riconferma della base reazionaria del riformismo.
Rifiutarsi di cominciare dall’uomo significa vedere scomparire il concetto stesso di classe restando con uno strumento – se si vuole efficiente per certi scopi – che è quello della sola avanguardia, il quale, prima o poi, finisce per lavorare nel proprio esclusivo interesse e sulla pelle degli sfruttati.
I sindacati dei lavoratori
I lavoratori hanno ormai sufficientemente chiaro che le organizzazioni sindacali non costituiscono più un’arma di lotta contro i padroni, ma uno strumento di contrattazione che cerca di fare andare d’accordo gli interessi degli sfruttatori con quelli degli sfruttati, evitando ogni sviluppo delle lotte.
Quello che non è chiaro è invece il fatto che queste limitazioni del sindacalismo non costituiscono una sua attuale degenerazione, ma sono connaturate alla stessa struttura del suo rapporto col capitalismo.
Gli obiettivi dei lavoratori sono da un lato la difesa della propria sopravvivenza, messa in pericolo dall’avidità del capitale che determina le crisi ricorrenti; ma sono anche costituiti dalla distruzione del sistema di sfruttamento e dalla creazione di un diverso modo di concepire la produzione, partendo dall’uomo e non dalla merce.
Gli obiettivi del sindacato sono invece dati principalmente dalla collaborazione col capitale. E non può essere altrimenti, infatti il sindacato stesso verrebbe eliminato nel caso di eliminazione del capitalismo, quindi collaborando col capitale il sindacato costruisce le possibilità della propria autoriproduzione futura, in quanto organizzazione che pretende difendere gli interessi dei lavoratori.
Alle origini, il sindacato nasce dalla necessità di contrapporre alla concentrazione del capitale una concentrazione della manodopera. Ma la contrapposizione non riesce ad avere uno sbocco, risultando del tutto illusoria la strada del sindacalismo rivoluzionario, come vedremo più avanti.
I marxisti (ad esempio, Gramsci) hanno concluso che il superamento della fase “sindacale” si può avere solo col partito dei lavoratori, il partito comunista. La strada della lotta è bloccata a livello strutturale, si realizza quindi una coesione diversa a livello sovrastrutturale, con cui si incide poi sul livello strutturale.
Diversamente hanno criticato il sindacato i militanti anarchici, ed è particolarmente interessante quella critica che è stata rivolta all’anarcosindacalismo. Uno dei dibattiti più illuminanti è quello tra Monatte e Malatesta al Congresso di Amsterdam del 1907.
Così Pierre Monatte nel suo intervento: «Il sindacalismo basta a se stesso... la classe operaia divenuta maggiorenne intende finalmente bastare a se stessa e non affidare più ad alcuno il compito della sua propria emancipazione... Il sindacalismo non si attarda a promettere ai lavoratori il paradiso terrestre. Chiede loro di conquistarlo, assicurandogli che la loro azione non sarà mai del tutto vana. È una scuola di volontà, di energia, di pensiero fecondo». (Congresso anarchico tenuto ad Amsterdam, agosto 1907 a cura di N. Dell’Erba, Torino 1978, p. 66).
E la risposta di Malatesta: «...sono per la partecipazione più attiva possibile al movimento operaio. Ma lo sono soprattutto nell’interesse della nostra propaganda il cui campo si troverebbe così considerevolmente ampliato. Solo questa partecipazione può escludere la rinuncia delle nostre più care idee. Nel sindacato, dobbiamo restare anarchici, in tutta la forza e in tutta l’ampiezza del termine. Il movimento operaio non è per me che un mezzo, il migliore evidentemente di tutti i mezzi che ci sono offerti. Questo mezzo io mi rifiuto di considerarlo un fine, e non lo vorrei nemmeno più se dovesse farci perdere di vista l’insieme delle nostre concezioni anarchiche, o più semplicemente dei nostri mezzi di propaganda o d’agitazione». (Ib., pp. 73-74).
Da precisare, riguardo questa posizione di Malatesta, che il sindacalismo non solo non è un fine, ma se dobbiamo considerarlo come mezzo occorre che sia ben vero che si tratti di un mezzo di preparazione della rivoluzione e non – come oggi è diventato chiaro – un mezzo per perpetuare lo sfruttamento. Anche Malatesta, possiamo dirci certi, di fronte alle esperienze di oggi, rivedrebbe la sua posizione che era perfettamente adeguata al clima ribollente delle “Borse” e del sindacalismo francese della fine dell’Ottocento.
Oggi il sindacato ha programmi vastissimi. Si sostituisce al governo quando questo dimostra palesi incapacità di fare continuare in modo indolore lo sfruttamento. Si adegua al suo partner, il capitale, per cui a capitalismo manifatturiero, ancora immerso in una dimensione di mercato, corrisponde sindacalismo “vecchia maniera”, corporativo, esaltante il lavoro, richiedente miglioramenti salariali ma principalmente ambientali. A un capitalismo multinazionale avanzato corrisponde un sindacalismo anch’esso tecnocratico, diretto a costruire un rapporto europeo e internazionale con gli altri sindacati.
Forse occorrerebbe dire molto di più sui pericoli di questa prospettiva. Senz’altro oggi uno degli elementi controrivoluzionari più efficienti è il sindacato, mentre l’ideologia sindacalista è uno dei freni più forti al progetto di liberazione dei lavoratori.
Il capitalismo
Oggi il capitalismo viene considerato come una struttura economica che può cambiare non essendo per nulla connaturata al vivere in società.
La vecchia concezione partiva dal presupposto che “capitale” fossero tutte le cose possedute dall’uomo, dall’arco e dalle frecce del selvaggio alla macchina dell’industria odierna. Questa concezione fu sviluppata da Eugen Böhm-Bawerk, che considerava capitale “tutto ciò che è prodotto per servire alla produzione ulteriore”.
Oggi il “capitale” non è più considerato un insieme di cose, ma un rapporto sociale, non lo strumento di produzione come tale, ma la proprietà privata di esso, e non soltanto questa (infatti anche in economie di tipo non capitalistico, ad esempio nell’economia medievale, si aveva proprietà dei mezzi di produzione), ma questa proprietà in quanto trova sviluppo attraverso l’impiego di salariati. In questo modo il “capitalismo” diventa un fenomeno storico, nato nel tempo e destinato a morire.
In precedenza, la tesi dell’eternità del capitalismo partiva da vecchi modelli di equilibrio della scienza positivista dell’Ottocento presi in prestito dalla meccanica. Lasciando libero corso alle forze di mercato, eliminando le restrizioni alla libera iniziativa, si aveva uno sviluppo progressivo, indefinito, sempre più ampio, non solo dell’aspetto economico ma di tutti gli altri aspetti dell’uomo: eliminazione della miseria, della disoccupazione, della povertà, delle malattie. Un sogno utopistico, caduto malamente col cadere del sogno imperiale inglese del periodo vittoriano.
Non fu Marx il primo a individuare e studiare il meccanismo della crisi economica del sistema capitalistico. È addirittura Smith il primo che parla della crisi. In pratica si hanno in lui due idee contrastanti: da un lato l’idea della definitività dell’ordine capitalistico, dall’altro l’idea della caduta del saggio del profitto. Contraddizione logica che sarà superata da Ricardo con la dimostrazione che la caduta del saggio del profitto è funzione dell’accumulazione del capitale.
Anche Malthus e Sismondi parlano di questa contradditorietà del capitalismo sostenendo che la crisi sarà determinata dall’insufficienza della domanda: quindi una malattia di sovrapproduzione. Non solo, ma questi due scrittori hanno una visione della sovrapproduzione che non è conseguenza finale e periodica del capitalismo, ma premessa iniziale, per cui se ne ricava che il capitalismo ha un errore di partenza che ne impedisce un regolare funzionamento.
L’analisi di Marx è troppo nota per esporla in questa sede, ci basta sapere che secondo lui – entusiasta elogiatore del capitalismo – non ci sarebbe stata soluzione migliore per l’umanità se questa forma economica oltre a garantire gli equilibri parziali (consumatore-produttore) garantisse anche l’equilibrio generale del sistema. È nell’impossibilità di quest’ultima condizione che il capitalismo, ammalato, manifesta le sue crisi periodiche che lo porteranno alla morte.
Tra gli economisti “ufficiali” più recenti Keynes, Schumpeter e Galbraith sostengono tutti l’ineluttabilità della crisi capitalista. Secondo John Maynard Keynes, il capitalismo assicura un rapido sviluppo della produttività e una soddisfazione dei bisogni, ma la trasformazione del risparmio in capitale, con cui si attua l’incremento della produttività, dovrebbe assumere un’ampiezza via via minore man mano che ci si avvicina al punto finale della soddisfazione dei bisogni. Al contrario, le istituzioni capitaliste, la diversa distribuzione della proprietà e quindi del reddito, insistono per una continuata formazione di risparmio indipendentemente dalla necessità oggettiva: da qui uno squilibrio e la crisi.
Per Joseph Alois Schumpeter, base dell’economia capitalista è l’attività innovatrice dell’imprenditore, attività che si va esaurendo man mano che si verifica quel progressivo soddisfacimento dei bisogni, per cui ci si avvia a una profonda trasformazione della dimensione aziendale che è poi una trasformazione dell’intero sistema capitalistico (sostituzione dell’imprenditore tradizionale con il tecnocrate moderno).
Con John Kenneth Galbraith sono i processi di redistribuzione del reddito che determinano lo squilibrio dell’economia di mercato. I salari vengono elevati al di sopra del limite della sussistenza, in questo modo si alza la domanda ottenendo due risultati: la classe dominante passa da un profitto molto alto a uno più modesto e viene eliminato l’ostacolo alla realizzazione del profitto in generale. Si tratta della “civiltà dei consumi”. Ma Galbraith si chiede in che modo si potrà frenare la corsa alla produttività: la formula risolutiva è quanto mai inconsistente: “non bisogna spingere la produzione al di là del sensato”.
Non bisogna dimenticare che queste teorie non hanno trovato la loro origine nel vano dialogare degli studiosi, ma si riflettono sulla realtà politica e sociale e da quest’ultima trovano a loro volta giustificazione. Keynes pensava alla grande crisi americana quando rifletteva sui destini del capitalismo, Galbraith guarda oggi all’imperialismo consumistico degli Stati Uniti quando parla dei disturbi endemici di una società opulenta.
Uno degli elementi meno presi in considerazione nello studio delle crisi e del futuro assetto capitalistico dell’economia, è l’influenza delle lotte dei lavoratori, elemento rivendicativo che spinge il capitalismo tradizionale, legato al concetto di salario di sussistenza, verso nuove forme che vanno dalle fasi di “ristagno” (esaminate ad esempio da Alvin Hansen) alla fase dell’opulenza. L’apertura al “consumo” è uno degli espedienti contro la spinta disgregatrice costituita dalla lotta dei lavoratori.
Oggi assistiamo all’aperta contraddizione tra “realtà” economica, caratterizzata in pieno dalle lotte dei lavoratori, e “teoria” economica che cerca di dare giustificazione e assetto logico a questa realtà, non riuscendo a trovare la strada giusta per tenere nel giusto conto questa variabile essenziale dell’equazione socioeconomica.
Naturalmente, aspetti non meno importanti sono le contromosse che i padroni compiono nel resistere alle pretese dei lavoratori, nel convogliarli in una prospettiva consumistica che li lega a un’accelerazione della produzione (società opulenta), nell’utilizzazione di tutte quelle forze eversive di estrema destra che da sempre sono state l’ultima speranza della classe dominante davanti alla paura del crollo totale.
Ecco alcuni princìpi che reggono il capitalismo:
a) Filosofici. La storia viene considerata come la realizzazione di un principio spirituale infinito, uno “spirito del mondo” o uno “spirito del popolo”. Questa concezione hegeliana è rimasta identica o quasi nel pensiero di Croce, che costituisce uno dei riferimenti costanti dell’antifascismo italiano: per lui “la storia è opera dello spirito universale”. Ma si tratta di uno dei filoni meno importanti nel quadro europeo dello sviluppo del problema.
È con Wilhelm Windelband che si sviluppa la teoria dei valori, considerati come aspetto oggettivo della realtà. L’uomo diventa un elemento di un quadro più ampio che, con Heinrich Rickert, assume gli aspetti del quadro culturale.
Ma è Max Weber che, nello sviluppare la sua posizione nei confronti del marxismo, chiarisce meglio il problema. In effetti, la storia diventa con lui, il campo dove operano i condizionamenti reciproci dei diversi settori della realtà. Non è, come sostiene il marxismo, che la sovrastruttura (fenomeni politici, giuridici, religiosi, ecc.) dipenda dalla struttura economica, ma, al contrario, si è davanti a un reciproco condizionamento. Weber precisa che nell’individuare di volta in volta una serie di condizioni che rendono possibile un certo avvenimento, occorre utilizzare dei concetti generali, non partire dal particolare, dal caso singolo, e ciò allo scopo di potere considerare la storia come una scienza sociale e non come il campo delle esercitazioni personali di un pensatore.
b) Economici. Il capitalismo viene considerato come una struttura che può cambiare.
La vecchia tesi dell’eternità del capitalismo è sostituita da una tesi che si preoccupa della collocazione storica dello stesso.
Il contrasto di classe viene visto come esistente ma superabile con l’aiuto e la collaborazione dello Stato, per cui il passaggio alla futura società dovrebbe avvenire dolcemente e lentamente, sotto il controllo degli organi statali.
Lo sbocco verso una forma di socialismo di Stato, naturalmente non di tipo rivoluzionario, viene considerato molto probabile, soltanto si cerca di far sì che la vecchia classe dominante, nella trasformazione, non venga a perdere nulla. Si cerca di ridurre la trasformazione solo all’aspetto nominale dei compiti della classe al potere.
Il fascismo
La dittatura di Mussolini si risolse in una “statocrazia”, una monarchia e un’autocrazia. Essa può costituire, anche oggi, un interessante modello di studio, sebbene, com’è logico, il fascismo odierno presenti non poche differenze. Comunque, i principi fondamentali che lo giustificano sono gli stessi del fascismo di tipo mussoliniano.
Mai l’esaltazione dello Stato fu spinta tanto oltre come da Mussolini. Lo Stato per lui era “la coscienza stessa, la volontà del popolo”, “l’autentica realtà dell’individuo”. Lo Stato diventa con lui un essere vivente, un organismo, che però non è soltanto un corpo, ma anche un “fatto spirituale e morale”, “la coscienza immanente della nazione”. “Esso ha una volontà ed è perciò che viene definito Stato etico”.
È facile capire quanto Hegel ci sia sotto queste formulazioni, con tutte le assurdità conseguenti, dato che per Hegel l’azione dei grandi uomini nella storia non ha praticamente significato al di là del processo complessivo delle istituzioni umane.
Qui ci interessa sapere per quali scopi concreti fu sviluppata questa filosofia irrazionalista dello Stato e vi fu posto come capostipite proprio Hegel. Per Mussolini, già al potere, divenne facile l’identificazione del potere dello Stato in generale con quello del suo governo. Inoltre, una volta affermato che lo Stato è un’“idea etica”, il fascismo poteva essere presentato come una forma di elevato idealismo politico, contrapposto al materialismo dichiarato dei comunisti e all’agnosticismo anticlericale dei liberali.
Su questa strada, della superdifesa a oltranza dello Stato, la teoria gentiliana divenne appena qualcosa di più di una giustificazione della brutalità delle squadre fasciste. Quando quest’ultime entravano in azione, ad esempio per disperdere le riunioni dei sindacati antifascisti, era la forza di uno Stato non ancora nato, ma sulla via di nascere, che agiva come forza incontrollata e irrazionale.
Così esattamente Giovanni Gentile, in un discorso tenuto a Palermo nel 1924: “Sempre il massimo della libertà coincide con il massimo della forza dello Stato... Ogni forza è forza morale, perché si rivolge sempre alla volontà; e qualunque sia l’argomento adoperato – dalla predica al manganello – la sua efficacia non può essere altro che quella che sollecita infine interiormente l’uomo e lo persuade a consentire”.
Certamente le basi dottrinarie del fascismo furono, e sono, molto deboli: appena una copertura della violenza ma, in ogni caso, è interessante notarle per vedere come si contrappongano al libero esercizio della decisione del singolo e della comunità. Non è un caso che il fascismo si ponga all’estremo esatto della posizione della libera organizzazione della vita e dell’economia.
Quello che il capitalismo socialdemocratico vuole raggiungere attraverso l’inclusione del fronte dei lavoratori all’interno della logica consumista, il fascismo lo raggiungeva, con la forza, attraverso le sue costruzioni corporative. Ministero delle Corporazioni, Consiglio nazionale delle Corporazioni, Camera dei Fasci e delle Corporazioni. Una struttura al servizio dello Stato. Secondo Mussolini il termine corporativo deve intendersi nel senso etimologico di “riduzione in corpo”, dietro il quale si scorge la funzione unica e centrale dello Stato. Al contrario di quanto può sembrare, il corporativismo non era un sistema autorganizzatore degli interessi economici, ma soltanto una ingegnosa creazione dietro la quale si celava la riduzione dell’economia agli interessi politici.
Alla base di ciò la lotta dottrinale contro il comunismo e la sua concezione della storia in senso materialistico come teatro della lotta di classe. Davanti alle strutture fasciste dovevano cadere le vecchie organizzazioni economiche e sociali: le società operaie, le associazioni commerciali e industriali, le organizzazioni a fini sociali, di mutua assistenza, quelle volontarie, quelle laiche e quelle cattoliche. Era l’aspetto esterno del totalitarismo, mentre l’aspetto interno manteneva la sua vera realtà di confusione, di domini privati, di eserciti privati, di servizi segreti privati.
Ecco alcuni principi che reggono il fascismo:
a) Filosofici. Si riferiscono in particolare alla concezione della storia. È implicito un riconoscimento dell’autonomia dell’uomo riguardo la situazione da cui è condizionato, di modo che la storicità diventa l’orizzonte delineante il quadro delle azioni umane. Da ciò la scarsa importanza data alle situazioni e la massima importanza data all’azione del singolo.
In effetti, se attraverso Gentile si ritrova Hegel, si ritrova un Hegel manomesso, frutto di una forzatura teorica scarsa di significato. Il fascismo non ebbe un vero e proprio corpo dottrinale e nemmeno l’abilità professionale di Gentile poté darglielo. La concezione della storia, tipica del fascismo, ha radici più profonde, risalenti al contrasto a Hegel. Queste radici si possono ricollegare a Wilhelm Dilthey e alla sua concezione della storia basata esclusivamente sull’individuo. È il lavoro di Kant nel campo fisico-matematico che con Dilthey passa nel campo storico, cioè l’indagine critica sulla struttura della ragione, ma diretta questa volta verso l’uomo inteso come essere concreto e storico. La storia, sempre con Dilthey, diventa scienza dello spirito, può, quindi, essere sviluppata attraverso lo studio dei dati dell’esperienza che l’uomo ha di sé e della comprensione che può avere degli altri.
Con Georg Simmel le categorie storiografiche diventano rapporti psicologici e quindi relativi. Non a caso Simmel parla di “intuizione” e non a caso nella sua filosofia esistono frequenti elementi vitalistici. Sulla strada si può anche trovare Oswald Spengler, le cui formulazioni saranno raccolte e utilizzate dal nazismo.
b) Economici. Si riferiscono alla concezione del capitalismo come struttura economica “permanente” della società. In effetti non esiste un’affermazione esplicita in questo senso, ma due cose ci confortano nella nostra tesi: 1) la presenza di un’idea dello Stato di tipo non dinamico: uno Stato sempre uguale a se stesso, da quello primitivo ed embrionale a quello moderno, 2) l’inesistenza di un sia pur piccolo riferimento alle lotte sindacali e rivendicative in genere, come elemento costitutivo di quell’equilibrio che caratterizza lo Stato democratico moderno. Una caratteristica appendice del fascismo è il sindacato giallo. Serve a confondere i lavoratori e viene utilizzato, nelle società a capitalismo avanzato, per agire all’interno del mondo del lavoro, reprimendo, per quanto è possibile, tutte le iniziative di lotta dannose ai padroni.
I sindacati fascisti rigettano il principio della lotta di classe e riprendono le idee corporative del regime fascista di Mussolini. Teoricamente perseguono la costituzione di uno “Stato lavorativo” che comprenda i rappresentanti diretti sia dei lavoratori che dei datori di lavoro. Sono nazionali e rigettano l’internazionalismo. In Italia, in modo particolare, si richiamano alla dottrina di Mazzini e alla Rerum novarum (non potendosi apertamente richiamare a Mussolini) e attribuiscono al sindacato una funzione etica intesa come alternativa di fronte al materialismo professato dagli schieramenti marxisti.
L’ideologia della produzione
Il neoliberalismo
L’ideologia dominante è quella della produzione. Questo termine ha un significato positivo e irrazionale nello stesso tempo. Nel pronunciarlo ogni uomo politico si riferisce a un ipotetico bene comune che bisogna proteggere e accumulare. Servitori del sistema di ogni colore, illustrano periodicamente i benefici collettivi di un aumento della produzione, calcolando redditi medi pro-capite, cercano di convincere la gente che tutto va per il meglio, nel migliore dei mondi possibili.
Si potrebbe facilmente dimostrare come l’ideologia della produzione non si limiti al settore dell’economia, ma investa tutta la società. La lingua, le strutture sociali, il sesso e tante altre cose, vengono trasformati, ingigantiti, moltiplicati, da questa mania produttiva. In termini marxisti, si tratta di un processo di reificazione, di trasformazione in oggetti. La stessa ideologia viene reificata e finisce nei supermercati.
La cultura è condizionata da questo fenomeno in modo estremamente chiaro. Viene distribuita già confezionata. Segue l’ideologia della produzione, allo stesso modo delle automobili e dei televisori.
La soluzione dell’inizio degli anni sessanta fu di aprire l’era del consumismo facendo entrare i lavoratori all’interno dell’area dei consumi signorili. Un grande processo di trasformazione e di sviluppo segnò questo passaggio dalle vecchie alle nuove forme di capitalismo. Come conseguenza immediata la concentrazione capitalista dette vita a nuove forme di impiego dello Stato, causando un condizionamento preciso non solo del processo produttivo ma di tutta la vita, in senso favorevole alla classe dominante.
Queste metamorfosi del capitalismo ridussero l’importanza dell’attesa dell’evento favorevole alla rivoluzione: la crisi. In pratica, quest’ultima si trasferì tanto a lungo da diventare inaccettabile come punto di riferimento per un immediato piano concreto di lotta. Crescevano, nel frattempo, i redditi della classe media e la sua capacità di risparmio incideva enormemente sulla spinta produttiva del nascente neocapitalismo. La classe dei risparmiatori medi veniva così attirata per intero nel ciclo dello sviluppo monopolistico, cessando la sua tradizionale attività di freno alle avventure speculative degli imprenditori più avanzati. Nasceva la classe dirigenziale, quella a diretto contatto con la struttura burocratica più elevata, la quale, a sua volta, finiva per condizionare le scelte e le forme della produzione, mettendo un’ipoteca sugli stessi indirizzi della classe dominante.
È la nascita e la stabilizzazione della società tecnocratica a espansione multinazionale. Ben presto ci si accorge che la soluzione consumistica ha limitazioni gravissime, che la partecipazione della classe lavoratrice all’utilizzazione della produzione determina uno sviluppo diseguale del capitalismo e lo lega a una realtà nazionale che deve essere al più presto abbandonata. La strada verso la costruzione di un totalitarismo multinazionale a fondamento economico può passare attraverso un superamento del consumismo e una nuova costruzione ideologica: quella dell’autogestione.
Il pericolo di una simile prospettiva è gravissimo. I lavoratori attirati in questa trappola verranno danneggiati in modo molto più grave di quanto non lo siano stati dal consumismo: tutta la società subirà una trasformazione radicale e terribile, la possibilità di uno sbocco rivoluzionario si allontanerà enormemente.
Ma un ostacolo all’attuazione di questa prospettiva, è dato dallo stesso capitalismo che non vuole abbandonare i suoi vecchi idoli e che resiste di fronte a questa crisi di trasformazione. E uno dei suoi idoli preferiti è, appunto, l’idolo della produzione. Allo stesso modo, per uno strano processo di compensazione, i nemici del capitalismo non riescono a superare l’illusione della produzione. Il dibattito futuro sarà sempre più accentrato su questo problema. Per i padroni si tratterà di trovare una nuova dimensione produttiva, capace di superare le limitazioni nazionali del disequilibrio interno, per ritrovare un equilibrio multinazionale basato sullo sfruttamento di precise zone del globo. Per i lavoratori si tratterà di liberarsi definitivamente dell’idolo della produzione, lottando non per ricostruire vecchie forme organizzative ormai superate, ma per un programma di lotta autogestito che parta dal presupposto che la nuova società di domani non dovrà più essere fondata sul mito della produttività. In questa direzione le concezioni della distruzione del lavoro e dall’autonomia della lotta dei lavoratori, aprono una nuova epoca. La problematica dell’autogestione, inserita in questa prospettiva, assume importanza determinante.
Il socialismo autoritario
La tesi dei partiti, cosiddetti dei lavoratori, non riesce a sfuggire allo spettro della produzione. Queste organizzazioni sostengono una “liberazione” delle forze produttive e confondono questo con la liberazione dell’uomo. Il pericolo di un simile errore è di portata vastissima.
Anche prescindendo dai paesi dove domina il socialismo di Stato [1979], paesi che hanno posto al centro dei propri sforzi l’aumento della produzione, restano le teorie dei partiti della sinistra ufficiale, nei paesi dove la sinistra non è ancora al potere. Il tono non cambia. Si assiste a una ripresa del migliore liberalismo, con un emendamento: cambiamento dei consumi signorili in consumi sociali.
Al fatto produttivo concreto corrisponde, anche per i teorici del marxismo, il fatto produttivo ideologico. L’uomo non viene lasciato libero di svilupparsi, ma viene collocato in uno schema preordinato di “generazione”, schema che di volta in volta può essere: il partito, il gruppo, la famiglia, la squadra sportiva, ecc. La dimensione umana è trasformata in un oggetto quantitativamente identificabile: operaio, contadino, proletario, sottoproletario, ecc. A ciò corrisponde la persistenza del modo produttivo precedente e, nei casi di radicale trasformazione, un modo produttivo cambiato nella forma (statalizzazione) ma intatto nella sostanza.
In questo modo i marxisti non si accorgono della contraddizione in cui cadono. La società borghese, con la sua organizzazione capitalista della produzione, è la massima espressione di questo modello organizzativo. La rivoluzione proletaria dovrà impostarne un altro. Pertanto la produzione non potrà essere continuata sulla base precedente, altre prospettive dovranno aprirsi davanti al lavoratore.
Il progetto rivoluzionario viene in questo modo deformato dalla persistenza di una organizzazione gerarchica dell’ideologia. Si vuole restare solidali con la struttura burocratica di oggi perché possa immediatamente essere trasformata nella struttura burocratica di domani. È la problematica della “distruzione progressiva dello Stato”.
In effetti l’ideologia della produzione esiste perché esiste il dominio (attuale) di una classe, ed esiste nella prospettiva marxista perché è previsto il dominio (futuro) di un partito. Il problema della dittatura del proletariato e quello dell’estinzione dello Stato ricevono una luce particolare in funzione della soluzione del problema del rapporto tra minoranza agente e massa.
Per la minoranza dominante (classe o partito) l’ideologia produttiva è indispensabile per fare permanere il proprio dominio. Il dominio stesso viene quantificato in termini produttivi. Distruggendo la dominazione della minoranza, l’ideologia produttiva risulta estranea agli interessi dei lavoratori, scomparendo automaticamente. Nel momento attuale, lottare contro l’ideologia produttiva significa lottare contro l’azione di sfruttamento di una minoranza e la parallela azione di sostituzione nello sfruttamento di un’altra minoranza, quella che intende impadronirsi del potere.
Bisogna quindi rifarsi sempre, anche riguardo il problema della produzione, all’azione della minoranza nei riguardi della massa. Se questo rapporto è risolto nel senso di un’azione all’interno della massa, un’azione che può dirigersi nel senso di certi fatti rivoluzionari e nel senso della propaganda e della diffusione di un modello associazionistico e libertario di organizzazione economica, allora l’ideologia della produzione risulta estranea e può essere facilmente eliminata dalle prospettive del movimento operaio. La dittatura del proletariato diventa lotta armata del popolo contro gli sfruttatori e le forze che li sostengono, guerra civile di una classe contro l’altra, temporanea parentesi che deve però contenere tutti gli sforzi possibili verso la costruzione della società nuova; mentre l’estinzione dello Stato significa abolizione immediata, nel momento stesso in cui la lotta divampa e si chiariscono efficacemente i termini del conflitto di classe, nel momento in cui, con la guerra civile, si sviluppa la costruzione autogestionaria della società nuova.
Ma la verità non è soltanto una faccenda terminologica. I marxisti hanno sempre avuto interesse a combattere gli anarchici come forza organizzata, e, per questo, hanno fatto ricorso anche alla mistificazione del vero significato dei termini da loro usati. Ad esempio Engels, nell’affermare la necessità della dittatura del proletariato, dice (cosa ovviamente assurda) che gli anarchici sono contro la dittatura del proletariato perché, nel momento della rivoluzione, sono per la riappacificazione delle classi, anche quando le forze nemiche della repressione e dello sfruttamento si stanno organizzando contro i lavoratori. È logico che in questo modo è molto facile convincere le persone. Chi potrebbe mai negare che la rivoluzione è un fatto violento, che la classe espropriatrice, una volta espropriata, non si organizzerà in tutti i modi per riprendere quello che gli è stato tolto?
Allo stesso modo per il problema dell’estinzione dello Stato. La malafede dei marxisti emerge dal fatto che spesso nelle loro formulazioni si contraddicono, nel tentativo di dare ora una maggiore e ora una minore importanza alla “persistenza” della macchina statale. Arrivano così, da una immediata distruzione a un rafforzamento temporaneo, rinfacciando agli anarchici di essere sostenitori di un’abolizione dello Stato, cosa che suonerebbe, secondo loro, come un’immediata abolizione delle classi (lo Stato, infatti, esiste in quanto esiste la lotta di classe); abolizione fatta subito e quindi contemporaneo rifiuto della lotta di classe contro gli sfruttatori e la loro coalizione. Al solito, il salto di qualità è del tutto gratuito e fatto soltanto per scopi propagandistici. Gli anarchici sono per l’abolizione immediata dello Stato e per l’organizzazione della lotta di classe contro gli sfruttatori su base popolare, ben sapendo che ogni utilizzazione della macchina statale, anche se intesa in senso antiborghese, è impossibile in quanto lascerebbe in piedi quella struttura (uomini, idee, modelli operativi, ecc.) che sostanzialmente costituisce lo “Stato”. È logico che gli anarchici si rendono conto dei compiti che si prospettano davanti al proletariato rivoluzionario, compiti di lotta, di organizzazione, di resistenza, di distruzione delle velleità capitaliste di ritornare a sfruttare, ecc., ma ciò non ha nulla a che vedere con l’“utilizzazione” della macchina statale.
Lo stesso ragionamento viene fatto dai marxisti riguardo la validità della produzione, validità considerata misurabile sulla base della stessa costruzione produttiva borghese. I loro programmi rivoluzionari sono quindi condizionati dall’uso da fare di questa produzione, almeno nei limiti in cui essa persisterà subito dopo l’evento rivoluzionario. Rimettere in discussione il fatto produttivo equivale a rimettere in discussione il fatto della possibile utilizzazione, a scopi “rivoluzionari”, dello Stato borghese.
Il neofascismo
Sebbene camuffato in forme molto diverse, secondo le necessità imposte dalla borghesia, il fascismo, anche nelle sue espressioni più recenti, presenta caratteristiche abbastanza costanti.
Per neofascismo possiamo oggi intendere le forze reazionarie che svolgono il ruolo di sostegno delle frange meno progressiste del capitalismo, quelle frange che insistono nel non voler comprendere l’evoluzione dell’organizzazione produttiva nel senso sovranazionale.
Per questo motivo l’ideologia della produzione sostenuta dal neofascismo ha notevoli rassomiglianze con quella del vecchio capitalismo: insistenza sul valore della produzione nazionale, richiesta di protezioni statali, interventi corporativi nel settore del lavoro, progetti di stampo autarchico a livello internazionale.
Quello che pare interessante notare è la presenza, anche in campo dichiaratamente fascista, di un’ideologia della produzione quasi identica, salvo sfumature diverse, a quella dei marxisti.
Le differenze più sostanziali si potrebbero trovare, al contrario, tra neoliberalismo e neofascismo.
Accantonando le nostalgie autarchiche, frutto di un ossequio ai passati regimi, il neofascismo di oggi, qualora dovesse arrivare al potere, si aprirebbe, con tutti gli sforzi possibili, verso l’esterno.
Lotta di classe e autogestione
Il problema della scelta dei mezzi e del condizionamento dei fini
Principio fondamentale dell’anarchismo è che la scelta dei mezzi finisce per condizionare il raggiungimento dei fini. Non è possibile affidarsi all’autorità di un partito sperando di distruggerlo dopo la rivoluzione: ciò finisce per trasformare la rivoluzione stessa. Non è possibile affidarsi alle tattiche del riformismo pensando di raggiungere un obiettivo preciso: questo obiettivo si sposta nel corso dell’attuazione delle riforme. Non è possibile utilizzare la struttura statale dopo la rivoluzione: la sola presenza di questa struttura finisce per causare le stesse degenerazioni del periodo borghese.
In questo modo sorge il problema della scelta dei mezzi. Solo basando questa scelta sulla decisione autonoma dei lavoratori, si può sperare che essa non si diriga verso fini fittizi, sovrapposti a quelli veri, che la lotta deve perseguire. Questa scelta è di già un fatto rivoluzionario, unione specifica della minoranza agente e della massa, in un rapporto che riceve la sua caratterizzazione dallo stesso problema della scelta dei mezzi. Non è pensabile un rapporto di “guida” in senso autoritario, perché in questo caso si potrebbe teorizzare la non nocività della scelta del mezzo sul fine da raggiungere. In altre parole, nel caso di una prospettiva autoritaria sarebbe la minoranza soltanto a scegliere il mezzo rivoluzionario non tenendo conto della massa. Essendo la rivoluzione sociale il fine da raggiungere, i mezzi adatti non potranno mai consistere in un partito guida, in un mitico condottiero o in qualche altra cosa del genere.
Ma questo problema della scelta dei mezzi, non si pone solo a livello generale, cioè a livello della scelta autogestionaria della rivoluzione; si pone anche a livello particolare, di fronte a tutte le evenienze della lotta.
Alcuni fanno una distinzione tra scelta di fondo e tattica quotidiana, tattica spicciola. La differenza, per noi, non esiste. La tattica quotidiana di lotta non può mai degenerare in una acquiescenza di fronte alla eventuale maggiore pressione degli autoritaristi, come non può degenerare in un isolazionismo, per un malinteso senso di purità.
Malatesta scriveva nel 1922: “Da soli non possiamo debellare il fascismo e anche meno abbattere le istituzioni. Dunque, o unirsi a coloro che, pur non essendo anarchici, hanno comuni con noi gli scopi immediati, o lasciare che i fascisti continuino, colla complicità del governo, a tiranneggiare l’Italia, e che la monarchia regni indisturbata”. “Ma nelle alleanze rivoluzionarie si è sempre ‘traditi’. È possibile, ma noi preferiamo rischiare di esser traditi dagli altri, anziché tradirci da noi spegnendoci nell’inazione”.
Sempre nel 1922, a distanza di pochi giorni scriveva: «Noi in questi ultimi anni ci siamo accostati per un’azione pratica ai diversi partiti d’avanguardia e ne siamo usciti sempre male. Dobbiamo per questo isolarci, rifuggire dai contatti “impuri”, e non muoverci o tentare di muoverci se non quando potremmo farlo con le sole nostre forze ed in nome del nostro programma integrale? Io non credo. Poiché la rivoluzione non possiamo farla da soli...». (“Umanità Nova”, 25 maggio 1922).
Malatesta è estremamente attuale specie per quei compagni che oggi, cogliendo l’occasione dell’indubbia confusione che regna negli schieramenti rivoluzionari (o cosiddetti tali), hanno finito per trovare l’alibi più proficuo per restare al caldo del grembo materno.
Noi siamo anarchici e rivoluzionari. Il nostro programma è chiaro. La prospettiva della lotta, dell’azione diretta, del rifiuto di ogni analiticità spinta all’eccesso, la ricerca di uno sbocco insurrezionale, l’autogestione dell’organizzazione rivoluzionaria e della produzione. Questi sono i nostri strumenti di contatto e di lavoro all’interno della masse. Il nostro messaggio è diretto sempre alle masse non alle avanguardie rivoluzionarie che possono trasformarsi in minoranze autoritarie restrittive delle libertà individuali.
Sempre nel 1922 scriveva Malatesta: «Noi non vogliamo aspettare che le masse diventino anarchiche per fare la rivoluzione, tanto più siamo convinti che esse non lo diventeranno mai se prima non si abbattono violentemente le istituzioni che le tengono in schiavitù. E siccome noi abbiamo bisogno del concorso della masse, sia per costituire una forza materiale sufficiente, sia per raggiungere il nostro scopo specifico di cambiamento radicale dell’organismo sociale per opera diretta delle masse, noi dobbiamo accostarci ad esse, prenderle come sono, e come parti di esse spingerle il più avanti possibile [...]. Ma quando noi parliamo di rivoluzione, quando di rivoluzione parla il popolo, come quando si parla di rivoluzione nella storia, s’intende semplicemente “insurrezione vittoriosa”. Le insurrezioni saranno necessarie fino a che vi saranno dei poteri che colla forza materiale costringeranno le masse all’obbedienza; ed è probabile, purtroppo, che di insurrezioni se ne dovranno fare parecchie prima che si sia conquistato quel minimo di condizioni indispensabili perché sia possibile l’evoluzione libera e pacifica e l’umanità possa camminare senza lotte cruenti ed inutili sofferenze verso i suoi alti destini». (“Umanità Nova”, 25 Novembre 1922).
Il punto centrale del discorso anarchico è quindi diretto a questa prospettiva: la lotta dall’interno delle masse, la lotta autogestita per l’insurrezione vittoriosa di oggi e la rivoluzione definitiva vittoriosa di domani, nella prospettiva dell’organizzazione autogestionaria delle forze produttive.
Ma la scelta dei mezzi non deve portarci davanti al vicolo cieco della grettezza ideologica, della meschinità chiesastica; non deve rivelarsi una strettoia davanti alla quale restano validi i princìpi teorici e cadono tutte le possibilità di un’azione concreta. Al contrario, deve essere un banco di prova per ogni tentativo di apertura e di azione con altri compagni, deve costituire un punto di riferimento per controllare le nostre tesi e le nostre posizioni, senza cedimenti o compromessi, ma senza atteggiamenti aristocratici, tipici dei portatori della verità e dei fanatici.
L’anarchismo è teoria della verificazione, prima di tutto. Teoria, anche, della verificazione di se stesso. Questo può avvenire solo uscendo fuori dalla chiusura mentale della dottrina cristallizzata. L’anarchico deve essere tale anche riguardo le proprie eventuali involuzioni, deve cioè essere custode geloso del proprio patrimonio di idee, ma, nello stesso tempo, spregiudicato innovatore, analista freddo e distaccato di quanto all’interno della teoria minaccia di diventare superato e libresco.
Questo, in grandi linee, il problema della scelta dei mezzi. C’è da dire però qualcosa di più riguardo l’idealizzazione di certi mezzi in quanto tali. Tutti siamo d’accordo che l’azione diretta è la chiave per interpretare la validità anarchica di un mezzo di lotta, la garanzia che questo mezzo non finisca per turbare il raggiungimento del fine rivoluzionario. Ma dobbiamo tenere presente che se il principio resta valido in assoluto, nella realtà concreta della lotta esso deve essere continuamente verificato.
Facciamo un esempio concreto. Abbiamo il caso delle richieste di miglioramenti salariali e delle condizioni di lavoro. Normalmente queste richieste vengono avanzate attraverso i sindacati, qualche volta, invece, è la stessa base dei lavoratori a organizzarsi per presentare, con la forza e senza alcuna direttiva sindacale, la richiesta del miglioramento. Siamo davanti, in quest’ultimo caso, a un’applicazione del principio dell’azione diretta, applicazione che ci trova pienamente d’accordo in quanto anarchici ma che, lo ripetiamo, davanti alla realtà storica specifica in cui bisogna sempre calare il fenomeno sociale, abbisogna di una riflessione che non è stata ancora fatta.
L’azione non è sufficiente ad autogiustificarsi. Anche se fondata sull’autogestione delle lotte occorre sempre rapportarla alla realtà storica specifica e, riguardo l’esempio sopra riportato, sembra che una richiesta di miglioramento vada considerata criticamente in se stessa, a prescindere dalla forma autogestita in cui si realizza, come possibile strumento nelle mani della controparte. Finchè si rimane all’interno dell’ideologia produttiva e del lavoro, allo stato attuale del conflitto di classe nelle società capitaliste avanzate, malgrado l’azione diretta e l’autonomia della base, si corre il rischio di essere inglobati lo stesso.
Scelta dei mezzi e crescita del movimento operaio
Dalla semplice riflessione sul problema della scelta dei mezzi, si potrebbe dedurre che il conseguimento del fine diventa un fenomeno determinato fin dall’inizio e quindi certo. Un simile modo di ragionare è errato, si tratta di un residuo deterministico che riesce a emergere anche attraverso il principio della scelta dei mezzi in relazione ai fini. Questo è, infatti, un principio che prevede la libera disponibilità della volontà umana, la capacità di autodeterminarsi, una struttura minima di base in forma autogestionaria ma, come tutti i princìpi, non può assolutizzarsi.
Se la scelta dei mezzi viene fatta in modo di non deteriorare il raggiungimento del fine rivoluzionario si ha la garanzia che 1’azione in se stessa si è incamminata verso la giusta direzione, ma essa può trovare, nel corso del proprio svolgimento, delle modificazioni della controparte, cioè del potere.
In pratica il ragionamento determinista dimentica che il problema rivoluzionario non è basato solo sul rapporto tra mezzi e fini, ma anche sul rapporto dinamico tra potere e forze di liberazione, cioè sulla lotta di classe. Inserendo il problema nella realtà della lotta di classe, ne viene fuori una visione nuova, storicamente determinata. Una visione che supera l’apparente astrattezza del principio ma che fa emergere un nuovo problema.
Pur applicando il principio della scelta dei mezzi il raggiungimento del fine rivoluzionario può essere disturbato da uno spostamento del potere, che s’intende combattere. In questo modo il rapporto conflittuale deve essere rivisto partendo dalla stessa scelta dei mezzi.
Riprendiamo l’esempio visto nel paragrafo precedente. Il motivo della positiva valutazione, da parte degli anarchici, della richiesta dell’aumento salariale e del miglioramento contrattuale fatto in forma autonoma, è dovuto al fatto che in questo modo si ha “una crescita del movimento rivoluzionario della base dei lavoratori”.
Che cosa intendiamo per “crescita”? La possibilità di autogestire la lotta.
Il discorso sembrerebbe completo ma continua a non soddisfarci. In effetti oggi siamo davanti a una lenta ma decisa modificazione del rapporto conflittuale che ha condotto il potere a fissare la lotta di classe sull’ideologia produttivistica. Pertanto, se oggi i lavoratori accettano di restare all’interno della lotta “ideologica” per la produzione, per il lavoro, per la salvaguardia del salariato, per il miglioramento delle condizioni del salariato; se i lavoratori non cominciano a individuare le differenti realtà di lotta (dove cioè questa dimensione diventa rivoluzionaria e dove resta solo funzionale al potere); se i lavoratori non rompono questo cerchio e non esaminano (sempre partendo dall’azione diretta) le prospettive di una “distruzione del lavoro”; essi corrono il rischio di nientificare le proprie lotte, per quanto autogestite siano. Si avrebbe, in altri termini, il curioso fenomeno che a uno sviluppo dell’autogestione delle lotte non corrisponderebbe una crescita rivoluzionaria del movimento dei lavoratori. La qual cosa si potrebbe spiegare nel senso che pur restando nell’ambito della scelta dei mezzi in modo idoneo, il raggiungimento del fine rivoluzionario verrebbe a essere turbato da una modificazione del rapporto conflittuale col potere.
Bisogna allora riesaminare proprio questo rapporto. Spesso restiamo impigliati nel gioco democratico suggerito dal potere, smarrendo sia il rapporto con le masse (e quindi la validità della scelta dei mezzi), sia la prospettiva rivoluzionaria.
Non basta, infatti, un discorso genericamente di critica alle istituzioni per fare, oggi, un discorso rivoluzionario. Lo Stato democratico moderno è uno Stato che si fonda sulla critica e che nella critica trova l’alibi per coprire lo sfruttamento e il genocidio. Ma deve trattarsi di una critica fatta in un certo modo e con certe garanzie di inefficienza. Guai se un movimento rivoluzionario cade nella trappola di questa critica: da un lato rende inefficace il suo discorso verso le masse perdendo il contatto con le stesse, dall’altro, si abitua alla coabitazione col potere, indebolendosi sempre di più.
Non bisogna dimenticare che noi anarchici, come tutti, viviamo in un mondo che è quello che è, che cerchiamo di cambiare con la nostra attività, ma che comunque non possiamo cambiare dall’oggi al domani. Questo nemico che ci sta davanti, e contro il quale lottiamo, ha però la particolare capacità di stabilire costantemente con noi dei contatti, ai quali non possiamo – per ragioni fisiche – rifiutarci del tutto. Pur essendo anarchici e rivoluzionari, anche noi abbiamo dei bisogni imprescindibili, dobbiamo mangiare, molti di noi hanno famiglia, molti di noi hanno un lavoro, studiano, in una parola tutti siamo inseriti all’interno di quello stesso meccanismo che dobbiamo lottare e, al limite, distruggere. Questa difficile posizione rende molto complicato il nostro lavoro pratico e, di riflesso, rende estremamente importanti le elaborazioni teoriche che gettano luce sui rapporti tra ideologia e azione nel campo del pensiero anarchico.
Non c’è dubbio, dicevamo, che combattiamo tutti quel meccanismo che ci ospita, ma che siamo legati a piccoli compromessi quotidiani. Ora, questi piccoli compromessi vengono, di volta in volta, considerati isolabili e risolvibili in loco, senza che la loro emersione a livello di “bisogno” e la loro rimozione a livello di “bisogno soddisfatto”, vengano a trovarsi in contatto con quel patrimonio ideologico che consideriamo come un tutto acquisito, messo in soffitta, in un posto sicuro, dove ci rechiamo ad attingere per continuare la nostra lotta contro il potere e contro quello stesso meccanismo che, in definitiva, è lo stesso produttore dei compromessi suddetti.
Ora, sono dell’avviso che anche la nostra situazione quotidiana, il modo di affrontare e risolvere quei piccoli problemi, in una parola, il modo di collocarci all’interno del meccanismo del potere, è in rapporto con la posizione di partenza, modificandola continuamente, diremo quasi giorno per giorno, in relazione al flusso continuo di risoluzione dei compromessi. Noi crediamo, in buona fede, che le piccole cose di tutti i giorni, il posto di lavoro, il concorso, gli esami, la laurea, il matrimonio, i figli, lo stipendio, la carriera, la casa, i debiti e così via, siano faccende isolabili e, senz’altro, staccate dall’idea che abbiamo dell’essere anarchici; ma, in pratica, non è così. Spesso tutte queste cose ci condizionano al punto che modifichiamo le nostre analisi, quasi inconsciamente, sotto l’influenza del modo con cui affrontiamo quella miriade di piccoli problemi che ci attanagliano e ci condizionano.
E così, può accadere che un compagno che ha raggiunto certi piccoli risultati (sicurezza materiale, titolo di studio, matrimonio, figli e qualsiasi altra cosa, che per lui abbia valore positivo) è tendenzialmente portato a interpretare la prassi di lotta contro il meccanismo di potere che, in definitiva, garantisce quelle cose a cui lui stesso attribuisce valore, in un modo più cauto e circospetto, un modo diverso di quello di un altro compagno che non ha quella premessa discriminante o l’ha per un altro valore quantitativamente o qualitativamente diverso.
Concludendo sul problema dei mezzi e del fine, dobbiamo sottolineare questo nuovo problema che emerge all’interno di quello: il problema delle modificazioni. Modificazioni negli atteggiamenti e negli interessi del potere, modificazioni anche all’interno della minoranza agente. È in questa prospettiva che va quindi riesaminata la tradizionale affermazione che la scelta dei mezzi condiziona il raggiungimento dei fini.
Coabitazione col potere e autogestione
È naturale che tutta la problematica che precede trovi la sua giusta collocazione all’interno del problema dell’autogestione.
Il fatto che le organizzazioni riformiste di qualsiasi tipo si rifacciano all’autogestione si può spiegare, adesso, con una modificazione del rapporto col potere che, appunto, rende funzionale agli sviluppi futuri dello sfruttamento lo strumento autogestionario, una volta che venga legato all’interno di una struttura centralizzata.
In questo senso, alcuni compagni fanno il gioco della reazione, quando affermano che i problemi dell’autogestione appartengono all’indomani della rivoluzione e che quindi è superfluo parlarne adesso, quando ancora dobbiamo lottare per rendere possibile il processo evolutivo che ci porterà alla società di domani.
È un errore per due motivi. Primo: l’autogestione è termine non chiaro per cui molti pensano che si tratti di una forma di organizzazione dell’economia soltanto. Secondo: ragionando in questo modo si conclude per l’inutilità dello studio di problemi che verranno dopo la rivoluzione, affidandosi ciecamente alla spontaneità creatrice del popolo.
Con il termine autogestione dobbiamo intendere non solo una forma di organizzazione economica che parta dalla base, coinvolgendo tutte le forze economiche del paese, ma anche la forma da dare alla lotta rivoluzionaria. Non è possibile prospettarsi in futuro una struttura autogestionaria e disporsi, adesso, a un’organizzazione della lotta su base autoritaria. Il contrasto emergente finirebbe per distruggere le possibilità di realizzo dell’autogestione futura che finirebbe strangolata dall’autoritarismo, dal centralismo, emergente dalle stesse forze che contribuirono a produrre l’evento rivoluzionario.
Alternativa all’ideologia della produzione
Se la produzione è la religione, il lavoro è il dio creatore. Il mondo contemporaneo vede nella produzione, sotto i suoi vari aspetti, la persistenza di una situazione di sfruttamento (conservatori), la prospettiva di un lento passaggio al socialismo (progressisti), la condizione prima della rivoluzione (marxisti). Tutti sono d’accordo nell’esistenza del dio, uno e indissolubile: il lavoro.
L’etica del lavoro è costante nella nostra civiltà. Qualche voce isolata non ha diritto di cittadinanza. Lo stesso Paul Lafargue e il suo Diritto all’ozio rientrerebbe nel discorso dialettico (positivo-negativo) del marxismo.
Il lavoro permette all’uomo la propria realizzazione, dice Marx, gli consente cioè di appropriarsi del mondo esteriore che, così, diventa una parte del proprio mondo interiore.
Ma il lavoro è un fatto penoso. Da ciò la concezione dell’aspetto negativo, intrinseco nella natura umana. L’uomo giunge a trovare se stesso attraverso l’avventura fenomenologica (in senso hegeliano) dello smarrirsi (alienazione) e del ritrovarsi (reificazione).
A parte questa mitologia, di cui ci rintronano ancora le orecchie, ci interessa notare due cose.
Primo: il passaggio obbligato attraverso l’alienazione e il successivo ritrovamento è un segno della “religiosità” della costruzione marxista, tipico di ogni prospetto d’azione che intenda strumentalizzare quel sentimento di “religiosità naturale” che è connaturato alla sofferenza “reale” del popolo. In pratica il popolo soffre perché lavora, e perché lavora in uno stato di bestiale sfruttamento. Non gli importa nulla che qualcuno gli dimostri che questo lavoro gli è “necessario” perché senza di esso non esisterebbe come popolo in quanto non esisterebbe la civiltà; come non gl’importa nulla che qualcuno gli chiarisca il perché della sofferenza. Sono problemi che avverte ogni giorno sulla propria pelle. La filosofia non lo sfiora nemmeno. Un modello di “interpretazione” della realtà, com’è quello dialettico, il romanzo fenomenologico dello smarrimento e del ritrovamento, lo lascia del tutto indifferente. Al contrario, i sacerdoti della nuova elite ascendente, hanno interesse che il popolo si ritrovi nella sofferenza, hanno interesse che veda in essa un fatto non eliminabile subito, ma soltanto in una futura, lontana, radiosa rivoluzione. Questa brava gente ha tutto l’interesse che la religiosità naturale del popolo venga fatta rientrare nella religione fabbricata dalla setta, e questa religione, come tutte le religioni di questo mondo, deve partire da quel fatto reale. Ecco perché sono molti coloro che trovano strani punti in comune tra marxismo e cristianesimo.
Ambedue queste forme di religione utilizzano un fatto concreto: il bisogno del popolo di liberarsi, il dolore che avverte per la propria situazione di sfruttamento, la religiosa attesa di una vendetta contro i potenti. E la costruzione dialettica marxista non è poi molto più raffinata della rudimentale dialettica cristiana. Non per nulla Hegel si ispirò ai mistici protestanti tedeschi nel costruire il suo modello logico.
In simile compagnia il destino del popolo è segnato. Il cerchio si chiude perfettamente. Lo sfruttamento genera il senso di religiosità nel popolo e lo spinge a richiedere il sacerdote di sempre nuove religioni, e sempre nuove religioni sorgono con la scusa di guidarlo verso la redenzione e fare così scomparire lo sfruttamento e con esso il senso religioso di vendetta che lo accompagna. È come un cane che vuole mordersi la coda.
Unica soluzione è la rottura del cerchio. I punti deboli sono: il lavoro e la guida spirituale, lo sfruttamento e coloro che lo rendono possibile. Nella considerazione del concetto stesso di lavoro si coinvolge il rapporto padrone-servo, cioè la lotta di classe; nel concetto di guida spirituale si coinvolge il fatto autogestionario. Autogestione della lotta contro lo sfruttamento è quindi la frase che racchiude necessariamente non solo una scelta dei mezzi in funzione dei fini, ma una scelta dei mezzi tenuto conto della modificazione della controparte. L’alternativa all’ideologia della produzione è la distruzione del lavoro attraverso l’organizzazione dell’autogestione.
La distruzione del lavoro
Niente è più dannoso alla rivoluzione del credere che la lotta della base, sia pure autogestita, conduca automaticamente, deterministicamente, a una crescita del movimento operaio e quindi alla soluzione rivoluzionaria.
Solo la verifica costante dei rapporti di potere, del conflitto di classe, delle condizioni storiche di questo conflitto, dei mezzi scelti per raggiungere gli obiettivi rivoluzionari, possono ovviare a questo pericolo. E tale processo è di tipo volontaristico. Riguarda direttamente quella parte dei lavoratori che hanno sensibilizzato la propria coscienza sulle reali possibilità di lotta e non si lasciano trascinare da sentimentalismi e fantasmi.
L’alternativa al lavoro è la distruzione del lavoro. Ma questa non deve essere intesa come spostamento dell’etica lavorativa in un’etica dell’ozio o, se si vuole, dell’estetica della produzione in un’estetica dell’attesa. Si deve vedere in essa una trasformazione del fine del lavoro in seno alla società alimentata dall’ideologia produttivistica, nel senso della liberazione dell’uomo. Non c’è dubbio che questa liberazione può avvenire solo attraverso una modificazione del rapporto uomo-lavoro e non solo attraverso una modificazione del rapporto di produzione preso in se stesso come valore assoluto (o quanto meno come valore imperante in una certa situazione storica).
Il segno rivoluzionario è nella liberazione dallo sfruttamento: ciò può avvenire in diversi modi, legati a diverse situazioni del conflitto di classe; ma non può fare a meno di collocare al centro del discorso il problema dell’eliminazione del lavoro.
Spesso alcuni compagni si chiedono se “distruzione del lavoro” significhi un preteso comunismo assoluto, tipo “presa nel mucchio”, portando avanti subito le arcinote critiche su questa impostazione kropotkiniana. Vogliamo dire subito alcune cose. Non siamo d’accordo con la “presa nel mucchio”, vista nel senso di una conclusione idilliaca (che per altro non corrisponde nemmeno esattamente al pensiero di Kropotkin), vediamo invece possibile la costruzione di una società comunista anarchica che si realizzi immediatamente, dopo l’evento rivoluzionario, almeno secondo certe situazioni obiettive, per cui si potrebbero avere soluzioni di tipo pluralistico, cioè non realizzanti direttamente la società comunista, ma dirette a essa attraverso il passaggio costituito dalla soluzione collettivista o altre soluzioni ancora da sperimentare. Non consideriamo il concetto di “distruzione del lavoro” come superamento di una fase storica (quella della manifattura), ma solo come accettazione della realtà di superamento in corso (trasformazione delle strutture produttive) e rifiuto dell’ideologia della produzione diretta a sostenere la necessità della vecchia gestione dell’economia, sia pure in forma cambiata limitatamente all’appartenenza dei mezzi di produzione. Intendiamo, infine, come “distruzione del lavoro”, anche l’autogestione provvisoria e parziale, in regime capitalistico, attuata in forma violenta ed espropriativa, da parte di nuclei produttivi anche staccati dal contesto generale della produzione di un paese o di una zona, purché la lotta venga condotta non a favore della produzione ma per una distruzione del lavoro e per una radicale trasformazione della produzione.
È chiaro che i concetti che abbiamo qui ammassati necessitano di un’elaborazione assai lunga e difficoltosa. In pratica, come vedremo più avanti, oggi possiamo più o meno prevedere la possibilità di una società comunista anarchica all’indomani della rivoluzione, almeno per i grandi paesi a capitalismo avanzato, in considerazione dell’attuale sviluppo della tecnologia produttiva e organizzativa (specialmente dell’informatica). Ciò non toglie che le diverse situazioni dello sviluppo diseguale del capitalismo ci facciano presupporre una grandissima difficoltà riguardo una simile soluzione su grande scala, mentre ci fanno apparire assai più probabili conflitti di struttura di enorme portata, capaci di fare emergere prospettive che non è facile prevedere. Il pluralismo anarchico ci sembra quanto mai valido in questo senso. A diverse situazioni, diverse soluzioni. Nessun preconcetto principio teorico da comprovare a tutta forza, anche sulla pelle dei lavoratori; nessun interesse di casta o di partito, nessun bisogno di dominio e di potere. Ma, una volta che partiamo dall’autogestione rivoluzionaria come elemento essenziale di ogni discorso, quindi anche del discorso sul pluralismo, dobbiamo concludere per la possibilità che questo discorso si evolva, nell’ambito di un’autogestione delle forze di liberazione, che poi sono le stesse forze produttive, verso il comunismo anarchico, soluzione del problema economico e del problema dell’uomo.
Le tecniche del sabotaggio
La lotta autonoma della base dei lavoratori, può estrinsecarsi tecnicamente in molti modi, più o meno tutti riportabili alle tecniche del sabotaggio. È infatti il sabotaggio che colpisce più a fondo la struttura produttiva, mettendo subito in difficoltà padroni e servitori dei padroni a causa della sua irriducibilità ai canoni interpretativi della lotta riformista.
È ovvio che la lotta autonoma della base dei lavoratori può svilupparsi attraverso altre tecniche, come, ad esempio, quella dell’autogestione di unità lavorative in situazione di gestione capitalista; ma il sabotaggio resta un elemento essenziale dell’autonomia delle lotte.
La pericolosità del sabotaggio è comprensibile anche dal fatto che tutti i borghesi, unanimamente, e, purtroppo, anche qualche pseudo-rivoluzionario, alzano la voce contro di esso, s’indignano, protestano, come di un mezzo di lotta delittuoso. Ma tutta questa gente, che alza così alti lamenti, è la stessa che sfrutta e uccide con grande disinvoltura nelle fabbriche e nelle campagne, che tratta i lavoratori come strumenti di produzione, quando non li invia a combattere al fronte, come carne da cannone.
La verità è che applicando il sabotaggio su vasta scala, come azione diretta della classe dei lavoratori contro i padroni, quest’ultimi devono scendere su di un terreno che per loro è ignoto, obbligati a combattere contro avversari che sfuggono alla presa e che non possono essere individuati, isolati e colpiti.
Autogestione e scelte economiche
Spagna
La situazione della Spagna non fu fra le più favorevoli alla risoluzione del problema della costruzione della società libertaria fondata sull’autogestione.
Nel 1936 in Spagna si aveva una percentuale di analfabeti di circa il 60 per cento della popolazione. A questo si deve aggiungere uno scarso sviluppo della tecnologia in genere e l’impossibilità oggettiva di far fronte a grosse trasformazioni a seguito del ritiro dei capitali da parte dei cartelli stranieri.
Per contro, una notevole propaganda comunista libertaria, fatta prima della guerra civile, e una tradizione di lavoro collettivo.
Opponendosi ai marxisti, che volevano consegnare tutto nelle mani delle Stato, gli anarchici sostennero che la socializzazione doveva essere effettuata dagli stessi lavoratori nelle officine, nelle fabbriche e in tutti i settori dell’economia.
La prima fase consistette nella socializzazione delle imprese, nelle zone dove questo fu possibile. Ogni industria, ufficio, magazzino di vendita vide i delegati sindacali incaricarsi dell’organizzazione. In massima parte si trattava di persone che non avevano alcuna esperienza tecnica in materia economica, ma sapevano perfettamente quali fossero i problemi tecnici del proprio settore in relazione al particolare momento. Se a questo aggiungiamo lo spirito d’iniziativa e la vera e propria esplosione di “soluzioni tecniche” che si ebbero a seguito del fatto che tutti si videro “responsabilizzati” in prima persona; possiamo farci un’idea del clima psicologico, elemento non trascurabile nella determinazione del fenomeno storico.
La coordinazione tra i diversi settori industriali venne fatta dal sindacato. Nei settori più ricchi si costituirono delle casse di sostegno per le industrie più povere. I vari delegati non erano per questo sollevati dall’obbligo di fornire lo stesso un lavoro manuale.
Si ebbe un certo aumento medio della produzione agricola in alcune zone e anche un accrescimento della meccanizzazione. Non poche terre vennero dissodate, irrigate e coltivate.
Poi l’intervento distruttivo del partito comunista mise fine a questa azione. La repressione di Lister contro le collettività di Aragona è da considerarsi un modello nel genere.
Queste, per grandi e superficiali linee, le iniziative della Spagna rivoluzionaria. Quali i problemi che occorrerà discutere? Problemi politici, militari ed economici. Non è possibile separarli: in una parola problemi rivoluzionari.
Le decisioni che furono prese sul piano dell’organizzazione militare si possono mettere in rapporto alle decisioni prese sul piano della collaborazione politica al governo. In questa prospettiva la resistenza della base sul piano della costruzione economica della società nuova, non poteva non essere destinata al fallimento.
Certo sarebbe illogico e superficiale criticare quelle esperienze alla luce di fatti teorici e sviluppi concreti della lotta di classe, che si sono chiariti solo in questi ultimi decenni. Comunque alcune cose emergono troppo chiaramente per essere dimenticate. Per impostare il problema del fronte unico in forma stabile, si sacrificarono molte cose, fra cui la stessa posizione anarchica. Di questo fu maggiore responsabile il sindacato. Lo stesso avvenne sul piano puramente militare. Accettata la tesi della guerra di linea, non si poteva più sostenere un’autogestione della base delle organizzazioni militari anarchiche. Per lo stesso motivo, infine, quando le collettività anarchiche vennero attaccate dai comunisti, non ci si poté decidere a contrattaccare. Al contrario, non furono pochi i compagni decisi a difendere le collettività con le armi, che vennero guardati con sospetto e quasi messi “fuori legge” dalle stesse organizzazioni anarchiche “ufficiali”.
Partendo dal concetto “globale”, di autogestione, concetto che abbiamo esaminato nel corso dei capitoli precedenti, l’esperienza della Spagna rivoluzionaria, ci porta a questa grande evidenza: non è possibile operare, nel fatto rivoluzionario, una scissione tra momento politico, momento militare e momento economico. Nel caso si sia costretti a fare questa distinzione, le probabilità di riuscire a organizzare l’economia sulla base autogestionaria sono limitatissime e i mezzi che bisogna impiegare (non esclusa la forza bruta) sono molto simili a quelli che occorrono per impiantare qualsiasi altra forma di organizzazione economica, non esclusa quella del capitalismo di Stato.
Non vale oggi chiedersi e riflettere che cosa abbia fornito la base giuridica delle collettività spagnole, se esse derivano dal sindacato o dal municipio, oppure dal comune nel senso medievale. A mio avviso, non è questo il vero insegnamento che possiamo trarre da quegli avvenimenti. Essi ci devono fare riflettere sulle necessità di mettere in risalto le possibilità positive di organizzazione spontanea della masse, evitando di uccidere questa spontaneità con errori che vengono fatti in alto, proprio in quella regione “direttiva” che non dovrebbe esistere “per definizione” fra gli anarchici, ma che di fatto si solidifica non appena si affrontano in modo acritico i problemi del fronte comune rivoluzionario e dell’organizzazione del lavoro.
In ambedue i problemi non si può mettere da parte il fondamento autogestionario della possibile rivoluzione. Occorre partire dalla base, dai nuclei produttivi fondamentali, per sviluppare l’azione rivoluzionaria, restando nell’ambito della creatività e della spontaneità della base, sia nella prospettiva politico-militare della collaborazione con gli altri gruppi, sia nella prospettiva più tecnicamente economica dell’organizzazione della produzione nei settori e nelle zone dove ciò è possibile per la presenza di larghe componenti anarchiche fra i lavoratori.
Nel caso in cui non venga seguita questa disposizione armonica delle forze spontanee della base, nel caso in cui sia una ristretta minoranza di dirigenti a decidere il modo di porre la collaborazine con le altre forze rivoluzionarie; la stessa capacità organizzativa dei lavoratori verrà uccisa nel momento in cui le loro costruzioni entreranno in contrasto con il resto della realtà produttiva, che, ovviamente, sarà diretta e impostata in maniera molto diversa perché influenzata proprio da quelle altre forze rivoluzionarie autoritarie con le quali – sul piano politico-militare – si sta collaborando. Allora i soliti “dirigenti”, si troveranno a un bivio: o abbandonare la primitiva collaborazione, negando la propria funzione e gettando nella più assoluta confusione la coordinazione politico-militare, o ingoiare il rospo della distruzione dei tentativi di organizzazione economica voluti e attuati dalla base in modo anarchico. Ma, così facendo, essi si oppongono alla massa, negandosi come minoranza anarchica agente e quindi come forza rivoluzionaria in senso libertario. O si è coerenti in tutto, nel nostro modo di pensare, o si rischia di tutto compromettere.
Jugoslavia
Classico esempio di economia autogestita con centralizzazione delle scelte economiche. La gestione operaia è assistita da una suddivisione comunale. Lo Stato sta dietro le quinte, cerca di apparire il meno possibile. Il suo centralismo si estrinseca attraverso i decreti e attraverso le tasse. Oltre, naturalmente, il piano economico.
I consigli dei produttori esistono a tutti i livelli. Partono dalla fabbrica e dal comune e arrivano fino a livello federale, dove sono rappresentate tutte le singole nazioni che compongono la Jugoslavia. Esiste una Pianificazione Centrale che però attua un forte decentramento attraverso le sei repubbliche federate.
Nella fabbrica bisogna distinguere il collettivo operaio, che è l’insieme degli operai, dal consiglio operaio, che studia i problemi della fabbrica insieme al comitato di gestione che ne studia i problemi riguardo l’aspetto economico. Al di sopra di essi c’è un direttore con responsabilità tecniche. Egli può anche assumere e licenziare gli operai. Il direttore è nominato dal Consiglio di fabbrica e dal Comitato popolare del comune.
Risulta chiaro che i lavoratori non possono lottare contro una costruzione centralizzata dell’economia, non ne hanno i mezzi a livello organizzativo, non ne hanno i mezzi a livello tecnico. Anche se l’apparato esteriore è autogestionario, nella persistenza di un piano globale di sviluppo economico e nella persistenza di un globale controllo politico, la loro funzione sarà quella di esseri sfruttati.
In Jugoslavia la situazione di sfruttamento è chiarissima, anche a prescindere dalle dichiarazioni fatte dai vari responsabili dei settori economici.
Nell’agricoltura esiste un settore privato e un settore collettivizzato. Il primo è di gran lunga più grande. Il secondo comprende tre tipi di organismi: cooperative generali, fattorie sociali (come i sovcoz), cooperative di produzione (come i colcoz).
Infine, abbiamo la cosiddetta “gestione sociale” (servizi pubblici, banche, ecc.) che non sono autogestiti.
Le critiche a questo tipo di organizzazione della produzione sono molto semplici: non si tratta di autogestione, almeno non nel senso in cui l’intendono gli anarchici. Non per nulla in Jugoslavia esiste lo Stato comunista [1972] e non si vede alcuna forma di “deperimento”.
Gli stessi critici interni al partito comunista jugoslavo e ai sindacati insistono sulla necessità di superare la struttura gerarchica e la divisione sociale del lavoro a tutti i livelli della società, ma si tratta di tentativi interessati unicamente a “spingere” la produttività di un sistema economico che minaccia di scendere sotto i livelli di sicurezza. Molti compagni hanno interpretato, erroneamente, queste critiche come un segno di apertura, come l’indicazione che qualcosa va cambiando all’interno della dimensione jugoslava; per cui, essendo la struttura sia pure malamente basata sull’autogestione, il risultato di un eventuale cambiamento dovrebbe essere quello di un progressivo avvicinarsi alla “vera” organizzazione autogestionaria. Niente di più errato. Come abbiamo cercato di dimostrare, l’autogestione non è problema parziale, non è problema di scelte economiche, ma problema totale, problema rivoluzionario.
Un elemento da non sottovalutare, in questo fallimento del tentativo autogestionario jugoslavo, è la presenza di una spinta concorrenziale, se non altro determinata dal rapporto con le economie straniere. Si tratta di qualcosa che matura all’interno dei ranghi dirigenti jugoslavi e che spinge, specialmente i giovani, a opporsi alla continuazione di una forma autogestionaria che si traduce in un peso per le motivazioni espansionistiche della loro visione di politica economica. Non si può non riconoscere un fondo di verità a queste spinte verso un capitalismo concorrenziale. Restando nell’ambito di una dimensione autogestita i dirigenti sono costretti a limitarsi alle piccole beghe interne, alla gestione di piccoli interessi locali, alle prospettive di una carriera non certo brillante, allargandosi al capitalismo di stato tradizionale, possono aprire meglio le loro prospettive, sviluppare interessi più ampi. Da canto loro i lavoratori restano apatici, non vedono un interesse oggettivo a difendere una struttura che autogestisce solo la loro miseria. Questa è la vera essenza delle lotte interne alla economia jugoslava: non è l’autogestione che viene posta in discussione, visto che essa non esiste, ma solo una più o meno efficace forma di sfruttamento dei lavoratori.
Germania federale
Non è sbagliato parlare qui della Germania federale e della sua cogestione. Salvo la differenza della parola si tratta, più o meno, di un fenomeno analogo a quello dell’autogestione attuata in alcuni Stati cosiddetti socialisti.
Tutte le aziende tedesche che hanno oggi [1972] più di 2.000 dipendenti sono cogestite attraverso i sindacati. Molte delle aziende più piccole hanno una forma assai simile di cogestione.
Il consiglio di fabbrica tedesco trae le sue origini dalla rivoluzione del 1918-1919. La struttura di questo consiglio è tale che consente una notevole azione ai rappresentanti sindacali che, spesso, a un certo livello, sono anche esonerati dal lavoro e pagati a tempo pieno. In concreto il consiglio si contrappone al comitato di direzione e al direttore dei lavori.
In questo senso si divide la partecipazione alle decisioni dell’azienda. I lavoratori non solo sono nelle mani dei proprietari, ma anche nelle mani di una forte classe sindacale che li strumentalizza come vuole.
Ecco una breve e precisa analisi di Heinz Zimmermann (“Interrogations” n. 1, 1973): «Non è difficile comprendere che la cogestione paritaria è una questione di apparecchi burocratici – padronali e sindacali – e che le decisioni importanti sono prese senza consultare i salariati.
«La cogestione agli occhi dei dirigenti sindacali, a nostro avviso, intende ottenere due scopi essenziali. Il primo riflette la concezione d’insieme del partito socialdemocratico (legato ai sindacati non sul piano formale, ma grazie a una simbiosi di personale e di mentalità tra le due organizzazioni): si tratta di arrivare a una “regolarizzazione” delle relazioni sociali con lo scopo, dice un dirigente sindacale, d’attenuare, nella misura del possibile, le ingiustizie sociali risultanti dal processo economico. Il secondo permette l’integrazione nel processo economico, e industriale, di tutta una classe di “funzionari” sindacali sociali, che vengono a far parte integrante del sistema economico e sociale, non abbandonando ai soli “manager” usciti dalla classe dirigenziale del paese questo ampio campo di attività».
Quindi eliminazione degli attriti e dei conflitti per quanto è possibile; partecipazione in prima persona alla gestione economica. Integrazione definitiva nella struttura di potere della precedente struttura di contro-potere. Ovviamente, sarebbe superfluo spiegare che questa integrazione è resa possibile non per una degenerazione dei sindacati ma per una loro essenziale caratteristica, eventualmente acuita nel corso dello sviluppo egemonico del capitalismo tradizionale.
Il mettere nello stesso sacco la cogestione tedesca e l’autogestione jugoslava ha il preciso significato di richiamare l’attenzione sulla fine comune che fa il movimento operaio quando si mette nelle mani di una minoranza che accede “ai posti di responsabilità”. Furono i rivoluzionari della Comune di Parigi che per primi compresero che il delegato deve essere revocabile in qualsiasi momento, in caso contrario si trasforma in burocrate; mentre il suo mandato deve essere preciso, limitato e dettagliato in ogni sua parte. Fin quando non si avranno chiare le idee su questo punto non si potrà sviluppare il vero progetto autogestionario che passa, per prima cosa, attraverso l’organizzazione rivoluzionaria.
Cecoslovacchia
Nell’aprile del 1968 i dirigenti del Partito comunista cecoslovacco cercarono di risolvere il grave problema determinatosi a seguito dell’abbassamento improvviso del reddito nazionale, per la prima volta dopo la fine della guerra. Il loro scopo era quello di risanare l’economia attraverso un passaggio da forme tradizionali di produzione e di direzione a forme nuove richiedenti un fondamentale mutamento del meccanismo dell’economia socialista. Questo mutamento doveva avvenire attraverso un’apertura verso il mercato mondiale allo scopo di rapportare i prezzi interni alla concorrenza internazionale, attraverso un riesame del ruolo dei sindacati, attraverso una democratizzazione dell’economia.
Il primo punto di questo piano di bonifica non merita molte riflessioni dal nostro punto di vista. Sotto un aspetto meno roboante si tratta, più o meno, della politica economica perseguita da quasi tutti i paesi dell’Est, che invitano gli investimenti di capitali occidentali all’interno delle proprie aree industriali.
Il secondo punto è più interessante. Riapre il discorso sul ruolo dei sindacati in uno stato socialista, in quanto anche l’economia socialista crea delle condizioni nelle quali è necessario per il lavoratore difendersi in modo organizzato contro interessi umani e sociali diversi dai suoi. Afferma l’autonomia dei sindacati di fronte al partito, facendo cadere la vecchia concezione del sindacato come “cinghia di trasmissione”. Si tratta di tesi che ebbero una grande importanza a livello di potere e che determinarono l’intervento sovietico, ma che, a livello della base, determinarono, insieme al terzo punto che vedremo subito dopo, profonde modificazioni e interessanti reazioni.
Il terzo punto è, per ovvie ragioni, il più oscuro nel programma di trasformazione. Non parla con chiarezza del nuovo ruolo dei lavoratori nel funzionamento di un’economia socialista, si limita ad affermare una “democratizzazione” dell’economia. Parla della necessità di collocare dei collettivi all’interno delle industrie socialiste capaci di assumersi le responsabilità della gestione e quindi necessitanti di un vero e proprio potere decisionale, sebbene limitato di fronte a quello della direzione. Ma, questi organismi potranno pretendere dei rendiconti da parte del direttore dell’industria e dei lavoratori dirigenti. Riguardo la composizione di questi collettivi vi entreranno a far parte, per metà i lavoratori dell’industria in questione e per l’altra metà delegati di altri settori e di corpi estranei all’economia.
In effetti, questi barlumi di modificazione, molto più deboli, tanto per fare un esempio, delle realizzazioni jugoslave, non sarebbero restati che esercitazioni letterarie sulla carta se, invece, un altro fenomeno, molto più importante e decisivo, non avesse preso consistenza: il movimento dei lavoratori.
Al contrario dell’ottuso paternalismo che emerge dalle proposte del programma, al contrario dell’immobilismo che doveva continuare a salvaguardare l’autorità dei dirigenti all’interno della fabbrica, al contrario di ogni condanna della spontaneità creatrice, al contrario di ogni esaltazione del “buon operaio”; i lavoratori presero alla lettera la proposta di democratizzazione e cercarono subito di darsi delle organizzazioni democratiche senza bisogno di aspettare che le disposizioni direttive del partito si realizzassero in una farsa, come di tradizione.
Per questo i lavoratori cecoslovacchi tentarono di arrivare prima dell’attuazione “legale” dei nuovi consigli di fabbrica, cercando d’imporre in forma rivoluzionaria i propri consigli. La fine di questa bella avventura fu lo scontro con i carri armati russi.
Di fronte al pericolo di un germe autogestionario vero e proprio si ricorse ai mezzi estremi, gli stessi usati a Budapest, mettendo a repentaglio la credibilità stessa della patria del socialismo a livello internazionale. Tale mossa, certo non avventata o improvvisa, ci dà la misura dell’importanza e della pericolosità che simili iniziative, provenienti dalla base, rivestono per il potere socialista.
Autogestione anarchica
L’azione della minoranza anarchica
La conclusione per l’autonomia della classe lavoratrice ci viene, come abbiamo visto, dall’impossibilità di rompere altrimenti il cerchio contro-rivoluzionario. Che questa oggettiva impossibilità si faccia derivare da un preteso processo deterministico ricavabile dalla storia è un fatto che non ci riguarda. L’autonomia dei lavoratori non è una “forma” filosofica, come tante altre, è una necessità oggettiva. I lavoratori devono curare in proprio gli interessi che li riguardano: gli stimoli “religiosi” alla delega nella cura di questi interessi devono essere messi da parte.
Qui sorge un problema ben preciso. Che cosa determina la nascita e lo sviluppo della tendenza all’organizzazione autonoma della lotta nella classe lavoratrice? Si tratta di un fatto automatico, diretta conseguenza dell’impossibilità degli sbocchi rivoluzionari causata dalla “santa alleanza” fra capitale, partiti e sindacati? Oppure esiste una componente precisa, minoritaria, che agisce all’interno della classe lavoratrice, sviluppando una progressiva chiarificazione dei pericoli, degli ostacoli e delle possibilità: cioè spingendo la massa a fare da sé?
La risposta più esatta sarebbe quella diretta a illustrare la compresenza di queste due componenti. Ma, in pratica, il problema più grave che si presenta è la figura storica precisa del proletariato e il suo “ruolo” egemone nella prospettiva rivoluzionaria. Sembrerebbe che senza la nascita del proletariato industriale questa tendenza all’organizzazione autonoma della lotta non si potrebbe verificare. Un ragionamento del genere ci sembra curioso, almeno per due motivi: primo, insiste nel conservare al proletariato industriale un ruolo di “guida”, pur parlando di autonomia; secondo, propone alla storia un’alternativa illogica, che poi sarebbe la possibilità della “non esistenza” del proletariato stesso.
Ma il proletariato esiste, l’industria e il suo sviluppo hanno un loro posto nella storia, la rivoluzione industriale ha determinato la nascita del capitalismo, questo si è evoluto fino all’epoca presente come sappiamo e manifesta chiari sintomi di evolversi in un certo senso. Tutto ciò finisce per semplificare il nostro problema. La classe lavoratrice di oggi comprende una grossa parte che è il proletariato industriale. Questo è direttamente legato, nella sua configurazione di classe, allo sviluppo della produzione industriale il che è logico. Non comprendiamo, però, come da questo si possa passare ad affermare che questa parte della classe lavoratrice debba avere un ruolo predominante sulla parte residua. Non solo, ma non comprendiamo neppure il secondo motivo, perché l’autonomia debba verificarsi soltanto all’interno del proletariato industriale.
Ammettendo un ragionamento del genere si deve pure ammettere che la crisi del capitalismo sia una crisi “mortale” e non una crisi di “trasformazione”. Nel senso che, essendo il proletariato industriale il lembo più sensibile della classe lavoratrice, ne sarebbe anche la parte più idonea a percepire i sintomi di malattia del capitalismo e a opporvi una specifica organizzazione di lotta: cioè l’organizzazione autonoma. Gli altri strati, poniamo i contadini, non essendo immediatamente a contatto con lo strato privilegiato della produzione non avvertirebbero questi stimoli e non ammetterebbero la possibilità dell’autonomia.
Ci sembra non provato che il capitalismo sia in “crisi mortale”. Al contrario, ci sembra che le sue forze siano quanto mai vive e vegete. Soltanto la sua crisi, evidentissima, si presenta come una crisi di passaggio, di evoluzione a forme di capitalismo diverse, sebbene identiche nella sostanza dello sfruttamento. Una evoluzione pacifica verso il socialismo di Stato sarebbe la nascita di un nuovo capitalismo, più rapace ed efficiente di quello attuale. Quindi non possiamo parlare di “crisi finale”. Eppure la tendenza all’organizzazione autonoma della classe lavoratrice esiste.
In effetti, le posizioni attuali dei riformisti (partiti e sindacati) non sono una “risposta” alla “crisi finale” del capitalismo più di quanto non lo sia l’autonomia proletaria. Il collaborazionismo dei partiti e dei sindacati non è una strategia di oggi, è la risposta costante dell’istituzione nascente nei riguardi dell’istituzione in atto, che si vuole abbattere ma che bisogna lasciar sussistere, perché la sostituzione avvenga con il minor danno possibile nella struttura, altrimenti al momento in cui l’élite ascendente prenderà il potere, si troverà con un cumulo di rovine nelle mani. Questo è il vero punto di vista dei riformisti. Allo stesso modo, l’autonomia della classe lavoratrice, intesa come restante possibilità di lotta, non deriva dalla “crisi finale” del capitalismo, ma fa parte dei tentativi costanti che si sono fatti all’interno di questa classe allo scopo di liberarsi dello sfruttamento. Possiamo vedere come i lavoratori abbiano cercato sempre organizzazioni autonome e nuove, contrastanti con le precedenti (superate e inglobate dal potere), allo scopo di sopravvivere e di lottare; e possiamo vedere pure come queste organizzazioni siano state consegnate nelle mani di portabandiera che sono passati subito a ingrossare le elite ascendenti, arrivando al potere e negando le istanze di liberazione della base.
Quindi dobbiamo studiare meglio questo meccanismo della “consegna” dell’autonomia nelle mani dei “capi” e dei partiti guida. Dobbiamo rivedere quali sono le cause di questa religiosità, i motivi irrazionali che entrano a far parte delle pretese determinazioni della struttura, la sfiducia complessiva che sembra far presa sulle masse gettandole in braccio al riformismo.
Ci siamo chiesti quale dovesse essere il ruolo della minoranza agente all’interno dell’autonomia della classe lavoratrice. La conclusione è per una costante misura con le forze oggettive che determinano le condizioni di fallimento dell’autonomia di classe, cioè con queste forze che abbiamo riassunto, forse impropriamente, nella parola “religiosità”, sottolineandone l’essenza irrazionale. Non è possibile teorizzare, in astratto, la formazione di un gruppo minoritario anarchico, agente sulla massa, al di là dei livelli corrispondenti agli interessi precisi di quest’ultima. Solo che bisogna intendersi sull’essenza e consistenza di questi interessi. La cortina fumogena alzata dal riformismo impedisce un’esatta valutazione dei veri interessi della classe lavoratrice in modo molto più drammatico di quanto, in passato, non riuscisse a fare il brutale potere dei padroni e dei fascisti. La socialdemocrazia alleata dei padroni è quanto di peggio si possa immaginare come ostacolo nella strada verso la liberazione dei lavoratori.
Dobbiamo quindi fissare un indice di concretezza all’azione anarchica all’interno dell’area dell’autonomia dei lavoratori. Esso ci viene dagli interessi obiettivi di quest’ultimi. Ma non si tratta di una prospettiva “guida”, la quale, anche se assumesse la visione dell’anarchismo più ortodosso, finirebbe per ricalcare le orme della socialdemocrazia, agente del potere. Al contrario, si tratta di un’azione interna al movimento stesso dei lavoratori, un’azione che parte dal concetto dell’autonomia e dell’organizzazione autonoma in funzione degli interessi dei lavoratori stessi, un’azione che si riallaccia all’autonomia del singolo rivissuta attraverso l’autonomia della classe in rapporto alle prospettive di liberazione rivoluzionaria.
Il guaio di tante situazioni concrete è che l’azione degli anarchici, se è chiara a certi livelli analitici, si smarrisce spesso nel momento della scelta dei mezzi. L’attacco alla visione interclassista dei partiti e dei sindacati, comprende una chiara visione dei mezzi di lotta che possono impiegarsi e non deve intendersi come una cieca rimessa delle decisioni nelle mani della spontaneità dei lavoratori. Il discorso sull’autonomia non si discosta dal discorso sulla scelta dei mezzi di lotta: le due cose sono concatenate e si condizionano a vicenda. La prospettiva violenta, l’azione diretta gestita dalla base, il sabotaggio, la distruzione del lavoro, non sono atti “più a sinistra” di qualcosa supposta “a sinistra”; sono scelte precise dettate dall’autonomia degli interessi, scelte nelle quali la presenza anarchica attiva ha una grandissima importanza.
Il discorso deve fermarsi con attenzione sugli “interessi” dei lavoratori. Se essi emergessero, come nell’analisi marxista, da una situazione di fatto, e precisamente dalla dominazione del capitale, si potrebbe parlare – con uno sforzo logico – di “interessi per se stessi”, corrispondenti alla “classe per se stessa”; ma questi interessi sono veramente quelli della classe lavoratrice solo a condizione che quest’ultima li riconosca per propri, riesca a superare gli ostacoli costruiti espressamente dal potere, rinneghi la falsa proposta dei riformisti, ecc. In altri termini, noi vediamo un aspetto volontaristico nell’azione autonoma dei lavoratori, un aspetto che coglie e oltrepassa il momento essenziale degli “interessi” oggettivi della classe, ma solo a condizione che questo momento venga ottenuto attraverso la lotta e la sensibilizzazione. E qui si colloca l’azione positiva degli anarchici.
Questa presa di coscienza dei propri interessi, questa riscoperta soggettiva di interessi oggettivamente dati, è la condizione essenziale perché si verifichi la rivoluzione sociale senza un passaggio preventivo attraverso il comunismo di Stato.
Altro aspetto dell’azione anarchica nell’area dell’autonomia è quello diretto a chiarire il rapporto col potere.
Il potere non può solidificarsi in un punto preciso dello schieramento reazionario. Differenze sostanziali emergono fra capitalisti, burocrazia, media e piccola borghesia, intellettuali, e altri elementi di un quadro molto complesso. Differenze non meno sostanziali si hanno fra partiti di governo, partiti riformisti, sindacati, organizzazioni repressive del capitale (esercito, polizia, magistratura, fascisti, ecc.). Ma, al di là delle specifiche differenze costitutive e di impiego, tutti questi schieramenti sono accomunati dalla necessità di ogni organizzazione di potere: la sopravvivenza.
Essi lottano, dapprima per la sopravvivenza di se stessi e per il perpetuarsi della situazione oggettiva che li rende possibili, poi per rendere sempre più agevole questa sopravvivenza.
Che la dottrina marxista sia espressione di un ceto medio e intellettuale che intenda impadronirsi del potere, superando l’ultimo ostacolo che lo separa dalla proprietà, è ipotesi allettante e valida, ma, almeno ci pare, necessitante di alcuni approfondimenti. Non siamo d’accordo con chi vede in questo solo un qualcosa da ricercarsi nelle attitudini e negli interessi della media e piccola borghesia. Un riflesso non secondario è costituito da quei residui irrazionali che sussistono nella classe lavoratrice e che, indirettamente, rendono possibile lo sviluppo degli interessi della classe intermedia, che intende raggiungere il potere. L’elite ascendente, in questo caso, non sarebbe in proprio la borghesia media e piccola, ma una minoranza di questa, partiti e sindacati, auto-definitisi rappresentanti degli interessi del proletariato, ma sostanzialmente portatori di interessi propri e, in secondo luogo, degli interessi della borghesia meno dotata finanziariamente.
È per questo che l’azione degli anarchici, in quanto minoranza agente, non deve proporsi solo come quella di un’avanguardia della massa che, in quanto tale, è sensibile a certi livelli di lotta e, proprio per questo, si sente autorizzata a rappresentare le masse. In questo modo si apre la strada all’azione violenta fine a se stessa, nella pretesa che si possa sollecitare il movimento dei lavoratori dall’esterno, in conseguenza di certe azioni “esemplari” nel loro isolamento. Il principio stesso dell’autogestione e dell’azione diretta, come principio della massa degli sfruttati e non come prerogativa esclusiva di una minoranza, entrerebbe in contrasto con una visione tanto parziale del compito rivoluzionario.
[Per questo paragrafo cfr. la seconda parte di “L’alternativa proletaria: l’autonomia dei nuclei produttivi di base”, op. cit., pp. 147-153]
Il problema organizzativo
Il socialismo autoritario ha risolto il problema dell’organizzazione in modo semplice: non avendo come principio la concezione che la scelta dei mezzi finisce per condizionare il raggiungimento dei fini, ha riprodotto la stessa struttura autoritaria che intende combattere, organizzandosi in partiti rigidi e centralizzati.
Questa forma, da un punto di vista distruttivo e immediato, può anche avere i suoi vantaggi, ma non dà alcuna garanzia riguardo gli obiettivi rivoluzionari. Attraverso il partito e tutte le strutture del genere, la rivoluzione subisce una radicale trasformazione e, in breve volger di tempo, si riduce da evento di grande portata a banale cambiamento di potere, dando vita alla nascita di una nuova classe dirigente ancora più famelica della precedente.
In pratica, il problema organizzativo presenta due aspetti: uno reale e uno immaginario. Il primo, di grande importanza, è in relazione diretta con lo sviluppo della lotta rivoluzionaria: con il procedere di questa da livelli minori a livelli maggiori di penetrazione nelle masse, sorgono necessità organizzative più precise. Il secondo, puramente intellettuale, è in rapporto inverso allo sviluppo della lotta: man mano che diminuisce l’intensità del conflitto, crescono i cavilli e le teorie, si moltiplicano le obiezioni, si acuisce il senso delle contraddizioni.
Naturalmente ciò non significa che l’organizzazione, creata in rapporto alla lotta concreta, non debba avere un’adeguata analisi teorica o non debba tenere presenti i risultati delle analisi delle lotte precedenti. Significa solo che, nei periodi di “stanca” rivoluzionaria, fiorisce l’attività degli intellettuali che si abbandonano alle loro riflessioni personali smarrendo la misura della realtà.
In generale si può affermare che il problema organizzativo diventa problema centrale, solo a condizione che lo sviluppo rivoluzionario della lotta ha determinato nelle masse la coscienza del problema stesso: solo allora i teorici avranno ragione di analizzarne le necessità e le forme di attuazione in dettaglio. Prima di questo momento, tutte le analisi del problema dell’organizzazione avranno una loro validità, ma limitata e circoscritta, e ben difficilmente riusciranno ad avere un’influenza vera e propria sul movimento dei lavoratori in lotta. Più i dettagli teorici si estenderanno, più i cavilli divideranno il movimento, più si allontanerà quella puntualizzazione delle energie dei militanti che può determinare risultati positivi all’interno delle masse.
Prendiamo, ad esempio, la situazione del movimento anarchico italiano. All’interno di esso, in una situazione di quasi totale lontananza dalle lotte concrete degli sfruttati, si dibatte accanitamente il problema organizzativo. Si discute se è utile o non è utile entrare nei sindacati, si discute di responsabilità collettiva o individuale.
La realtà è che il movimento anarchico italiano è tagliato fuori dai sindacati. Invece di vedere la cosa nella sua reale portata, esaminando l’essenza di questo strumento e se valga la pena di costruire dei mezzi organizzativi per entrarvi a far parte o se invece non ci si debba indirizzare verso le lotte autonome degli sfruttati, negando in assoluto la validità del mezzo sindacale perché non idoneo al raggiungimento del fine rivoluzionario; si insiste a teorizzare la validità del sindacalismo. In questo modo la ricerca analitica, il dibattito all’interno dei gruppi, diventano un alibi per nascondere l’effettiva incapacità d’azione. Ci si attiene alla discussione sull’organizzazione quando invece si dovrebbe mettere da parte questo problema e mettersi seriamente a lavorare accanto a quei gruppi di lavoratori che cominciano a prendere coscienza della necessità di una lotta autonoma. In questo modo si corre l’assurdo rischio di costruire fatiscenti organismi para-sindacali, presentarsi nelle lotte autonome degli sfruttati a nome di questi organismi, ed essere accomunati con i sindacati veri e propri per mancanza di una chiara linea di azione.
Lo stesso discorso vale in merito al problema della responsabilità e della divisione dei compiti all’interno dell’organizzazione anarchica. Esistono compagni, ed è la maggioranza, che non svolgono i compiti che si sono assunti all’interno del gruppo, compagni che prima assumono un incarico e poi fanno passare intere settimane senza farsi vedere. Questo comportamento è indice di scarsa responsabilizzazione e, da un punto di vista teorico, va condannato; ma nessuno si chiede veramente se lo scarso impegno del compagno sia dipeso dalla coscienza della vacuità e della superficialità della sua azione? Nessuno si chiede se a un livello di lotta differente lo stesso compagno avrebbe mantenuto lo stesso comportamento? Può essere facile rispondere che chi non s’impegna nelle piccole cose non s’impegnerà nemmeno nelle grandi; ma questa è una concezione borghese della selezione: il bambino che non è bravo a scuola non sarà mai capace di andare avanti nella vita, e con questa scusa si stabilisce una selezione precisa.
In queste condizioni, ci pare impossibile stabilire precetti e codificare norme, firmare patti e sancire accordi federali: tutto si perde nella nebbia della futilità. Moltissimi compagni attivi e dotati sono letteralmente fuggiti dalle nostre organizzazioni per andare in quelle autoritarie, specie fra i giovani che erano venuti a noi dopo il 1968. E non vale affermare che se l’hanno fatto vuol dire che non erano elementi degni di essere anarchici ed è meglio così, che si siano rivelati prima per quello che erano, denunciando magari chissà quali segni premonitori nella loro più o meno lunga permanenza all’interno dei nostri gruppi. Tutti questi fenomeni sono carenze di lotta, carenze di impegno rivoluzionario, ancor prima di essere carenze organizzative.
Posto in questi termini il problema organizzativo diventa problema di prassi e problema teorico. Quest’ultimo aspetto può solo servire ad accelerare la lievitazione del livello coscienziale delle masse e delle stesse minoranze anarchiche considerate come elemento interno alle masse, mai può risolversi in se stesso come problema al di sopra della prassi di lotta, come problema staccato da obiettivi precisi raggiungibili in concreto e non soltanto sognati o fantasticati da speranzosi intellettuali.
Nella lotta è il rivoluzionario anarchico che vede la struttura organizzativa e media il precedente contrasto tra formulazioni arretrate della visione organizzativa del problema rivoluzionario e livelli di lotta sempre più avanzati. In questa mediazione interviene la sua sensibilità, la sua presenza fisica nella lotta stessa, la sua vita nella totale interezza della dedizione alla causa dell’anarchismo. Egli può commettere degli errori, può avere una visione errata, ma il suo lavoro, accanto a quello degli altri compagni, e tutti insieme all’interno della situazione di lotta delle masse, finirà per smussare queste angolazioni fuorvianti e questi errori.
La pluralità delle considerazioni del problema organizzativo è solo apparentemente giustificata dal pluralismo teorico dell’anarchismo. Non è vero che a fianco delle diverse teorie esistano forme diverse di organizzazione della lotta, tutte ugualmente possibili per l’anarchico. Se le diverse teorie prevedono forme e strutture diverse della società futura, secondo diverse condizioni obiettive che si verranno a determinare, esse non prevedono forme e strutture diverse del rapporto col potere: in quest’ultimo caso se una teoria sostenesse un compromesso col potere, una forma di partecipazione al potere, finirebbe automaticamente per negarsi in quanto teoria anarchica.
La crescita del movimento anarchico non è separata dalla crescita della coscienza rivoluzionaria nelle masse. Se anche a livelli di coscienza ristretti esiste sempre una minoranza specifica, ciò è dovuto al fatto che certi individui hanno avuto particolari privilegi (economici e morali, oggettivi e soggettivi) e che usano questi privilegi per porsi contro uno stato di cose accettato dalla maggioranza delle persone. Ma quando il processo rivoluzionario è avviato verso la sua naturale crescita, cioè verso il progressivo aumento dei livelli di lotta, allora lo sviluppo della presa di coscienza delle masse è fatto essenziale alla stessa continuazione del processo rivoluzionario. In queste condizioni le chiarificazioni organizzative s’impongono automaticamente. I tiepidi, gli indecisi, coloro che non sanno mantenere le proprie responsabilità, gli intellettuali dilettanti della rivoluzione, restano a casa di fronte alla paura della repressione: una naturale selezione facilita l’orizzonte organizzativo e le cose si chiariscono.
Si potrebbe obiettare che la presa di coscienza delle masse non è fenomeno che procede necessariamente in misura parallela alla situazione economica e sociale nella sua totalità, cosa quest’ultima che influenza grandemente il livello di lotta. Certo, tra i due fatti esiste sempre una differenza che può influire sulle forme concrete che il movimento anarchico può scegliere di volta in volta per inserirsi nel vivo delle contraddizioni che questo sviluppo determina; ma, in ogni caso, non vi potranno mai essere scompensi tali da consentire e rendere valida o accettabile un’astratta teorizzazione organizzativa, magari basata sulla considerazione esclusiva delle condizioni economiche e sociali di un dato momento storico.
Se le crisi che il capitalismo affronta, e via via risolve, sono un fatto legato alle condizioni della sua struttura economica e sociale, l’azione delle masse sfruttate può rendere sempre più difficile questa prospettiva di risoluzione, fino a determinare sbocchi rivoluzionari più maturi e più completi, dalle prime fasi della rivoluzione economica alle ultime fasi della rivoluzione sociale. Ora, l’azione consapevole degli anarchici può spingere questo processo verso la rivoluzione sociale, solo a condizione che la loro struttura come strumento attivo e non solo come mera componente ideologica, sia in grado di mantenere costantemente il rapporto col continuo evolversi dei livelli di lotta delle masse. Ogni disarmonia in questo contatto ha come risultato immediato l’isolamento degli anarchici, la facile vittoria degli schieramenti autoritari, la sconfitta sostanziale della rivoluzione.
Un rapporto preciso lo possiamo individuare, in merito a quello che abbiamo detto, nella compresenza, all’interno delle lotte, dei sindacati. Questa compresenza assume carattere di grande pericolosità sia nella fase prerivoluzionaria che in quella immediatamente successiva alla rivoluzione.
Se l’avvenimento rivoluzionario è stato un fatto pilotato da un partito e realizzato a seguito dell’azione di una minoranza ben organizzata militarmente, capace di trascinare le masse ma di togliere nello stesso tempo fiato a ogni iniziativa spontanea di queste ultime; l’azione dei sindacati può essere solo quella di consegnarsi armi e bagagli al partito rivoluzionario e, con questo, di consegnare i lavoratori nelle mani della nuova classe dirigente e sfruttatrice.
Se la rivoluzione è stata un fatto eminentemente burocratico, una crisi del potere a livello centrale, come nell’Ungheria dei Consigli, i sindacati si autodefiniscono il potere in prima persona e garantiscono il passaggio senza danni delle strutture di produzione allo Stato, avendo cura di smussare ogni tentativo originale e spontaneo delle masse verso una liberazione definitiva.
Se sono, infine, i lavoratori, spontaneamente, come in Russia, in Germania, in Italia, a prendere l’iniziativa, a costituire le loro organizzazioni di base, i loro consigli, e a dichiarare guerra alla struttura di sfruttamento, i sindacati passano immediatamente dalla parte del potere e cercano di negoziare con quanto meno danno possibile il passaggio alla successiva fase di normalizzazione e di centralizzazione. In una ulteriore fase di accentramento, come accadde in Russia al momento del debutto stalinista, saranno gli stessi sindacati a perdere terreno davanti al partito.
È indispensabile, quindi, che le minoranze anarchiche tengano presente il rapporto sindacati-masse, allo scopo di chiarificare tempestivamente l’evoluzione del ruolo sindacale riguardo l’integrazione del potere. Nello stesso tempo, è indispensabile che l’azione concreta e la stessa organizzazione delle minoranze anarchiche si adegui allo svolgimento del rapporto suddetto, ponendosi come elemento alternativo ed elemento di spinta delle organizzazioni autonome dei lavoratori, dirette a costruire l’autogestione delle lotte e della produzione.
Certo non è possibile prevedere la situazione dell’economia durante e dopo la rivoluzione. Fatti di grande importanza entrano in gioco al momento della crisi decisiva, fatti di minore importanza, ma altrettanto determinanti, restano agenti all’interno dell’intero sistema, in modo tale da rendere velleitaria ogni pretesa analitica di grande approssimazione. Non è possibile fare un programma dettagliato, ma è possibile vedere alcune cose con chiarezza. La presenza del controllo statale è un fatto negativo, esso è obbligatoriamente portato a determinare le condizioni sociali perché si metta in atto un’economia pianificata in un certo modo. Al contrario, l’economia postrivoluzionaria dovrà necessariamente essere un’economia naturale, nella quale sia la produzione che la distribuzione verranno assicurate in base ad accordi orizzontali tra produttori e consumatori.
Il problema contabile
Non separato dal problema organizzativo della lotta rivoluzionaria e della futura organizzazione postrivoluzionaria, è il problema dell’assetto contabile da dare all’economia socialista autogestita, una volta distrutta l’attuale alleanza controrivoluzionaria.
Difficilissimo trovare una “unità di misura” per regolare, in situazione postrivoluzionaria, la produzione e la distribuzione comunista. Una volta risolto, questo problema consentirebbe di far cadere l’uso della moneta e di eliminare tutte le conseguenze della presenza di quest’ultima. Allo stesso modo cadrebbe il mercato dei prezzi e gli scambi verrebbero fissati su di una base diversa.
Marx ha lasciato alcune indicazioni, molto importanti, sulla possibilità di operare questo passaggio sulla base del tempo di produzione dei diversi prodotti. Ma, al solito, il suo ragionamento risulta scarsamente utilizzabile (al di là del dato tecnico in se stesso) a causa della presenza del costante riferimento all’organizzazione statale “in via di indebolimento”.
Si tratta di un contrasto molto importante. Data l’esistenza della dittatura del proletariato, e concessa pure la tendenza alla sua progressiva eliminazione, ne consegue che il passaggio da un’economia di mercato a un’economia autogestita deve seguire il progressivo indebolimento suddetto, cioè deve restare soggetta alle vicende politiche di una classe dirigente che, in quanto tale, non ha certo fretta di cedere il comando. Il tutto si trasforma in una lotta tra forze popolari che vogliono creare la nuova organizzazione di produzione e distribuzione, e forze antipopolari che vogliono ritardare questo processo.
Da qui l’impossibilità di utilizzare il discorso marxista. Accanto ai nuclei di organizzazione autonoma dei lavoratori, nella dimensione capitalista è possibile individuare un processo di concentrazione e centralizzazione del capitale: i marxisti preferiscono mettere l’accento su quest’ultimo fenomeno, mettendo da parte il primo. In questo modo si precludono la strada alla stessa applicazione della tesi di Marx riguardo l’organizzazione dei produttori liberi e uguali.
In ogni caso sono contraddizioni interne allo schieramento marxista che qui ci interessano fino a un certo punto. Che la futura organizzazione della produzione e della distribuzione debba avvenire in forma diversa da quella che essa assume nell’economia di mercato, è un fatto da cui dipende il futuro stesso della rivoluzione.
Abolendo il mercato “libero” capitalista, sorge il problema di trovare un’unità di misura che possa risolvere il difficoltoso conteggio sulla base quantitativa delle merci prodotte e impiegate nella produzione. Questa unità di misura non e più il prezzo, perché occorrerebbe o il “libero” mercato capitalista o un centro incaricato di gestire l’economia nella sua totalità. Deve quindi essere un’altra cosa. Può essere, secondo l’ipotesi di Marx, il tempo di produzione, ma, in un’economia veramente comunista, può anche mancare del tutto.
La formula proposta dal “Gruppe Internationaler Kommunisten Hollands” (G.I.K.H.) è la seguente: “Mezzi di produzione” ± “materie prime e sussidiarie” ± “forza lavoro” = “Prodotto”. Calcolando in ore lavorative tutte le componenti della formula si ottiene il prodotto rapportato in ore lavorative. Da ciò la necessità di una contabilità sociale generale che dia il riassunto ideale del processo economico e che costituisca un controllo veritiero della base su tutto il processo stesso. Problemi di carattere particolare vengono affrontati riguardo le aziende pubbliche (cioè quelle che non danno un “prodotto” nel senso normale del termine), ad esempio le università.
Partendo sempre dalla suddetta formula si ottengono sia i costi della singola fabbrica, che quelli del singolo settore e, da questi, i costi dell’intera produzione. Tutto procede così senza la necessità di un controllo dall’alto e senza che si possa sostenere l’impossibilità di un’economia autogestita direttamente dalla base.
A parte i problemi e le limitazioni che sorgono da questa proposta contabile, la prima condizione perché essa possa avere un funzionamento ragionevole è che la produzione e la distribuzione comunista vengano organizzate senza alcun intervento da parte dello Stato o di un qualsiasi altro organo centrale. Le unità produttive di base, i nuclei di produzione, i gruppi autonomi, i consigli, o come li si voglia chiamare, devono esercitare in proprio quell’attività di spegnimento della controrivoluzione che i marxisti insistono nell’assegnare allo Stato.
Da per se stesso un sistema contabile fondato sul tempo di lavorazione va incontro ad alcune difficoltà che bisognerà risolvere.
Un importante problema è costituito dal fatto che una volta impiantato il sistema di calcolo della produzione sulla base del tempo sociale medio, bisognerà adeguare tutto il settore produttivo all’azienda che produce a costi medi minori, cioè che produce con una combinazione più vicina alla media del lavoro sociale per tutto il settore. Si tratta però di una visione troppo scheletrica della realtà economica che non è esente da alcuni preconcetti tipici del capitalismo, fra cui quello della produttività. In questo modo lo sviluppo complessivo delle lotte operaie resta legato a specifiche condizioni ambientali e non riesce a superarle, non riesce cioè a porsi problemi relativi alla produttività del lavoro che oggi ci sembrano fondamentali e che, a un certo livello, sono molto avvertiti.
Come dicevamo, è in questo senso che si debbono sottolineare, parlando dell’autogestione, i problemi connessi all’automazione, all’informazione, ai miglioramenti tecnici. Dalla loro analisi deriveranno profonde trasformazioni per le tecniche contabili come quella suddetta, anche se non le renderanno del tutto inutilizzabili. Abbiamo quindi una prospettiva sociale di sviluppo industriale con progressiva sostituzione dell’industria quantitativa in industria sociale qualitativa, diretta a soddisfare consumi sociali. Non sappiamo fino a che punto, in questa direzione, si possa ancora arrivare a riformulare, con dati nuovi, la tesi della “presa nel mucchio”. Certo che il problema della riduzione della “forza lavoro”, nella stessa equazione vista prima, anche permanendo termini quantitativi che comunque andranno rivisti, lascia aperta la problematica dell’accelerazione dell’accumulazione sociale, sostituente l’accumulazione capitalista allo scopo di provvedere a tutte quelle trasformazioni necessarie perché si possa veramente parlare di comunismo in concreto.
È qui il punto più interessante del problema: questo processo di accumulazione sociale può essere spinto fino a garantire un enorme successo di produttività e dentro un tempo ragionevolmente breve. Al contrario, nel settore delle relazioni e dei rapporti fra gli uomini, si potrebbe verificare il cristallizzarsi di una struttura diretta a regolare dall’alto (cioè a rallentare) il processo stesso per scopi ben diversi dagli obiettivi comunisti. Ancora una volta il primo e unico problema, condizionante la stessa “logica” di una contabilità sociale immune dal cancro monetario, è la soppressione di una gestione centralizzata.
[Per questo paragrafo cfr. la mia recensione a: Gruppo Comunisti Internazionali Olandesi (G.I.K.H.), Principi fondamentali di produzione e distribuzione comunista, tr. it., Milano 1974, in “Anarchismo” n. 3, 1975, pp. 178-181]
Sull’organizzazione autonoma del proletariato
Le difficoltà che il capitale incontra nei processi di razionalizzazione dello sfruttamento, difficoltà che non sono solo quelle dell’abbassarsi del tasso di profitto, ma sono anche di natura più complessa, specie adesso che il processo di produzione sta esaurendo le ultime risorse del consumismo tradizionale, producono quei periodi di crisi che sollecitano le speranze proletarie della liberazione definitiva.
In questi ultimi anni, la crisi del capitalismo in Italia è stata analizzata in tutti i sensi, si è cercato di vedere i rapporti che il capitalismo italiano ha con le altre economie e le presenze delle multinazionali al suo interno, come segno di questi rapporti. Si è cercato di capire il perché del rompersi di alcuni equilibri che parevano rassodati da decenni di politica internazionale, si è cercato di preparare il proletariato ad affrontare l’acutizzarsi della crisi suggerendo una prospettiva di sacrifici a favore dei padroni.
Le lotte all’interno delle fabbriche, segnatamente all’inizio degli anni settanta, hanno fatto comprendere alla borghesia revisionista che il primo colpo andava portato all’interno della stessa struttura produttiva, costruendo tutte quelle forme di intervento necessarie a spezzare un probabile raccordo tra le lotte operaie e le lotte degli strati tagliati fuori dalla salarizzazione. Questa strategia è stata operata ricorrendo a un massiccio uso delle organizzazioni che una volta rappresentavano gli interessi propri dei lavoratori – PCI e sindacati – e giocando, prima sull’equivoco, poi sul conseguente riflusso e sulla stanchezza del proletariato.
Fissando un più rigido cordone sanitario attorno alla salarizzazione, provvedendo a un processo di criminalizzazione più duro nei confronti dei ghettizzati, dei disoccupati e dei “diversi” in genere, la borghesia revisionista italiana si è preparata ad affrontare lo scontro futuro, e le eventuali conseguenze dell’acutizzarsi della crisi, sostenendosi su una parte del proletariato, allo scopo inquadrato da partiti riformisti e sindacati.
Resta da vedere se questo progetto potrà passare in forma piena o troverà delle difficoltà, in quanto è fuor di dubbio che i bisogni dei proletari sono là e nessuno schema ideologico e nessun discorso mistificante potrà cancellarli del tutto.
Proprio per far fronte all’insorgere violento della necessità di soddisfare questi bisogni, la borghesia italiana non può non rafforzare lo Stato e le sue istituzioni, dandogli quella verniciatura democratica che oggi è più o meno un gioco di parole per nascondere la raffinatezza della nuova repressione. I cosiddetti uomini di “sinistra”, avendo ormai ceduto armi e bagagli alla borghesia ogni residua velleità rivoluzionaria, si battono per un rafforzamento dello Stato, che poi, una volta effettuato il cambio tra i vecchi padroni e i nuovi, inquadrati nella burocrazia degli automi stupidi del PCI, sarà il loro Stato. Quindi, questa operazione tornerà utile a loro doppiamente: prima per garantire un passaggio indenne (così almeno loro credono) a una situazione meno burrascosa della presente, poi per trovarsi tra le mani uno strumento di repressione meglio organizzato e più produttivo per i loro scopi.
In questa prospettiva, ogni cenno all’autonomia della classe proletaria è considerato come un’eresia. Lo stesso concetto di lotta di classe sembra svanire nel gioco di parole degli esegeti della chiesa revisionista, mentre un gran da fare si danno gli stupidi chierici delle università (dove il verbo marxista dilaga con la classica cocciutaggine dei neofiti imbecilli), per vestire queste operazioni con un minimo di credibilità teorica.
Ancora una volta, pur cambiando il linguaggio e le formule, è il capitale che comanda ed è l’intellettuale al servizio del capitale, che esegue gli ordini senza farsi tante domande purché trovi qualcosa nel piatto.
Al contrario, il movimento generale degli sfruttati, pur confusamente, nel momento stesso che avverte i propri bisogni, avverte anche che qualcosa non va nelle formule classiche della difesa degli interessi della classe.
Avverte pure che non ci si può più affidare a partiti, sindacati e forme del genere, in quanto ormai chiaramente al servizio dei padroni.
Occorre costruire, di sana pianta, nuovi strumenti, per combattere nuove lotte, in forme nuove, forme capaci di denunciare il tradimento e di costruire un progressivo avvicinamento alla liberazione.
Per questo motivo, l’insieme del movimento, ferme restando le sue varietà e i contrasti che ospita, ha proposto un alleggerimento delle tradizionali analisi sulla “situazione” attuale, sullo scontro delle forze, e sulla valutazione di quello che di positivo c’è nelle contraddizioni interne al capitale stesso. Ha deciso che tutto questo patrimonio analitico, adesso, deve essere superato, se non si vuole, ancora una volta, arrestare l’azione, e consegnare il movimento stesso agli avvoltoi recuperatori.
Alle analisi stantie sulla situazione attuale, bisogna sostituire le aperture reali alla lotta, nella concretezza del territorio, aperture basate sull’azione diretta, sull’autonomia.
Una metodologia di lotta fondata sull’autonomia del proletariato ha necessariamente caratteristiche antiistituzionali e antistatali.
Primo, perché la componente di fondo è data da quella parte della classe che ha subito di già il processo di ghettizzazione e di criminalizzazione; poi perché l’unico sbocco di questa parte della classe proletaria è solo la distruzione del capitale, non la sua sistemazione a livelli di maggiore razionalizzazione.
Il capovolgimento delle prospettive tradizionali, si coagula, quindi, nel rifiuto di battersi per inviare rappresentanti al parlamento, nel rifiuto di accettare controlli gestiti dall’alto, nel rifiuto dei moduli di comportamento dettati dal capitale. La lotta, pertanto, prende una strada diversa. Gli interessi proletari, nell’ambito dell’autonomia, indicano impegni di lotta più inerenti al territorio e sempre più lontani dalle zone di potere che vedono solo il gioco dei riformisti e quello del capitale.
Lo scontro avviene sul territorio, da dove nasce un movimento autonomo di distruzione delle forme di potere, a loro volta distribuite sul territorio, anche le forme di potere più periferiche, quelle che sembrano le più innocue (centri di produzione, settore distribuitivo, commercio, rapporti internazionali, informazioni, burocrazia, strutture sindacali e partitiche e così via). La lotta viene condotta, quindi, con interventi diretti a colpire questa distribuzione di potere sul territorio, per eliminarla o metterla in crisi, e per costruire i rapporti autonomi, sempre sul territorio, rapporti, per quanto possibile, liberati dall’oppressione che quelle forme di potere territoriale rendevano costante e insopportabile.
Questa decisione della classe proletaria non è stata imposta da nessuna analisi teorica, non è stata accettata attraverso una illuminazione di tipo ideologico. Il ragionamento è stato molto semplice, quasi elementare. Poiché i bisogni reali non vengono soddisfatti da quelle strutture classiche di difesa dei proletari, ma anzi queste strutture rappresentano ormai solo gli interessi dei padroni, allora occorre che si provveda diversamente, attraverso una forma di organizzazione autonoma. Ma questa forma non potrà mai assumere la pretesa di agire sul controllo di potere centrale, non potrà cioè mai diventare un partito o qualcosa che gli somigli, deve pertanto restare una struttura che agisce sul territorio e che si mantiene in rapporto con altre strutture che anche loro agiscono sul territorio.
Se un’origine va ricercata alla presente spinta verso l’autorganizzazione agente all’interno del movimento degli sfruttati, questa deve individuarsi nella pratica dei nuovi bisogni che si sono ormai delineati con chiarezza. Le lunghe lotte degli anni passati non sono state inutili, hanno segnato le caratteristiche di un comportamento che sta, sia pure con non poche difficoltà, estendendosi a macchia d’olio. Il rifiuto del lavoro, l’assenteismo, l’impiego del sabotaggio, l’attacco contro i tentativi di ristrutturazione del capitale, la richiesta del salario garantito generalizzato [1974], si riassommano in una pretesa sempre più dettagliata, avanzata dal movimento degli sfruttati, di incidere a livello di gestione, sul territorio, pretendendo imporre un nuovo processo di ricomposizione, di crescita e di sviluppo delle difese di classe.
Questo andamento ha caratteristiche di massa che non negano, però, una corretta pratica per le minoranze antiautoritarie. Sarebbe, pertanto, contraddittorio l’intervento dei vecchi ruderi stalinisti, e difatti non per nulla costoro sono costretti, se vogliono farsi ascoltare, a camuffarsi sotto nuove spoglie, parlando una lingua biforcuta, utilizzando le parole d’ordine dell’autonomia proletaria e insistendo (ma sapientemente) sulle loro vecchie passioni di partito. Ma una pratica antiautoritaria è possibile. Non si tratterebbe di una “sostituzione” nei confronti della struttura di autorganizzazione che sta lentamente formandosi, ma piuttosto della proposizione di comportamenti, in dettaglio, che la struttura generale del movimento potrebbe avere maggiori difficoltà a reperire da sola.
Vediamo di spiegarci meglio. L’andamento generalizzato verso l’autonomia proletaria, cioè verso l’autorganizzazione del contropotere sul territorio, delle lotte contro il potere, della gestione quotidiana della vita e così via, si riassume in un comportamento (spessissimo illegale e antiistituzionale) che potrebbe trovare difficoltà a elaborare, nello specifico di una situazione, le condizioni migliori d’intervento. In questo caso, la minoranza antiautoritaria, potrebbe (diciamo potrebbe in quanto la cosa va vista con cautela e sempre sottoposta ad autocritica), potrebbe, diciamo, realizzare, anche se in piccolo, certi modelli d’intervento che, poi, potrebbero diventare di larga diffusione all’interno del movimento nel suo complesso.
Ma questa minoranza deve eliminare il pericolo di porsi e considerarsi come “punto di riferimento politico” del movimento stesso. In sostanza, il punto di riferimento politico del movimento è il movimento stesso, in quanto le analisi che svolge come le azioni che realizza, sono intimamente legate e, nel loro insieme, rappresentano l’indicazione politica necessaria, senza bisogno di ulteriori approfondimenti o di specialisti che si mettano al lavoro in separata sede.
Questo, però, non significa che il movimento nel suo insieme sia omogeneo e quindi proponga un’indicazione politica uniforme. Prima di tutto, all’interno del movimento ci sono settori che subiscono in forma differenziata la repressione, per cui emergono quei settori più criminalizzati e sfruttati, capaci di fornire indicazioni più avanzate, poi c’è il fatto contraddittorio del “consenso” che tutti i settori del movimento degli sfruttati, chi più chi meno, forniscono.
Questa composizione così varia dà un’indicazione a quelle minoranze antiautoritarie che agiscono all’interno del movimento, che si può riassumere nel garantire quel contatto tra i vari settori del movimento stesso, evitando l’isolamento e la ghettizzazione, ed evitando che il potere riesca nel suo progetto di mettere gli sfruttati gli uni contro gli altri.
[Per questo paragrafo, cfr. il mio articolo: “Sull’organizzazione autonomia del proletariato”, in “Anarchiamo” n. 23-24, 1978, pp. 252-254]
Autogestione e dominio reale del capitale
Dibattito sull’autogestione con “Tribune Anarchiste Communiste”
1. Il problema dell’autogestione non è soltanto un problema tecnico, di come assicurare il funzionamento della produzione prima, durante e dopo la rivoluzione. È un problema più complesso, che coinvolge la stessa dinamica del processo rivoluzionario. Studiare possibili modelli autogestionari senza collocarli nella loro posizione rivoluzionaria non significa nulla dal punto di vista della liberazione.
Chiedersi che cos’è l’autogestione significa chiedersi quali sono le possibilità di funzionamento di una società affidata nelle mani dei produttori ma, nello stesso tempo, significa chiedersi quali sono le possibilità di autogestire le lotte nel momento attuale, di fronte allo sfruttamento e al genocidio.
In primo luogo autogestione della lotta, dopo autogestione del lavoro e della società.
Se l’autogestione deve servire al produttivismo statale, siamo contro di essa; se deve servire come strumento per ingannare ancora una volta i lavoratori, siamo contro di essa; se deve servire come alibi per un partito per fissare la sua egemonia sulle spalle delle masse, siamo contro di essa.
2. La rivoluzione la fanno le masse perché sono costrette in una situazione di sfruttamento, di progressiva perdita di ogni aspetto positivo della vita sociale. Il movimento di massa si sviluppa sul deterioramento delle condizioni economiche, sociali e culturali che resero possibile la gestione precedente. L’opera di spinta e di chiarificazione esercitata dalle minoranze agenti, si inserisce in questa struttura contraddittoria, sollecitando le forze autonome presenti nelle masse, spingendole a costruire i rudimenti di quell’organizzazione autogestionaria che partendo dalla lotta consentirà il formarsi dell’autogestione totale futura attraverso il fatto rivoluzionario autogestito.
3. Nella fase calante del consumismo, sviluppandosi la logica delle multinazionali, il potere economico mondiale potrebbe utilizzare su grande scala il modello autogestionario di tipo jugoslavo. Il danno di una soluzione di questo tipo sarebbe grandissimo per il movimento degli sfruttati. Attirato nell’equivoco, accetterebbe la gestione delle imprese di produzione (soltanto di quelle più facilmente controllabili, mai di quelle fondamentali come le banche o le società finanziarie, le ferrovie o le linee di navigazione) facendo persistere il controllo da parte di un centro burocratico-politico, nelle mani dei dirigenti di un partito, di tecnocrati al servizio di un capitale reso assolutamente anonimo o di un qualche capo carismatico di nuovo conio.
Solo l’aspetto esteriore resterebbe della prospettiva autogestionaria. Gli operai, sotto le direttive fondamentali del centro programmatore, autogestirebbe il proprio sfruttamento. Gli scioperi, tanto per fare un esempio, sarebbero impensabili quando non condannati in modo specifico. In questo modo, autogestione sarebbe sinonimo di militarizzazione della produzione.
4. Per porsi nella prospettiva autogestionaria il lavoratore deve per prima cosa collocarsi contro le strutture attuali di collaborazione allo sfruttamento padronale. Queste sono: a) i partiti, compresi quelli che si definiscono di sinistra e si considerano detentori della tradizione rivoluzionaria, b) i sindacati, compresi quelli che si richiamano alle dottrine del sindacalismo rivoluzionario e dell’anarcosindacalismo.
La presenza di questa triplice alleanza: padroni, partiti e sindacati, obbliga l’operaio, il lavoratore in genere, a costruire le basi della propria autonomia, a conquistare gli elementi essenziali che rendono possibili i primi passi verso l’autogestione. Non siamo davanti a un vero e proprio avanzamento del livello della lotta, quanto a un salto qualitativo che cerca di attaccare l’alleanza antioperaria realizzata dalle forze della reazione e dai loro collaboratori. È la situazione di classe nel suo complesso che viene posta in causa e presa nuovamente in esame, L’autonomia operaia è il primo passo verso l’autogestione.
5. Altra fase essenziale nella prospettiva autogestionaria è il recupero della capacità creativa del lavoratore. Il sistema capitalista, fondandosi sulla proprietà privata dei mezzi di produzione, non rende possibile l’impegno creativo di questi mezzi da parte del lavoratore. L’attività di produzione è quindi distorta e produce il fenomeno dell’alienazione; la produzione sfugge al lavoratore, il suo è un vero e proprio lavoro forzato.
Ma la capacità creativa dell’uomo lavoratore può essere recuperata solo recuperando la disponibilità completa del prodotto, cioè applicando un processo rivoluzionario di riappropriazione nel momento in cui si realizza il processo reazionario di sfruttamento. La “rivoluzione nel lavoro” è quindi organizzazione autogestionaria della rivoluzione e contemporanea organizzazione autogestionaria di quei primi elementi della società futura che sono i “nuclei produttivi di base”, che, a loro volta, escono dall’autonomia delle lotte.
6. L’informazione è l’elemento chiave del modello di sfruttamento del futuro. La fase di crisi del consumismo imperialista può essere superata con l’attuazione di una vasta ammissione cogestionaria attuata attraverso un dominio assoluto sull’informazione. Ogni forma di controinformazione, ogni deviazione dai dati forniti dal centro dirigente deve essere accuratamente esclusa. L’applicazione di quella che si chiama “censura preventiva” deve consentire la globalizzazione del processo, il frantumarsi dell’unità della classe lavoratrice, l’eliminazione degli strati inutili (controli, segnatempi, ecc.), la ghettizzazione di alcuni strati produttivi intermedi (impiegati amministrativi, ecc.).
In questa strategia reazionaria l’elemento di lotta, che si inserisce perfettamente nella prospettiva autogestionaria, è la “conquista dell’informazione”. La classe lavoratrice organizza in proprio e partendo dalla base la formazione, l’elaborazione e l’interpretazione dell’informazione, rifiutando ogni intermediario che funzioni da filtro, cominciando naturalmente, in primo luogo, dai sindacati.
7. La prospettiva autogestionaria comincia a delinearsi attraverso i punti essenziali che abbiamo elencato: a) autonomia operaia, b) recupero della capacità creativa, c) conquista dell’informazione. Resta da vedere in che modo tutto questo può avvenire, cioè se per germinazione spontanea all’interno del movimento dei lavoratori a causa del verificarsi di certe modificazioni strutturali; oppure se per intervento preciso, specifico, programmato, di una minoranza agente.
L’azione di una “minoranza anarchica” all’interno delle masse si inserisce, a nostro avviso, nella prospettiva autogestionaria in modo ottimale. Non si tratta di una ipotesi di “guida” che, in ogni caso, finirebbe per ripetere i programmi della socialdemocrazia; ma si tratta di un’azione interna al movimento stesso dei lavoratori, un’azione che cerca di coordinare l’organizzazione autonoma in funzione degli interessi dei lavoratori stessi, un’azione che salvaguarda l’autonomia del singolo nella dimensione dell’autonomia della classe.
8. Ora, la presenza di una minoranza anarchica all’interno delle masse coinvolge la scelta degli strumenti di lotta, fissandola in un certo senso. Si attaccano i partiti riformisti e interclassisti, ma non per questo dalla loro prospettiva dirigista si cade nel più vieto spontaneismo. Il punto di riferimento sono gli “interessi” dei lavoratori e questi ultimi devono riconoscerli come tali in quanto non sempre un certo svolgimento della struttura rende possibile un “riconoscimento automatico”, basato esclusivamente sul fatto economico. Ad esempio, una lotta per un aumento salariale, condotta dai sindacati, non sempre riguarda interessi della classe lavoratrice, può riguardare interessi “apparenti” ma non sostanziali; al contrario può riguardare interessi “effettivi” della classe degli sfruttatori. Comprendere questo è il fondamento necessario all’autogestione delle lotte e, quindi, della ferma stabilizzazione della prospettiva autogestionaria.
La scelta dei mezzi di lotta, ad esempio: l’azione diretta, il sabotaggio, la distruzione del lavoro, comporta un processo di chiarificazione e di individuazione dei “veri interessi” della classe lavoratrice, lavoro che non può essere negato da una malfondata visione volontaristica del fenomeno.
La presa di coscienza dei propri interessi è la condizione più importante per la realizzazione della rivoluzione sociale.
9. Le formule di lotta del passato: cooperative, consigli di fabbrica, comitati di base, comitati di settore, ecc., nella maniera in cui sono state sperimentate in situazioni storiche passate e in altre condizioni dei rapporti di produzione, devono essere sottoposte a una severa analisi.
In sostanza, il limite di queste formule è dato dalla persistenza della gestione capitalista della società. Il lavoratore deve analizzare con esattezza l’influsso negativo che questa situazione alienante determina su strumenti che presi in se stessi contengono elementi validi di cooperazione e autogestione. Per esempio, le cooperative potranno produrre – così come sono oggi organizzate – solo l’alimentazione di uno spirito autarchico e corporativo, spirito negatore della lotta di classe e di ogni sentimento di solidarietà. Chi ragiona diversamente, chi si illude che dalle cooperative possa uscire il germe della società futura, il muto appoggio a beneficio di tutti, si illude in quanto attribuisce al capitalismo non solo una componente tecnologica da utilizzarsi (insieme dei mezzi produttivi), ma anche una componente psicologica autogestionaria che, a nostro avviso, non esiste.
10. Il passaggio dal momento pre-rivoluzionario alla rivoluzione e, quindi, alla costruzione della società nuova, non potrà avvenire in modo immediato e brusco, senza che nella prima fase non si sia provveduto a costruire i primi elementi di una struttura di lotta autogestita. L’autogestione precede la rivoluzione, non la segue come fatto automaticamente necessario. La precede nel senso in cui l’autogestione non è fatto meramente tecnico e produttivo, ma è fatto universale e, più specificamente, fatto di lotta.
Se si considera l’autogestione sotto l’aspetto produttivo soltanto, si è tentati di realizzarla separatamente dalla contemporanea autogestione delle lotte, avendosi come conseguenza la delega della lotta a un corpo specifico (braccio militare del proletariato) o a un partito specifico (partito dei lavoratori) o a una precisa minoranza di governo (democrazia in genere). Il capitalismo è fortemente interessato a questa scelta del movimento operaio ed è proprio in questa direzione che preme con tutti i mezzi, in modo particolare con un impiego massiccio dell’informazione. Non bisogna cadere nella trappola.
Inserendo nella prospettiva autogestionaria il momento dell’organizzazione della lotta accanto al momento dell’organizzazione della produzione, le forze reazionarie e capitaliste vengono automaticamente espulse dal campo d’azione del movimento dei lavoratori. Infatti, il capitale non potrà mai gestire una lotta condotta dai lavoratori in forma autonoma, gli strumenti che di solito impiega (partiti e sindacati) risultano inutilizzabili in questo caso.
11. Il progetto rivoluzionario si basa sul rapporto esistente tra produttore e prodotto. In questo rapporto si inseriscono tutti gli altri elementi che l’affermano e lo modificano nello stesso tempo senza riuscire a trasformarlo in modo radicale. È chiaro che questo rapporto deve essere ugualitario, cioè a ciascuno secondo i suoi bisogni e da ciascuno secondo le sue possibilità; deve essere gestito dalla base, altrimenti non sarebbe ugualitario; e deve tendere all’abolizione del meccanismo del mercato che deforma bisogni e aspetto finanziario della produzione.
Con l’autogestione della lotta, organizzata dal basso tramite piccoli nuclei produttivi di lavoratori che attaccano i centri dello sfruttamento, si pone in atto una “palestra di coesione” per lo sviluppo ulteriore del conflitto, sviluppo che attraverso la conquista dell’informazione, arriverà alla definitiva espropriazione del capitale, cioè al fatto rivoluzionario.
Lottare per l’autogestione e l’indipendenza dell’organizzazione di lotta, significa battersi, nello stesso tempo, per l’indipendenza nell’organizzazione della produzione. Ogni distinzione in merito non è possibile.
12. La prospettiva autogestionaria deve oggi essere accuratamente costruita evitando tutti gli errori inerenti a una “separazione” tra autogestione della lotta e autogestione della produzione. I primi a essere interessati a questa separazione sono proprio i capitalisti. Separando l’autogestione della lotta dalla sua logica conseguenza (l’autogestione della produzione), si ottiene il grosso risultato di stancare le minoranze coscienti del proletariato, lasciandole di fronte a uno scontro che, proprio perché privo di sbocchi, finisce prima o poi per adagiarsi nella prospettiva “comoda” suggerita dai partiti e dai sindacati. Separando l’autogestione della produzione dalla sua logica premessa (l’autogestione della lotta), si ottiene un altro grosso risultato per il capitale: lo svuotamento del significato rivoluzionario dell’autogestione, l’incremento della produzione, il ritorno del profitto, la salvezza delle istituzioni, la classe dei lavoratori un’altra volta nel tranello dei partiti e dei sindacati.
Unità dei lavoratori nell’autonomia delle lotte, unità della prospettiva autogestionaria, unità del processo rivoluzionario e del processo produttivo. Questi sono, a nostro avviso, i punti essenziali di ogni corretta analisi sull’autogestione.
[Pubblicato a firma “La redazione di ‘Anarchismo’” in “Anarchismo” n. 13, 1977, pp. 1-4].
Intervento di “Tribune Anarchiste Communiste”
I compagni di “Anarchismo” insistono in tutti i modi per spiegare che l’“Autogestione” è una società globale e non un semplice modo di produzione. In questo senso, è utile ritornarvi e, benché formulato in maniera maldestra, è necessario denunciare coloro che si servono del termine per ricoprire l’egemonia del loro partito che prenderà domani il potere, cioè lo Stato. Si vede che i mistificatori del genere Mitterand esistono anche in Italia.
Di contro, la condanna senza appello del “modello” jugoslavo porta ad alcune riserve. Abbiamo già discusso su questo problema: ci vediamo costretti a ritornarvi.
Non si tratta di truffe sociali democratiche ma di una società che “esiste”, la sola società autogestionaria del mondo che dimostra come il sistema sia possibile, e ciò non è poco ai nostri occhi. Da parte nostra, discutiamo della Rivoluzione che esiste, dell’Autogestione che esiste e non rigettiamo sistematicamente (attitudine della “sinistra”) le realtà, i contesti che non corrispondono assolutamente ai nostri libri e alle nostre teorie anarchiche che molto spesso sono “a priori”.
Ora, l’Autogestione jugoslava si evolve verso una concezione globale della società e non è affatto “solo” gestione di imprese. Coloro che ci leggono da tempo lo sanno per via dei numerosi documenti che abbiamo pubblicato. Esiste in Jugoslavia una democrazia diretta che ha per cellula la Comune di base ed è in questo quadro che si inserisce la gestione delle imprese. Ma, se abbiamo detto che l’Autogestione non è un semplice modo di produzione, essa è “anche” un modo di produzione.
Per contro sappiamo che il Socialismo jugoslavo è fortemente handicappato dalla sua partenza. L’autogestione vi ha trionfato ma è stata “concessa” da uno Stato e da un partito di tipo leninista. L’evoluzione vi è stata e abbiamo modo di pensare che lo Stato è liquidato progressivamente, ciò non significa che non vi sia la resistenza della tecno-burocrazia.
Non dispiaccia ai nostri amici italiani, parecchie imprese fondamentali sono già autogestite. Vi ritorneremo...
Non si può credere che il sistema jugoslavo possa inserirsi in una qualsiasi “logica dello sviluppo delle multinazionali” dal momento che ha liquidato – a eccezione dell’artigianato di cui parleremo in questo stesso numero – la proprietà privata dei mezzi di produzione.
Che vi sia pericolo di una forma di Autogestione del tipo descritto al punto 3, noi non lo contestiamo e anche noi pensiamo sia utile porre il problema. Il riferimento alla Jugoslavia è superfluo.
È evidente che una gestione diretta scaturente dall’autogestione delle lotte è la sola soluzione alle contraddizioni di una certa autogestione tecnocratica del tipo di quella che esiste in Jugoslavia. È così d’altronde che i comunisti jugoslavi considerano quella che chiamano “l’economia del periodo amministrativo”, termine con cui definiscono il loro periodo di statalismo staliniano. Quanto a noi, pensiamo che le premesse del Maggio ’68 possono far considerare seriamente l’ipotesi di una presa dei mezzi di produzione nel momento stesso dell’atto rivoluzionario.
Questo suppone, come viene detto al punto 4, un rifiuto dei “partiti” da parte della classe operaia. Aggiungeremo che è necessario demistificare la Sinistra classica, cioè mostrare il vicolo cieco in cui conduce la strategia socialdemocratica.
Nello stesso tempo è anche necessario mostrare lo scacco del bolscevismo. Si può ammettere che con la presa diretta avendo per scopo la gestione diretta e la democrazia diretta, i partiti di cui qui si parla non avrebbero più ragione d’essere in quanto sono degli Stati in miniatura. La loro liquidazione è una necessità se non si vuole vedere la democrazia diretta confiscata così come è avvenuto nella Russia del 1917.
“Anarchismo” riprende le tesi ultrasinistre del rifiuto sistematico dell’azione sindacale. Meglio, bisogna combattere i sindacati allo stesso modo dei partiti, anche se sono rivoluzionari o anarcosindacalisti.
È vero che il sindacalismo attuale è divenuto riformista negli scopi e nella pratica. Influenzato dalla socialdemocrazia, è stato molto spesso al potere gestendo il capitale in molti paesi europei, è stato anche manipolato dai partiti leninisti dei quali non era che la “cinghia di trasmissione”. Questa spiegazione puramente politica non è tuttavia sufficiente e bisogna ritornare sul fatto che la contraddizione del sindacalismo rivoluzionario ha permesso questa manomissione riformista o bolscevica. Esiste in effetti opposizione fra una rivendicazione per un cambiamento globale della società, che era lo scopo del sindacalismo prima del 1914, e la rivendicazione immediata per una migliore sorte dei lavoratori in seno al sistema per quanto si migliori detto sistema e lo si renda sopportabile agli sfruttati. La soluzione si trova nella formulazione di rivendicazioni immediate che toccano le strutture.
Questa ricerca è cominciata e si traduce già, soprattutto dopo il ’68, in nuove rivendicazioni e nuove forme di lotta. Per noi, le nuove pratiche ancora minoritarie ma dalle quali si libera una prospettiva, si chiariscono sia all’interno dei sindacati che all’esterno. Ecco perché questo rifiuto di principio del sindacalismo non ci sembra difendibile.
Il sindacato, anche riformista, costituisce nella sua essenza una struttura di lotta per gli sfruttati. Altre strutture possono nascere come i diversi comitati, i comitati di sciopero, ecc., che possono divenire organi di gestione diretta, nel corso dell’atto rivoluzionario che si crea nella lotta stessa. Queste sono ancora premature. Al limite, combattere il sindacato, è anche far sì che i lavoratori siano disarmati nella rivendicazione giornaliera che resterebbe puramente teorica (nel senso peggiore della parola) e quindi da combattere o da negare.
Dove non ci si comprende più è quando “Anarchismo” vuole combattere i sindacati rivoluzionari o anarcosindacalisti. Alcune frasi del testo mostrano che si tratta di combattere ciò che fa da schermo alla lotta reale, l’informazione reale e i lavoratori in lotta. A questo punto tutte le strutture sarebbero uno “schermo”! Cosa che è vera in assoluto ma che mostra una volta di più una pratica intellettuale “di sinistra”, cioè tagliata dalla realtà della lotta. Benché conosciamo i limiti del sindacalismo attraverso l’esperienza storica, non abbiamo princìpi astratti di questo tipo e saremo d’accordo con ogni sindacato che tradurrà nei fatti la rivendicazione globale (qualitativa) di un cambiamento delle strutture della società. Ciò sembra emergere da numerose pratiche della C.F.D.T. in Francia.
Le nostre divergenze con l’anarcosindacalismo si piazzano altrove. Questo concepisce che il sindacato, struttura di lotta, deve diventare l’organo della presa diretta dei mezzi di produzione e in seguito l’organo stesso della produzione.
Questo è successo anche in Spagna. E può ancora esistere in certi casi. Ciò non deve corrispondere a un monopolio sindacalista della gestione così come Besnard la concepiva nel 1917. La lotta può generare e genererà altre forme strutturali. Questo monopolio sindacale è anche pericoloso perché molto spesso può rimettere la gestione nelle mani di un “apparato” sindacale. È ciò che è accaduto parecchie volte in Spagna dove il sindacato stesso si è sostituito alla “classe”. Qui il sindacato è un vero e proprio “schermo”.
Infine, poiché non esistono società perfette, sappiamo bene che l’Autogesione darà vita a delle contraddizioni delle quali attualmente non abbiamo idea. Il sindacato, lontano dall’essere inutile, sarà sempre un organo di lotta e di difesa dei lavoratori di fronte al pericolo tecnocratico. Ecco perché non possiamo seguire “Anarchismo” in questa negazione sistematica del sindacalismo.
L’“autonomia operaia” che si dice sia il primo passo verso l’autogestione, non sarebbe che un concetto astratto se gli sfruttati non disponessero di strutture di lotta. È qui che bisogna studiare profondamente quelle strutture che non sono “recuperabili” dal sistema. Non lo sappiamo ancora con certezza. Nello studio di un processo verso l’Autogestione, i nostri compagni parlano di “nuclei produttivi di base nati dall’autonomia delle lotte”. Ciò è verosimilmente e logicamente probabile. Ed è allora che si pone il problema della nascita di organi di coordinamento delle lotte, all’inizio e, in seguito, dei nuclei produttivi. Tutto questo nascerà spontaneamente?
“Anarchismo” definisce molto bene la prospettiva: Autonomia operaia – recupero della creatività (questo potrebbe essere l’oggetto di uno studio) – conquista dell’informazione. Come si produrrà tutto ciò? I nostri compagni intravedono due ipotesi che sembrano qui definite contraddittoriamente:
-
Generazione spontanea all’interno del movimento operaio “scaturente da certe modificazioni di strutture”.
Una tale proposizione così formulata ci lascia scettici. Essa riprende certe teorie di un certo maoismo politicamente morto. In tal modo la Rivoluzione sarebbe il processo di “generazione spontanea” scaturente da certe condizioni oggettive. Queste condizioni sarebbero provocate da “certe modificazioni di strutture”. Non si sa quali e se vi sarà la possibilità di definirle scientificamente.
Questa concezione è autogestionaria solamente in apparenza nel momento in cui concepisce la Rivoluzione come un atto oggettivo che nascerebbe indipendentemente dalla coscienza. Si arriva qui a un marxismo meccanicista che, al limite, nega ogni forma di azione politica e sociale.
-
L’altra ipotesi è l’intervento “preciso, specifico, programmato da una minoranza agente”.
Se capiamo bene, questo intervento diviene necessario se le condizioni per l’apparizione di una “generazione spontanea” non sono riunite. Sarebbe, in un certo qual modo, una piccola “spinta” alla storia.
Nonostante questo non sia sicuramente il pensiero degli autori del testo, si arriverebbe in questo caso rapidissimamente a una concezione “avanguardista” leninista che prenderebbe in mano la Rivoluzione per suo proprio conto. Non si può, in materia, dar fiducia agli individui, anche se i loro scopi sono definiti come autogestionari. Esistono esempi di politiche reazionarie o autoritarie coperte da una “fraseologia” rivoluzionaria.
Errore o maldestrezza di formulazione?
Bisognerebbe discutere. Da parte nostra pensiamo che sarebbe sufficiente non opporre più le due proposizioni e considerarle come complementari perché la prospettiva sia cambiata.
Ci spieghiamo:
La Rivoluzione può nascere e nascerà forzatamente partendo da condizioni oggettive. Non si può fare la Rivoluzione senza che certi elementi (da definire) siano riuniti. Una crisi di regime nascerà al di fuori di noi. Un movimento di massa a livello di rivolta può nascere così “spontaneamente”. Ma questo movimento sarà rivoluzionario solo se è cosciente. È qui che interviene il ruolo di un’organizzazione rivoluzionaria che possiamo anche chiamare “minoranza agente” benché non sia affatto giusto volerla definire anticipatamente “minoranza” anche se praticamente dovrà essere tale. Questa organizzazione deve tendere a essere la maggioranza o a esprimere le aspirazioni della maggioranza, sotto pena di morire o di mantenersi con mezzi autoritari che negherebbero l‘autogestione.
Le definizioni date da “Anarchismo” dell’azione in seno alle masse sono chiare e, a nostro avviso, positive. Per non ricadere nel partito leninista, è necessaria effettivamente un’azione che non sia “esterna alla classe” (interna dicono loro) “che tenda a coordinare l’organizzazione autonoma”.
Ciò che è detto al punto 8 definisce praticamente ciò che noi chiamiamo una trasposizione politica delle aspirazioni o delle azioni delle masse. Per riprendere la nostra tesi, l’organizzazione rivoluzionaria deve rendere cosciente l’aspirazione incosciente della classe. Sta proprio qui il partito di “tipo nuovo” che è necessario nelle prospettive attuali.
È qui che noi affermiamo che non è affatto necessario che questa organizzazione sia esclusivamente “anarchica”, anche se pensiamo che tutti gli anarchici rivoluzionari debbano parteciparvi. Nella prospettiva autogestionaria, la sua costruzione passa obbligatoriamente dalla risoluzione del problema della riunificazione del movimento rivoluzionario internazionale. I nostri compagni italiani devono discuterne con noi e con gli altri.
[“Anarchismo” n. 13, 1977, pp. 4-8].
Un’accusa di estremismo
L’intervento pubblicato dai compagni di “Tribune anarchiste communiste” relativo alla nostra posizione riguardo la teoria autogestionaria, costituisce un cospicuo esempio di come possa prendersi in considerazione in modo parziale la questione “globale” dell’autogestione.
La nostra tesi, subitamente tacciata di “sinistrismo”, era che non si deve tenere conto “solo” del problema della produzione, nell’entrare all’interno della tematica autogestionaria, ma si deve considerare il processo rivoluzionario nella sua globalità; per cui il funzionamento di una società affidata nelle mani dei produttori diventa un tutt’uno col problema di come organizzare la lotta oggi, di fronte a una situazione di sfruttamento.
Ma i nostri compagni, mettendo avanti una critica radicale della nostra tesi, ci dicono che così facendo ci sfugge il senso del parziale e del progressivo, i piccoli vantaggi di un processo di decentramento amministrativo e contabile (e, concediamolo, anche politico), vengono a perdersi in una considerazione “estremista” del problema, che non tiene conto del fatto che, in definitiva, non possiamo avere tutto e subito e quindi tanto vale avere qualcosa a poco a poco.
E qui viene spinto avanti il “modello” jugoslavo, da noi condannato senza riserve come modello “assolutamente” lontano da quell’autogestione rivoluzionaria che sola riteniamo possa condurre alla definitiva liberazione degli sfruttati. Secondo i nostri compagni, la società jugoslava è “la sola società autogestionaria del mondo che dimostra come il sistema sia possibile”. La conclusione è chiara: “L’evoluzione vi è stata e abbiamo modo di pensare che lo Stato è liquidato progressivamente...”.
Queste affermazioni ci lasciano perplessi. Sarebbe mai possibile la liquidazione dello Stato? Gli anarchici non hanno da sempre sostenuto che lo Stato deve distruggersi e che non può porsi in liquidazione? Non sarebbe questa novella lettura del marxismo, del tipo del Lenin di Stato e rivoluzione? E la resistenza della tecno-burocrazia (ammessa anche dai nostri compagni), non sarebbe, in definitiva, una forma di ricostituzione dello Stato “posto in liquidazione”?
Riteniamo che il “modello” jugoslavo sia molto interessante da un punto di vista “tecnico”, in quanto quelle strutture statali “decentrate” hanno scoperto un modo di reperimento del consenso che è tra i più avanzati del mondo, modo che per realizzarsi deve impiegare certe forme “tecniche” di strutturazione della produzione e della distribuzione che hanno sostanziale contenuto autogestionario, ma solo dal punto di vista tecnico, non da quello rivoluzionario e liberatorio. Ammettere che quelle forme tecniche autogestionarie, controllate da un apparato centrale di tipo leninista (o quasi, poco importa), costituiscano qualcosa di più di un “modello tecnico”, ma formino addirittura un esempio di liquidazione statale, è non solo pericoloso ma anche ingiusto oggettivamente, in quanto significa fare un salto di qualità tanto grande che nemmeno gli stessi dirigenti jugoslavi, nella pur grande necessità propagandistica, hanno potuto fare.
Ecco cosa scrive Svetozar Stojanovic: “Da noi in Jugoslavia vi sono delle correnti non socialiste che concepiscono l’economia di mercato e la distribuzione stimolatrice come una specie di economia del ‘laissez faire’ che permette enormi differenze sociali e un esercito di disoccupati per i quali nessuno deve seriamente preoccuparsi (dentro di sé queste persone considerano il diritto al lavoro una pura espressione propagandistica, benché esso venga proclamato dalla Costituzione jugoslava). Nella loro variante più radicale costoro cercano di trasformare la proprietà sociale in proprietà azionaria dei collettivi dei lavoratori, addirittura di rendere possibile il possesso privato di piccole fabbriche. Dietro, la retorica dell’autogestione e dell’economia razionale od efficiente piccolo-borghese della riforma economica”.
Certo non mancano i teorici jugoslavi che sostengono la necessità di realizzare un sistema unitario di autogestione, ma, come afferma lo stesso Stojanovic, bisogna superare la dimensione dell’aspetto economico, per arrivare all’aspetto etico-umanistico, per cui continua... “In realtà è possibile raggiungere un alto grado di uguaglianza e di giustizia solo quando questo principio soppianti totalmente la distribuzione conforme alla società classista: quella secondo la proprietà, la gerarchia, il potere, i privilegi ereditati e ottenuti. Se inoltre l’autogestione sociale ha anche un profondo significato etico, e se oggi non c’è vera autogestione se non ci si fonda sul principio della distribuzione secondo i risultati del lavoro, allora ne consegue anche che questo principio è eticamente giustificato”.
Come si vede, uno dei più chiari teorici jugoslavi di oggi, autore di un libro (Gli ideali e la realtà, tr. it., Milano 1974) che è, secondo noi, uno dei più evidenti ripensamenti della problematica umanistica in chiave marxista, si domanda affannosamente deve vada la società jugoslava, se verso la liberazione o verso un persistere di quelle strutture che proprio per avere dato preminenza all’aspetto tecnico, quindi all’aspetto distributivo e produttivo dell’autogestione, hanno perduto di vista la totalità dell’uomo, totalità che può raggiungersi solo con la rivoluzione.
Che poi sarebbe lo stesso discorso del dire: non è possibile, attraverso lo Stato, arrivare alla liberazione dell’uomo, essendo quest’ultima vicenda la definitiva eliminazione di ogni prospettiva gerarchica e di potere. Non basta ammettere che la Jugoslavia non accetterà mai le multinazionali, come non basta affermare, poniamo, che per risolvere i problemi della Francia o dell’Italia bisognerebbe gettare fuori gli Americani e rinchiudersi in una economia protezionistica. Il discorso rivoluzionario se è anche questo, non è solo questo.
E qui si coglie l’altro elemento – non troppo distaccato dal primo – di contrasto con l’analisi dei compagni di “Tribune anarchiste communiste”: la nostra critica al sindacalismo di qualsiasi matrice, anche quello anarchico o rivoluzionario.
La nostra negazione della prospettiva rivoluzionaria del sindacalismo non deriva solo dalla banale constatazione che oggi i sindacati sono riformisti, ma risale all’elemento più intrinseco della motivazione della lotta sindacale: quella difesa del lavoro che ci appare più legata da un lato a schemi corporativi ben utilizzati dai padroni e dall’altro a una prospettiva di sostituzione del vecchio potere imprenditoriale con un futuro anonimamente statalista.
La difesa corporativa del lavoro conduce a una necessaria razionalizzazione del mercato capitalista, mai a una sua esposizione in senso comunista. Essa può condurre all’eliminazione o all’appianamento di alcune differenze o privilegi; può fare scomparire la pluralità dei monopoli, le speculazioni errate e può ridurre le conseguenze negative della coincidenza casuale di alcune circostanze conflittuali capitale-lavoro, ma fin che si pone come tale non può negare il fondamento stesso dello sfruttamento: l’assoluta libertà del mercato capitalista, che poi sarebbe l’assoluta libertà di sfruttare.
Dall’altro lato, la tendenza dei sindacati alla gestione totale, in un rapporto ben fissato con i partiti aspiranti alla totalizzazione dell’economia in nome di un presupposto interesse del proletariato, sostiene lo stesso la necessità di lasciare “libero” il mercato, allo scopo di entrarvi come controparte, agente, una volta spazzati via quei ruderi storici che oggi sono gli imprenditori. Dobbiamo capire che una economia di mercato, necessitante dell’azione sindacale, è il presupposto ideale per la costituzione di uno statalismo politocratico. In questo modo i principi del mercato vengono salvati, la forma autogestionaria viene applicata nei limiti fissati dal centro politico dirigente (cosa quest’ultima che salva la qualifica “socialistica” della struttura), e l’oligarchia può tranquillamente decidere quali settori controllare di più e quali di meno, purché il mito del lavoro resti salvo e la scala di valori individuale si commisuri sempre sul vecchio modello.
Ora, per noi, l’autonomia operaia non è tanto uno strumento di lotta “contro” il sindacato, quanto uno strumento organizzativo di base che intende svilupparsi a prescindere dal sindacato, primo passo verso quell’autogestione globale che non riusciamo a vedere separata in tempi e quadri diversi.
Dalla funzione che riteniamo di potere assegnare all’autonomia operaia scaturisce l’ultima obiezione di fondo sollevata. Il rapporto tra minoranza agente e elementi oggettivi di una trasformazione strutturale come punti non ultimi di trasformazione sociale in una prospettiva rivoluzionaria. I nostri compagni ci accusino di determinismo maoista, ma qui crediamo siano incorsi in una lettura un poco affrettata del nostro testo che intendeva sottolineare, cosa pacifica per gli anarchici, la paritetica e compresente ingerenza dell’uno e dell’altro aspetto del meccanismo globale della trasformazione sociale. Quindi, la generazione spontanea all’interno del movimento operaio non è frutto deterministicamente necessario di certe modificazioni di strutture (dove il termine strutture non vediamo perché deve essere letto in chiave economica soltanto, come il tanto deprecabile maoismo ha fatto in momenti di riflusso rivoluzionario), ma è frutto di quell’insieme di elementi di cangiamento che se tengono conto di alcune condizioni precise non prescindono dall’azione di uomini e organizzazioni, di analisi e idee.
[Cfr. la mia Risposta a “Tribune Anarchiste Communiste” in “Anarchismo” n. 13, 1977, pp. 8-19]
Sviluppi recenti
Facciamo insieme il punto sulla situazione attuale [1979] dei problemi inerenti all’autogestione.
Questa proposta viene qui lasciata aperta non potendosi considerare soddisfacenti le analisi che pubblichiamo in questo capitolo, in quanto le stesse colgono solo in piccola parte la vasta serie di contraddizioni che scaturiscono dal concetto stesso di “autogestione”, specie oggi, a distanza di cinque anni da quando cominciammo a fare uscire i primi interventi in Italia sull’esperienza della LIP francese.
Da allora molta strada si è fatta, in modo particolare nella direzione della distruzione del lavoro, nella rielaborazione degli elementi che portano a limitare fortemente le concessioni classiche sul ruolo rivoluzionario o trainante della produzione e della fabbrica. Polemiche sanguinose sono nate e si sono sviluppate.
Anche noi, pressati dalla necessità di fare presto e di fare quanto meglio possibile, abbiamo finito per prediligere altre tematiche, ma, in fondo, si tratta solo apparentemente di “altre” tematiche, non potendosi considerare diversa la tematica che si occupa degli strumenti di produzione.
Se il movimento rivoluzionario ha saputo chiarire, dentro alcuni limiti, l’analisi intorno alla necessità della distruzione del lavoro, il potere non è rimasto indietro. Non potendo, ancora, per ovvi motivi, procedere esso stesso a un suo progetto di “distruzione” del lavoro – che poi sarebbe il più grande progetto di recupero a tutti i livelli – ha operato nel senso della distruzione concreta delle strutture tradizionali che organizzavano il lavoro nei luoghi fisici della produzione: le fabbriche. I processi di destrutturazione, qui, sono veri e propri processi di “distruzione” a lungo termine di un certo modello di produttività in vista di garantire la persistenza di un altro modello produttivo, quello che dalle cose passa alla visione generale del flusso del capitale: quella visione che è realizzabile solo eliminando, o alleggerendo, la pressione dello scontro di classe.
La risposta dei lavoratori deve essere ancora quella della lotta, ma, per potere realizzare un livello adeguato di quest’ultima, adeguato all’attuale situazione della distribuzione dei rapporti di forza, occorre sviluppare un’analisi che dia conto dei progetti “destrutturanti/distruttivi” del capitale, in modo da contribuire alla costruzione di un progetto rivoluzionario autogestito di distruzione del lavoro, dello sfruttamento, dell’economia e del capitale.
[Per questo paragrafo cfr. la nota redazionale relativa all’articolo: “Facciamo il punto sull’autogestione”, in “Anarchismo” n. 26-27, 1979, p. 72]
GEPI. Un esempio di destrutturazione del capitale
Secondo la nostra analisi resta tuttora valida l’interpretazione di fondo dell’autogestione anarchica, come contemporanea, autogestione delle lotte e della produzione.
Tale elemento di base è corroborato, anche in questa fase dello scontro di classe, dalla tendenza del capitale a spezzare la resistenza degli sfruttati operando “separazioni” che sono non solo a livello della classe o del territorio, ma anche al livello del “luogo fisico” della produzione.
Per realizzare quest’ultimo progetto, il capitale spezza il proprio modello integrato, che riceveva unità e armonia dalla disunità e dalla lacerazione dello sviluppo diseguale a livello nazionale e internazionale, ma che a livello di fabbrica si vedeva neonato come modello integrato.
Anche il capitale, quindi, si è chiaramente convinto che il progetto produttivo non è solo un fatto tecnico (soluzione del problema dell’imprenditore o giusta miscela dei fattori di produzione) ma è principalmente un fatto politico, quindi un fatto che trova la propria caratterizzazione nello scontro di classe.
Questo progetto capitalistico è abbastanza evidente, come si è detto, nei luoghi della produzione, ed è stato indagato dalle tematiche sulla fabbrica destrutturata. Ci sembra, invece, meno evidente all’interno di quelle operazioni finanziarie di ristrutturazione che il capitale compie con il paravento della salvaguardia del livello occupazionale, operazioni che sono, in sostanza, progetti di ristrutturazione ma con l’alibi della disoccupazione e l’imprimatur dei sindacati.
Prendiamo il caso della GEPI, azienda costituita per gli interventi diretti alla ristrutturazione e alla riconversione delle imprese industriali.
Ne fanno parte l’EFIM (Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera), l’ENI (Ente Nazionale Idrocarburi), l’IMI (Istituto Mobiliare Italiano) e l’IRI (Istituto per la Ricostruzione Industriale). Attraverso questi enti è lo Stato che finanzia le imprese industriali in difficoltà per “concorrere al mantenimento e all’accrescimento dei livelli di occupazione compromessi da difficoltà transitorie”, come recita la legge costitutiva della GEPI.
A un esame superficiale dei compiti della GEPI, che presto elenchiamo, sembrerebbe che il capitale voglia, con questo strumento, cristallizzare i suoi interventi passati, proprio davanti alla minaccia della pressione sociale derivante dalla mancata occupazione. Vedremo più avanti che le cose non stanno propriamente in questo modo.
Per il momento elenchiamo i casi in cui la GEPI interviene:
1) assunzioni di partecipazioni in società industriali in condizioni di difficoltà finanziarie o gestionali giudicate (dalla GEPI sulla base delle direttive del CIPE e in base al piano di riassetto o di riconversione) transitorie o superabili, al fine di realizzare le migliori condizioni per la riorganizzazione delle imprese e per una successiva cessione delle partecipazioni stesse;
2) costituzione (o concorso alla costituzione) di società per la gestione o per il rilievo di aziende industriali al fine di realizzare le migliori condizioni per la riorganizzazione di aziende o per una loro successiva cessione;
3) cessione di finanziamenti anche a tassi agevolati.
Abbiamo, pertanto, che l’attività della GEPI consisterebbe nel sostegno dell’occupazione da ottenersi attraverso la ristrutturazione e il recupero dell’efficienza economica delle imprese, trasformandole da imprese “fuori del mercato” in imprese competitive sul mercato, e tutto ciò senza che si incorra in un impegno a tempo indeterminato della società stessa.
C’è da notare, in breve, non essendo questo l’oggetto del nostro discorso, che questi interventi della GEPI hanno di già, in partenza, una anomalia. Cioè non sono, come accadeva per gli interventi dell’IMI a favore di imprese industriali, anche per l’attuazione di programmi e anche per le modificazioni di strutture aziendali e produttive, interventi per salvare l’azienda; ma sono interventi per salvare il livello occupazionale.
Il capitale si trova, in questo momento, davanti alla necessità di operare delle grandi distruzioni di produzione allo scopo di sostenere il livello occupazionale, cioè allo scopo di evitare un acuirsi del conflitto di classe. Ciò non è possibile attraverso lo strumento tradizionale dei finanziamenti al settore industriale, come non è possibile (per motivi di quantità delle somme necessarie) attraverso lo strumento della fiscalizzazione degli oneri sociali. Per questo ricorre alle spericolatezze della GEPI.
Questa società infatti è autorizzata a compiere operazioni finanziarie di grande ampiezza che vanno dalle partecipazioni azionarie, all’assistenza amministrativa, organizzativa, tecnica e finanziaria delle aziende acquisite; come pure è autorizzata a effettuare riporti, anticipazioni, sconti. Può acquistare immobili, mobili, fare avalli, fideiussioni e garanzie a emettere obbligazioni.
Quando entra in funzione è il 1971, verso il mese di settembre, e il primo bilancio, quello del 1972, si chiude con un ventaglio di assistenze a imprese industriali di 150 unità.
In concreto la situazione dell’economia italiana è già sufficientemente critica, e gli elementi principali che hanno cominciato a mettere in difficoltà le industrie emergono dal ciclo di lotte di classe esauritosi da poco. A questo fanno riscontro le vicende monetarie internazionali che sono quanto meno inquietanti, mentre il “malessere” nei rapporti di lavoro non accenna a diminuire.
Ragionando da un punto di vista tradizionale, la GEPI doveva essere chiusa subito. Infatti non era affatto vero che i rischi assunti per gli interventi nelle aziende assistite potevano essere ripartiti in tutti i settori dell’economia nazionale, anche in quelli più produttivi, per il semplice motivo che settori di questo genere non ne esistevano più e la situazione di “malessere” nel bilancio della società, si era praticamente generalizzata a tutta l’economia.
Di più, la tutela del livello occupazionale contrastava fortemente con la logica dell’intervento temporaneo di salvataggio. Quando le aziende erano “stracotte”, a rigore di logica economica bisognava buttarle a mare, oppure restarci dentro per lunghi decenni, correndo tutti i rischi imprenditoriali.
Senza volere addentrarci nei complessi meccanismi di questa forma quanto mai interessante di parziale autodistruzione del capitale allo scopo di garantire la persistenza generale del sistema di sfruttamento, già dai pochi accenni fatti si può concludere con alcune notazioni assai interessanti.
– Non risulta vero che i livelli occupazionali siano stati totalmente garantiti, ma, grazie alle facilitazioni delle operazioni finanziarie, si è fatto un ricorso nascosto alla cassa integrazione senza “dare nell’occhio”. Nel 1973 si calcola che circa 5.000 lavoratori di aziende “assistite” dalla GEPI erano a zero ore in cassa integrazione.
-
Dall’esame dei bilanci non risulta individuabile il reale costo di intervento nelle aziende e non si conoscono le partecipazioni cedute.
-
Alcuni critici non certamente rivoluzionari hanno sottolineato che questa società è chiaramente uno strumento per coprire operazioni finanziarie prive di controllo politico.
-
Col sistema della gestione GEPI si è tagliata la trattativa sindacale in quanto la società sostiene che le aziende assistite sono le delegate a trattare con i sindacati e le aziende, ogni volta, rinviano alla GEPI.
-
Il reale scopo della GEPI risulta quindi: da un lato quello della redistribuzione delle unità produttive (taglio dei rami secchi), e dall’altro la riduzione dell’organico (proprio il contrario di quello che ufficialmente viene dichiarato: salvaguardia del livello occupazionale). Solo che questo progetto trova ostacolo nello scontro di classe e nella posizione di freno dei sindacati, i quali se sono disponibili alla ristrutturazione non possono esserlo all’attacco al livello occupazionale.
Qui il capitale opera un vero colpo di genio. Si inserisce nell’andamento del modello di sviluppo sovra-nazionale, cercando di adeguare la propria “pressione” occupazionale a quella del ciclo capitalistico dominante (Germania/USA). Cioè non vuole più realizzare un piano di ristrutturazione a medio termine, che contrasterebbe con questo ciclo internazionale (specie appunto con gli interessi riflessi dei paesi emergenti); ma non vuole nemmeno che il disinvestimento avvenga in modo traumatico, facendo di tutto perché si realizzi in modo graduale e dolce. Un aumento dei disoccupati da un lato significa un alleggerimento delle rivendicazioni sindacali, ma significa (ben più pericolosamente) un aumento della pressione dello scontro di classe. È proprio in quest’ultima paura, cioè che il controllo sfugga ai sindacati, che si vede la chiara coscienza che il capitale ha del pericolo dell’autorganizzazione dei lavoratori e dell’autorganizzazione della lotta.
In questo modo la GEPI diventa un intelligente strumento che il capitale ha trovato per asfissiare in modo lento e preciso il programma di ristrutturazione privata dei vari settori produttivi, evitando i contraccolpi provenienti dalla lotta di classe.
Ancora una volta il capitale è stato il primo a comprendere con grande chiarezza che non è la produzione l’oggetto più importante del riassetto dell’economia, ma proprio il comando delle lotte. La ristrutturazione in forma razionalmente economica, avrebbe da un canto fatto abbassare il livello dello scontro, in rapporto al miglioramento delle condizioni del lavoro, ma avrebbe, nello stesso tempo, rafforzato le condizioni della produzione stessa, quindi le condizioni dello sfruttamento, ciò avrebbe preparato il terreno per nuove lotte e nuove situazioni conflittuali. Asfissiando la stessa ristrutturazione privata, il capitale, destruttura se stesso, candidandosi al futuro comando di domani, al momento del passaggio al settore pubblico in forma definitiva.
La sede delle lotte è, una volta per tutte, il luogo dell’autogestione, il rifiuto della delega, lo smascheramento delle intenzioni del capitale. In questa direzione deve incamminarsi un’analisi sull’autogestione, che è poi la direzione della distruzione del dominio dell’economia (regno del fittizio) sul reale. Avverrebbe così la coordinazione tra lotta e produzione all’interno della dimensione autogestionaria, da parte del movimento degli sfruttati, coordinazione che potrebbe, via via, strutturarsi con aggiustamenti adeguati, alle istanze di recupero e di attacco portate avanti dal capitale.
Superamento delle contraddizioni non significa, in questo caso, passare l’iniziativa dello scontro alla controparte, ma, al contrario adeguare la propria potenzialità di classe alle capacità di invenzione repressiva del capitale.
[“Anarchismo” n. 26-27, 1979, pp. 76-79]
Verso il dominio reale del capitale
Come abbiamo detto altrove, con una formula forse eccessivamente generica, l’autogestione deve essere autogestione generalizzata, cioè autogestione delle lotte e autogestione della produzione. Una eventuale autogestione della produzione, in presenza di un potere centrale che stabilisca i limiti e gli obiettivi del piano, è solo autogestione del proprio sfruttamento (Jugoslavia, Algeria, ecc.).
Le profonde modificazioni del tessuto produttivo del capitalismo in alcuni paesi come l’Italia, ci fanno vedere, abbastanza chiaramente, come non sia più possibile parlare nei termini dell’analisi classica degli economisti, sia di tendenza marginalista, sia di tendenza keynesiana, sia di tendenza marxista, sia delle tendenze – più recenti – che vengono chiamate “radicali” e che sono elaborate nelle università americane. Queste interpretazioni cercano di darci – nel micro, come nel macrocosmo dell’economia – un’analisi settoriale delle forze produttive, un modello di come si svolgono i fenomeni legati alla produzione della ricchezza e del consumo. Il tutto viene generalmente visto da un’angolazione individualistica, tranne i tentativi marxisti che cercano di cogliere il momento macroeconomico di una interazione complessiva di tutte le forze in gioco sul mercato.
Da questo punto di partenza non è possibile parlare di autogestione, se non come forma organizzativa della produzione, che non mette affatto in causa la produzione stessa, che non si propone nulla al di fuori di una razionalizzazione dei processi produttivi – al massimo di una ottimizzazione dal punto di vista della qualità (anche umana) – nulla che metta in gioco il concetto stesso di produzione secondo un modello prefissato in opportuna sede, quella sede che poi, in fondo, costituisce il potere vero e proprio.
Avviandosi il processo capitalistico dalla primitiva forma del dominio apparente del capitale, alla forma avanzata del dominio “reale”, ci sembra sempre meno centrale l’aspetto dell’estrazione del plus-valore e della relativa accumulazione, come fatto quantificante del flusso produttivo. Il capitale, una volta concretizzatosi nella sua “realtà”, si presenta spoglio di quelle estreme metodologie che lo vedevano obbligato alla violenza dell’estrazione forzata, della miseria obbligata come elemento diretto della possibilità stessa della produzione. La “realtà” del flusso capitalista fa spuntare la violenza per altra via, come separazione all’interno stesso della divisione di classe, come progetto incompleto di dominio totale che necessita, quindi, di una ghettizzazione e di una criminalizzazione di quella parte dei produttori-consumatori che non entrano immediatamente nel progetto garantista.
Però, mentre nella fase del dominio formale il capitale aveva una vera e propria strategia di riduzione alla linea del mero sostentamento per tutelare il massimo del tasso di profitto, nella fase del dominio reale questo non solo non gli interessa più oggettivamente (perché si ritiene in possesso del potere che globalmente annulla i valori contraddittori – merce-denaro – e complementari – produzione-consumo), ma cerca di allargare la prospettiva garantista, suggerendo una gestione “globale” del potere, superando il momento preistorico della divisione tra potere politico e potere economico. In questa gestione globale, il capitale emerge orgogliosamente per quello che è “veramente”, ciò un flusso costante, non un equilibrio instabile di accumulo e di variazioni di tasso di profitto, ed emergendo come flusso propone l’unificazione in una sola merce: quella che abbiamo spesso definito come “pace sociale”.
In un mondo che produce oggetti specifici, fra i quali è possibile cogliere un oggetto (merce) particolare che – per sue caratteristiche intrinseche o fittizie – si rapporta facilmente a tutti gli altri oggetti, cioè il denaro, in un mondo del genere che produce oggetti (merce e denaro), il capitale appariva snaturato, ondeggiante tra estremi di gestione “politica” del potere per via indiretta, ed estremi di sfruttamento ideologico delle masse (sempre per via indiretta) attraverso meccanismi pseudo di base (l’autogestione fittizia sarebbe uno di questi meccanismi).
In un mondo, al contrario, che si indirizza verso l’unificazione della produzione e del consumo in una merce singola, capace di dare significatività a tutte le altre merci, cioè la “pace sociale”, il capitale si spoglia di tutte le contraddizioni apparenti per presentarsi nella sua vera veste di flusso costante dotato di un’unica contraddizione permanente: la resistenza attiva e diretta degli sfruttati, la lotta rivoluzionaria.
Altrove abbiamo anche cercato di spiegare come il capitale, nella fase di passaggio al dominio “reale”, può ancora c0ercare di portare “sul mercato”, per la relativa trasformazione in merce, anche la “ribellione” degli sfruttati, anche la forza distruttiva che gli attacchi di questi ultimi fanno emergere contro il potere (basta ricordarsi dell’uso che la stampa fa dei fatti rivoluzionari che vengono realizzati, di come li distorce, di come li impacchetta e di come li vende, ecc.), ma questa capacità di immettere sul mercato una merce che si potrebbe chiamare “guerra di classe” è tanto meno grande, per il capitale, quanto più lo scontro si acuisce e tanto più crescono le difficoltà alla produzione della merce fondamentale per la costituzione del dominio reale, cioè la merce “pace sociale”.
Con questo vogliamo affermare che ogni atto di ribellione, dal più piccolo al più grosso, non costituisce, da solo, il fatto risolutivo della contraddizione che “dobbiamo” vivere in quanto compartecipi di una situazione oggettiva di vita che è contrassegnata dalle leggi del capitale; ma, pur essendo trasformabile in merce, è un elemento di disturbo della produzione della pace sociale. Va da sé che ogni elemento riformistico di accettazione del dialogo capitalistico, non fa altro che aumentare direttamente la produzione della pace sociale ed evitare ogni acuirsi della contraddizione che esiste tra pace sociale e guerra di classe.
La negazione del lavoro, la distruzione della sacralità della produzione, l’attacco alle strutture produttive, il rifiuto cosciente del consumo folle, una strategia di vita che capovolga il condizionamento imposto dal capitale (nei limiti in cui tutto ciò è possibile), una lotta costante contro i simboli della ricchezza e del potere, un attacco contro tutte le concrete incarnazioni del potere stesso; tutto ciò costituisce un atteggiamento distruttivo (e quindi rivoluzionario) ma, nello stesso tempo, costituisce un atteggiamento produttivo, cioè capace di produrre quegli elementi che (sebbene parzialmente recuperabili dal potere e, anche, trasformabili in merce – per come abbiamo visto) servono da disturbo per la produzione dell’unica merce che il potere è interessato a produrre: “la pace sociale”. In questo senso l’autogestione delle lotte diventa, nello stesso momento in cui si realizza in forma diretta – senza intermediari e senza avanguardie – un’autogestione della produzione (sia pure in forma embrionale). Tanto più sarà sviluppato il concetto “distruttivo” (senso che si ricava dalla lettura voluta dai padroni) dell’azione realizzata dagli sfruttati; tanto più si alza la capacità “autogestita” di produzione della guerra sociale, cioè di quella qualità dello scontro che è oggettivamente l’unico bene di cui possiamo (dentro alcuni limiti, visti prima) organizzare la produzione, oggi, in forma autogestita.
Finché non comprenderemo che la produzione sotto il dominio del capitale – è rivoluzione solo quando è produzione della distruzione di quello che il capitale vuole produrre (pace sociale), non comprenderemo mai cosa possa significare “autogestione”, e andremo in cerca di questo o di quel momento produttivo, settoriale, per vedere in che modo e a quali condizioni si potrebbe organizzare una produzione in forma autogestita. Ecco, quest’ultima ipotesi porta soltanto a una conclusione: la produzione autogestita è sempre una forma produttiva del capitale, anzi la forma più razionale ed efficiente e si conclude invariabilmente nella produzione del proprio sfruttamento e nella sua autogestione. Solo quando questa produzione è produzione di distruzione del dominio reale del capitale, anche se con i limiti di recupero che il capitale può riuscire a imporre, è di già l’embrione della futura autogestione della produzione nella società liberata.
Riassumendo possiamo dire che come problemi economici dell’autogestione consideriamo quelli relativi alla produzione del dominio “reale” del capitale, che devono essere compresi per comprendere a quali condizioni è possibile una lotta rivoluzionaria; poi i problemi dell’autogestione delle lotte e della produzione; i problemi del passaggio dal dominio formale (con estrazione di plus-valore e accumulazione) del capitale al dominio “reale” (con unificazione della produzione delle merci sotto un’unica merce: “la pace sociale”); i problemi della produzione autogestita della distruzione della produzione del capitale e del suo dominio “reale”; i problemi della trasformazione in merce di questa distruzione che il capitale cerca di realizzare in tutti i modi; i problemi del recupero di quella parte distruttiva che non può essere trasformata in merce dal capitale reale e che viene quindi a costituire un forte elemento di disturbo nella produzione della merce “pace sociale”; infine, i problemi dell’utilizzo rivoluzionario delle potenzialità tecnologiche e scientifiche che la stessa produzione della merce “pace sociale” obbliga il capitale a realizzare.
È su questi problemi che bisogna portare la riflessione se si vogliono fare passi avanti nella trattazione della tematica autogestionaria. Problemi che possono anche essere quantificati – da un punto di vista economico – per rendere più chiare le conseguenze e le implicanze di ordine politico e sociale. Si tratta – almeno ci pare – di un grosso lavoro da fare, allo scopo, tra l’altro, di dare più solido fondamento alle vaghe dichiarazioni di principio che, nel loro massimalismo estremista, hanno l’aria di rimanere fondate sul nulla.
[Cfr. il mio articolo: “Problemi economici dell’autogestione”, in “Anarchismo” n. 26-27, 1979, pp. 73-76]
Autogestione, dominio reale e pace sociale
Paradossalmente, in questi ultimi anni, che hanno visto il risorgere dell’interesse per la tematica anarco-sindacalista (specie dopo l’evoluzione della situazione spagnola), si è insistito a lungo proprio su alcuni aspetti strutturali, finendo per sfondare porte che erano aperte da tempo.
Struttura orizzontale, azione diretta, controllo permanente della base, verifica assembleare, fino alle ipotesi meno credibili di “opposizione” interna ai sindacati cosiddetti riformisti. Tutto questo materiale di dibattito si può dire sia stato sviscerato fino in fondo, onde, a questo punto, tornare a insistervi, significa correre il rischio di veleggiare verso tematiche ancora più astratte, come quella del rapporto mezzi-fini, del passaggio dal momento economico al momento politico, della contraddizione tra movimento e organizzazione sindacale, ecc.
Ci pare importante fermare l’attenzione su di un fatto che, per quanto evidente, ci sembra sia stato un poco trascurato. A che cosa serve un sindacato anarchico? La prima risposta che si penserebbe logica è: per lottare contro i padroni, sul piano economico, e per consentire ai lavoratori di raccogliere organicamente le proprie forze in vista di questa lotta in modo autogestito, senza delegare ai burocrati sindacalisti le proprie capacità e potenzialità di tipo operativo.
Bene. Mettendo da parte tutta un’altra serie di problemi, come quello della possibilità o meno di una lotta autogestita di tipo economico, come quello della possibilità o meno di una eliminazione dei meccanismi della delega e così via, vogliamo – per sgombrare il campo – fermarci a un’altra domanda che ci consentirà un maggiore approfondimento. Contro chi dovrebbe essere impiegata la capacità offensiva di un sindacato anarchico? Domanda che ne fa generare immediatamente una subordinata: esiste una capacità offensiva che sia distinguibile dalla capacità difensiva del sindacato stesso?
Siamo, in questo modo, molto vicini al problema che intendiamo porre in questi appunti. La risposta più ovvia alla domanda principale suddetta è che il sindacato va impiegato contro i padroni. Alla domanda subordinata risponderemo subito dopo. Ma, parlando di padroni, non da un punto di vista genericamente politico, ma da un punto di vista del rapporto economico che consente sia la produzione della ricchezza che lo sfruttamento del lavoratore, il problema non è così facile. Chi sono questi padroni?
Qui si potrebbe rispondere con una delle tante analisi sociologiche in corso di utilizzo in questi ultimi tempi, ma svieremo, ancora una volta dal nostro obiettivo. In fondo quello che ci interessa è sapere se oggi è ancora possibile operare una scissione netta tra momento economico della produzione e momento politico dell’organizzazione Stato, se è ancora possibile distinguere tra controparte economica e controparte politica; se è ancora possibile dividere l’economia in un settore privato (con ingerenza statale) e in un settore pubblico (specializzato in alcuni servizi). In una parola i padroni, contro cui dirigere le potenzialità sindacali (difensive o offensive che siano, questo lo vedremo); sono i padroni dell’economia oppure sono i padroni di un nuovo dominio che comprende l’insieme dell’economia e della politica (intese in senso tradizionale); padroni, pertanto, che gestiscono il potere in modo nuovo e che non possono essere attaccati con le armi tradizionali del sindacalismo, fosse anche rivoluzionario?
Se non si fa chiarezza su questo punto centrale, se quindi non si cerca di dare un minimo di approfondimento alla struttura dei rapporti economici che si sono andati sviluppando in questi ultimi anni nei regimi a capitalismo in via di perfezionamento (come in Italia), diventa inutile tornare a insistere sulla domanda di maggior peso contrattuale e politico che viene dalla base sindacale che si scontra con i burocrati che oggi gestiscono i sindacati e, quindi, diventa vago e contraddittorio proporre (a rischio di farsi rompere la faccia) la costituzione di un nuovo sindacato, sia pure anarchico.
Affermiamo qui che se i rapporti economici sono mutati, tanto da rendere leggibile una rete di interessi capitalistici in chiave sempre più differente da quella che costituiva la “norma” del capitalismo in via di evoluzione, con le sue contraddizioni; allora dovrebbe essere anche modificato non solo lo strumento sindacale, ma il rapporto stesso di forza che contrappone sfruttati e sfruttatori, e modificato al punto da rendere del tutto superato il concetto stesso di “unione” sindacale o di lotta sindacale, per quanto acrobatici siano i salti ideologici o verbali che di solito vengono fatti per ingannare noi stessi e i lavoratori che intendiamo fare entrare nelle strutture di nostra invenzione.
Cerchiamo, adesso, di dar conto, sia pure in modo approssimativo, di questi mutamenti intervenuti nei rapporti economici.
Fermare l’attenzione sulla crescente importanza dell’attività che lo Stato svolge in prima persona nel campo dell’economia è certamente cosa importante, ma, nello stesso tempo, cosa marginale che rischia di non cogliere il senso profondo del fenomeno che sta realizzandosi ai nostri giorni. Gli economisti si sono dati un gran da fare in questo senso, applicando i criteri marginalisti all’economia pubblica (o almeno, a quella che essi considerano l’economia pubblica), proponendo infine – nei casi di scarsa attendibilità dei risultati così ottenuti – un ritorno a Ricardo o una migliore riflessione sul problema dell’insufficienza della domanda effettiva (stranamente studiato ai suoi tempi da Malthus).
Colpiti dal fenomeno del rapido crescere dell’ingerenza statale, gli economisti si sono accorti che forse potevano impiegare gli strumenti che erano falliti nell’analisi tradizionale del mercato capitalistico, per vedere se potevano, invece, funzionare nell’analisi dell’economia pubblica. Il fatto curioso è che questo neomarginalismo, riprendendo gli ottimi paretiani e rivalutando, quindi, tutta l’economia classica che si era contrapposta all’analisi di Marx, viene proposto da gente che in altri campi – cioè in quelli del vago sociologismo – non partirebbe mai dalle posizioni individualiste che il marginalismo classico rende indispensabili.
In un certo senso queste contraddizioni sono indicative. Un economista, come il canadese Breton, può rifarsi agli studi di Schumpeter e Downs per arrivare alla convinzione che gli Stati, l’unica cosa che fanno, è proprio la massimizzazione della propria persistenza come potere, ma quando sviluppa un’analisi sulla teoria della domanda di beni pubblici, cerca con tutti i mezzi di separare questa analisi dai presupposti sociologici, riuscendoci malamente, e facendo concludere al lettore che in definitiva una separazione tra settore privato e settore pubblico dell’economia, oggi, non è tanto agevole come sembra.
Difatti risulta difficile rispondere alla domanda: esistono beni pubblici e beni privati? Solo prescindendo dallo scontro di classe in atto (cosa che gli economisti fanno – e non possono evitare di farlo) si può concludere che la distinzione è possibile. Per cui diventano beni pubblici quelli prodotti dallo Stato o da altri enti pubblici, e privati quelli prodotti dagli individui o da enti di diritto privato. Distinzione che quanto meno fa ridere.
Quale distinzione è possibile sostituirvi? Qui gli economisti si sono immersi in una serie di contraddizioni insuperabili. Lo Stato produce beni che immette sul mercato come qualsiasi impresa privata e, pertanto, questi beni non possono dirsi beni pubblici solo perché è lo Stato a produrli; a loro volta le imprese private producono beni ma con i soldi dello Stato, soldi che loro provengono parzialmente in modo diretto (sovvenzioni, sussidi, sgravi, ecc.) e parzialmente in modo indiretto (come vedremo più avanti). A sua volta lo Stato introita il gettito delle imposte che costituiscono una parte del prodotto nazionale, quindi è – in un certo senso – anche da questo lato un “partecipante” agli utili delle industrie e un “lenone” dei salari.
Fa restare perplessi pure la distinzione tra fondi che provengono allo Stato dalle sue attività industriali per il mercato e fondi che provengono dal bilancio (imposte). Ma quale mercato? quale bilancio? quali imposte?
La verità è che lo Stato non è più il “cassiere” dell’economia, e quindi non è più il suo “cane da guardia”; ma è diventato esso stesso “economista”, è diventato – sia in forma diretta che in forma indiretta – l’unico gestore dell’illusione produttiva che i borghesi e la loro scienza definiscono come “produzione della ricchezza e suo impiego”.
Il vecchio strumento del mercato non regge più. Non è possibile dire: sono beni privati quelli che vengono regolati dalle leggi del mercato (quindi hanno un prezzo che copre i costi e determina un guadagno), e beni pubblici quelli che si reggono sulla base dell’imposizione tributaria (quindi servizi che lo Stato renderebbe al cittadino). È questa stessa inconsistenza del concetto di mercato capitalista che rende inservibile un’altra distinzione, quella tra beni che possono essere divisi e beni che sono indivisibili, inteso che si considerano beni pubblici quelli indivisibili. Ad esempio la presenza di un faro è bene pubblico in quanto il suo utilizzo da parte di una certa persona non diminuisce la possibilità dell’utilizzo degli altri. Questo concetto è assurdo in quanto non tiene conto che il faro può essere di volta in volta, secondo i punti di vista, un bene di mercato, in quanto entra nelle singole situazioni produttive a seguito delle modificazioni attive o passive che la sua produzione ha determinato (salari, produzioni collaterali, premi di assicurazione modificati, ecc.), e può essere un bene non identificabile come valore attraverso il meccanismo di mercato proprio perché risulterebbe difficile la quantificazione delle suddette modificazioni, che però, non per questo non esistono e non hanno conseguenze economiche.
Il difetto di questi ragionamenti sta nella pretesa di fondo che siano possibili produzioni di beni “astrattamente” pubblici, beni che non hanno un rapporto diretto con i processi produttivi in generale. Questo mito corrisponde specularmente all’altro, quello che afferma che siano possibili produzioni di beni per il mercato da parte di aziende private, senza che la cosa abbia conseguenze e generi rapporti di tipo più ampio (politici, sociali, fisici, ecc.).
Su queste illusioni si basa tutta la scienza economica, cavallo di battaglia della borghesia. Una volta che si entra all’interno delle sue contraddizioni ci si accorge che non esistono produzioni “pure”, né nel senso del mercato (beni privati), né nel senso del servizio extramercato (beni pubblici).
Allo stesso modo non si può parlare di una maggiore o minore ingerenza dello Stato (leggasi, del potere) nell’economia privata, ma si dovrebbe accennare (trattandosi di problema assai complesso, comunque non risolvibile in questa sede) ai rapporti che rendono possibile la produzione di svariatissimi beni (si fa per dire) all’interno della produzione globale di un bene unico, misura di tutti gli altri beni, in assenza del quale tutti gli altri beni, perdono di significato o acquistano valori profondamente diversi.
Ma questo bene non è la “merce” nella sua astrattezza, come non è il “capitale” nella sua astrattezza, o per essere più esatti il “denaro”. I tre termini del rapporto denaro-merce-valore sono significativi solo nella possibilità che diventi significativa la produzione di un altro bene che renda intelligibili sia la merce, sia il denaro, sia il valore della merce e del denaro.
A questo bene possiamo dare nomi diversi, e forse qualcun altro compagno riuscirà a trovare una terminologia migliore della nostra. Per il momento, in fase di prima approssimazione, preferiamo chiamarlo “pace sociale”.
Questo è l’unico, vero e solo “bene pubblico” cui la borghesia è interessata. La scienza economica, se bene indagata, studia proprio la produzione di questo unico bene, e ciò spiegherebbe la grande confusione che regna nei tentativi di separare gli studi sul mercato dagli studi sulla finanza pubblica.
Quando la produzione di questo bene è scarsa perché sempre maggiori quantitativi di strati sociali sfruttati impediscono quell’ideale produttivo che gli sfruttatori intendono raggiungere, le quantità e la composizione di ogni settore produttivo risultano modificate. Quando quella produzione cresce, arrivando a livelli ottimali per gli sfruttatori, si giunge al limite che anche il meccanismo stesso del mercato – con tutte le sue approssimazioni – sembra funzionare (non si dimentichi il lungo periodo del liberalismo inglese, fondato sul brutale sfruttamento delle colonie).
A nostro avviso non esistono aspetti specifici o settori dell’attività del potere (leggasi, dello Stato). Queste analisi interessantissime, sono analisi di tipo sociologico e possono avere grande valore strategico e pratico, ma non sono mai – in fondo – analisi di tipo economico. Un’analisi economica è necessariamente un’analisi globalizzante, in quanto, al di sotto dell’apparente eterogeneità delle produzioni e degli aggiustamenti in base alle conosciute leggi dell’economia, si sviluppa un’unica grande produzione, con un unico grande aggiustamento: la produzione della “pace sociale” che trova il suo ostacolo nello scontro di classe.
Se l’essenza del processo economico è, per gli sfruttatori organizzati in potere statale, l’ottenimento di un quantitativo sufficiente di “pace sociale”, la lotta non può separarsi in due tronconi: una lotta sul livello economico (tramite i sindacati) e una lotta sul livello sociale (tramite le organizzazione rivoluzionarie). È una divisione che non esiste in quanto presenterebbe un’azione fittizia a livello economico, smarrendo il senso profondo che lega le attività economiche alle attivita sociali, nel senso più ampio del termine.
Ad esempio, la fabbrica non è diversa dal carcere, dal manicomio, dal ghetto. Non si opera in alcune di queste istituzioni una “repressione” e in altre una “produzione”; ma in tutte si realizza un unico, generale, processo produttivo, quello della merce che rende possibili, esistenti, traducibili in concreto, tutte le altre merci: la merce che abbiamo definito “pace sociale”.
Quindi non è logicamente pensabile una lotta a livello economico separata dalle lotte a livello sociale.
Una gran conclusione, alcuni compagni potrebbero dire, conclusione che certo non necessita di tanti discorsi preventivi. E poi, anche gli stessi anarcosindacalisti hanno sempre affermato che le lotte non possono essere realizzate a livello settoriale, ma devono servire da collegamento tra i diversi settori del quotidiano.
Ma è proprio qui che si colloca l’ultima riflessione che vogliamo fare. Questa riprende l’alternativa lasciata in sospeso prima, quella tra lotte difensive e lotte offensive.
Immediatamente qualcuno potrebbe dire: nessun problema, le lotte che il sindacato anarchico si prefigge sono offensive, nessun rivendicazionismo fine a se stesso, nessun riformismo mascherato.
E questa risposta sarebbe ancora fuori dal raggio di quello che vogliamo dire.
In fondo, se ben consideriamo, nel suddetto concetto di analisi economica, in quelle poche righe che abbiamo tracciato sopra e che ci hanno portato a identificare, al di sotto della miriade dei fatti economici produttivi, un fatto unificatore dello sfruttamento, il fatto produttivo della merce “pace sociale”, in quel concetto è insito un principio globalizzante che costituisce l’elemento di leggibilità di tutto quello che agisce all’interno della dimensione fissata dallo stato attuale dello scontro. Cioè, se il potere intende produrre la merce principale che gli interessa (la pace sociale), gli sfruttati, ribellandosi, distruggendo i mezzi e le forme dello sfruttamento, non per questo escono – di colpo e magicamente – dal cerchio globalizzante della realtà dello sfruttamento stesso. Lo scontro di classe non si esaurisce fin quando non si romperà questo cerchio di significatività, fin quando non sarà portata a compimento la rivoluzione sociale, fin quando non solo si sarà limitata la produzione della merce “pace sociale”, ma si sarà interrotto il suo processo produttivo, completamente e definitivamente.
Fino a quel momento le ribellioni degli sfruttati saranno leggibili, nei termini della decodificazione assegnata dal potere, come produzione di un altro tipo di merce che (sempre in attesa di migliori nomenclature) possiamo, per il momento, definire come guerra di classe.
Difatti, negli interventi distruttivi che i compagni e le organizzazioni di lotta realizzano contro lo Stato, il potere opera decodificazioni molteplici e, in base alle leggi della sua scienza prediletta, l’economia, ne utilizza una parte in quanto merce (impiego massiccio attraverso l’informazione, ristrutturazione degli impianti colpiti, accelerazione dei processi di obsolescenza, aumenti degli organici, diminuzione della disoccupazione, ecc.).
Ma questa è una lettura che i padroni realizzano in termini economici, lettura che, per chi ne avesse voglia e tempo, potrebbe anche essere trasferita in simboli matematici e in grafici di grande chiarezza. Eppure resta l’altro aspetto del processo distruttivo, come – in senso contrario – resta l’altro aspetto del processo produttivo della pace sociale.
Questi altri due aspetti sono quelli che determineranno le possibilità della rivoluzione sociale. Il processo distruttivo se è decodificabile in quanto merce nel linguaggio dei padroni, è anche processo di crescita della coscienza e della scienza rivoluzionaria; come il processo della “pace sociale”, se è decodificabile, nella scienza dei padroni, come estensione all’infinito dello sfruttamento, è anche processo di crescita di quelle produzioni utili per la vita dell’uomo che saranno la base della società del futuro.
Ci pare sufficientemente chiaro, arrivati a questo punto, che la lotta difensiva non fa altro che arrecare il suo contributo alla produzione della merce “pace sociale”, nei termini in cui i padroni, intendono impostare questa produzione. Al contrario, la lotta offensiva, pur essendo, al momento, traducibile in merce e come tale trasferibile sul mercato borghese in cento modi diversi (tutti mistificatori), non è assorbibile in totale, e non arreca un incremento diretto alla produzione della pace sociale.
[Cfr. il mio articolo: “Spunti di critica economica alle tesi anarcosindacaliste”, in “Fronte Libertario della lotta di classe” n. 16, 1979, pp. 4-5]
Un movimento autogestionario?
Queste brevi riflessioni s’indirizzano verso il nucleo di quell’ipotesi di movimento autogestionario che si pretende indicare come di fatto esistente. Penso che questo movimento non esiste, o meglio, che nei limiti in cui ne esistono tracce o embrioni, questi siano l’esatto contrario di ogni forma possibile di autogestione.
Certo, un assunto del genere potrà sembrare arbitrario, ma non lo sarà più dopo una piccola riflessione.
Non basta costruire una struttura produttiva, quale essa sia, dalla casa occupata alla scuola libertaria, dalla banca alternativa alla cooperativa di produzione e servizi, alle autoproduzioni editoriali o musicali. Occorre anche che si individui in queste strutture un fondamento libertario, se non proprio anarchico e rivoluzionario. E questa base essenziale non può identificarsi con una dichiarazione di principio o con un simbolo. In altre parole non basta che un centro sociale si dica anarchico, o metta fuori la bandiera nera dell’anarchia, per essere tale. Occorrono altri due elementi.
Primo, che la pratica verso cui quella struttura si orienta sia realmente anarchica, quindi contraria al potere, irriducibilmente diretta ad attaccare quest’ultimo in tutte le sue forme. Secondo, che sia dal potere staccata in maniera decisiva, cioè che non si accordi con quest’ultimo in modo da ricevere finanziamenti, agevolazioni, statuti o altro.
Non si tratta di una questione di lana caprina. Non stiamo parlando del sesso degli angeli, ma di una cosa pratica.
Se una struttura entra in contraddizione con le istituzioni che la fronteggiano, non potrà mettersi d’accordo con queste. E se si mette d’accordo, cessa di entrare in contraddizione, cioè di essere rivoluzionaria e quindi anarchica.
Lo stesso vale per l’intero, ipotizzabile ma non reale, movimento autogestionario.
Questa tesi l’ho sostenuta più di vent’anni fa e resta immutata, perché non è stata ancora contraddetta dai fatti. Ma su cosa si basa? Si basa su di un fenomeno politico che diventa ogni giorno più evidente. Il potere non ha bisogno soltanto di servi umiliati e oppressi, ma anche di persone che pensandosi libere contribuiscano, spesso senza saperlo e volerlo, a mandare avanti la gestione della cosa pubblica.
Pensate alla funzione indispensabile che oggi svolgono le associazioni di volontariato. Così, diventa sempre più ampia l’aria del possibile recupero e utilizzo, in termini di mantenimento e gestione degli equilibri di potere, di strutture che si accordano con le istituzioni per fare il loro alternativo discorso di critica.
Nel momento in cui questi interessi del potere dovessero cambiare, o nel momento in cui l’azione pratica delle strutture autogestite dovesse diventare realmente pericolosa, tutti gli accordi salterebbero in nome del realismo politico, e si tornerebbe indietro, verso la repressione più brutale: ultima carta e ultima dea.
E con che cosa lotterebbero, contro un rincrudelimento repressivo, compagni disarmati da anni di chiacchiere, accordi e assurde fantasie di coabitazione?
Ben diverso è invece il progetto di quelle strutture gestite dalla frangia variopinta di marxisti e non marxisti, che si coprono con l’etichetta di “Autonomi”. Qui il riconoscimento delle istituzioni, e il dialogo aperto e programmato con loro, risponde a una strategia di medio e lungo termine. Strategia, prima di tutto, politica e di penetrazione nella realtà sociale, strategia che (con tutte le stupidaggini teoriche che vogliamo) ha almeno il pregio di essere conseguente con l’obiettivo che vuole raggiunge (per quanto questo sia del tutto fuori portata): cioè l’impadronimento e la gestione del potere politico.
Ma gli anarchici che cosa hanno a che vedere con questo tipo di strategia?
[Cfr. “Canenero”, n. 1 28 ottobre 1994, p. 4]
La banca etica
Una banca che garantisca una gestione del denaro attenta alla dimensione etica, inserita quindi in un progetto globale in cui la giustizia e la solidarietà siano gli scopi e l’autonomia e la nonviolenza i mezzi impiegati.
Questo bel programma è possibile?
Alcuni pensano di sì e si dedicano a realizzare questo tipo di organizzazione, cioè creano banche che possono, a loro dire, operare nel campo dell’economia in modo sociale e solidale, cioè in maniera di soddisfare necessità fisiche, culturali, affettive e spirituali e non il guadagno che di regola le banche commerciali ricavano dall’attività finanziaria.
Queste banche etiche non si prefiggono quindi il profitto, ma la realizzazione di un interesse sociale, in modo da evitare l’emarginazione, la disoccupazione, la distruzione dell’ambiente, favorendo la cooperazione tra società più avanzate e società meno avanzate, insomma realizzando un’armonia tra etica, politica ed economia.
Non è pensabile la gestione “separata” di un settore economico. Nessuno può realmente pensare di entrare nel mondo della gestione finanziaria mantenendosi rigorosamente separato dal sistema finanziario complessivo. Ciò è impossibile non appena si supera la cosiddetta soglia di significatività, cioè non appena la dimensione della banca o della rete bancaria alternativa diventa capace di costituire un punto di riferimento per l’offerta di denaro.
Il fascino di un credito alternativo risale ai tentativi pratici e alle elaborazioni teoriche di Proudhon, il quale comunque non si pose mai il problema sotto l’angolazione etica, ma invece lo sviluppò proprio come strumento di lotta contro lo strapotere del capitale. Coloro che invece si posero il problema etico della gestione economica non solo della finanza ma di tutta l’economia furono gli economisti di scuola cattolica, dal loro capostipite Toniolo, fino a Vito e fino a Parrillo, ultimo teorico ad avere formulato il problema in termini accettabili per il capitale. La stessa Santa Romana Chiesa ha più volte preso il problema, con tutte le cautele del caso.
A noi sembra che non sia possibile una gestione “etica” del denaro, per lo stesso motivo per cui non può esistere un modo non conflittuale di porsi nei riguardi del capitale e dell’economia nel suo insieme.
Basta leggere l’elenco di questi principi, definiti non a caso “etico-politici” dai loro stessi promotori, per rendersi conto di cosa stiamo parlando. “1 - Il mio denaro non deve essere semplicemente uno strumento lucrativo. 2 - Il mio denaro non deve servire per finanziare il commercio delle armi. 3 - Il mio denaro non deve mischiarsi ai capitali in fuga. 4 - Il mio denaro non deve sostenere dei regimi dittatoriali. 5 - Il mio denaro non deve speculare sulla povertà. 6 - Il mio denaro non deve sostenere attività ove sia presente denaro riciclato, derivante da attività illecite”.
Tutto ciò va bene, purché ovviamente il “mio denaro” resti il “mio” e purché mi si riconosca un adeguato interesse al lordo delle ritenute di legge.
Si può veramente autogestire e “umanizzare” il capitale? Chi scrive pensa seriamente di no.
[Cfr- “Canenero” n. 1, 28 ottobre 1994, p. 4]
La produzione snella
Fra le diverse caratteristiche di questi ultimi anni, si deve segnalare nella fabbrica (intesa in senso stretto) il fallimento dell’automazione globale, fallimento dovuto al venir meno delle prospettive, e se si vuole dei sogni, della produzione di massa.
L’impatto storico tra la telematica e la produzione fissa tradizionale (linee di montaggio rigide, poi automizzate fino a un certo punto con l’inserimento dei robot), non si è evoluto verso un perfezionamento delle linee di automazione, e ciò non per problemi di natura tecnica, ma per problemi di natura economica e di mercato. La soglia di saturazione delle tecnologie di sostituzione del lavoro manuale, non è stata superata, anzi sempre nuove prospettive si aprono in questa direzione. Invece, sono superate, e quindi diventano insignificanti per il modello economico del massimo profitto, le strategie della produzione di massa.
Quella flessibilità che la telematica garantiva, e che ha costantemente reso possibile nella fase di crescita della trasformazione postindustriale, a un certo punto ha causato tali profonde modificazioni nell’assetto del mercato, e quindi della domanda, da rendere inutilizzabili fino in fondo le aperture che la telematica stessa rendeva possibile, anzi poneva a portata di mano. Così, la flessibilità e la snellezza della produzione, dall’ambito della fabbrica si è trasferita nell’ambito del mercato, determinando un arresto dello sviluppo telematico dell’automazione, e un rifiorire di nuove prospettive della domanda, estremamente diversificate e fino a pochi anni fa del tutto impensabili.
Si ha adesso, come è facile constatare leggendo i resoconti agli azionisti di alcune grandi industrie, che l’automazione è ormai sostenibile solo a costi crescenti che in breve diventano antieconomici. Solo la prospettiva di perturbamenti sociali di grande intensità, potrebbe ancora spingere sul sentiero dissestato dell’automazione globale.
Per questo motivo, la riduzione dei costi di produzione è adesso affidata non alla diminuzione del costo del lavoro soltanto, come è avvenuto negli ultimi dodici anni a seguito di una massiccia sostituzione telematica, ma anche a una ragionata gestione delle cosiddette ridondanze produttive. Insomma, un’analisi spietata degli sprechi, sotto qualsiasi punto di vista, e, in primo luogo, anche dalla prospettiva dei tempi di produzione. In questa maniera, per vie diverse, la pressione produttiva si esercita ancora una volta sul produttore in carne e ossa, andando in frantumi l’ideologia di contenimento in base alla quale negli ultimi decenni si era accreditata alla tecnologia telematica un alleviamento delle condizioni di sofferenza e di sfruttamento da sempre caratteristiche del lavoro salariato.
La riduzione degli sprechi diventa quindi il nuovo scopo della produzione snella, a sua volta fondata sulla di già consolidata flessibilità del lavoro e sulla potenzialità produttiva garantita come base di partenza dall’innesto telematico. Ed è questa riduzione degli sprechi che cade interamente sulle spalle del produttore. Difatti, l’analisi matematica, realizzata anche attraverso i sistemi complessi ormai di ampio impiego nelle grosse industrie, può agevolmente risolvere i problemi tecnici dell’imprenditore, in altre parole quelli relativi alla combinazione di materie prime e di macchinari, in vista del mantenimento, ma la soluzione di questi problemi resterebbe fatto marginale alla produzione nel suo complesso, se non si mettesse a regime di controllo anche l’uso dei tempi di produzione.
Ancora torna quindi di moda, sia pure filtrato attraverso le nuove tecniche psicologiche e computistiche, il vecchio taylorismo. La flessibilità complessiva della grande industria, si basa su di una flessibilità settoriale delle diverse componenti, come pure sulla flessibilità della miriade di piccoli produttori che perifericamente supporta l’unità produttiva di comando. Il tempo di lavoro è quindi l’unità di base per la nuova produzione, il suo controllo, senza sprechi, ma anche senza esacerbazioni stupidamente repressive, resta la connessione indispensabile tra vecchio e nuovo modello produttivo.
Queste nuove forme di controllo hanno una natura pervasiva, cioè tendono a penetrare nella mentalità del singolo produttore, a creare le condizioni psicologiche generali perché al controllo esterno, fissato duramente attraverso una tabella dei tempi di produzione, si sostituisca man mano l’autocontrollo e l’autoprescrizione dei tempi e dei ritmi produttivi in funzione della scelta degli obiettivi, questa sì ancora fissata dagli organismi dirigenti l’unità produttiva. Solo che questi progetti decisionali possono ulteriormente essere sottoposti a una decisione democratica dal basso, interpellando i singoli lavoratori all’interno delle varie unità di produzione, allo scopo di radicare ancora più profondamente il processo di autodeterminazione.
Si parla così di una sorta di “sincronismo adattativo”, non realizzato una volta per tutte, ma affrontato di volta in volta, per singoli periodi produttivi, o per singole campagne o programmi di produzione, allo scopo di creare una convergenza di interessi tra lavoratori e datori di lavoro, convergenza da realizzarsi non solo sul terreno della produzione, ma anche su quello indiretto di una sollecitazione a qualsiasi titolo della domanda, cioè sul terreno del mercato.
Difatti è proprio nel mercato che si saldano i due movimenti interni alla nuova flessibilità produttiva. La vecchia fabbrica guardava a se stessa come al centro del mondo produttivo, e alle sue strutture, come l’elemento di rigidità da cui partire per conquistare sempre maggiori fette di consumi da soddisfare. Ciò, indirettamente ebbe a produrre un’ideologia operaiocentrica, gestita da un partito guida delle sorti del proletariato. Il tramonto di questa prospettiva ideologico-pratica non può essere oggi più evidente, non tanto per il crollo del socialismo reale, e per tutte le conseguenze dirette o indirette che ne sono seguite e che ne continuano a derivare, ma proprio per le modificazioni produttive di cui stiamo discutendo. Non c’è più quindi una distinzione tra la rigidità della produzione e la flessibilità caotica e imprevedibile del mercato. Ambedue questi aspetti sono stati ora ricondotti sotto il denominatore comune della variabilità e della snellezza. La maggiore capacità di incidere sui consumi, sia prevedendoli e sollecitandoli, sia frenandoli, permette di ricondurre l’antica caoticità del mercato a una flessibilità accettabile, per quanto non interamente prevedibile. Nello stesso tempo, l’antica rigidità del mondo produttivo si è modificata nella nuova sveltezza produttiva. Questi due movimenti si stanno incontrando in una nuova dimensione unificante, in cui si costruirà il dominio economico e sociale di domani.
[Cfr. “Canenero” n. 5, 25 novembre 1994, p. 8]
Spazio e capitale
Nello svolgersi delle vicende del capitale si può descrivere una vera e propria storia della funzione che lo spazio ha assolto nella logica produttiva. Dalle iniziali chiusure di grandi masse all’interno di spazi circoscritti, le prime manifatture, alle fabbriche industriali più avanzate, il capitalismo ha cercato di ritagliare porzioni di spazio per adibirle a uso specifico, cioè alla produzione di merci. Poi, con l’avvento dei recenti sviluppi postindustriali e con l’accumularsi del patrimonio tecnologico, la gestione dello spazio è profondamente cambiata. Dalla parcellizzazione si è passati alla gestione globale. In questo il capitale ha avuto il sostegno e il potere di razionalizzazione dello Stato.
Oggi, nessuna parte dello spazio resta separata dall’ingerenza del capitale. Dagli spazi siderali alle profondità oceaniche, dalle montagne ai fiumi, dai mari ai deserti, dalle grandi metropoli al più piccolo e sperduto villaggio, in questo modo, si intersecano e si coprono a vicenda infinite relazioni tra elementi che sembrano lontani fra loro, ma che sono legati dalla comune matrice di costituire elementi dello sfruttamento. Si può avere così l’illusione di andare in un posto lontano, fuori dal mondo, come si dice, e poi scoprire che anche in quel posto, perfettamente, arriva e funziona il meccanismo del capitale. Ciò spiega perché sono contro l’ecologismo come sono contro qualsiasi altra proposta alternativa che pretenda fare qualcosa contro lo sfruttamento, ritagliando una parte della realtà. Per fare qualcosa, occorre superare la parcellizzazione in cui la scelta globale dominante ci sta racchiudendo.
Ora, fra i furti realizzati attraverso lo sfruttamento, i più gravi perché gravidi delle maggiore conseguenze, sono il furto del tempo e quello dello spazio. Essendo non cose reali ma coordinate strumentali indispensabili alla vita nel mondo di tutti i giorni, la loro sottrazione significa riduzione delle possibilità vitali nell’ambito del campo. Il capitale ci ruba il tempo obbligandoci al lavoro e condizionando, fin nei minimi particolari, la nostra vita che viene infestata da orologi, impegni e scadenze. Rubandoci il tempo ci impedisce di capire noi stessi, ci estranea da noi stessi. Ci aliena. Senza il tempo anche il campo si sgancia dalla sensazione spaziale. Per accorgerci della presenza dello spazio abbiamo bisogno di tempo. Per pensare, per ascoltare, per sognare, per desiderare. Vivendo lo spazio in termini di distanze, di chilometri da percorrere, di spostamenti da un luogo a un altro, perdiamo di vista il nostro rapporto con gli oggetti e con quello che di costruttivo abbiamo realizzato. Non possiamo partire da nessuna immediatezza per andare verso una diversità.
Così ci rubano il tempo, perché ne hanno bisogno per la produzione, e ci rubano lo spazio, perché ne hanno bisogno dapprima come parcellizzazione dei luoghi produttivi, poi come sistema di controllo e repressione, infine come generalizzazione del consenso. Dovendoci riprendere il nostro tempo e il nostro spazio, riacquistando senso all’interno del campo, dovremo esproprialo, e ciò non potrà avvenire senza traumi e violenze. Il tentativo di rientrare in possesso è sempre causa di danneggiamenti e rovine. Il progetto di dominio, infatti, è progetto globale, non può accettare che qualcosa torni nelle mani degli espropriati, non può accettare spazi vuoti.
Fortunatamente, la strada repressiva è ancora lunga. Siamo solo agli inizi di un disegno che si fonda sulla divisione della realtà in due parti, anche fisicamente separate. Dopo l’impadronimento globale dello spazio e del tempo, il capitale li separa in due parti. Non si tratta più della vecchia parcellizzazione ma di una divisione netta. In questa prospettiva la classe dominante degli inclusi ha bisogno della totale disponibilità dello spazio. Nulla deve sfuggire al suo controllo.
Non solo. Il capitale dispone adesso di tecnologie che gli consentono non tanto il possesso fisico, puro e semplice, dello spazio, ma anche la sua riproduzione. Pensate alla capacità di operare in tempo reale comunicazioni tra due punti distanti migliaia di chilometri. Ciò modifica non soltanto l’assetto produttivo: qualità, varietà, creatività, stoccaggio della merce, ecc., ma anche, e principalmente, l’assetto umano dei rapporti sociali, che sono anche rapporti economici. Quindi, il capitale produce lo spazio sulla base del suo progetto di sfruttamento e di dominio. Trasforma la natura distruggendola, modifica le città e le campagne, distrugge i mari, i fiumi, i laghi, condiziona le distanze stellari alle sue logiche militariste. Poi, gli spazi così riprodotti. servono da incanalamento per gli individui. Così, ci ritroviamo nelle lunghe file di automobili, nelle autostrade, nelle code dei supermercati. Ci ritroviamo afflitti da caotici percorsi di viaggio, da appuntamenti che non possiamo mancare, da interessi fittizi che ci fanno stare in pena e ci obbligano a continui spostamenti privi di senso. Ci muoviamo all’interno di spazi che sono stati programmati per noi e che noi abbiamo solo l’illusione di avere scelto, le nostre case sono ripiene di oggetti inutili e dannosi. Lo spazio si è così ristretto o, meglio, si è modificato secondo le necessità della produzione capitalista, la quale deve vendere televisori, frigoriferi, lavatrici, stanze da letto e cucine.
Senza quasi accorgercene, il nostro tempo scompare nel nulla e il nostro spazio si riduce a rapporti con oggetti che testimoniano la potenza di convincimento del dominio. Veniamo educati, in questo modo, alla ripetitività. Facciamo gli stessi gesti, tocchiamo gli stessi oggetti, spingiamo gli stessi pulsanti. La ripetitività è, come tutti sanno, ma sistematicamente dimenticano, l’anticamera del consenso. Da parte sua, il capitale ci deve sottrarre lo spazio, ne è praticamente obbligato. E ciò perché non può lasciare spazi alla nostra creatività, alle nostre capacità di bricolage, al nostro desiderio di novità, che è lo stimolo per trovare soluzioni le quali, se all’inizio sembrano arrangiate, poi rivelano impensabili doti di spontaneità e di ricchezza. Se lasciasse spazio a queste forze dell’individuo non potrebbe raggiungere quei ritmi di ripetitività che sono indispensabili alla produzione, la quale è tale solo a condizione di potere essere anche ri-produzione. Pensate agli sforzi che ricorrendo alle tecniche elettroniche il capitale sta facendo per soddisfare i desideri di tutti con la massima diversificazione possibile, però centralizzata. e codificata. Le grandi marche di vestiti alla moda, le catene di fast food, la pubblicità che esalta i gusti del singolo all’interno della produzione di massa, sono tentativi di impedire altre strade, le quali sono oggi ancora percorribili.
La spazio che viene prodotto e ri-prodotto, si basa quindi sul consenso, ma possiede notevoli aspetti repressivi puri, nel senso poliziesco del termine. Il controllo regola i diversi flussi nel modo più stretto possibile. Le materie prime e gli uomini, le idee e le macchine, i soldi e i desideri. Tutto viene coordinato perché tutto è stato, preventivamente, omogeneizzato. Le differenze non sono più diversità radicali, ma si ritrovano ridotte al rango di apparenze e, in questa loro nuova veste, esaltate al massimo, come conquistato regno della libertà.
Cosa fare? Andare alla ricerca del tempo perduto? dello spazio perduto? Certo, ma non nel senso di un percorso nostalgico da ricostruire. Nella vita nessuna cosa si ripresenta in modo identico. Il vecchio rapporto con lo spazio lasciava una traccia. Un segno nel luogo fisico. Il segno dell’uomo e dei suoi oggetti. Una strada, una piazza, un crocevia di campagna, un fiume, lo stesso mare e il cielo, i boschi e le montagne, avevano un discorso aperto con l’individuo che sapeva, e voleva, ascoltarlo. E l’affinità con gli altri individui portava gli uomini negli stessi luoghi, ne animava i sentimenti, spronava all’azione e alla riflessione. Ci si ritrovava singoli, mentre adesso ci si nasconde come elementi di un insieme, di una folla. Una volta eravamo scoperti, spesso anche impreparati e vulnerabili. Adesso siamo sotto la copertura dell’uniformità, della ripetitività. Ci sentiamo più sicuri perché siamo nel gregge. Non esistono punti di riferimento nello spazio, nel tempo. Tutto sta per essere cancellato. I suoni, gli odori, i pensieri, i sogni. Tutto viene prodotto e ri-prodotto. Tutto sta per diventare merce.
[Cfr. “Anarchismo” n. 56, Inserto, pp. I-II]
La lotta della LIP
Cronologia
1867. Lipmann fonda una fabbrica di orologi. Vi lavorano 10 salariati. 1931. Costituzione della società LIP SA, 350 salariati. 1960. Apertura della nuova industria LIP a Besançon-Palente, più di mille salariati. 1967. Il gruppo svizzero Ebauches SA si appropria del 30% del capitale della LIP, poi del 43% nel 1970. 1968. Maggio e giugno sviluppano la resistenza dei lavoratori al paternalismo. 1969. Un primo tentativo di smantellamento è fronteggiato dai sindacati attraverso le normali lotte. 1970. A causa dei licenziamenti non potuti attuare la direzione cerca di rimangiarsi gli aumenti già concessi. Immediata risposta operaia. 1971. Partenza di Fred Lip al posto di presidente del consiglio di amministrazione, Saintesprit lo rimpiazza. Il nuovo presidente annuncia per il 1972 un “anno sociale”. 1972. La direzione chiede alle organizzazioni sindacali di mettere “in frigorifero” le loro rivendicazioni. Appaiono difficoltà nei settori dell’armamento e delle macchine utensili. 1973. Costituzione di un comitato d’azione sull’esperienza del maggio ’68 composto da sindacalisti e operai non iscritti al sindacati. (12 aprile) Si costituisce un comitato di sostegno nella città su iniziativa degli stessi lavoratori. (18 aprile) Dimissioni di Saintesprit. Il tribunale di commercio nomina due amministratori provvisori. I delegati di fabbrica si trasformano in militanti a tempo pieno. Si organizzano dei gruppi per la redazione di manifesti murali. Ogni operaio attacca i propri manifesti e se ne rende responsabile. (20 aprile) Gli operai rallentano la produzione. 800 orologi giornalieri al posto dei 2000 prodotti. (25 aprile) 500 lavoratori manifestano in Prefettura. (27 aprile) Stessa manifestazione con 1000 lavoratori. (10 maggio) Molti operai s’incaricano di diffondere le notizie della lotta nella città. Un gruppo di manifestanti si reca davanti al consolato svissero dove trova la polizia. (18 maggio) Alcuni lavoratori vanno in Svizzera e manifestano davanti alla sede della Ebauches SA a Neuchâtel. (24 maggio) Manifestazione a Besançon con 5000 partecipanti. (29 maggio) 500 lavoratori si recano a Parigi dove trovano la polizia pronta ad accoglierli. (12 giugno) Occupazione dell’industria. Sequestro degli amministratori provvisori. La polizia costringe gli operai a liberarli. Perquisizione nella borsa del direttore compiuta su iniziativa degli operai di guardia alla porta. Successiva perquisizione negli uffici del capo del personale, del presidente e degli altri dirigenti. (15 giugno) Grande manifestazione a Besançon con più di 15000 partecipanti. (17 giugno) Decisione di mettere in funzione una delle catene di completamento degli orologi. (18 giugno) L’assemblea generale approva l’utilizzo di uno stock di 2000 orologi come moneta di scambio. Si decide di rimettere in marcia la produzione dell’industria e di vendere gli orologi prodotti. Rottura con i quadri impiegatizi: soltanto quindici restano con gli operai. Si nominano 5 commissioni: a) produzione, b) manutenzione e sicurezza, c) propaganda, d) gestione, e) vendita. Riprende il lavoro in forma autogestionaria. (31 luglio) Il liquidatore della società impone l’obbligo di restituire gli orologi presi. (1° agosto) Ordine del presidente del tribunale del commercio di arrestare la produzione. Il ministro Charbonnel presenta un piano per impiegare in altre società una parte degli operai. (2 agosto) Denuncia del liquidatore contro ignoti per il pagamento “selvaggio” dei salari effettuato dagli stessi lavoratori con il ricavato della vendita degli orologi. (8 agosto) L’ufficiale giudiziario cerca di apporre i sigilli ma è scacciato dai lavoratori che occupano l’industria. Conferenza nazionale dei sindacati a Parigi sulla LIP. I documenti sequestrati alla direzione vengono discussi pubblicamente in assemblea. (14 agosto) Scontri tra polizia e manifestanti. Approfittando del “ponte” festivo la polizia opera un colpo di mano occupando la fabbrica senza che la notizia susciti troppo scalpore nel paese. La fabbricazione degli orologi è sospesa. Si cercano gli orologi nascosti dagli operai. Un giornalista della “France Presse” è condotto (bendato) dagli operai presso una fabbrica allestita clandestinamente in un altro posto. Lo stesso avviene con due operatori della televisione. (22 agosto) I sindacati comunicano che la fabbricazione degli orologi continua nelle piccole fabbriche clandestine. (23 agosto) Sciopero nazionale. Sciopero di 24 ore della televisione che interrompe il silenzio solo per trasmettere comunicati sulla LIP. Denuncia di 103 operai arrestati nel corso di scontri con la polizia. (24 agosto) 32 persone condannate a pene da 3 giorni a 3 mesi. (30 agosto) Secondo pagamento dei salari. 1973. (1° settembre) Nuova proposta del governo: riduzione dei licenziamenti da 500 a 350. (2 settembre) Manifestazioni di solidarietà a Billancourt (Renault), Lione, Digione, ecc. Lo stesso avviene in Svizzera. (7 settembre) Manifestazione di operai a Parigi.
Nel corso delle lotte della LIP, come si può vedere dalla cronologia sopra riportata, al di là dei risultati, c’è stato uno sviluppo metodologico assai interessante che, grosso modo, si può riassumere in due aspetti: a) impadronimento violento delle informazioni da parte della base; b) tentativo attuato di autogestione della produzione sempre da parte della base.
Contrariamente a tutte le cose che sono state scritte su questo “fenomeno LIP” sia all’estero che in Italia, il nostro compito non è né quello di dare una informazione generica più o meno attendibile (cosa questa per la quale sarebbe stata sufficiente la sola cronologia), né una esaltazione trionfalistica dei risultati ottenuti che, in ogni caso, sarebbe nociva per l’avvenire stesso delle lotte operaie. Non a caso, infatti, i sindacati e, sulla loro scia, i partiti riformisti di buona parte d’Europa, si sono lanciati sulla notizia speculandone sotto tutti gli aspetti i lati positivi e annegando la vera realtà dei fatti “rivoluzionari” sotto una congerie di “evviva” e di “finalmente”, con l’immancabile riferimento al maggio 1968, trascurando di aggiungere che quell’ormai lontano “avvenimento” fu proprio da loro ucciso nella più intima spontaneità di rivolta.
In una dichiarazione alla stampa, riportata da “Le Monde” del 18 settembre 1973, Piaget, responsabile confederale della C.F.D.T., diceva: «Il Maggio ’68 ci ha fatto scoprire che i lavoratori debbono avere una maggiore audacia, che essi hanno dei diritti ai quali non osano credere perché i padroni hanno loro inculcato l’idea che non è possibile pretenderlo». E più avanti: «A partire dalla LIP, altre tappe saranno raggiunte dalla classe operaia fino a quando i lavoratori non prenderanno su di loro tutta l’economia, e ciò non sarà che giustizia».
È opportuno ricordare qui il breve scritto programmatico a firma “Gruppo di ricerche sull’autogestione”. Dopo il Maggio francese del 1968 il termine “autogestione” è diventato di moda specie in Italia, i princìpi dell’autogestione sono spesso richiamati come qualcosa di noto, sebbene esistano pochi lavori seri intorno ai problemi economici che scaturiscono da una prospettiva autogestionaria. Il più delle volte ci si riduce a un concetto vuoto. Non sappiamo “come” attuare l’autogestione, non sappiamo “perché”, non sappiamo “a profitto di chi”. Una volta erano soltanto gli anarchici a teorizzare e cercare di realizzare l’autogestione. Oggi tutti parlano di questo “problema fondamentale”: i partiti riformisti, i sindacati, i teorici della sinistra. Il nostro “Gruppo di ricerche sull’autogestione” cercherà di dare un modesto contributo al problema, illustrando le varie tendenze, i risultati ottenuti con le realizzazioni del passato, le prospettive del futuro, gli spunti autogestionari nel corso di lotte operaie presenti, i diversi punti di vista teorici.
Abbiamo di già accennato quali sono le perplessità che sorgono davanti alla parola d’ordine “autogestione”, sbandierate dai riformisti come prospettive per le lotte del proletariato. Che l’autogestione debba servire a costruire la società di domani è cosa certa, ma che possa riuscirci da sola è una delle tante illusioni che i padroni e i loro servitori costruiscono per tenere a freno la spinta rivoluzionaria delle masse.
L’autogestione in regime di sfruttamento capitalista, per quanto possa assumere aspetti diversi, non è altro che “l’autogestione del proprio sfruttamento”. Questa parola diventa allora priva di contenuto.
Ma la LIP ci offre la possibilità di una riflessione più profonda, al di là di voli teorici che non riguardano il presente lavoro. In quella situazione, nel corso dell’occupazione dell’industria, il lavoro venne ripreso in parte e la produzione degli orologi venne organizzata dagli operai (i quadri tecnici e impiegatizi erano sostanzialmente assenti in quanto su circa 300 soltanto 15 restarono dalla parte degli operai occupanti l’industria). Non solo, ma la radicalizzazione della lotta portò all’espediente di creare delle officine clandestine, fuori del complesso produttivo, officine formate con materiale e strumenti sottratti all’industria stessa. Ci rendiamo conto che questa possibilità non è sempre attuabile specie quando si tratta di industrie che producono oggetti voluminosi, però, dal punto di vista della metodologia della lotta e di ciò che si intende per “autogestione”, la cosa ci sembra della massima importanza.
Gli stessi sindacati – una volta assicuratosi che a lotta assumeva uno svolgimento non più recuperabile con i normali mezzi e constatato pure che tutto il paese seguiva gli avvenimenti di Besançon, non avendo nulla da temere nel dirsi d’accordo con un atto illegale che trovava consenziente lo stesso vescovo della città ne assunsero la paternità teorizzandone la validità e portando – nei luoghi di produzione clandestina – giornalisti e operatori TV, opportunamente bendati. Messa in scena che nulla toglie però alla sostanziale validità dello strumento di lotta, voluto e attuato dalla base e poi, come sempre, recuperato dai burocrati sindacalisti.
Oggi non si parla più della LIP: l’ordine regna a Besançon, ma si può essere certi che quegli avvenimenti saranno tenuti presenti nelle lotte di domani. Un piccolo punto di riferimento ma sempre qualcosa: un passo avanti verso la liberazione della classe lavoratrice attuata da essa stessa, senza intermediari e senza rappresentanti.
Documenti
I documenti che qui di seguito pubblichiamo in traduzione sono stati trovati dai lavoratori della LIP nel corso delle loro perquisizioni negli uffici della direzione dell’industria occupata.
Il commento che accompagna ogni documento è diretto soltanto a inquadrarlo da un punto di vista tecnico e politico nello svolgimento complessivo delle lotte che precedettero l’occupazione stessa. Non ci è sembrato opportuno aggiungere considerazioni di altro genere.
Documento n. 1
Lettera degli amministratori provvisori diretta alla TV francese datata 29 maggio 1973, nella quale si vede la preoccupazione che fatti interni della LIP e le sue difficoltà diventino di dominio pubblico. Ecco il testo della lettera:
«Nel corso di un colloquio telefonico ci è stata confermata la voce di una Vostra intenzione di fare un reportage sulla Società LIP. Nello stesso tempo ci avete confermato che questa Vostra intenzione faceva oggetto di una lettera che ci è stata indirizzata e che fino a oggi non abbiamo ricevuto.
«Comunque, senza attendere quest’ultima, crediamo nostro dovere confermarVi quanto faceva oggetto del suddetto colloquio telefonico riguardo la nostra posizione.
«Il Vostro desiderio d’informazione è perfettamente legale e comprendiamo benissimo lo spirito che Vi anima, ma dovete ammettere che da parte nostra vi sono ugualmente, nel quadro del mandato di giustizia che ci è stato conferito, delle necessità che ci spingono a prendere tutte le disposizioni per meglio salvaguardare la Società e in particolare il suo marchio di fabbrica. Per questo ci pare inopportuno oggi reportage effettuato all’interno della Società LIP, di cui siamo gli amministratori.
«Vi preghiamo di credere Signor Direttore regionale...».
Documento n. 2
Nel 1967 la società Ebauches, svizzera, acquista una partecipazione del capitale LIP. Il piano di questa impresa è quello di creare un grosso complesso multinazionale capace di fronteggiare la concorrenza degli Stati Uniti e del Giappone nel settore degli orologi. In via subordinata il suo interesse è quello di penetrare nel mercato francese dove gli orologi svizzeri trovavano una collocazione inferiore alle previsioni. Ma la LIP non fa solo orologi, essa ha anche un settore di produzione di macchine utensili. Questi due settori non interessavano alla Ebauches: da ciò la decisione di chiuderli.
Tra le carte sequestrate sono stati trovati gli appunti di alcune riunioni dove alcuni dirigenti avevano segnato le istruzioni ricevute dagli amministratori della società dominante della Svizzera, il 7 marzo 1973.
Il documento che presentiamo è costituito da un foglio annotato a mano dove si legge, tra l’altro, quanto da noi tradotto:
«Interessarsi unicamente dell’orologeria.
«Lasciar cadere l’industria meccanica.
«Lasciar cadere i settori annessi sopratutto quelli degli equipaggiamenti».
Documento n. 3
Stessa origine di questo documento. Esso si riferisce a una riunione tenuta l’8 giugno 1973 sempre con i responsabili della società svizzera e sempre riguardo la sorte dei settori annessi.
Anche questo documento è un foglio scritto a mano dove si legge:
«Diminuzione del numero del personale dell’orologeria.
«400 persone da licenziare».
Documento n. 4
Memorandum relativo alla LIP redatto dalla Ebauches SA riguardante la situazione della società francese al 18 maggio 1973, Il documento porta la data del 21 marzo 1973 e, dopo un esame relativo alla cifra di affari della LIP e alla sua situazione finanziaria, alla pagina 3 e alla pagina 5, leggiamo:
«Pagina 3:
«Bisogna precisare che le misure dirette a scaricare la società [LIP] del suo numero di lavoratori troppo eccessivo (1310 persone a oggi) e ad alleggerirla dei pesi di struttura troppo pesanti, non si sono potute attuare all’inizio del 1973 a causa delle elezioni francesi, da cui un ritardo di tre o quattro mesi.
«Pagina 5:
«Ebauches SA è pronta a partecipare a una soluzione che permetta alla LIP SA di superare questi momenti difficili, permettendo alla società bisontina di continuare, in condizioni valide, lo sfruttamento unicamente del settore dell’orologeria».
Documento n. 5
Lettera di risposta ai sindacati scritta da un deputato di Besançon in data 9 marzo 1913. Dal tono della lettera si capisce che le elezioni legislative del marzo 73 pesano sulle eventuali decisioni da prendere in merito alla LIP e alla sorte del lavoratori:
«Signor Segretario.
«Ho ricevuto la Vostra lettera del 28 febbraio e del 3 marzo 1973 ed ho analizzato il documento che mi avete trasmesso con la più grande attenzione.
«Il problema che sollevate mi preoccupa, penso che si tratti di cosa assai grave e che tutti siano d’accordo a mantenere l’integrale attività della LIP.
«Non mancherò d’intervenire efficacemente dopo le elezioni nel caso che sarò rieletto.
«Restando sempre a Vostra disposizione».
Documento n. 6
Si tratta di una lettera “personale e confidenziale” indirizzata da Fred Lip a due dei 5 amministratori facenti parte del consiglio di amministrazione della società, qualche giorno prima della riunione del 26 febbraio 1969. La lettera porta la data del 22 febbraio. Essa è utile per capire come le discussioni fatte in consiglio, con la partecipazione dei delegati sindacali non rappresentavano affatto la “realtà aziendale”, non solo per questi ultimi ma anche per buona parte degli altri amministratori.
«Prima del consiglio eccovi uno schema per nulla ufficiale che sottopongo alla Vostra riflessione.
«Ciò a titolo personale.
«Io presenterò, con la Vostra approvazione, al consiglio, una versione meno ottimista ma più ammorbidita di quella qui unita.
«StateVi bene».
Documento n. 7
Lettera di Fred Lip a un direttore di sezione in data 22 aprile 1967. Si tratta di un documento quanto mai interessante per capire la mentalità paternalistica e medievale con la quale veniva condotta la gestione. Lip si preoccupava di costituire un piccolo gruppo, tra i dipendenti, più elevati in grado, da lui chiamato “terzo collegio” da utilizzare come strumento di potere all’interno dell’azienda.
La scoperta di documenti come questo e i due successivi, causano una forte spinta di ribellione nei lavoratori i quali non s’immaginano neppure quanto essi siano frequenti e quanto un comportamento come quello di Fred Lip sia la regola generale:
«Mio caro A.
«Vi confermo quanto ha fatto oggetto della nostra conversazione di ieri:
«1) Verrete sempre in ufficio con la Vostra auto personale, un impiegato della LIP non viene a piedi o in autobus;
«2) Desidero che la Vostra famiglia e Voi stesso comprendiate che il Vostro destino è lo stesso della LIP...
«3) Al fine di farVi abituare alla Vostra nuova vita Vi incoraggio portando il vostro stipendio a 6.000 franchi mensili...
«Gradite, caro A., i sensi...».
Documento n. 8
Conto di liquidazione di un dipendente. Da notare due cose: a) il preavviso è stato regolarmente pagato ma non preteso come lavoro dalla società; b) è stata pagata una “indennità di licenziamento” forfettaria, cioè non commisurata all’effettiva anzianità del soggetto. Non si possono sapere i “veri” motivi di un tale trattamento particolare:
«Conto liquidazione del sig. P. Maurice.
«Indennità di preavviso non effettuato 6 mesi FF. 48.000. Diversi (indennità di licenziamento) FF. 135.000.
Documento n. 9
Legato al precedente o riguardante la stessa persona. Dichiarazione della direzione LIP con la quale si solleva il dipendente di cui alla precedente liquidazione dell’obbligo della non concorrenza:
«Signore.
«Vi informiamo che vi dispensiamo espressamente di rispettare la clausola della non concorrenza figurante nella nostra lettera del 21 aprile 1954.
«Vi preghiamo gradire...».
Documento n. 10
Si tratta del conto di liquidazione del genero di Fred Lip, Bernard Vidal, che figurava prima come dipendente della ditta. Questo documento e i seguenti due si collegano ai rapporti personali di Fred con la sua famiglia e i suoi amici. Questi rapporti costavano cifre enormi alla società ed erano, ovviamente, del tutto ignorati dal personale. La loro scoperta presenta le caratteristiche di un nuovo orizzonte che si apre davanti alla volontà di lotta degli operai, dapprima ipnotizzati dal paternalismo socialdemocratico dei Lip:
«Conto liquidazione del sig. Vidal Bernard.
«Indennità di licenziamento: FF 138.000.
«Indennità di preavviso (senza altra indicazione): FF. 45.000.
«Saldo salario: FF. 15.000.
«Indennità congedo pagato: FF. 3.750».
Documento n. 11
Lettera indirizzata a Maurice Bokanowsky, ex ministro, amico personale di Fred Lip, figurante come consigliere della società e in pratica gratificato di una certa cifra mensile. La lettera è del 12 febbraio 1970:
«Signore.
«Abbiamo l’onore di informarvi che conformemente a quanto previsto dalla legge in vigore, forniremo alle Imposte Dirette un prospetto indicante gli onorari pagatevi per l’anno 1969 dalla nostra società.
«I versamenti che vi abbiamo fatto nel corso dell’anno passato a titolo di onorari, ammontano FF. 48.000 (quarantottomila).
«Salvo indicazioni contrarie da parte vostra consideriamo esatta la cifra sopra riportata.
«Vi preghiamo...».
Documento n. 12
Lettera del 22 febbraio 1964 di Fred Lip a H. Ottonio, capo del personale. Inizia il controllo poliziesco all’interno dell’imprese:
«...Dopo il grosso sciopero vi prego di farmi avere, senza complicazioni un prospetto indicante il numero dello persone che hanno abbandonato l’industria, uomini e donne, nelle due categorie, generici, manovali e specialisti, allo scopo di sapere non tanto i nomi quanto il numero di coloro che erano e non erano tra gli scioperanti.
«Una volta che sapremo il numero delle persone che hanno lasciato l’impresa e che erano scioperanti, sapremo di quanto diminuirà il numero totale degli scioperanti reali, di coloro che non hanno partecipato a tutti gli scioperi, conoscendo in questo modo in anticipo il loro comportamento».
Documento n. 17
Lista di dettaglio di tutti i momenti di uno sciopero della sezione confezionamento, datata 27 settembre 1965. Questa lista rinvenuta tra il materiale sequestrato, dà la prova della collusione tra la direzione dell’impresa, la polizia e l’ufficio del lavoro. Quello che per molte industrie è solo un fatto presunto, per la LIP è un fatto provato:
«Sciopero dei confezionatori.
«Giovedì 23 settembre 1965, ore 15,55 uscita di 10 confezionatori.
«...
«Lunedì 27 settembre 1965, ore 15,05, colpo di telefono della polizia (tra parentesi – non chiaro – il nome del commissario che ha passato la comunicazione relativa allo stato di sviluppo dello sciopero).
«Stesso giorno, ore 16, visita del commissario Jovet e del suo aiuto.
«Martedì 28 settembre 1965 telefonata della polizia (Jovet).
«Mercoledì 29 settembre 65, ore 8,10 ricevuta telefonata dalla Gendarmeria di Chaprais annunciante la ripresa dello sciopero.
«Stesso giorno, ore 9. Telefonato alla polizia (Jovet) per annunciare la ripresa dello sciopero».
Documento n. 14
Nota della direzione in data 29 ottobre 1970 con la quale si autorizza uno sconto speciale:
«Vogliate fatturare al sig. R..., della polizia, l’orologio 42287 con lo sconto del 42%».
Documento n. 15
Carta da visita di un ufficiale di Polizia in pensione inviata alla direzione della LIP. Lo stesso tono usato dai fattorini che chiedono la mancia:
«Polizia Privata. Agenzia privata di ricerche e investigazioni.
«Georges (autorizzazione ministeriale)...
«M. Georges, ufficiale di polizia, presenta i suoi complimenti alla Direzione generale».
Documento n. 16
Nota diretta alla direzione dell’impresa redatta dopo le elezioni del comitato interno. Nella nota sono importanti i “profili” dei nuovi rappresentanti dei lavoratori:
«Nuovi delegati del comitato di fabbrica.
«... CGT
«41 anni. Servizio 251/controllo forniture... Assunta il 22 agosto 1966. Nota del capo reparto: professionalmente buona, contestatrice, cattivo carattere.
«... CGT
«46 anni. Servizio 359/meccanico rettificatore. Assunto il 17 marzo 1969. Nota del capo reparto: professionalmente mediocre, tipo contestatore.
«... CFDT
«21 anni. Servizio montaggio orologeria. Assunto il 13 settembre 1965. Nota del capo reparto: professionalmente buono, tipo proletario, anticapitalista.
«... CFDT
«23 anni. Servizio montaggio orologeria. Assunto il 13 giugno 1966. Nota del capo reparto: professionalmente buono, difficile da trattare».
Documento n. 17
Lettera del prefetto della Franca Contea al sindaco di Besançon, in data 3 maggio 1973. Tra l’altro vi si legge:
«... Sarà bene che i dipendenti uniscano i loro sforzi ai nostri allo scopo che tutti insieme si riesca a concretizzare le nostre intenzioni costruttive e si pervenga a risultati positivi: la situazione della LIP è in effetti preoccupante, ma io ho l’intima convinzione che la Ditta può essere salvata a prezzo di una coraggiosa ristrutturazione della quale io sono partigiano e alla quale credo la Vostra Signoria non mancherà di associarsi».
Documento n. 18
Rapporto in data 17 maggio 1973 sugli avvenimenti del giorno precedente:
«A seguito agli incidenti avvenuti nella notte tra il 16 e il 17 maggio 1973, attiriamo la vostra attenzione sulla impossibilità di garantire la sicurezza all’interno della società.
«Il guardiano si è trovato nella necessità di chiudersi nel proprio sgabuzzino a seguito delle minacce di un gruppo di una trentina di persone (uomini e donne) che tentavano di penetrare nella fabbrica. Pensiamo si sia trattata di una manovra di diversione allo scopo di permettere a un gruppo di entrare all’interno, tramite effrazione, nei locali degli uffici spedizione, per sconfezionare i pacchi pronti e distruggere le bolle di spedizione.
«Questo fatto non è il primo, per cui attiriamo la vostra attenzione sull’impossibilità materiale del servizio di guardia di assicurare un’efficace sorveglianza, e sui rischi che si possono correre in certe situazioni, una volta che i guardiani sono stati oggetto di minaccia da parte di questi gruppi. Precisiamo che questi guardiani sono armati e che non possiamo rispondere del loro comportamento.
«Riguardo il servizio “sicurezza incendio” fino a oggi l’abbiamo assicurato a mezzo di frequenti ronde, ma ora non possiamo continuare nello stesso modo per cui i rischi sono aumentati anche in considerazione del fatto che molte persone circolano all’interno della fabbrica fumando.
«A causa della presenza costante di questi gruppi all’interno della società, è bene che i locali dove si lavora per la Difesa Nazionale siano chiusi a chiave, in quanto pensiamo che ci sia impossibile garantire la sicurezza o la difesa di questo punto delicato.
«Sarà opportuno che le autorità prendano dei provvedimenti allo scopo di assicurare la custodia di questo settore con le forze di polizia, essendo chiaro che noi ci troviamo in una situazione particolare. È bene che i documenti segreti o confidenziali della Difesa debbono restare chiusi nello cassaforte murata, non potendone più garantire la custodia in altro modo».
Documento n. 19
Lettera del 18 maggio 1973 degli amministratori provvisori agli operai della LIP:
«Dopo il 17 aprile, data della nostra designazione come amministratori provvisori della Società dal Presidente del Tribunale di commercio di Besançon, è in corso un’agitazione permanente, tanto sul posto di lavoro che all’esterno della fabbrica.
«Questa agitazione, nel suo insieme, perturba considerevolmente l’attività e rallenta notevolmente la produzione.
«Essa porta un grave pregiudizio alla Società compromettendo le possibilità di consegna e di fatturazione indispensabili per la continuazione dell’attività produttiva e ciò, per tutti i settori dell’industria. Parallelamente, essa rende più ardua ancora la nostra ricerca di una sana soluzione per l’avvenire della Società e del suo personale.
«Più l’industria si degrada e meno possibili partner saranno ad essa interessati.
«È dunque essenziale che l’attività sia continuata nel difficile momento che stiamo attraversando, che ogni collaboratore resti al suo posto e assolva normalmente al suo compito.
«Dobbiamo inoltre ricordare che da questo momento solo le ore di lavoro effettivo saranno pagate.
«Desiderio della maggior parte di voi è quello di lavorare, lo scopo degli amministratori, della Direzione e degli impiegati superiori quello di assicurare il lavoro per tutti».
Aspetti tecnici dell’autogestione realizzata alla LIP
Il breve periodo in cui si realizzò un saggio di lavoro autogestito alla LIP è stato oggetto di un vero fiume d’inchiostro. Molte parole sono state spese per sottolineare il significato “politico” di questo atto degli operai di quell’industria, molte conclusioni affrettate e assurde sono state tratte.
A nostro avviso, la cosa più importante resta il fenomeno in se stesso, con i problemi relativi. Degni di attenzione, quindi, sia la ripresa della produzione come pure la difesa di questa produzione dai tentativi dei padroni di appropriarsene.
Per questa breve e schematica esposizione ci serviremo del materiale pubblicato a cura degli stessi lavoratori della LIP nei 7 Bollettini stampati dal 11 giugno al 23 agosto 1973. Naturalmente ci limiteremo a tradurre solo le note relative alla produzione autogestionaria e ai suoi problemi.
Bollettino n. 1 dell’11 giugno 1973
«Soltanto noi possiamo garantire la qualità degli orologi. I padroni ci accusano di sabotare gli orologi che produciamo e che vendiamo. Ora, questi orologi sono prodotti con le stesse identiche caratteristiche di sempre. Al contrario è la direzione della LIP che mette in commercio orologi sui quali decliniamo ogni responsabilità. Solo noi, lavoratori della LIP, possiamo dare e garantire la qualità.
«L’attività nella fabbrica è assicurata da diverse commissioni (propaganda, ricevimento, gestione, produzione, vendita, sicurezza e manutenzione) alle quali accedono tutti i lavoratori. Ogni commissione si riunisce ogni mattina alle 8 per fare il punto e distribuire il lavoro. Funziona sotto il controllo dell’assemblea generale dei lavoratori che si riunisce tutti i giorni alle 14.
«Commissione produzione. Ad oggi circa trenta volontari assicurano la produzione e sono sufficienti per il lavoro che bisogna fare. Tra quindici giorni avverrà l’avvicendamento.
«Commissione vendita. Consigli ai compratori. Dal 2 giugno al 30 giugno sono stati venduti 14.216 orologi per un totale di FF 2.216.979 [pari a circa 300.000.000 di lire italiane dell’epoca]. A causa dell’affluenza notevole si è dovuto limitare a due ore soltanto la vendita a singoli compratori (dalle 10 alle 13). Sino alle 17 continuano le vendite nei Comitati d’Azienda il sabato pomeriggio e la domenica.
«In questo modo si è reso disponibile un maggior quantitativo d’oro por le ordinazioni collettive. Ciò impedirà che alcune delegazioni ripartano con meno orologi di quelli ordinati, come è accaduto spesso. Ricordiamo che non è più possibile soddisfare le richieste sul campionario in quanto diversi modelli si sono esauriti e non sono disponibili tutti i giorni. Chiediamo ai Comitati d’Azienda di presentarsi con una somma globale e una indicazione globale del numero degli orologi con la indicazione del tipo desiderato: 1) uomo o donna, 2) meccanico, automatico e elettrico, 3) forma, 4) bracciale in acciaio o no.
«I membri della commissione vendite faranno il possibile per darvi ciò che corrisponde alle indicazioni. Per le ordinazioni individuali bisogna passarle alle sedi CGT e CFDT del vostro dipartimento che faranno una ordinazione raggruppata.
«Queste decisioni sono state prese in assemblea su proposta della commissione vendite, dopo l’organizzazione del lavoro è migliorata sensibilmente con miglioramento anche delle altre commissioni (gestione, stock, ecc.).
«Speriamo che in questo modo le delegazioni avranno più tempo per informarsi della lotta della LIP e riferirci sulle lotte aziendali nelle rispettive loro sedi di lavoro».
Bollettino n. 2 del 19 luglio 1973
«Commissione posta. Più di 300 lettere arrivano ogni giorno. È impossibile rispondere a tutte. Ogni giorno partono circa 200 risposte con precedenza alle lettere con unito il francobollo o con assegni e a quelle pervenuteci dai Comitati d’Azienda.
«Commissione produzione. La produzione va avanti con un certo ritardo. La catena “montaggio-casse” è ferma. Fino al 1° agosto si farà solo la rifinitura, la messa in opera dei cinturini e il controllo.
«Commissione vendita. La vendita continua tutti i giorni escluso sabato e domenica dalle 10 alle 14 per i privati e dalle 10 alle 15 per Comitati d’azienda che sono meno numerosi adesso perché in periodo di vacanze. Alcuni Comitati sono al loro secondo o terzo viaggio. Dal 10 luglio sono stati venduti 10.106 orologi per un totale di FF.1.467.388.
Bollettino n. 3 del 27 luglio 1973
«Rianimare il Comitato d’azione. Questo ha funzionato un poco al rallentatore causa il numero limitato dei lavoratori presenti in fabbrica e di un gran numero di membri nelle commissioni. In ogni caso, anche se al rallentatore, esso ha continuato la sua marcia.
«Un numero sia pure piccolo dei suoi partecipanti ha continuato a incontrarsi durante il mese di luglio per continuare lo studio del senso della lotta e per stabilire i concreti mezzi di azione. Un grande impegno l’attende dopo il 1° agosto quando assisteremo al ritorno di una gran parte dei lavoratori. Sarà allora indispensabile riprendere le riunioni del Comitato che, come siamo tutti convinti, consentono una più ampia partecipazione e quindi una maggiore democrazia, sempre in vista dell’assemblea generale. Una assemblea generale molto pesante forse a causa del sonno relativo del Comitato d’azione.
«L’attività nella fabbrica: trasporti. Il servizio di autobus riprenderà lunedì 30 luglio alle 7 come normalmente.
«Commissione produzione. Circa venti lavoratori continuano una produzione diretta a rifinire, mettere i cinturini e controllare, come per il periodo precedente. Funziona anche un servizio dopo-vendita limitatamente agli orologi fabbricati e venduti attualmente. Per celebrare i 100 giorni di lotta, 100 orologi sono stati incisi e messi in vendita con l’iscrizione “100 giorni di lotta 17-4 / 25-7-73”.
«Commissione vendita. Continua la vendita degli orologi dalle 10 alle 15. Dal 23 al 25 luglio si sono incassati FF 120.766».
Bollettino n. 4 del 2 agosto 1973
«Facciamo la paga da noi stessi con 24 ore di anticipo. Alle ore 8,30 del l° agosto l’Assemblea generale (riservata solo al personale LIP) decide sul pagamento dei salari di giugno rifiutato dal liquidatore. La decisione di darci la paga direttamente se non veniva data dalla direzione era già stata presa fin dalla fine di giugno. Ciò che era in discussione era la maniera di fare la paga. Si sono avute diverse proposte. Eccole:
«1) alcuni proponevano un salario uniforme di 1.500 franchi [circa 200.000 lire dell’epoca], altri che avrebbero aumentato certi salari e diminuiti certi altri, infine si aveva anche qualcuno che sosteneva una diminuzione generale del monte salari;
«2) proposta dei salari abituali con una diminuzione del 10%;
«3) proposta che ciascuno dicesse di quanto aveva bisogno;
«4) proposta di fare la stessa paga di prima il più rapidamente possibile perché non c’era tempo di riflettere seriamente anche per la prossima partenza del personale per le vacanze.
«Si è deciso in queste condizioni di pagare salari abituali che la vecchia direzione ci doveva.
«Ecco il bollettino diramato dai sindacati:
«1) Si tratta della paga di Giugno che è stata oggetto di lunghe controversie con il liquidatore
«2) L’Assemblea generale ha ripiegato sulla paga in corso data la situazione attuale in cui ci troviamo. La decisione di dare la paga integrale e a tutti i lavoratori della LIP è stata presa a grande maggioranza. Quest’ultimi prendendo la paga firmano un documento in cui si dichiarano d’accordo a continuare nella lotta in corso. Riguardo il “terzo collegio” per coloro che si inseriscono nella lotta e che rientrando nell’azienda si collocano nelle commissioni, il salario è a loro disposizione alle stesse condizioni degli altri lavoratori.
«3) I lavoratori della LIP nel corso di questo lungo dibattito hanno preso coscienza di tutti i problemi che condizionano questa prima paga.
«4) Nel corso del pagamento verrà fatta una colletta a favore dei lavoratori in lotta negli attuali conflitti.
«... È possibile: si fabbrica, si vende... ci si paga!».
«L’attività nell’officina. La commissione propaganda si è divisa in 9 sottocommissioni che hanno compiti precisi coordinati ogni giorno:
«1) Corrispondenza. Risponde alla corrispondenza un gruppo di dattilografi ciascuno per suo conto, secondo le istruzioni ricevute nel corso dell’Assemblea generale.
«2) Controllo. È stato aumentato il personale del centralino data la notevole affluenza di chiamate da smistare nei vari reparti.
«3) Ordinazioni. Si occupa delle ordinazioni collettive che arrivano per lettera. Non possono far fronte alle ordinazioni singole. Se volete un orologio rivolgetevi al Comitato d’impresa o ai sindacati locali che faranno delle ordinazioni collettive.
«4) Ricevimento giornalisti.
«5) Rassegna della stampa. Tutti gli articoli di stampa che ci riguardano vengono affissi perché tutti possano leggerli. Questa sottocommissione ascolta anche le diverse stazioni radio e i canali TV.
«6) Lip-Unité. Per fare ogni settimana questo bollettino che è espressione collettiva dei lavoratori LIP.
«7) Organizzazione viaggi e meeting.
«8) Fornitori e fabbriche in lotta. Diversi fornitori e subappaltatori hanno gravi difficoltà a seguito dell’arresto dell’attività della LIP. Costituiamo un’unità con i lavoratori di queste imprese che rischiano di trovarsi senza lavoro come noi.
«9) Segretariato e fotocopie.
«Commissione vendita. Dal 26 al 31 luglio sono stati venduti 27.122 orologi per un totale di FF. 3.719.617.
«Commissione gestione. È studiato un sistema di lavoro a rotazione. Adesso il lavoro è di 8 ore al giorno per tutti. L’ammontare delle vendite a tutto il 31 luglio tocca la cifra di FF. 7.524.750.
«Commissione stock. Questa commissione collauda i pezzi della produzione, contabilizza giornalmente su di un prospetto e rifornisce la commissione vendite fissando uno stock di magazzino (con listino delle quantità e dei tipi di orologi). Un numero grandissimo di invenduti (che erano nello stock, a causa del modificarsi ogni 6 mesi di 150 nuovi modelli) è stato venduto.
«Commissione produzione. Rallentata durante il mese di luglio la produzione si mette in marcia. Uno degli elementi più notevoli della giornata di chiusura delle ferie (31 luglio) è l’aumento del numero di persone che si pongono al lavoro (150 contro le 76 del 18 giugno) lavorando con orario fisso dalle 8 alle 12,20. Hanno ripreso due catene di montaggio: 15 persone lavorano fuori della catena (operaie che mettono in opera le incastratrici). È assicurato il lavoro di rifinitura, dei posa bracciali e il controllo. Per i futuri 6-8 giorni si programma una produzione di 600 orologi al giorno, finiti e controllati. Un gruppo fabbrica gli astucci. Non ci sono problemi di approvvigionamento ma la commissione studia il sistema di rinnovare lo stock dei pezzi quando questo si sarà esaurito.
«Servizio dopo-vendita. Tutti gli orologiai specializzati sono presenti, oltre a due tecnici orologiai che accompagnano fuori le delegazioni. Il servizio dopo-vendita è collegato con il personale addetto alle vendite. Il numero degli orologi difettosi restituiti alle vendite segue il procedimento normale delle precedenti fabbricazioni».
Bollettino n. 5 del 9 agosto 1973
«Commissione di produzione. Reparto orologeria. Una settimana dopo la fine delle vacanze si produce al ritmo regolare di 800-1000 orologi al giorno che vengono commerciati dopo i prescritti controlli in un periodo di 6 a 8 giorni.
«Commissione vendita. Ogni orologio venduto deve costituire una testimonianza della nostra battaglia. Per questo motivo ogni compratore viene ricevuto dalla commissione di ricevimento che spiega i motivi della nostra lotta. L’orologio viene comprato prima o dopo questa spiegazione. Le condizioni di vendita sono migliorate ma gli orari dei partecipanti alla commissione sono sempre troppo pesanti. Bisogna rinforzare la commissione assicurando un lavoro a squadre specie durante le ore dei pasti. Al 6 agosto il totale delle vendite era di FF. 8.230.937 per complessívi 56.500 orologi.
«Lip-Unité. La preparazione materiale del bollettino è fatta presso la tipografia Néo-Typo di Besançon dai lavoratori LIP con il consiglio tecnico degli operai di questa tipografia che contribuiscono con tutta la loro competenza ed estrema buona volontà. La commissione si occupa anche della spedizione del bollettino indirizzato ogni settimana a tutto il personale della LIP e a quelli che sostengono la lotta dei quali abbiamo l’indirizzo. Il numero 4 è stato stampato in 8.000 copie di cui 3.000 sono state comprate e diffuse dal comitato di sostegno di Dole. 2.500 sono state inviate in tutta la Francia e all’estero. Se ne conserva un certo numero a disposizione dei visitatori che possono procurarselo presso la commissione ricevimento e delle delegazioni che partono per tutta la Francia spiegando la lotta della LIP».
Teorie sull’autogestione
Pierre-Joseph Proudhon
Il “padre dell’anarchia”, secondo l’affermazione di Kropotkin. Teorico del “prima” e del “dopo” la rivoluzione. Si batte sempre per l’analisi di un socialismo “costruttivo”. Ecco le sue affermazioni più importanti riguardo l’autogestione:
“Sì, io sono socialista, ma socialista con premeditazione e coscienza, socialista non solo perché protesto contro l’attuale regime sociale ma perché affermo un regime nuovo, che dovrà risultare, come tutto ciò che si produce nella società, dalla negazione di una realtà trasformata allo stato di utopia. Sono socialista, cioè di volta in volta riformatore e innovatore, demolitore e architetto; perché, nella società questi termini, per quanto opposti, sono sinonimi.
“Ho detto cento volte che il socialismo, riguardo tutto ciò che rivolge alla critica dell’economia presente e tutto ciò che svolge come critica delle sue ipotesi, è una protesta; riguardo tutto ciò che formula in idee pratiche e positive, esso non si differenzia dalla scienza sociale. Protesto contro la società attuale, e cerco la scienza: a questo doppio titolo, sono socialista.
“Da quando mi interesso della cosa pubblica, ho inteso spesso i patrioti porsi questa scabrosa questione: ‘Che cosa fare l’indomani della rivoluzione?’. E non ho inteso mai alcuno dare una risposta. Si prenderà, dicono, consiglio dalle circostanze; e la questione, lasciata in aria, non è più ripresa. È in questo modo che il frutto di ogni rivoluzione è stato perduto dal popolo. In ogni rivoluzione, chi sa quello che vuole e quello che fa è sicuro di comandare sugli altri: questa è la logica laica dei fatti, la politica delle masse. ‘Che cosa faremo l’indomani della rivoluzione?’. Questo è il problema che il popolo deve porsi esso stesso, studiandolo senza tregua, risolvendolo nel più breve tempo possibile. Va bene votare, manifestare o assalire alla baionetta l’Hôtel de Ville e le Tuileries, ma bisogna sapere utilizzare la vittoria. Che il popolo s’interroghi e si risponda. Perché se il giorno della Rivoluzione esso non avrà pronta la soluzione, dopo un arresto nell’orgia demagogica, esso ritornerà per secoli sotto la monarchia o il capitalismo, sotto il governo dell’uomo da parte dell’uomo, sotto lo sfruttamento dell’uomo da parte dell’uomo.
“Che un comitato provvisorio si istituisca a Parigi, per l’organizzazione degli scambi, del credito e della circolazione tra i lavoratori. Che questo comitato si metta in rapporto con altri comitati simili stabiliti nelle principali città. Che tramite questi comitati, una rappresentanza di lavoratori si formi, imperium in imperio, di fronte alla rappresentanza borghese. Che il germe della nuova società sia gettato nel mezzo della vecchia società. Che la carta del lavoro sia immediatamente messa all’ordine del giorno e i principali articoli definiti nel più breve tempo possibile, che le basi del governo repubblicano siano interrotte e che poteri speciali siano accordati a questo riguardo ai mandatari dei lavoratori.
“Infine appariranno le compagnie operaie, vere armate della rivoluzine, dove i lavoratori, come i soldati in un battaglione, manovreranno con la precisione delle macchine: dove migliaia di volontà, intelligenti e fiere, si fonderanno in una superiore volontà come le braccia che esse animeranno e concerteranno una forza collettiva più grande della stessa moltitudine.
“Questo sindacato sarà composto, come membri attivi, dai delegati naturali delle diverse branchie della produzione. I suoi attributi sono:
“1) Costituire la corporazione libera e democratica come regime assoluto e definitivo di tutti i lavoratori, quale che sia la loro presente condizione nella società; sia che essi risultino già organizzati in associazioni, che siano appartenenti ancora al padronato, o che siano lavoratori soltanto. Provocare la costituzione delle associazioni.
“2) Liquidare la posizione dei lavoratori, cioè rendere le loro persone e i loro strumenti di lavoro disponibili. Le proposte da fare ai lavoratori riposano su tre basi: a) liquidazione preventiva di ogni produttore; b) associazione cooperativa dei lavoratori per gli strumenti di lavoro; c) cooperative per l’alimentazione delle industrie e del lavoro.
“3) Centralizzare i rapporti dei fabbricanti di tutti i prodotti.
“4) Controllare i prodotti.
“5) Concorrere alla ripartizione del lavoro, e conseguentemente alla indennità di disoccupazione tra le diverse fabbriche, allo scopo di ottenere l’equilibrio tra la produzione e il consumo.
“6) Fissare la liquidazione della vecchia industria riguardo la nuova.
“7) Provvedere alle spese generali del movimento industriale e alla compensazione degli spostamenti operati nell’industria in conseguenza dell’adozione dei nuovi procedimenti.
“8) Sollecitare le invenzioni e i miglioramenti.
“9) Costituire un fondo comune per le indennità da accordare alle diverse industrie a seguito di processi di compensazione reciproca.
“10) Costituire l’assicurazione mutua di tutte le corporazioni contro ogni tipo di sinistro valutabile a priori.
“11) Negoziare e garantire i prestiti di ogni corporazione speciale direttamente presso la Banca del Popolo.
“12) Organizzare l’apprendistato come segue: a) il fanciullo deve trovare dove collocarsi secondo la sua vocazione; b) l’ingorgo di lavoratori non deve prodursi in nessuna corporazione; c) l’apprendista, mediamente rimborsato in seguito ad accordo con i suoi parenti, deve ricevere un credito di alimentazione, necessario per tutto il tempo in cui il suo lavoro non coprirà le sue spese; d) tutte le corporazioni che hanno bisogno di apprendisti dovranno poterne avere a volontà.
“13) Regolare i rapporti di ogni corporazione con il sindacato generale riguardo le spese dell’apprendistato.
“14) Regolare le condizioni d’indennità e dei servizi mutualistici in caso di malattia, incidente e invalidità.
“15) Organizzare una cassa centrale per le pensioni di vecchiaia. I fondi di questa cassa si formeranno a mezzo di quotizzazioni dei lavoratori.
“16) Cercare i modi di organizzare i diversi lavori tra loro, allo scopo di evitare la disoccupazione inerente a certe industrie, e controbilanciare l’influenza funesta esercitata sull’uomo della divisione del lavoro.
“Fare l’anarchia: ciò sembra loro inconcepibile, un complotto contro la repubblica e la nazionalità. Eh! che cosa metteremo al posto del governo? Noi non siamo affatto imbarazzati a rispondere. Quello che metteremo al posto del governo, l’abbiamo già fatto vedere: è l’organizzazione industriale. Ciò che metteremo al posto delle leggi, saranno contratti. Non leggi votate dalla maggioranza, e nemmeno dall’unanimità; ogni cittadino, ogni comune o corporazione farà le sue. Quello che mettiamo al posto dei poteri politici sono le organizzazioni economiche Quello che mettiamo al posto delle antiche classi di cittadini, nobili e plebei, borghesi e proletari, sono le categorie e le diverse specialità produttive: Agricoltura, Industria, Commercio ecc. Quello che mettimo al posto delle armate permanenti sono le compagnie industriali. Quello che mettiamo al posto della polizia è l’identità di interessi. Quello che mettiamo al posto della centralizzazione politica è la centralizzazione economica”.
Michail Bakunin
Se Bakunin, in un certo senso, parte da Proudhon, lo supera per una visione più ampia del processo della rivoluzione sociale e dell’organizzazione della società futura:
“Che cos’è questa idea? È l’emancipazione non soltanto dei lavoratori di questa industria o di quel paese, ma di tutte le industrie possibili e di tutti i paesi del mondo, è l’emancipazione generale di tutti coloro che, nel mondo, si guadagnano faticosamente la loro miserabile esistenza quotidiana con un qualsiasi lavoro produttivo e sono economicamente sfruttati e politicamente oppressi dal capitale, o piuttosto dai proprietari e dagli intermediari privilegiati del capitale. Questa è la forza negativa, bellicosa e rivoluzionaria dell’idea. E lo forza positiva? È la fondazione di un mondo sociale nuovo, basato unicamente sul lavoro emancipato, che si crea da se stesso, sulle rovine del mondo antico, attraverso l’organizzazione e la federazione libera delle associazioni operaie liberate dal giogo, tanto economico che politico, delle classi privilegiate. Questi due aspetti della stessa questione, l’uno negativo e l’altro positivo, sono inseparabili. Nessuno può voler distruggere senza avere almeno una lontana immaginazione, vera o falsa, dell’ordine delle cose che dovrà, secondo lui, succedere a quello esistente al momento presente; e più questa immaginazione è vivente più la sua forza distruttiva diventa possente, e più si fa vicina della verità, cioè più essa si conforma allo sviluppo necessario del mondo sociale attuale, più gli effetti della sua azione distruttiva diventano salutari e utili. Perché l’azione distruttiva è sempre determinata, non solo nella sua essenza e nel grado della sua intensità, ma ancora nei modi, nelle prospettive e nei mezzi che essa impiega, dall’ideale positivo che costituisce la sua ispirazione prima, la sua anima.
“Le associazioni cooperative operaie sono un fatto nuovo nella storia; noi assistiamo alla loro nascita e possiamo solo presentire, ma non determinare oggi, l’immenso sviluppo che senza alcun dubbio esse prenderanno e le nuove condizioni politiche e sociali che sorgeranno nell’avvenire. È possibile, o almeno assai probabile, che, oltrepassando un giorno i limiti dei comuni, delle province e anche degli Stati attuali, esse daranno una nuova costituzione alla società nel suo insieme, che risulterà divisa non più in nazioni, ma in gruppi industriali differenti e organizzati secondo i bisogni non della politica; ma della produzione.
“Quando le associazioni produttrici e libere cesseranno di essere gli schiavi e diventeranno a loro volta i padroni e i proprietari del capitale che sarà loro necessario, comprenderanno nel loro seno, a titolo di membri cooperatori, a lato, delle forze operaie emancipate dall’istruzione generale, tutte le intelligenze speciali richieste da ogni impresa; quando si combineranno tra di esse, secondo i propri bisogni e le proprie tendenze, formeranno una immensa federazione economica con un parlamento illuminato da visioni più larghe possibile e assistito da dettagli statistici a livello mondiale; di un modo che non è possibile avere idea oggi, e che combinando l’offerta e la domanda, potrà governare, determinare e ripartire tra i diversi paesi la produzione e l’industria mondiale, facendo sì che non si avranno più, o quasi più, delle crisi commerciali e industriali, delle stagnazioni forzate, dei disastri, dei capitali perduti, per cui il lavoro umano, emancipazione di ognuno e di tutti, rigenererà il mondo.
“Per prima cosa, tutti gli aderenti alla Lega della Pace e della Libertà dovranno cercare, con tutti i loro sforzi, di ricostituire le loro rispettive nazioni, al fine di rimpiazzare l’antica organizzazione, fondata dall’alto in basso sulla violenza e il principio di autorità, con un’organizzazione nuova avente per base gli interessi, i bisogni, le attrazioni naturali dei popoli, senza altri principi che la federazione libera degli individui nei comuni, dei comuni nelle province, delle province nelle nazioni e, infine, di queste ultime negli Stati Uniti d’Europa prima e, poi, del mondo intero.
“La futura organizzazione sociale dovrà essere fatta soltanto dal basso in alto, a mezzo di libere associazioni e federazioni di lavoratori, dapprima nelle associazioni, poi nei comuni, nelle regioni, nelle nazioni e, finalmente, in una grande federazione universale. È soltanto allora che si realizzerà il vero e vivificante ordine della libertà e della felicità generale, ordine che invece di rinnegare, afferma al contrario e mette d’accordo gli interessi degli individui e della società.
“La terra, gli strumenti di lavoro, come ogni altro capitale, diventando proprietà collettiva della società intera, non potranno essere utilizzati che dai lavoratori, cioè dalle associazioni agricole e industriali”.
Pëtr Kropotkin
Di fronte a Bakunin, teorico del collettivismo, si pone Kropotkin, teorico del comunismo anarchico.
«Nel 1848 e nel 1871 la borghesia sapeva quello che voleva, ma il popolo non sapeva niente. Nella questione politica, ripeteva dietro lo borghesia ‘Repubblica e suffragio universale’, nel 1848, e nel marzo del 1871, con la piccola borghesia, diceva: ‘La Comune!’. Ma, sia nel 1848, che nel 1871, non aveva alcuna idea precisa di ciò che bisogna fare per risolvere la questione del pane e del lavoro. L’organizzazione del lavoro, questa parola d’ordine del 1848 (fantasma resuscitato recentemente sotto un’altra forma dai collettivisti tedeschi), era una parola così vaga che non diceva niente; lo stesso che il collettivismo, così vago che l’Internazionale del 1869 in Francia. Sì, nel marzo 1871, tutti quelli che lottavano intorno alla Comune posero il problema di ciò che bisognava fare per risolvere la questione del pane e del lavoro ma quale terribile cacofonia di risposte contraddittorie si ebbe!
“Sfortunatamente le vecchie aspirazioni comuniste (Mably, Morelly, Roux) non prendevano mai una forma netta, concreta, anche se si trattava di pensatori che volevano il bene del popolo. Mentre presso la borghesia istruita, le idee di affrancamento si traducevano in tutto un programma di organizzazione politica ed economica, al popolo si presentavano solo delle vaghe idee di liberazione e di riorganizzazione economica. Quelli che parlavano al popolo non cercavano di definire la forma concreta nella quale questi desideri e queste negazioni si potevano manifestare. Si può pensare anche che essi evitavano espressamente di essere chiari. Comunque, scientemente o no, essi sembravano dire: ‘Perché parlare al popolo del modo in cui si dovrà organizzare più tardi? Ciò raffredderà le sue energie rivoluzionarie. Per il momento che esso trovi solo la forza di andare all’attacco dalle vecchie istituzioni. Più tardi ci arrangeremo’. Molti socialisti e molti anarchici ragionano oggi ancora allo stesso modo! Impazienti di accelerare il giorno della rivolta considerano teorie addormentatrici tutte quelle che cercano di chiarire ciò che la rivoluzione dovrà introdurre.
“La parte che dovrà svolgere il popolo nella rivoluzione dovrà essere positiva e nello stesso tempo distruttiva, in quanto esso solo potrà riuscire a riorganizzare la società su basi di uguaglianza e di libertà per tutti. Rimettere questa cura agli altri, significa tradire la causa della Rivoluzione”.
James Guillaume
Collaboratore di Bakunin, professore di storia, autore del monumentale lavoro L’Internazionale: documenti e ricordi.
“Ciascuna officina, ciascuna fabbrica formerà dunque una associazione d’operai, che resterà libera di amministrarsi come meglio le piace, purché i diritti di ciascuno siano garantiti ed i principi d’eguaglianza e di giustizia siano messi in pratica.
“L’amministrazione della comunità, eletta da tutti gli associati, sarà affidata o ad un solo individuo, o ad una commissione di parecchi membri; sarà anche possibile separare le diverse funzioni amministrative e rimettere ciascuna ad una commissione speciale. La durata della giornata di lavoro sarà fissata non da una legge generale applicata a tutto il paese, ma da una decisione della stessa comunità; solamente siccome la comunità starà in relazione con tutti i lavoratori agricoli della regione, è probabile che avrà luogo un’intesa tra tutti questi lavoratori per l’adozione, su questo punto, di un sistema uniforme. I prodotti del lavoro appartengono alla comunità, e ciascun associato riceve da essa, sia in natura (alimenti, vesti, ecc.), sia in moneta di scambio, la rimunerazione del lavoro fatto da lui. In qualche associazione questa rimunerazione sarà proporzionale alla durata del lavoro e della specie delle funzioni compiute; altri sistemi potranno essere provati e praticati.
“Quando, per esempio, il giorno della Rivoluzione, gli operai tipografi di Roma avranno preso possesso di tutte le tipografie di questa città dovranno immediatamente riunirsi in assemblea generale per dichiarare, che l’insieme delle tipografie di Roma costituisce la proprietà comune di tutti i tipografi romani. Poi, quando sarà possibile dovranno fare un passo in più e stringere solidarietà con gli altri tipografi delle altre città d’Italia: il risultato di questo patto di solidarietà sarà la costituzione di tutti gli stabilimenti tipografici d’Italia in proprietà collettiva della federazione dei tipografi italiani. In conseguenza di questa messa in comune, i tipografi di tutta l’Italia potranno andare a lavorare in qualunque città italiana e trovarvi dovunque degli strumenti di lavoro, di cui avranno diritto di servirsi. Ma, se la proprietà degli strumenti di lavoro deve, secondo noi, essere devoluta all’associazione, non vogliamo dire con ciò, che debba esservi al disopra dei lavoratori dei diversi opifici una specie di governo industriale che abbia il potere di disporre a sua volontà degli strumenti di lavoro. No: i lavoratori dei diversi opifici non abbandonano per nulla gli strumenti di lavoro, che hanno conquistati, nelle mani di un potere superiore che si chiamerebbe associazione. Ciò che essi fanno è questo: si garantiscono reciprocamente, sotto certe condizioni, il godimento degli strumenti di lavoro di cui hanno acquistato il possesso, ed occorrendo ai loro colleghi degli altri opifici la compartecipazione a questo godimento, ottengono in cambio di essere a loro volta compartecipanti alla proprietà degli strumenti di lavoro detenuti da quest’ultimi, coi quali hanno stretto il patto di solidarietà. In quanto ai rapporti delle diverse associazioni tra di loro, ai modi con cui sarà determinata la quantità normale di prodotti, che dell’essere offerta al consumo da ciascuna branca d’industria, e al modo di organizzare lo scambio, si procederà come segue. [Segue dettagliatamente la struttura dei comuni, delle federazioni delle associazioni di categoria, delle federazioni dei comuni, ecc.].
“Quando tutte le branche della produzione, comprese quelle della produzione agricola, si saranno organizzate in tal modo, un’immensa rete federativa, abbracciante tutti i produttori e per conseguenza anche tutti i consumatori, coprirà il paese, e la statistica della produzione e del consumo, centralizzata dagli uffici delle diverse federazioni delle associazioni, permetterà di determinare in modo razionale il numero delle ore della giornata normale di lavoro, il prezzo di produzione dei prodotti e il loro valore di scambio, nonché la quantità necessaria di questi prodotti per soddisfare i bisogni del consumo”.
Errico Malatesta
“La rivoluzione, come la vogliamo noi, deve essere l’inizio della partecipazione attiva, diretta e vera delle masse, cioè di tutti alla organizzazione e alla gestione della vita sociale.
“Per organizzare in grande una società comunista bisogna trasformare radicalmente tutta la vita economica: modi di produzione, di scambio e di consumo; e questo non si potrebbe fare che gradualmente, a misura che le circostanze obiettive lo permettessero e la massa ne comprendesse i vantaggi e sapesse provvedervi da se stessa. Se invece si volesse, e potesse, fare d’un tratto per il volere ed il prepotere di un partito, le masse, abituate ad ubbidire e servire, accetterebbero il nuovo modo di vita come una nuova legge imposta da un nuovo governo, ed aspetterebbero che un potere supremo imponesse a ciascuno il modo di produrre e gli misurasse il consumo.
“L’Organizzazione, che poi non è altro che la pratica della cooperazione e della solidarietà, è condizione naturale, necessaria della vita sociale: è un fatto ineluttabile che s’impone a tutti, tanto nella società umana in generale, quanto in qualsiasi gruppo di persone che hanno uno scopo comune da raggiungere.
“Noi vogliamo che nell’atto stesso della rivoluzione, non appena la sconfitta del potere militare borghese ce lo permetterà, per l’iniziativa libera di tutte le organizzazioni operaie, di tutti i gruppi coscienti, tutti i volontari del movimento, si pratichi subito, immediatamente, l’espropriazione e la messa in comune di tutta la ricchezza esistente per procedere, senza por tempo in mezzo, all’organizzazione della distribuzione della produzione secondo i bisogni ed i desideri delle diverse regioni, dei diversi comuni, dei diversi gruppi ed arrivare quindi sotto la spinta dell’idea e dei bisogni alle intese, ai patti, agli accordi che occorrono alla vita sociale.
“La produzione e la distribuzione debbono essere regolate, cioè si deve sapere quali e quante sono le cose che occorrono, dove occorrono e quali sono i mezzi disponibili per produrle e distribuirle. Un individuo non può produrre da sé tutto quello che gli occorre e deve scambiare i suoi prodotti con quelli degli altri, è necessario che ciascuno sappia non solo quello che egli può fare e quello di cui ha bisogno, ma conosca anche i bisogni e le capacità degli altri”.
Élisée Reclus
Teorico di fama mondiale, geografo e scienziato, colse l’aspetto della ricostruzione della nuova società in termini quanto mai attuali:
“Spesso veniamo interrogati con sarcasmo sui tentativi d’associazione più o meno comunitari già fatti in varie parti del mondo; e avremo poco giudizio se il rispondere a tali domande ci imbarazzasse comunque. È vero: la storia di tali associazioni racconta assai più insuccessi che successi; né potrebbe essere altrimenti, perché si tratti di una rivoluzione completa si deve sostituire il lavoro individuale o collettivo, a profitto di uno solo, col lavoro di tutti a profitto di tutti. Le persone che si raggruppano per entrare in una di queste società con un ideale nuovo non sono neppure esse completamente sbarazzate dai pregiudizi, dalle pratiche antiche, dall’atavismo inveterato, non si sono ancora “spogliate dell’uomo antico”! Nel microcosmo “anarchico”, e “armonista” debbono sempre lottare contro le forze di dissociazione, disgregazione, rappresentate dalle abitudini, dai costumi, dai legami familiari, sempre così potenti; dalle amicizie coi loro consigli dolciastri, dagli amori con le loro gelosie feroci, dal risveglio di ambizioni mondane, dal bisogno di avventure, dalla smania del mutamento”.
Ricardo Mella
Sindacalista anarchico, autore dell’Ideale anarchico:
“Quando tutta la ricchezza sociale sarà messa disposizione di tutti per produrre, scambiare e consumare, il bisogno di una intesa generale s’imporrà per legge di natura. I produttori si raggrupperanno in associazioni diverse, le une si occuperanno della produzione degli alimenti, le altre della produzione degli abiti, altre ancora della costruzione degli alloggi, ecc. A loro volta, le associazioni si raggrupperanno, costituendo gruppi d’associazioni, per cui grazie a questa organizzazione settoriale, si costituirà una grande federazione di società autonome che abbraccerà in una ampia sintesi l’immensa varietà della vita sociale, riunirà tutti gli uomini sotto la bandiera di una felicità reale e positiva”.
José Prat
Compagno di Mella, animatore del movimento anarcosindacalista spagnolo fino al 1936:
“Il proletariato si sforza di realizzare subito combattendo, con i suoi sindacati, gli interessi di classe che si manifestano col progresso sociale, poi fissando le basi della società nuova a mezzo della cooperazione. È vero che la cooperazione, così, com’è realizzata oggi nelle cooperative operaie, non è per nulla la società nuova, ma si tratta soltanto del germe, carico delle deficienze che provengono dall’insieme sociale. Essa non risolve il problema nel suo insieme, non produce l’armonia degli interessi, non assicura il benessere, e non può farlo perché il simbolo monetario, la concorrenza, la proprietà, ecc., la trasformano in una società commerciale che si aggiunge alle altre, la fanno divenire borghese e la costringono ad arrestarsi davanti all’idea collettiva della socializzazione totale. Ma la base cooperativa sulla quale si reggerà la società futura è di già inventata, lo slancio verso la cooperazione libera è di già dato, e si modella di già su come potrà funzionare la società futura.
“Le cooperative operaie non possono lottare contro l’unione dei capitali borghesi. Per il fatto di essere una società di capitali operai i cui beneficiari non possono essere che i membri stessi, le cooperative limitano la pratica della solidarietà. Ma il lavoratore vi si forma, vi apprende ad amministrarsi, a far andare la produzione e la distribuzione dei prodotti senza bisogno di tutori né di classi dirigenti. Supponiamo per un momento che la rivoluzione ha soppresso la proprietà privata e il suo difensore, l’autorità; che i mezzi di produzione e di trasporto sono nelle mani dei lavoratori; estendete questa cooperazione della produzione e del consumo attraverso i mestieri federati, nelle diverse località, regioni, nazioni, fino a tutta l’umanità; supponiamo che nello stesso tempo siano stabilite le necessarie statistiche perché in ogni momento ed in ogni luogo si possa sapere esattamente in quale zona i prodotti e i bisogni sono più numerosi, in modo da distribuire i primi secondo la domanda. In questo modo si organizzeranno le linee generali della società futura, basandole sulla natura stessa: il mutuo appoggio, la cooperazione per tutti gli aspetti dalla vita, a beneficio di tutte le razze umane”.
Christian Cornelissen
Olandese, l’economista anarchico più conosciuto dopo Proudhon, autore di Verso la società nuova:
“Ci deve sembrare naturale – a parte l’esecuzione dei dettagli – che i campi siano coltivati secondo il modo scelto in ciascun comune dalla popolazione adulta. Allo stesso modo, è naturale che le messi siano conservate non nei trecento granai di cui ci ha parlato Fourier, ma in un solo granaio comune, o, almeno, in un ristretto numero di magazzini provvisori. Ciò che caratterizza la proprietà di una cosa, è il diritto di disporne, il pieno potere, riconosciuto come un ‘diritto’ della società stessa, non soltanto di utilizzare per se stessi questa cosa, secondo le proprie necessità, ma anche di alienarla. Quando nella società comunista i campi comuni saranno coltivati nella maniera stabilita tra gli abitanti adulti dei comuni, non vi saranno problemi che nell’ambito delle decisioni delle direzioni dei lavori all’interno dei recinti dei rispettivi comuni. Ma questi comuni non saranno “proprietari” dei campi nel senso in cui la parola “proprietà comunale” è inteso oggi. I mandatari degli abitanti non potranno alienare i domini dei rispettivi comuni. Questa è la conseguenza di ciò che chiamiamo società comunista. Ma gli abitanti di un comune potranno intendersi con quelli di un altro comune allo scopo di migliorare la forma della coltura di certe zone, per l’immagazzinamento, il trasporto, ecc., dei prodotti raccolti, e, in generale, per tutto ciò che riguarda l’organizzazione del lavoro necessario. Allo stesso modo, gli operai di una miniera, di una fabbrica o di una industria collettiva, come pure quelli che lavorano nelle compagnie ferroviarie, o di navigazione, decideranno, secondo l’organizzazione ‘comunista’ della società, su tutto ciò che concerne l’esecuzione del proprio lavoro, risultando in questo modo autonomi nel settore della propria attività. Mancherà il diritto di proprietà, ma nel senso della libertà di alienare, di annientare e anche di deteriorare, nei rispettivi stabilimenti, gli edifici e le macchine, i materiali o gli utensili affidati alla loro cura. Essi non avranno quello che si chiama nel diritto romano: jus utendi et abutendi.
“Supponiamo per scegliere un esempio in una certa industria, che le vetrerie di un paese siano state veramente socializzate. Ne sortirà questa conseguenza, che gli operai organizzati di tutte le vetrerie del paese tasseranno per un certo periodo la quantità di vetri di diverso tipo che, dopo il consumo degli anni precedenti, sarà domandata per l’uso del paese stesso o per l’esportazione. Questa quantità dovrà essere ripartita proporzionalmente tra le vetrerie nelle diversi contrade del paese secondo la forza produttiva di ciascun stabilimento. Se le vetrerie esistenti non saranno sufficienti per la produzione voluta, gli operai organizzati delle vetrerie di questo paese dovranno, per fondare nuovi stabilimenti in questo settore d’industria, entrare in rapporto con gli operai delle costruzioni. La quantità di prodotto che si dovrà fornire per ogni vetreria una volta fissata, dovrà essere attentamente portata a termine da tutto il personale di ogni vetreria in quanto l’organizzazione del lavoro appartiene a tutti, in questo modo tutti si interesseranno che la quantità fissata di ogni vetreria venga consegnata e che quella consegnata sia veramente la quantità voluta. Insomma saranno gli operai stessi a regolare la durata e la divisione del lavoro. Presa nei dettagli, questa produzione sarà diretta dalla natura stessa del lavoro e modificata a seconda delle condizioni locali”.
* * * * *
“Il nome razionalismo è fuorviante, perché per Hegel il pensiero e il concetto non indicano qualcosa che si potrebbe contrapporre a qualcos’altro, ma qualcosa che si contrappone a se stesso, che diventa l’altro di se stesso e nell’altro si riunisce di nuovo con sé. Il razionalismo di Hegel contiene quindi un irrazionalismo in se stesso: il concetto si pone dei limiti ed è concetto proprio soltanto in quanto è lui a porre a sé dei limiti e a superare di nuovo i limiti posti come posti da sé e a se stesso. Soltanto tenendo presente questo, si intende correttamente la pretesa hegeliana per cui al concetto spetta il dominio universale, ma allora non si parlerà più di razionalismo. Il pensiero è onnipotente soltanto perché pone da sé a se stesso i suoi limiti, perché sa che l’essere del pensiero si estende fino al nulla del pensiero, che pensabilità e impensabilità non soltanto si toccano, ma si compenetrano in ogni punto del pensiero. Il pensiero di Hegel è altrettanto razionale, quanto irrazionale, soprarazionale o antirazionale. Far sì che la negatività del pensiero domini proprio nel pensiero – questo è la più ardente, anzi l’unica aspirazione del pensiero hegeliano [...]. La verità è che prima di Hegel non vi è stato mai un irrazionalista che lo fosse in modo così filosofico, così pensante, così scientifico, come lo è stato Hegel; nessuno che ritenesse così necessario e possibile rendere il motivo dell’irrazionalismo dominante e impellente. Hegel senza dubbio è il più grande irrazionalista di tutta la storia della filosofia. Nessun filosofo prima di lui ha saputo tanto irrazionalizzare il concetto, illuminare mediante il concetto ciò che è più irrazionale. Confrontati con Hegel, tutti gli irrazionalisti che pongono o postulano un irrazionale di qualche sorta al di fuori del pensiero, sono piuttosto razionalisti, perché si fermano all’opporre e perché l’opporre che non contrappone se stesso a sé e non si supera nella contraddizione, è piuttosto l’essenza della ratio, cioè dell’intelletto. Hegel è irrazionalista perché fa valere l’irrazionale nel pensiero, perché irrazionalizza il pensiero stesso [...]. Hegel è irrazionalista perché insegna che il concetto si muove e che questo automovimento include la propria autodistruzione. Hegel è irrazionalista, perché è dialettico, e perché la dialettica è l’irrazionalismo stesso diventato metodo; l’irrazionalismo fatto razionale, perché il pensiero dialettico è pensiero razionale-irrazionale”.
(R. Kroner, Von Kant bis Hegel, ns. tr.)
Annotazioni di Amfissa
È tempo che dalla parola “autogestione”, come da un vecchio cappello di giocoliere, escano altri significati. Quelli di quarant’anni fa non corrispondono più, il tempo si compiace sempre di essere cattivo consigliere di chi intende chiudere la propria curiosità nel cassetto.
Andiamo avanti con tono ruvido, non allettiamo ancora una volta gli interessi di circostanza dei lettori appassionati di economia. Il fatto è che quest’arte da imbonitori non ha punti fermi, nemmeno per il capitale, e le sue pretese leggi non sono altro che una giustificazione retorica a posteriori di quanto il capitale ha di già fatto in termini di massacri e di distruzione. Non ci sono teorie da reclutare in campo rivoluzionario prelevandole dall’economia, e questa è un’affermazione puntualmente incontrovertibile. Tutti coloro, anarchici compresi, che sono partiti da questa cosiddetta scienza per costruire un “mondo migliore”, hanno concluso con un abominio fastidioso. Farfugliare teoremi economici, con tutta l’aria di dire verità consolidate dalla pratica, non sarà quello che il lettore troverà in questo vecchio libro e, meno che mai, in queste giovani annotazioni.
Ma, visto che ci siamo, e che un grosso fardello di teoria economica pesa sulle nostre spalle, andiamo avanti per un poco. Non ci vuole un gran talento per occuparsi di economia, basta la lettura delle imprese pratiche dei capitalisti, questi ultimi sì che devono avere talento, gli economisti non ne necessitano. Sono gli imprenditori che aprono la strada, coltello tra i denti, che azzannano e mordono, che vincono e perdono, gli economisti si siedono spesso sul carro del vincitore, ma con l’abbigliamento da schiavo.
Una teoria economica si regge sulla pratica produttiva, modifica quest’ultima per le necessità del mercato e dello sfruttamento che il capitale impone dovunque, la teoria cade e viene sostituita da un’altra. Perfino l’autogestione, ma quale?, è stata presa con sé dal capitale e portata a suo completo svuotamento. Certo, non stiamo parlando di questa autogestione, e vedremo il perché. Tanto per chiamare le cose col loro nome, si è trattato più di cogestione che di autogestione, ma siccome la confusione se non altro fa brodo, tante vale giocare sull’equivoco. I compagni tedeschi e svedesi di trent’anni fa lo hanno fatto. Le esperienze teoriche italiane, a parte questo libro e a parte la modestia che non mi è congeniale, sono di uno squallore unico. Bandire le chiacchiere, ecco un buon metodo. Spacciare strumenti recuperativi o repressivi di nuovo conio come strumenti rivoluzionari, sono chiacchiere fastidiose.
Chi soffre lo sfruttamento è in un doloroso stato di schiavitù. Il lavoratore è lo schiavo moderno, in nulla diverso dallo schiavo dell’antichità. Fornirgli una bella teoria economica per conforto e viatico significa sputargli in faccia.
Nessuna indulgenza per i propagatori della miseria altrui, pur di guadagnare la propria ottima condizione privilegiata aiutando chi tiene in mano la ferula con cui manda avanti il lavoro degli schiavi. Sono questi i veri miserabili, anche peggio degli sfruttatori in presa diretta, che almeno mettono davanti al mattatoio l’insegna di fabbrica.
L’economia, se fosse una scienza, dovrebbe conformare di sé il mondo della produzione, e dovrebbe essere costretta a seguire l’andamento generale della scienza, con tutti i suoi ripensamenti e i suoi squilibri, le sue approssimazioni e i suoi fantocci di paglia. Invece pensa ancora di misurare il mondo con le sue formule, le quali nel frattempo sono diventate ridicole esercitazioni manualistiche.
Ho puntigliosamente seguito, negli ultimi decenni, le comiche vicissitudini di questa scienza dalle gambe troppo fragili. Non ho trovato teoria che valga la pena di chiamare con questo nome. Il teorema Modigliani-Tarantelli è un esempio per tutti. Datevi un governo duraturo, capace di fare le riforme, e potete rifondare lo sfruttamento sulla flessibilità. Non preoccupatevi, il resto – globalizzazione in primo luogo – verrà da sé. Purché non si facciano movimenti troppo bruschi, altrimenti chi sta sotto la sferza potrebbe risentire il cambio dei colpi che riceve.
La miseria permanente dell’economia si può riassumere nel concetto di crisi, nemmeno degno di una teoria vera e propria. Le varie disfunzioni fisiologiche del capitale sono sempre state viste come “crisi” e all’uopo si sono suggerite ricette forse peggiori del male. Il bello è che alcuni rivoluzionari autoritari, specie di matrice marxista, sostengono ancora queste assurdità, e con loro non pochi anarchici, digiuni, bontà loro, proprio di studi seri di economia. Non che questi studi possano fare la differenza, ma certo permettono una riflessione che un rapido volo d’uccello non consente. C’è come un impaccio ad accostare la scienza principe del capitale, e non ci si rende conto che scrostando la vernice – quasi sempre matematica – il resto è assoluta nudità.
Forse in anni passati ho peccato di eccessiva cautela parlando di economia, e la trattazione dei problemi organizzativi dell’autogestione mi pare, con l’occhio dell’oggi, si possa ricondurre a questa cautela, ma ormai si possono dire le cose come stanno. Allontaniamoci da questa cautela.
L’autogestione non deve confondersi con l’autodeterminazione. Questa sovrapposizione ha fatto più danni del necessario. L’autodeterminazione è ciò che la volontà continuamente impone all’individuo, senza sosta, come un inarrestabile martello pneumatico. Tu devi volere, ecco l’ordine della volontà, e questo volere è te stesso. Un circolo chiuso. Una cecità. In questo cerchio si concentrano i valori, l’essenza della vita e la positività di qualsiasi progetto che dà senso alla vita. Ma sempre chiuso questo circolo rimane. Su che cosa posso difatti fondare la mia autodeterminazione? Evidentemente su me stesso, con tutti i miei limiti. Così questi ultimi divengono l’unità di misura per giudicare il mondo che mi circonda e penso di essere il centro e la concentrazione di questo mondo. In genere, chi pensa così ha – e vuole avere – sempre ragione. Triste destino di qualsiasi circolo chiuso. Ciò raggiunge la perfezione automatica nell’imbecille che, non potendo fare altro, autodetermina la propria imbecillità.
Autodeterminarsi è pertanto quasi un’antitesi di autogestirsi. Lo vedremo nel corso di queste pagine, per il momento bisogna sottolineare che il primo concetto si chiude nella volontà mentre il secondo si apre all’affinità. La volontà esalta se stessa e procede diretta come un treno, vuole volere fino in fondo. Darle libero accesso alla nostra vita significa costruire noi stessi in una macchina del fare. L’affinità cerca l’altro ed è disposta ad accettarlo nella propria cerchia più intima, per quanto questo aspetto dell’autogestione non sia stato trattato se non di sfuggita con preferenza dell’autogestione produttiva e della lotta.
L’autodeterminazione è una forte lente d’ingrandimento rivolta verso l’interno, scava e seziona, ma solo quello che c’è, non può portare dentro quello che sta fuori. Ciò produce una visione ristretta del mondo perché puntuale e centralizzata, per di più basata sul possesso della verità. L’altro, e le sue eventuali chiacchiere, mi sono remoti, non ho neanche il piacere di considerarlo uno stupido, quindi non affine con me. Pongo, determinandomi da solo, un altro punto fermo da cui non posso spostarmi, sono io che reggo il gioco e l’evidenza e il ribollire degli accadimenti non mi turbano. La mia cornice autodeterminata mi racchiude e mi consola, mi fa sentire al sicuro. Chi si autodetermina vive prigioniero di se stesso, si muove in un territorio seminato e arato solo dalla propria volontà. Non c’è altro.
L’affinità con l’altro non è la collettività, quindi il mondo dominato dalla politica del capitale, ma è un punto di riferimento che sono disposto a prendere in considerazione. Non tengo i piedi nella politica e la testa nell’autogestione, faccio con l’altro un esperimento che vuole essere diverso.
Ma in che voglio che consista questa diversità? Ecco il punto. L’autogestione della produzione non è che un pallido riflesso dell’autogestione generalizzata. Quando la prima è stata realizzata si è trattato di un esperimento di autosfruttamento, non certo di liberazione. L’autogestione della lotta, da parte sua, è costruzione di strumento di attacco, allontanamento di fittizie collaborazioni pelose, progetto rivoluzionario, ecc. Ma la diversità?
Ecco, la diversità è ancora oltre, ancora più in là. La diversità è il caos, il rifiuto delle regole, l’anarchia. Ma come posso portare il caos nella produzione e nella lotta se ho bisogno di mezzi di produzione e di mercati, da un lato, e dall’altro di un progetto di attacco? Non posso. Ecco perché ogni discorso sull’autogestione è destinato ad allontanarsi dalla diversità, a venire a patti con il caos, a organizzare e a produrre modelli di comportamento.
Ma l’importante aspetto del caos, per quel che ci riguarda, è tenere presente che nel corso dell’autogestione non tutto può essere ricondotto ai modelli produttivi ai quali ci ha abituati il capitale, o alle tradizionali forme di lotta sindacalista. Nell’autogestione c’è un pullulare di novità formali e sostanziali, di forze e di progetti, di intrecci tra produzione e distruzione, tra fare e agire, tra dare vita a nuovi prodotti e attaccare il nemico di classe distruggendo vecchi prodotti, ricchezze accumulate e irriducibili abitudini capitaliste. Insomma bisogna aprire la porta al diverso, anche al diversamente mostruoso, cioè a quello che la normalità codificata del capitale ci faceva considerare mostruoso. E ciò può avvenire producendo diversamente oggetti diversi e lottando diversamente. Tra i vecchi modelli e i nuovi, le vecchie teorie e le nuove, ci deve essere una delimitazione radicale non una benevola, reciproca accondiscendenza. È questa una nuova concezione dell’affinità nella lotta e della collaborazione autogestita nella produzione, tutto fondato su di un dislivello tra la lotta che si distingue ma non contraddice la produzione, anzi in questa si rispecchia e vi trova elementi di sviluppo, e viceversa. Accade allora che l’autogestione riflette una nuova e potente trasformazione della realtà naturale, realtà che ormai non può essere nemmeno più seriamente distinta dal produttivismo cieco del capitale.
Ora, questa distinzione è prima di tutto coscienza di sé in un metodo che penetra nelle fibre dell’individuo e ne scandisce i ritmi alternativi, a volte anche contrastanti. Non si tratta di sostituire un profilo ornamentale a un altro, ma di scalzare dalle fondamenta un mondo vecchio, che ha fatto il suo tempo e che avvolge l’uomo come un sudario. Incidendo l’enorme bubbone del mondo, la lotta lo fa esplodere, e tutta la melma che copre le cose della politica viene fuori ribollendo. La distruzione non può ritagliare qualcosa di marcio da un corpo sano, ormai questa è una credenza del passato rivelatasi infondata, deve azzerare l’informe circostanza della vita collettiva basata sulla politica, non può osservare, compiaciuta dell’opera sua, quello che ha staccato come un prezioso cammeo.
Certo, nella prospettiva pratica della lotta autogestita, l’affinità agisce producendo occasioni, a volte minime, capacità di sprigionare forze residue e meccanismi scartati. Ma poi occorre andare avanti, l’aspetto produttivo prende decisamente il sopravvento, e questo non può rimanere molto nell’ambito delle occasioni, deve avere un progetto preventivo il più possibile largo, fino a includere la società nel suo insieme. O questo immenso movimento si scatena ed evolve, oppure tutto ripiomba nella fase della lotta, ancora preparatoria e occasionale, non decisiva.
Il mondo autogestito è certamente possibile chiamarlo “mondo nuovo”, anche se questa definizione dei sindacalisti rivoluzionari del passato è ormai troppo abusata, ma bisogna intendersi sulla “novità”. Non si tratta tanto di nuovi rapporti, a volte mostruosamente inimmaginabili – questo è l’aspetto meno interessante – quanto di nuove energie distruttive che si aprono nel corso stesso dell’azione di lotta e di produzione.
Tutto quello che avviene nell’ambito di questo processo autogestionario duplice – lotta-produzione – interagisce reciprocamente, si ibrida in fioriture improvvise e spesso incomprensibili, mai sperimentate, che necessitano di coraggio e di mano ferma, due elementi che gli schiavi di oggi, i lavoratori, hanno perso quasi del tutto. Eppure saranno loro, all’interno del processo distruttivo, e il loro mondo nel suo stesso crollare, che rimetteranno in circolazione coraggio e mano ferma. Il “nuovo” viene fuori dal “vecchio” in questo modo inaspettato. Mutano le forme dei rapporti sociali, esplodono non le contraddizioni – che queste si sono assopite nel cimitero del conformismo partecipativo – ma i rapporti totali, socialmente complessivi, che costituiscono la società nel suo insieme. Non sto parlando delle occasioni di lotta, ma di una lotta che ha realizzato la sua occasione rivoluzionaria, lotta autogestita che non contempla compiaciuta o desolata il proprio concludersi, ma che va oltre ogni possibile occasione e nega l’intermediarietà con qualcosa di vecchio che vuole sopravvivere e cerca in tutti i modi di presentarsi modificato e accattivante.
L’autogestione è questa avventura epocale, questo mostruoso scaraventarsi del nuovo nel vecchio, questa distruzione senza residui attivi, questa fecondazione della fantasia che crea e riempie di materia nuove forme di vita.
So bene che tutto questo non c’è nel mio libro e che il lettore resterà sorpreso o consolato a seconda che leggerà queste Annotazioni prima o dopo, non posso farci niente, spetterà a lui trarre le conclusioni del caso e se penserà di aver perso il suo tempo leggendo il libro, vorrà dire che io avrò perso il mio scrivendolo.
L’autogestione non possiamo più racchiuderla nei paludamenti dell’epoca produttiva, quando si riteneva seriamente che la rivoluzione sarebbe stata una semplice espropriazione dei mezzi produttivi, un passaggio di consegne. Usava dire così quarant’anni fa, oggi non sono in grado nemmeno di tornare a immaginare le basi di quella situazione e di quella cecità. Personalmente ho sempre pensato impossibile questo trasferimento, giusto corollario di una sorta di presa del Palazzo d’Inverno. Questo libro stesso ne è testimonianza. In ogni caso il tempo è scaduto e i giochi sono fatti, evocare condizioni morte da tempo è prurito storico oppure stupido interesse di partito. La distruzione adesso è la sola via praticabile per la lotta e la produzione autogestite, dolorosa ma ineludibile constatazione. C’è stata una perdita, una irreparabile perdita? Non lo so. Quello che si è perso è un mondo, un intero mondo che non ci era mai appartenuto. E poi, i mondi muoiono vecchi e rinascono bambini, la vita è questo alternativo concludersi e fiorire. Occhi blu me lo ha spiegato regalandomi una piccola pietra che ora stringo nella mia mano sinistra.
Ma bisogna capire quello che si perde e così meglio concorrere alla sua perdita, in caso contrario non si capirà quello che di nuovo arriva, scandito da ritmi sconosciuti, lancinanti. Bisogna convincersi che non si tratta di lenire una pena o rimediare a una perdita, ma alzare le vele verso l’avvenire. Bisogna essere fieri di questo scontrarsi e collidere di mondi in trasformazione, un processo mai visto, a cui partecipiamo noi con la nostra autogestione della lotta e della produzione. E come dare torto a simile fierezza? Si tratta di una svolta epocale, mai accaduta nella storia, e deve essere questo fatto unico, o sarà solo una ulteriore farsa per attoniti spettatori vicini ma incapaci di capire.
Questa sconvolgente avventura sarà possibile cominciare a prepararla a partire da ora? Ecco una domanda che molti si pongono anche se in effetti la rivolgono a qualcosa di più stabile, immaginato come società futura, libertà realizzata, anarchia, ecc. In materia di utopie passo la mano, non sono di mia competenza, qui ci si riferisce all’autogestione della lotta e della produzione intesa come distruzione radicale del mondo vecchio, e a questo voglio rispondere. Si può cominciare fin da ora solo se si è capito il pathos di quello di cui discutiamo, il battere del cuore rivoluzionario all’interno di un progetto di lotta che potrebbe presentare insegne pubblicitarie inadeguate. E siccome qui non facciamo questione di parole, “autogestione” è parola ancora utile e pregnante nella sua corrispondenza con il progetto che si sta illustrando, cioè è in grado subito di farsi capire.
Il pathos è la commozione umana che ci coglie tutti quando il destino ci chiama a un compito distruttivo. In epoca di progetti, metodi e razionalismo, l’autogestione corre il rischio di smarrire questo suo sostrato distruttivo e apparire come un modo intelligente e democratico di coinvolgere i lavoratori nella produzione. Non è così, quello che essa ci chiede è niente di meno che un comportamento epico, chiama allo scontro, alla lotta definitiva. I lavoratori non sono pensati, in questa prospettiva, come vile bestiame che passa da una gestione a un’altra. È povera prospettiva tenere presso di sé un minuscolo simulacro del vecchio mondo produttivo per misurarne le distanze e le differenze. Ecco perché la sfiducia stipulata una volta per tutte nei riguardi della scienza economica.
La nuova vita a cui fa appello questa prospettiva autogestionaria è un’esperienza non solo immediata, di lotta e di invenzioni produttive, ma intima, che coinvolge la coscienza di tutti coloro che la vivono. Non si tratta solo di un metodo, ma di qualcosa che trascende la procedura e si innalza a cuore filosofico di una società nuova, non adiacente alla vecchia, ma al posto della vecchia che da essa viene annientata. In questo nucleo centrale si mantiene, ribollendo in forme sempre nuove, la spinta alla lotta e, all’interno di questa, in un cerchio concentrico privo di limiti, la forza produttiva, l’insieme dei processi che possono non solo soddisfare vecchi bisogni ma inventarne di nuovi, senza limiti, senza che tutto si livelli al minimo denominatore della miseria. Questo cuore pulsante non è un’Acropoli da difendere, ma una sorgente di acqua limpida, di sogni, di mostruosità, di caos vivo che ogni giorno può ricominciare daccapo. Insomma quanto di più vicino all’anarchia si possa immaginare, qui e ora, mentre boccheggiamo nella melma politica che regola e viene regolata dalla produzione.
Le rovine del mondo vecchio non sono però faccende che possano liquidarsi solo col desiderio di pulizia, di aria libera, di entusiastica vita diversa, occorrono decisioni che non sono facili e che portano in sé una parte del mondo vecchio la quale, in questo modo, può intrufolarsi e guadagnare spazio e significato. Autogestire la lotta può essere progetto metodologico indispensabile quando la produzione capitalista sta di fronte, compatta e quasi indisturbata. In queste condizioni l’autogestione della lotta si presenta – e l’abbiamo visto – come una serie di occasioni da mettere a frutto, invece nel momento della fusione tra lotta e produzione, cioè nell’autogestione matura, la lotta, diventando più intensa e generalizzata, potrebbe prendere il sopravvento e sviluppare due pericoli. Il primo è un’atrofizzazione dei metodi di lotta e perfino un ritorno alle forme militariste tradizionali. Il secondo è quello di fare venire meno alla produzione il sostegno di difesa che appare indispensabile. Ciò condannerebbe lo sforzo complessivo a un ritorno indietro, a una catastrofe. Affidarsi all’incrudelimento dello scontro, e soltanto a questo, è sempre un passo indietro. Se all’inizio la lotta è un insieme confuso, e perciò stesso incomprensibile al nemico, con le nuove necessità smetterebbe di essere un bric-à-brac per irreggimentarsi.
Bisogna far crescere la foresta, non trasformarla in un giardino coltivato. È nella foresta che la lotta si sviluppa facendo interagire uomini e cose, problemi e creatività, dando vita a un labirinto di efficienza involontaria, di caos non risolvibile, di sconosciute iniziative – spesso minime – e perciò stesso difficilmente estinguibili. Questa foresta deve crescere rimanendo lussureggiante e imprevedibile di fronte al nemico adesso in pieno assetto di guerra in atto. Non esiste, nella guerra sociale, anche nell’espressione della sua massima generalizzazione, un epicentro dove fare convogliare tutte le proprie forze, come non esiste uno scontro decisivo.
La nostalgia di un mondo passato, dove stavamo come midollo in un osso rosicchiato dai cani, è uno degli ostacoli maggiori. Spesso ci si blocca nel corso del processo distruttivo perché non si sa come rispondere alle sollecitazioni della memoria. Il ricordo delle stesse sofferenze è a volte allettante. Dopotutto, anche esse sono state parte della nostra vita e coinvolgerle nell’azzeramento produce di riflesso la cancellazione di una parte della nostra stessa vita. Eccoci quindi demolitori a metà, si vuole ma ci si rammarica. È difficile trovare chi sappia usare decisamente l’accetta fino in fondo. Essendo profondamente materialisti abbiamo una fede fisica nella materia e ci duole distruggerla, fossero pure le carceri di ieri o le catene di montaggio di un ieri più recente. Non è meglio cambiarle in biblioteche? E le chiese? e i musei? La lista è lunga e dentro tutti questi luoghi abitano ancora i fantasmi di quello che abbiamo sofferto. E noi questi fantasmi li amiamo e non vogliamo spazzarli via, essi piangono sotto i colpi della distruzione e le loro lacrime sono quelle delle nostre pene. In fondo siamo convinti dell’imperituro mantenersi della materia e della continua trasformazione della vita.
Impariamo a congedarci dal passato, dal nostro passato, non solo da quello del nostro nemico – in fondo non si tratta di due cose diverse. Dentro di esso non ci sono i fantasmi ma c’è la nostra vita, e questa ha un senso rivoluzionario solo se proiettata violentemente verso il futuro. Si tratta di un fardello che dobbiamo mettere a terra per guardarci dentro con attenzione, come sto facendo con questo libro. Non si tratta di congedo ma di tensione. Sono tanto vecchio da potermelo permettere, la vita – per me ormai breve – è solo nel futuro, dal passato proviene la storia delle nefandezze umane, delle atrocità che la bestia continua a perpetrare senza fermarsi, con i piedi ben piantati nella melma della politica.
Continuare ad abitare nel passato, nelle emozioni del passato, è di già un forte freno alla distruzione. Ma come faccio a mettere in gioco tante cose? Si tratta di tutto quello che ho, mi rintoccano le campane a morto nelle orecchie. Non è vero, posso rispondere, non sono tutto quello che hai, ma tutto quello che sei. Racchiuditi pure nel tuo guscio, amico mio, in questo prezioso involucro le disgrazie si alterneranno alle gioie e viceversa, ma tutto avrà pari peso, tutto si compenserà e si eguaglierà in una prospettiva commisurata alla miseria stessa della tua vita. Non accettandone la distruzione si resta prigionieri di un mondo vecchio che finirà per immiserire le pratiche nuove – di lotta e di produzione – anche se si è profondamente convinti di sapersi autodeterminare all’autogestione.
Nella mia vita ho ascoltato tante proteste contro i misfatti dello sfruttamento da parte di coloro che avrebbero voluto distruggerlo salvando le sue realizzazioni “migliori”, o almeno più tollerabili. Qui c’è aria di buonsenso mista a sacrificio. Chi assiste a questi battibecchi da galline si rende conto che c’è tanto spirito quanto se ne può tollerare in un polemista francese, quanto ne basta per renderlo leggibile e insignificante.
Siamo davanti alla vera follia, quella usata per non farci definire folli da chi ascolta le nostre tesi inaccettabili. Questo modo di procedere significa salvare la faccia. Siccome non abbiamo nessuna faccia da salvare, eccoci qua a deporre per terra il fardello di questo libro sull’autogestione.
Bisogna intendersi. Siamo davanti alla miseria estrema del capitale, da un canto, dall’altro alla proposta autogestionaria, di lotta e produzione, si tratta di scegliere. Se vogliamo lasciare le cose come stanno, con le nostre teorie messe in bella mostra una dietro l’altra, bisogna convivere con la miseria, quella del capitale e anche quella delle nostre povere tesi, cooptate dal tornado capitalista e trattate come un fuscello. Misero il capitale, misere le nostre tesi. La miseria iniziale è infettiva e condiziona qualunque cosa diciamo. Perfino lo spirito estremo degli scrittori rivoluzionari – loro si credevano tali – francesi, si è evaporato a contatto con questa miseria. Poiché non vogliamo aggiungere miseria a miseria, o rompiamo il cerchio, o buttiamo le nostre tesi nel cestino.
Eppure questi contrasti si sono fronteggiati, personalmente lo confermo per gli ultimi quarant’anni. Sì, fronteggiati come occasioni da mettere a frutto nella miseria dove avrebbero potuto sbocciare come fiori dal concime. Non è stato così. Qualche pallido tentativo e mai nel senso pieno dell’autogestione della lotta e della produzione. Questo mancato accadimento ha avuto un senso? Io penso di sì.
Capire una tesi rivoluzionaria richiede alcuni elementi che non sono tutti di natura intellettuale. Occorre essere rivoluzionari, cioè avere scelto una vita rischiosa, contraddittoria, problematica, che continuamente propone a se stessa esperienze e le rinnega per andare avanti. Per queste persone, che hanno fatto questa scelta, quella tesi ha ridondanze che non ha per altre, forse più intelligenti e più colte. Occorre quindi che si realizzino incontri sfolgoranti tra tesi e persone che quelle tesi fanno entrare nella propria vita. Questa alleanza, aleatoria, produce l’autogestione e non la semplice lettura di questo vecchio libro o di queste Annotazioni. Lo splendore di tale incontro non può essere descritto, deve essere vissuto. Improvvisamente tutto diventa più chiaro e ricomincia a vivere quello che si conosce, conoscendo nello stesso tempo quello che si vive.
Ma nel mondo, oggi aperto in modo ormai non nascondibile alle oscenità del capitale, una simile idea splendida, una irradiazione tanto potente, capace solo di sbocciare nella distruzione definitiva, ha perfino qualcosa di ridicolo. Il pauroso buonsenso di coloro che tengono i piedi per terra insorge subito per bacchettare chi ha colto il significato profondo di queste parole: Distruzione Totale e Autogestione. Oggi nessuno, nemmeno i rivoluzionari anarchici, crede nella distruzione totale e parla di autogestione senza sentirsi un po’ ridicolo. È proprio quello che queste Annotazioni, scritte in un luogo in cui non si conosce il senso del ridicolo ma solo quello dell’orrenda oscenità repressiva, non intendono accettare. La splendida coabitazione del binomio: Distruzione Totale / Autogestione, può fare paura, come è comprensibile che sia, ma non per la propria inverosimiglianza – fonte consueta del ridicolo – piuttosto per la sua radicale lontananza dai due concetti che lo costituiscono, una volta separati. Ed è di questo che ci occuperemo adesso.
La distruzione – di cui ho parlato a lungo altrove – non si riassume nella lotta autogestita e non può essere presupposta nell’autogestione della produzione. La distruzione è all’inizio uno stato mentale. Il mondo si sta prosciugando e noi strisciamo nella melma alla ricerca di una polla d’acqua pura, camminiamo radenti un muro nella nebbia e non sappiamo dove andare. Il significato umano di questi gesti è scomparso e non può essere recuperato. La nostra capacità di vivere è estranea a questo mondo, è stata mandata in esilio. Volendo tornare indietro troveremmo realtà incomprensibili, marciume e oscenità, tra noi e il mondo si è scavato un vallo incolmabile dove precipitiamo sempre più. Pochi sono quelli che si rendono conto di questa estraneità, quei pochi sono gli uomini dell’autogestione, a essi il compito di distruggere quello che sta ingoiando tutti gli altri.
La scomparsa di un mondo non è un fatto avvertibile con facilità, accade, e quasi nessuno si rende conto del lutto che ci colpisce, che ci immalinconisce, che ci rende ciechi e orfani. E questa cecità è progressiva e irreparabile. In questa caduta siamo tutti coinvolti, anche coloro che la sostengono e concretamente la realizzano quasi senza saperlo, i capitalisti. Non è vero che loro si stanno salvando nei castelli teutonici del passato, questa non è la peste, è la morte senza colore, è la morte di un mondo. Qualche decennio fa anch’io ho pensato possibile per loro un salvataggio in questi castelli arroccati sul nulla, oggi non più. Le condizioni di vita sono profondamente cambiate. So bene che qualcuno potrebbe trovare incomprensibili queste parole, non sono un interclassista, gli inclusi stanno distruggendo il mondo per il loro interesse esclusivo, noi lo distruggeremo perché nasca una società autogestita nuova, per tutti, non solo per gli esclusi. Questa distinzione ha un senso in un mondo morente, in un mondo distrutto è priva di senso. Per il momento stiamo calpestando le future rovine che possiamo intravedere in filigrana nella stupida pompa del mondo multicolore che addormenta ogni giorno la nostra fantasia. Grattiamo la patina che ricopre questo mondo e subito vedrà la luce l’oscenità sottostante, la melma politica, la gozzoviglia produttiva insensata, l’improntitudine finanziaria senza scopo. Tutto questo è destinato irrimediabilmente a perire, può spegnersi da solo nel sacrificio di tutti, affogando ignominiosamente nella propria melma, o il progetto autogestionario lo distruggerà. Ecco il punto.
Quale che sia il mezzo distruttivo che sceglieremo, il nostro avrà la prospettiva di dare vita a un mondo nuovo, la distruzione capitalista ha in prospettiva solo la sopravvivenza a breve scadenza, sacrificandoci tutti alla miopia del 3%. Questo luogo che chiamiamo mondo deve quindi essere distrutto, esso è stato reso malato e inservibile dalla cecità capitalista, noi siamo stati soltanto complici per non avere avuto la capacità di reagire in tempo. Ormai è troppo tardi, è un altro luogo che portiamo nei nostri cuori, ed è questo nuovo luogo che l’autogestione vuole realizzare.
L’infelicità intrinseca a questo progetto è immensa, ce ne rendiamo conto, ma non ci sono alternative. Non si tratta di allungare la catena degli schiavi o di verniciarla, si tratta di spezzarla, e nessuna distruzione si fa senza lacrime e sangue. Ma questa infelicità futura, le pene che subiremo e che causeremo, non possono misurarsi in base all’infelicità passata, sono due mondi diversi, tra loro incomparabili. Domani potremo solo constatare l’assenza della passata infelicità.
Scrivendo queste considerazioni estreme sull’autogestione mi rendo conto di tirare troppo la corda, ma il tempo stringe e voglio dire esattamente quello che penso, non quello che posso presumere risulti gradevole a chi vorrà leggermi. Sto per diventare irrimediabilmente estraneo alle mie ipotesi di lavoro, dopotutto non ho molti anni davanti a me, e non vorrei che questa estraneità più o meno prossima, che nel posto dove mi trovo si profila quotidianamente nelle forme più violente, mi faccia velo. Ecco quindi che mi sforzo di andare un poco più oltre, di essere un poco più efficace. L’autogestione senza distruzione del mondo vecchio è un progetto intermedio, valido, interessante, ma condannato alla sua veste di occasione o di esperimento produttivo. Autogestione e capitalismo si escludono a vicenda. E per eliminare il capitalismo bisogna distruggere il mondo che esso ha ormai definitivamente fagocitato.
Parlando di autogestione viene subito in mente la sua condizione essenziale ed efficiente, la distruzione totale del mondo vecchio. È una sorta di resa dei conti in cui a spese di tutti le sofferenze millenarie di alcuni vengono pareggiate con magnanimità equanime. Non voglio dire che dalla distruzione del mondo vecchio nascerà un mondo perfetto, solo che nascerà un mondo nuovo, forse con nuove sofferenze e nuovi conflitti, ma diversi.
L’autogestione, producendo un mondo diverso, produce anche se stessa come struttura complessiva di questo mondo così perigliosamente venuto alla luce. Quello che chiamavamo autogestione prima era una dicotomia formata da lotta e produzione, adesso è semplicemente la società autogestita. Certo, le ombre dei problemi passati si ripresenteranno ed evocheranno soluzioni già sperimentate come fallimentari, ma questo fa parte dello scontro distruttivo iniziale, poi ci saranno altri conflitti, sui quali non si può prevedere nulla, gli anarchici saranno sempre portatori del loro messaggio di liberazione da tutti i vincoli, anche in una società prodotta da un mondo nuovo.
Certo, queste ombre e questi fantasmi saranno impersonati da uomini con i quali bisognerà fare i conti fisicamente, come è sempre accaduto, e da idee del passato avventurosamente sopravvissute al cataclisma distruttivo, idee che bisognerà criticare, ma anche questo fa parte della spinta distruttiva. La rivoluzione marcia sempre su uomini e idee che non intendono accettarla. Nella rivoluzione tutti perdono qualcosa che non possono più ritrovare, vi troveranno altro, forse il mostruosamente altro, nessuno può garantire guanciali di piume. Tutte le sofferenze di coloro che hanno subito i colpi della ferula sotto la schiavitù si presentano compatte nella distruzione, non solo la loro idea restaurata come spauracchio per i vecchi responsabili, ma concretamente. Gli schiavi non avevano nulla se non la pelle spianata dalla frusta, i capitalisti di ieri, dopo la distruzione procurata in maniera generalizzata dall’autogestione, non avranno più nulla non potendo nemmeno offrire la propria pelle mancando la frusta. I dimenticati, i poveri – che trista parola – gli sconfitti, insomma quella grande massa di esseri umani che i capitalisti usavano come carne da macello, entreranno anch’essi nella distruzione, ed è all’interno di questa enorme catastrofe generalizzata che perderanno anche loro non le ricchezze che non hanno mai avuto, ma l’interiorizzazione della propria miseria, il proprio statuto di ultimi, di dimenticati.
Insomma, ben lontana dal quadro idilliaco di un’autogestione riassumibile in forti teoremi di autodeterminazione riguardanti la lotta e l’assetto produttivo, questa appare adesso nella sua veste rivoluzionaria di coinvolgimento generale di tutti, nessuno escluso, nella distruzione. In questo evento epocale moriremo tutti, forse non della morte fisica, che in fondo sarebbe per ognuno di noi l’evento più estraneo, ma di una morte riguardante quello che siamo, rivoluzionari parziali in primo luogo. Il colmo della tristezza si capovolge nel colmo della gioia. Il progetto, dapprima ridicolmente inadeguato al suo compito radicale, si espande e permette di far vedere le prime tracce di quello che verrà dopo, la produzione autogestita, e altro ancora.
Non pretendo di essere convincente, so bene che qualcuno dei tanti che mi hanno assillato per tutta la vita si chiederà se non è questa un’utopia rovesciata, dandomi sulla voce, a me, odiatore di ogni genere di utopia. Ebbene non è così. Se si parla di “autogestione” è di questo sconvolgimento del mondo vecchio che stiamo parlando, non di qualcosa che ci è familiare e che anche oggi quasi possiamo toccare con mano – lotte intermedie, anche insurrezionali, e produzione autodeterminata o cogestione – ma di una realtà che non ci è consanguinea, qui nel mondo della melma politica e capitalista. E poi, il fatto di non essere frequentatori assidui di scontri rivoluzionari – qualcuno si limita a codificarli sulla carta andando avanti e indietro nella storia – non ci toglie la patente di distruttori, per il semplice fatto che nessuno ce l’ha mai data.
Capisco che ci vuole una certa ampiezza di vedute, senza stare a scomodare vastità di pensiero, per rendersi pienamente conto di quello che stiamo dicendo, e ci vuole anche ciò che definirei un ottimismo melanconico, cioè una sollecitazione verso la catastrofe distruttiva totale, voluta da noi, secondo il progetto autogestionario, e non imposta cinicamente dal capitale, a modo suo e con i tempi suoi.
E per accettare questa prospettiva occorre una grande fiducia nel progetto insurrezionale e autogestionario, oltre a una profonda conoscenza del mondo in cui viviamo, della sua povertà, della sua irrimediabile decadenza, un mondo che da se stesso chiama a gran voce la propria liquidazione. Gli scultori e i sottolineatori del particolare che può ancora essere salvato sono legione, non speriamo di convincerli, lascino qui la lettura se mai l’hanno intrapresa, vadano altrove a impiegare il proprio tempo, l’assistenza sociale è un grande fiume che accetta qualsiasi ruscelletto.
Se azzeriamo la prospettiva autogestionaria che qui stiamo delineando, riduciamo i nostri stessi tentativi di lotta intermedia a pallidi riflessi di un progetto più grande, messo da parte per paura o per accondiscendenza alla tradizione sindacalista rivoluzionaria del tema che ci occupa. Lontano dalla distruzione come programma totale, la stessa lotta rinsecchisce e la produzione che potrebbe fare un tentativo di autogestirsi sviene nelle braccia della cogestione. L’idea che fonda questo meraviglioso progetto getta le sue basi nel futuro, ed è qui che diventerà pienamente comprensibile, adesso è come se si parlasse di una meraviglia mai vista da alcuno, che non è possibile dettagliare se non si vuole cadere nel ridicolo. Oggi questa meraviglia è assente, quindi stiamo parlando di un’assenza, ecco perché le nostre tesi sono condannate in partenza a essere una versione sminuita, smozzicata, che arranca e non convince se non coloro che di per sé si procurano i mezzi per convincersi. Quello di cui parliamo, che appare come l’estremo lembo della terra radicale dove attecchisce la terribile pianta della distruzione, è invece un pallido riflesso attenuato, qualcosa che nelle parole traspare ma che è privo di calore e di vivacità. Inesauribili sono gli elementi che mancano, noi che ce li prefiguriamo restiamo sbalorditi del loro estendersi e del loro reciproco intricarsi.
Entrando in questo intrigo maestoso tutti gli elementi che posso scegliere – ad esempio, la selezione dei beni di sussistenza immediata da espropriare e non distruggere – appaiono paradossalmente immiseriti dalla fioca luce che filtra nel clima ovattato e fiacco che ci ospita (per una volta non mi riferisco al lager dove scrivo queste righe). Ecco perché questo esercizio è disperante e, in questa sede, nemmeno necessario.
Dall’esercizio precedente, se si vuole infelice quanto gli altri che avremmo voluto scegliere, viene fuori come il coniglio dal cappello il problema della fase transitoria, centro oscuro e palude mefitica di ogni progetto rivoluzionario. Se immagino questa fase come una grande festa, sulla scia dell’esperienza di Bakunin, potrei essere facilmente smentito. Se l’immagino come un urgente mattatoio da montare in fretta perché in fretta cominci a tagliare teste, potrei essere accusato di dare la stura a vendette individuali, con le miserie da cortile che si portano dietro. Se l’immagino come una vasta distesa di macerie e di campi di baracche, potrei essere additato come fautore del tanto peggio tanto meglio.
La questione è che la distruzione totale non l’abbiamo conosciuta, essa appartiene all’autogestione realizzata, quindi al futuro. Quella che conosciamo è una serie sterminata di distruzioni parziali attuate dal capitale, quindi un ammasso informe di uomini vivi e morti, di cose giacenti smembrate e derelitte, di animali in putrefazione. Ma sono realtà che non possono essere comparate tra loro. Quello che il futuro può realizzare, cioè la distruzione totale autogestita, non è un serraglio di meraviglie, con i responsabili dello sfruttamento alla fine castigati, ma è qualcosa di inimmaginabile.
Chi vuole piangere su questa enorme quantità di latte che verseremo, lo faccia pure, forse non se ne rende conto ma è implicitamente un coadiutore del presente stato di miseria e di sfruttamento. Pianga, se crede, per le sofferenze patite, per la distruzione realizzata dal capitale, per l’immonda necropoli politica che ci soffoca, ha una vasta serie di cose su cui poter piangere. La massa dei misfatti del capitalismo può così alla fine rovesciarsi in una prospettiva di liberazione purché tutto venga capovolto, anche se in questo modo tutti lamenteranno una perdita, chi le proprie ricchezze e chi le proprie catene.
Dobbiamo renderci conto della potenza visionaria che occorre per parlare di autogestione, in contrappunto polemico perfino con il libro mio che qui insisto a ripresentare. E certo è carente in esso proprio questa potenza, anche accennandovi a tutto quello che occorre per saldare la produzione autogestita alla lotta. Quello che abbiamo nelle mani è il nostro patrimonio di lotte, ma per quanto insurrezionalmente sviluppate, esse sono troppo livellate dall’assenza della distruzione totale, a cui però, inevitabilmente, rinviano. Lottiamo stringendo nelle mani, qui e ora, i nostri miserrimi possessi, mentre la produzione langue in lager separati, dove fischia la ferula del capitalista. Anche se i dolori sono innominabili e la nostra rabbia esplode feroce, non c’è rapporto con la distruzione totale, se non attraverso la visione della mostruosità indicibile. Questa cosa che non è possibile dire mi spinge all’azione.
È disperante descrivere un panorama sconosciuto di cui non si hanno né le proporzioni né i colori. È grottesco insistere in un lavoro di Sisifo. So che anche questa giustificazione a continuare è sgangherata ed ha bisogno di più di un sostegno per riuscire almeno a zoppicare. È il mio destino quello di coinvolgermi in imprese impossibili.
Ci sono condizioni che è possibile immaginare, perfino nei dettagli, e condizioni che si riferiscono a un’atmosfera non immaginabile. Queste ultime richiedono una visione d’insieme – pratica e teorica – che non trova riscontro in quello che si ha sotto gli occhi, anche se da ciò deriva come conseguenza mostruosamente diversa di un evento traumatico radicale. Questa è l’autogestione realizzata sulle macerie che la distruzione totale ha generalizzato nel mondo vecchio. Occorre quindi installarsi in tale dimensione non con la semplice fantasia – questa sarebbe vera e propria utopia – ma concretamente sulla base di ciò che il mondo vecchio mette a disposizione, selezionando ciò che va espropriato subito per rendere possibile l’avviamento dell’autogestione generalizzata, da ciò che va distrutto subito, uomini e cose. Niente di ciò, insomma la melma politica e capitalista, può essere considerato pegno del progetto distruttivo. Niente è più in vendita e niente più si paga, quindi non ci sono mallevadori che possono garantire per qualcun altro, ognuno salda i suoi debiti e i suoi crediti, tutto è azzerato e ricomincia daccapo, dall’organizzazione autogestita della produzione e del consumo dei beni preventivamente espropriati.
Una logica perversa insiste sulla durata limitata di questi beni espropriati e sulla lentezza con cui si possono organizzare i nuovi processi produttivi. Qui c’è tanta verità quanta ne trovano di solito i benpensanti di fronte a ogni impresa disperata. Ma la rarefazione stessa delle possibilità di riuscita porta necessariamente con sé una radicalizzazione dei comportamenti, non ci può essere tempo per i tentennamenti o per le scelte estetiche migliori. Tutto deve nascere di nuovo, quindi sarà un mondo che emette vagiti non parole o discorsi. In questa atmosfera neonata bisogna calarsi se si vuole parlare di autogestione. La bilancia dei pro e dei contro immediati, quella su cui pesiamo continuamente la quotidianità, va rotta in uno con la responsabilità di cui ci siamo da sempre fatti carico, quella che vuole a tutti i costi ridurre i danni. Ebbene, occorre alla fine essere irresponsabili, il passaggio alla distruzione totale è questo ribaltamento, solo così le scelte decisive sono più aspre e decise.
L’alzarsi di un processo di ribaltamento complessivo non è uguale e semplice come la mano che colpisce o annienta chi ci opprime. Mille mani possono alzarsi in questo gesto liberatorio senza che nulla succeda, quale è allora il mistero che opera all’interno di un movimento epocale senza precedenti come l’autogestione generalizzata? Il fatto straordinario è che sofferenze e godimenti vengono allo stesso modo azzerati, non si eredita una condizione comoda e confortevole per goderne, non si espropria nessuno – se non della trascurabile ma necessaria parte dei beni di consumo immediati – ma si porta a completamento, in tutt’altra direzione, la distruzione che ottusamente il capitalismo aveva cominciato per garantire i propri interessi. La vendetta è portata così dentro il cuore stesso del capitale, dentro la sua dissennata smania di considerare proprio possesso il mondo intero. Invece il mondo è dichiarato vecchio e inservibile, quasi totalmente, e ribaltato nel mondo nuovo.
Non limitandosi a sostituire un pezzo della macchina oscena, l’oscenità stessa della macchina è portata alle sue estreme conseguenze, quindi distrutta, cancellata, nientificata. C’è un incontro segreto e mostruoso tra la distruzione in corso attuata dal capitale e la distruzione totale futura che attuerà l’autogestione generalizzata, una circolazione sotterranea che non può essere colta nel singolo sfruttamento o nella singola azione di lotta intermedia, questi sì ben separati tra loro.
Viene così alla luce, nel mondo nuovo, una incomprensibile coesione di macerie, quelle della melma e quelle che mettono fine alla melma. Non avremmo mai potuto aspirare alla distruzione totale autogestionaria se il capitale non avesse di già distrutto una parte considerevole del mondo vecchio, ci saremmo sempre limitati alla prospettiva di una espropriazione dei mezzi di produzione e a un progetto diverso di organizzazione produttiva. In questo incontro mostruoso si vengono a mettere in evidenza le grandi possibilità della distruzione come prodromo della creazione della società nuova.
Le sofferenze dello sfruttato saldano così il godimento dello sfruttatore? Non proprio, perché entrambi finiranno nell’autogestione dove non dovrebbe essere possibile il potere sugli uomini, in caso contrario bisognerebbe cominciare daccapo, e questo gli anarchici lo sanno bene. Ogni azzeramento è sempre un complice scambio di possibilità. Distruggendo la forma e la sostanza dello sfruttamento si rende accessibile il godimento anche a coloro sui quali prima fischiava la ferula, e distruggendo il godimento dei privilegiati si rende possibile una produzione senza sfruttamento per tutti. Siamo entrati nella zona oscura della distruzione, qui dentro non ci sono separazioni se non quelle provvisorie a carico degli stupidi che non sapranno cogliere la trasformazione epocale in corso. In fondo, il metro con cui misurare il mondo nuovo non sarà più la ghigliottina.
A questo punto i miei pochi lettori si possono dividere in due gruppi, il primo si interesserà solo dei processi distruttivi – adesso soltanto con la fantasia –, il secondo solo ai nuovi processi produttivi – anche questi con la fantasia –. Mi dispiace ma io non mi schiero né con una parte né con l’altra. Se questa separazione avviene non si è capito il lato oscuro di questo precipitarsi nell’autogestione, a capofitto e senza garanzie. Certo, mi rendo conto che è pericoloso pensare questa condizione inimmaginabile, ma è proprio di questa ipotesi disagiata che stiamo parlando. L’intelligenza media, educata alle cautele e alle prudenze, non ha accesso a questa zona oscura e se per caso vi piomba dentro si sente fuori luogo. I concetti che maneggia sono quelli dell’a poco a poco e si stomaca del tutto e subito.
Fermarsi sulla soglia di questo accadimento epocale è certo possibile a una condizione, collaborare con lo sfruttamento, oggi, in modo che quel principio non si apra e che tutto si mantenga in bilico tra essere e avere, in attesa di un altro genere di catastrofe, quella che il capitalismo sta mettendo in scena senza pietà per nessuno.
Il fatto è che in molti preferiscono annegare nella noia, nell’angoscia, nella tristezza e cadere alla fine sotto la sferza dello sfruttatore, piuttosto che scatenare un conflitto epocale. Scavando a fondo c’è nella delega del comando produttivo il desiderio di non pensare, il pensiero è troppo pesante, meglio l’accattonaggio e la schiavitù. Ben al di là dello scambio capitalista, osservabile alla superficie tramite l’intermediarietà fittizia del denaro, c’è questo scambio reale che struttura il mondo, sofferenza contro sopravvivenza. È così che la vita procede acciaccando le proprie possibilità, azzoppandosi per non correre, una sorta di ritmo metastorico che non è facile capire seguendo le due filiere separate della difesa produttiva, da parte di chi ritiene di avere bisogno dello sfruttamento, e l’attacco produttivo di chi ha bisogno realmente dello sfruttamento per dominare e garantire l’avvenire del progetto capitalista.
Questo stupefacente meccanismo trova origine nel crimine stesso che l’uomo è capace di realizzare sia nel ruolo di soccombente che in quello di sopraffattore. Questa melma, di cui esempio eclatante è la putredine politica, si accumula infinitamente, interagendo senza tregua con tutti i progetti di liberazione, da un lato, e con quelli produttivi dall’altro lato. Questo rapporto può essere continuamente sottoposto a manutenzione per meglio funzionare, ma strutturalmente rimane sempre lo stesso. Niente può eliminarlo, cancellarlo, perché questa cancellazione cancellerebbe il mondo. Noi vogliamo proprio questa cancellazione, per noi non ha alcun senso diversamente intesa, cioè lasciando questo mondo in piedi così com’è o continuando a sottoporlo a periodiche manutenzioni.
È questa connivenza che apre in me una ferita profonda e larga non appena mi rendo conto di essere complice dei crimini che intessono la storia dell’uomo con monotonia ributtante. Non c’è modo di sanare questa ferita che anzi imputridisce sempre più ignorandola e ricorrendo allo svago prodotto dal capitale tra un colpo di frusta e l’altro. Non appena la mia coscienza se ne rende conto per me è finita, come uomo attivo il mio ruolo è concluso, non mi resta che morire ogni giorno un poco facendo finta di vivere. In questa prospettiva funeraria l’autogestione, correttamente pensata, fa scivolare il controveleno del dubbio. I valori sacrosanti del capitale e della melma politica sono finalmente denunciati alla luce del sole, non ci sono più connivenze involontarie ma soltanto complicità volontarie, e da queste non ci si salva, si cade con loro.
La maggior parte degli schiavi alimenta una fallace acrimonia contro lo sfruttamento che cresce per tutta la vita, fino all’età della pensione. Di regola questa amarezza accelera l’esistenza senza che ce ne rendiamo conto, la immiserisce, la sgualcisce e la riduce a un relitto, mentre la famiglia copre le sue vergogne con una patina di perbenismo. perfino nella diversa ma equanime distribuzione delle responsabilità sessuali, a ognuno la sua parte. I sussulti ribellistici che qua e là balenano nelle lotte intermedie, privi di uno sbocco distruttivo concreto e totale, si avvitano su se stessi e si macerano nella ricerca del progetto più puro e coerente. Il recupero di questa immensa potenzialità di rivolta è una delle industrie più fiorenti.
Abbiamo in passato visto in che modo si possono catalogare le responsabilità di questo recupero e della sostanziale inazione. Ed è stato lavoro utile, eppure, come le lotte intermedie, non può bastare. Il vero responsabile, al di là del sindacato o del partito, è lo stesso sfruttato, colpevole se non altro di non insorgere e morire. L’aria trionfante dei capitalisti è là a dimostrare questa amara notazione critica. Essi hanno vinto le loro battaglie riuscendo a distruggere, a poco a poco, il mondo. La triste vicenda di questo tramonto del mondo vecchio, che si avvia a svuotarsi dall’interno come una mela marcia, mantiene in vita una incredibile aura di benefattore attorno alla figura del capitalista, e questa è l’ultima beffa, il tocco finale di comicità della tragedia che ci circonda.
Ma può una tale prospettiva di radicale sconvolgimento, distruzione totale, qualificare in senso positivo la società autogestita che ne verrebbe fuori? Non è possibile rispondere a questa domanda, alla quale non vogliamo comunque sfuggire per due motivi. Il primo è che nessuno ha la ragione assoluta, nessuna realtà nasce buona in tutte le sue parti, nemmeno l’autogestione generalizzata. Il secondo è che nell’autogestione tutto va reinventato nuovamente, lotta e produzione, ovviamente su basi nuove, e non è detto che queste basi nascano connaturate alla bontà dell’ipotesi autogestionaria. Niente lusinghe, torneremo a lottare, anche nelle mutate condizioni, contro ogni nuova idolatria. L’uomo della condizione a venire è inondato – alla pari delle cose che lo circondano come disiecta membra – dall’autogestione, è saturato da quello che occorre realizzare di nuovo, praticamente tutto il mondo, ma è pur sempre una bestia maligna e potrebbe trovare, fra le pieghe, la possibilità di ricostruire il meccanismo con cui coprire di melma la realtà, il meccanismo politico, anche senza saperlo, non essendo possibile che le passate esperienze scompaiano nel nulla, sia pure in un mondo completamente mutato. La vita stessa di questo maligno essere può suggerirgli le sotterranee vie della novella prevaricazione. Contrastare questi nuovi progetti sarà il compito del fronte interno da aprire subito mentre si stanno realizzando i processi autogestionari generalizzati.
Il mondo nuovo non è retto da un’armonia cosmica stabilita una volta per tutte, è sempre un mondo dell’uomo ed eredita le caratteristiche di questo straordinario animale, capace di sublimi azioni e atrocità senza limiti. Ma è sempre un mondo nuovo, dove ogni debolezza può capovolgersi nel suo contrario, in un processo in cui questi capovolgimenti non sono mai bilaterali ma multipli, interagendo fra loro in una rete praticamente sterminata. Non è un modello già conosciuto che stiamo delineando, siamo nella zona oscura della vita sociale, e qui la malevolenza a priori è solo uno stupido gioco al massacro. Bisogna entrare nei singoli momenti di questo progetto, nei collegamenti che produce, e ammettere che la sua radicale estremizzazione è più che ragionevole, essendo ormai l’unica strada da percorrere se non si vuole andare incontro all’altra distruzione, quella ciecamente priva di sbocchi, voluta dal meccanismo capitalista.
Inoltrarsi in questo nuovo territorio significa non portare bagaglio con sé, non possedere più nulla che faccia compagnia, che conforti e ci identifichi per quello che siamo. Le macerie sono la sola proprietà comune pensabile, a parte qualche rimasuglio di immediata sopravvivenza. Quello che si possiede adesso è esclusivamente quello che si è, ma si è quello che si produce in maniera autogestita. Nasce così una nuova intimità con le cose che finiscono per avere la meglio sulle rovine, intimità non d’uso ma di fraterna collaborazione. Sono cose che diventano familiari all’uomo, non sue incomprensibili nemiche, e gli parlano non più nella solitudine ma nella nuova realizzata affinità collettiva. Quello che comincia a profilarsi non è più un fantasma mentale, ma concrete produzioni e altrettanto concrete distruzioni. Nasce l’uomo nuovo produttore, muore l’uomo vecchio, e se non vuole morire lo si obbliga a cadere insieme al vecchio mondo che cerca a tutti i costi di mantenersi in vita.
Questo radicale capovolgimento non è un pretesto o un artificio per eliminare il capitalismo, non è una radicalizzazione testarda delle lotte intermedie con in più un maggiore uso della dinamite e della ghigliottina. È un passaggio obbligato, anche con pause più o meno lunghe, ma obbligato, dove è secondario, sebbene non superfluo, l’intervento diretto a mettere fuori uso preventivamente gli elementi più inflessibili della repressione capitalista. Intendo qui riferirmi alle azioni insurrezionali realizzate prima dell’autogestione generalizzata, che a questa esclusione tendono anche se spesso, a livello di analisi, sembrerebbe non ne siano consapevoli. Quello che corre il rischio di restare vago e indistinto, perché la realtà dello scontro ha mille contrappunti inconsapevoli che lo rendono tale, di colpo rientra nel grande alveo rivoluzionario dell’autogestione e non è più una piccola polla d’acqua isolata nel deserto, ma un grande fiume che travolge e toglie di mezzo tutti gli imbrogli e tutte le incertezze. Non c’è una dottrina rivoluzionaria capace di distillare questo capovolgimento, non c’è un timbro giusto con cui gridarlo forte ai quattro venti. In ogni caso queste eventuali possibilità arriverebbero sempre troppo tardi. Ed è d’altro canto stupido trascorrere tutta la vita con gli occhi fissi su questo snodo essenziale, imbambolati nell’attesa, è questo un modo principe per disseccare ogni possibilità di realizzazione del mondo nuovo.
La distruzione è una forma di consumo, violento e immediato. Sto parlando della distruzione totale autogestionaria, invece quella che il capitale realizza è lenta ma procede verso un abisso privo di futuro, la semplice soppressione del mondo, non la creazione di un mondo nuovo. Restando nei termini economici dello stesso capitale, il consumo è l’antecedente logico della produzione, legge che è valida proprio perché appartiene alle cose in generale ed è legge della vita, prima di essere formulata dall’economia. L’autogestione produttiva segue pertanto al tipo particolare di distruzione che abbiamo presagito, non può innestarsi sul tronco marcio della distruzione capitalista.
Io ho difficoltà a immaginare di essere capito, non mi capita spesso e non vedo perché deve accadere giusto adesso, di fronte a un fatto di tale portata. E poiché ho fatto l’abitudine a questa tragica condizione di lavoro, vado avanti. Potrei lanciare un appello lancinante, per favore fermatevi un momento a riflettere, potrebbero essere queste le ultime righe che vi indirizzo, considerata la situazione oggettiva in cui mi trovo, ma non sarebbe che un sotterfugio per richiamare attenzione per pietà. Lontano questi sepolcri imbiancati, lontano da me.
Non basta la pura esistenza della necessità di produrre a partire da macerie generalizzate, perché questa produzione venga alla luce in forma autogestionaria. Certo, visto il panorama complessivo, ci sono tutti i presupposti ma non c’è un rapporto obbligato di causa ed effetto. L’assillo, per limitarsi a questo, è un elemento di ritardo o di confusione programmatica, cattivo consigliere per chi lavora sulle macerie. C’è in esso la spinta a stabilire una scala di graduazione che potrebbe essere falsa. I benefici di consumo che ci si attende dalla nuova produzione devono provenire da lontano, non dal passato ma dal futuro. Intendo dire che a reggere le scelte devono essere le relazioni che si vanno intrecciando da parte delle varie esperienze autogestite, non i quadri stereotipati dei bisogni del passato. Il beato guadagno del capitalista non esiste più, non è esso che regge gli esperimenti ma la libera cooperazione fra unità produttive non concorrenti, le quali sono nello stesso tempo destinatarie della produzione, cioè unità di consumo.
In queste condizioni, non dimenticando le macerie su cui si è costretti a lavorare, l’esperimento produttivo è diverso da ciò che conosciamo sotto questo nome. In esso c’è una immagine sognata diversa, stravagante, forse inutile in termini strettamente legati alla soddisfazione di certi bisogni, e ciò per il fatto che anche questi bisogni sono sottoposti a profonde trasformazioni creative. Produzione e consumo potrebbero incontrarsi in questo modo su un territorio incognito e non riconoscersi direttamente, mentre l’allargarsi della rete produttiva e di consumo potrebbe sviluppare altri incontri, impensabili a priori, forieri anch’essi di altre ulteriori trasformazioni. Il sogno si converte in prodotto consumato e questo meccanismo della vita, immiserito in maniera indegna nel capitalismo, potrebbe far nascere altri sogni e altri consumi. La superstizione della corrispondenza a priori tra consumo e produzione, una volta che si è cominciato a costruire sulle rovine, potrebbe essere messa da parte.
Non c’è motivo alcuno per accettare un canovaccio produttivo arcaico visto che si parte dalle rovine. Non c’è sul fondo la colpa originaria dell’estraniazione del valore dalla materia bruta grazie allo schiavo, adesso siamo in condizioni differenti. Occorre in ogni caso non correre il rischio di punirsi ricorrendo a modelli del passato, ora necessariamente contraddittori. La grande fame di novità e la conseguente inevitabile disillusione derivata da errori e risultati non confacenti alle attese può generare questa volontà di punirsi.
Qui bisogna chiarire l’equivoco naturale, l’autogestione non può affidarsi alla spontaneità e affermare di seguire in questo modo la natura. Di che natura hanno parlato, e continuano a parlare, tanti facitori di chiacchiere? La natura umana non è certo un buon terreno per alimentare grandi speranze. La natura nel senso del mondo nuovo, questa deve essere ricostruita quasi totalmente di sana pianta. La melma è sempre dietro l’angolo e l’opera di autogestione educativa è ancora da inventare, non potendo contare che in maniera trascurabile sulla pedagogia libertaria.
In effetti, la possibilità di un riemergere della melma politica per come la conosciamo è remota, ma esistono categorie melmose che ancora si conoscono poco e che potrebbero proliferare. L’uomo è un animale pericoloso per contare troppo sulla sua spontanea capacità di orientarsi verso il bene. L’anarchia conosce profondamente le pieghe dell’animo umano perché parte dal rifiuto di qualsiasi principio archetipo, ciò non vuol dire che è incapace di programmare e realizzare processi di trasformazione autogestiti e diretti a rendere accessibili territori di sensibilità che l’uomo spontaneamente non riuscirebbe a raggiungere.
Vivere in una società autogestita in modo generalizzato costituisce di già un programma di questo tipo pienamente in atto. Più cresce la coscienza partecipativa dell’autogestione e più la connaturata tendenza verso il male si attenua nell’uomo. Realizzare il male significherebbe colpire se stesso nel colpire il proprio simile, legati come si è dal processo autogestionario nel suo insieme. Questa crescita educativa autogestita non spontanea costituisce la profonda diversità che potrebbe prodursi all’interno della creatura umana, ma il percorso è lungo e non si può misurare in tempi storici.
Allo stesso modo, la ricostruzione di una natura risanata, sulle rovine di quella del passato, non significa creazione di innocenza, un’arcadia dove inserire il mondo nuovo autogestito. Sono ipotesi ridicole che non meritano discussione. L’autogestione generalizzata è una condizione altamente artificiale, tecnicamente avanzata, capace però di creare quella rete interrelazionale che sogna e inventa l’imprevedibile, che non copia e non vuole soltanto modificare, migliorandolo, il mondo vecchio. Ogni ipotesi di innocenza umilia il progetto autogestionario e lo riduce a un’utopia bucolica.
C’è una sorta di insolenza da parte di coloro che pretendono addomesticare l’uomo e la natura riducendoli ai loro dettami di allegra spensieratezza. E l’immane abisso dei misfatti passati? Sparito nella distruzione totale, mi si potrebbe rispondere, e a ragione. Eppure ciò che ricompare nelle cose, nelle singole cose distrutte, permane nell’animo umano e qui si acquatta come una belva con cui bisogna fare i conti. Lo stesso per la natura. A lungo violentata, non potrà ripresentarsi esente da colpe nel mondo nuovo, le conseguenze dell’antico uso dissennato delle risorse hanno lasciato il segno dappertutto, e le rovine possono coprirlo fino a un certo punto. Il male dell’uomo serpeggia sotto la forma finalmente liberata del mondo nuovo, e gli fa da contraltare il male della natura. Nessuno è innocente, neanche coloro che decideranno di cominciare a saltare da una liana all’altra.
L’autogestione permetterà la crescita di una coscienza immane che fino al suo completamento avrà molta strada da percorrere, dovrà anche – e parallelamente ai risultati positivi – fare venire alla luce la malinconia di quello che è andato perduto. Il mondo vecchio, con tutti i suoi guai e la sua melma, aveva alte espressioni di umanità e di cultura che ora – dopo la distruzione totale – non potranno essere più intelligibili se non a sprazzi. Uno splendore malinconico, un tramonto che ricorda qualcosa di cui non sarà più possibile parlare. Dalla stessa distruzione, dalle rovine, emana questo splendore ma per i produttori autogestionari esse saranno soltanto rovine, ogni intenzione archeologica essendo scomparsa per sempre. Il fatto è che nel mondo nuovo bisognerà reinventarsi la gioia, e questo non sarà possibile a seguito di un progetto autogestito qualsiasi. Come nasce la gioia in un mondo che l’ha cancellata insieme al mondo precedente, che la conservava e la usava quasi soltanto per lenire il dolore dello sfruttamento o per dare un senso al risultato ricavato dallo sfruttamento stesso? In questa direzione non solo si va avanti a tentoni ma si incoraggiano anche le controtendenze.
Per un controsenso più che comprensibile, un mondo produttivo nuovo cerca di puntare tutto sulle cose e sulla rete vastissima di correlazioni che permette la creatività necessaria al progredire e all’estendersi della produzione autogestita. Ne deriva una scarsa propensione per l’equilibrio indispensabile tra cose e animo umano, e quest’ultimo, rompendo gli indugi, potrebbe sfuggire in una ricerca astratta dello spirituale, un rifugio come un altro contro il pericolo dell’appiattimento sulle cose. Una vita angelicata è di già conosciuta oggi nelle piccole comunità accerchiate dal capitalismo. Gli Stati Uniti sono il luogo in cui queste sette, fuggite nello spirituale, proliferano più che altrove. Ciò potrebbe essere un vicolo cieco e un ostacolo, uno fra i tanti.
È duro inventare tutto da principio, ascoltare il rumore assordante della caduta dei vecchi dèi e sapersi assegnatari di un compito immane. A questa durezza si potrebbe rispondere con un lavoro di routine, macchinoso e ripetitivo, utilizzando il modello autogestionario classico e non sforzandosi di dare vita alla parte essenziale, l’innovazione. Il pericolo di attivismo puro e semplice, freddo, diretto a portare a termine il proprio compito, è forse peggiore di una poco probabile contromisura capitalista. Il ritmo di una volta, coatto e obbligatorio, adesso banalmente autodeterminato, potrebbe tornare dalla finestra dopo essere stato messo fuori dalla porta. Nessuno negherebbe così il nuovo mondo, anzi vi farebbe parte a pieno titolo, ma contribuirebbe a soffocarlo con la propria apatia, con il proprio entusiasmo da impiegato al catasto. Come un manichino folle, questo produttore si accartoccerebbe sui propri sogni con un sorriso ebete sulle labbra.
Corriamo il rischio di costruire un mondo nuovo di manichini folli? Certo è che si tratta di un compito durissimo, quello di giocare due ruoli, l’inventore creativo e il produttore di cose che adesso ricevono una pregnanza diversa dal classico scambio capitalista. Si può essere disponibili, benevoli, accondiscendenti nei riguardi del progetto, ma si resta sempre uomini, con tutti i limiti e le nefandezze umane. Ricostruire su basi sconosciute può scatenare scontentezze orribilmente catastrofiche. Questo è un altro problema.
A volte, nelle alzate di ali degli utopisti, è stato detto che la spontaneità viene fuori dalla semplice autodeterminazione associata a mutate condizioni sociali, dove per l’appunto non c’è più lo sfruttamento. Ciò potrebbe essere una clamorosa banalità. Non c’è nulla di ritualmente obbligatorio nella libertà, neanche la libertà stessa, che è conquista non aria che involontariamente si respira. Non basta affermare che l’adozione di un processo autogestito produce automaticamente creazioni nuove e forme produttive mai viste prima. Tutto questo è possibile ma richiede molto di più della semplice volontà di volerlo. E questo molto di più viene fuori a stento e con sofferenza dalla realtà che impregna il mondo nuovo, non è irresistibilmente dato alla luce dalle mutate condizioni produttive. Nelle utopie che ricorrono ad affermazioni come quelle qui temute è disarmante la puerilità e l’insistenza su dettagli inessenziali che mostrano il tentativo di riempire il nulla con desolanti fantasie.
Lo scontro, a mio avviso, dovrebbe continuare anche nella condizione generalizzata dell’autogestione. Scontro di mentalità e di coscienze diverse, scontro di persistenze non sufficientemente demolite, scontro di progetti e non più di ambizioni, scontro di turbolenze umorali ma anche di teorie produttive, di sistemi e procedimenti, di ritrovati e di trasformazioni. La lotta è vita e considerarla definitivamente conclusa è morte, morte della creatività, la quale è la forma più congeniale alla vita che l’uomo riesce, a volte, a esprimere. Non è la felicità di un’atarassia noiosa e insopportabile che può venire fuori dall’autogestione nel modo in cui ne discutiamo, ma l’angustiante processo umano di costruzione su basi diverse del mondo nuovo, impresa né facile né di per sé soddisfacente tutti alla stessa maniera. Non occorre una grande sottigliezza per rendersi conto di queste difficoltà ed è facile capire che proprio in esse risiede la ricchezza creativa per cui si lotta e la stessa possibilità di dare vita a procedimenti produttivi mai visti prima.
In genere gli uomini fuggono via dalla noia o dalla paura, nello sconvolgimento della quotidianità la maggior parte di loro dà fondo alle proprie forze e fa venire fuori una fiammata a volte non prevedibile. Certo, la zavorra resta tale ma è sempre una perdita trascurabile. E poi a spingere saranno coloro che non disposti ad arretrare di fronte alle difficoltà si lascerebbero sfiancare subito da un precipitare nell’obbligatorio della routine. Non sono i nodi difficili da sciogliere che bloccheranno l’autogestione generalizzata ma, al contrario, la sua istituzionalizzazione, cioè la sua modificazione in un processo chiuso, autoreferenziale, che dichiara una volta per tutte di essere nel giusto. Lo scontro vivifica le soluzioni trovate e ne fa intravedere di nuove, lo sfinimento quotidiano le azzera.
Non si deve pensare che un progetto autogestito e generale sia qualcosa di conchiuso, senza nemici esterni contro cui lottare, senza bufere interne, senza inadeguatezze o altrettanto perniciosi eccessi. Sono queste incertezze che alimentano la passione e impediscono che si spenga il fuoco creativo.
Non essendoci più – o essendosi essenzialmente attutite – le convenienze e le separazioni, ognuno può essere libero di esprimersi al meglio, senza timore di essere sanzionato? In linea di massima sì, nella pratica anche qui sorgeranno conflitti e perfino azioni inevitabilmente distruttive nei confronti di coloro che vorranno fare tornare in vita il mondo vecchio. Anche il mostruoso è produttivo nell’autogestione generalizzata e contribuisce a creare i nuovi processi che fondano appieno il mondo nuovo, ma il mostruoso o il caotico non è il gioco voluto e predeterminato di sconvolgere ogni progetto in banale negazione dell’ordine produttivo, riducendolo a semplice e vago caos. Qui si nasconde uno dei nodi più terribili per il futuro autogestito, qui è in agguato la sua stessa possibilità di svilupparsi e crescere.
C’è in fondo all’autogestione, nel senso che veniamo descrivendo, una strana ambivalenza. Da un lato si ha in essa una componente intrinseca inarrestabile che le deriva dal precedente logico della distruzione totale, dall’altro si ha la rete imprevedibile e sterminata delle correlazioni che essa stessa mette in moto. Questi due movimenti non possono procedere all’unisono, ci sono fra loro differenze strutturali e fisiologiche, sgorgano irresistibili ma ognuno per conto suo e si gettano a capofitto nelle braccia dell’altra. Le rovine precipitano nella rete complessiva e qui testimoniano di una inadeguatezza passata. Sono le carte ereditarie di un mondo morto ma non per questo privo di conseguenze. Non è tanto la nostalgia delle catene e della frusta, o il ricordo dei passati godimenti, ma è il fascino stesso del passato che entra nel processo autogestito e generalizzato.
Nessuna cosa infatti vive esclusivamente nuova, anche il momento ha una storia, se non altro la sua storia genetica, che a un certo punto si fa imperiosamente sentire. Le nuove strutture produttive saranno radicalmente diverse ma avranno a fondamento e come scopo la produzione, e ciò ricorda qualcosa che è andato in rovina, qualcosa di diverso – va bene – ma non del tutto diverso. Queste componenti non sono ricordi individuali, scherzi di sentimenti assistiti dalla memoria, sono condizioni oggettive di mezzi di produzione, sono cose e rapporti fra cose. La sensazione fisica di un prodotto, il vellicare di una pelliccia, proviene dalle rovine. È andata distrutta la cosa non il ricordo della sensazione. Ciò è un’eredità che finirà per rovesciarsi dalla rete produttiva causando sollecitazioni verso progetti che potrebbero contraddire l’indirizzo complessivo delle correlazioni in corso di sviluppo. Lo stesso per lo splendore di un gioiello o lo stimolo olfattivo causato da un profumo. Tutto questo, tornando insieme a tanti altri ricordi dalle rovine, potrà essere sovvertito e abbagliato da nuove sensazioni, mostruosamente diverse, che saranno prodotte dalle infinite possibilità dell’autogestione generalizzata. Ed è di uno scontro completamente aperto che stiamo parlando.
Occorre tenere presente questo gioco di sensazioni, ricordi, sovrapposizioni, cancellature, nuove intuizioni, e occorre anche considerarlo un mondo parallelo a quello produttivo con cui interagisce sia nelle invenzioni progettuali che nelle stesse scelte di consumo. L’autogestione non è solo un’aspra e difficoltosa riorganizzazione produttiva, da questo punto di vista rimane il limite della completezza, com’è giusto che sia, un progetto in evoluzione aperto a nuove esperienze, ma è anche l’autogestione dell’uomo nuovo, o almeno lavora in questa direzione, non su velleitarie ipotesi di pedagogia libertaria, ma attraverso la trasformazione dei rapporti produttivi. I due compiti non cercano reciprocamente di condizionarsi, ma sono in sviluppo parallelo, anche con tutte le contraddizioni che possono emergere, alcune delle quali le abbiamo viste prima.
È l’autogestione che per la prima volta rimette in discussione il problema del primato della produzione. Sulle rovine risuonano ancora i teoremi dell’economia. Primato scosso a parole da tanta parte dell’anarchismo, senza capire che proprio qui si colloca la distanza di sicurezza dal marxismo. Critiche ce ne sono state, anche le nostre, ma il loro inveramento può aversi solo nell’autogestione generalizzata. È uno dei motivi che rende inconfondibile questa riorganizzazione del mondo sulle rovine del passato.
Riconfermare qui tale grande impresa potrebbe avere l’aria esornativa di un pleonasmo o di un’allegoria. Non è così, non c’è nulla in me del costruttore di monumenti, caso mai il contrario, essendo pratico nell’uso della dinamite. Le riconferme reboanti si ergono come montagne inarrivabili e sono un po’ gelide nella loro solitudine. Nella piccola dimensione sono monumenti funebri alle buone volontà messe a partito da degni portatori d’acqua. Queste analisi sono imprecise e aperte a tutte le critiche, anche quelle malevolmente fondate. Per questo fanno acqua da tutte le parti. Forse se le avessi scritte con i miei strumenti a portata di mano sarebbero state più onnicomprensive e cimiteriali.
Ogni argomento deve avere la sua espressione, non può sovraccaricare né farsi dominare dalle parole. Sono queste che devono servire le cose e non il contrario. Spesso, quando le parole prendono il sopravvento, costruiscono delle posture, rigidi manichini d’esposizione, monumenti funerari, ma non conducono le cose alla comprensione. In ogni caso, il luogo in cui mi trovo, una bolgia, mi aiuta a essere sobrio e a non farmi prendere la mano dagli aspetti tecnici dell’argomento, che da parte sua ne possiede parecchi.
La glorificazione dell’oggettività, come ideale assoluto di verità, trova parecchi ostacoli nel mondo dell’autogestione generalizzata. Molti processi produttivi sono sprovvisti di chiarezza immediata, mancando del riscontro del mercato. La singola avventura produttiva non ha niente di manageriale, si potrebbe presentare malleabile e quindi irripetibile nella sua realizzazione, questione di dettagli, a volte, questione di sostanza, non si può sapere. Lo sforzo creativo può essere assorbito in una forma precisa, durevole nel tempo, ma non può essere imposto con la forza dei mezzi impiegati nel mondo vecchio, ad esempio la pubblicità. Occorrerebbe conoscere il ritmo delle corrispondenze, ciò che si ripercuote nella rete complessiva, non cogliere solo ciò che si infrange negli ostacoli che sorgono improvvisamente davanti a una singola unità produttiva. Questa eminente contraddizione è segno di maturità dell’intero sistema produttivo autogestionario. Sono proprio questi i punti di forza che non sclerotizzano il processo e nello stesso tempo non lo rendono troppo fluido da risultare inintelligibile. La produzione ha bisogno di modelli ma questi non possono essere statue turrite, immobili, da riprodurre meccanicamente. L’autogestione ne verrebbe bloccata, questi modelli devono presentarsi e svanire, con un ritmo corrispondente a quello delle nuove forme produttive che si riversano nel consumo. Nessuno di questi modelli è in sé perfetto, né come prodotto né come oggetto di produzione, dappertutto si registrano soltanto approssimazioni, incertezze, ammaccature, incongrui risultati, velleità frustrate, ma si registrano comunque risultati, cose vengono prodotte.
Mandare avanti la produzione autogestita forma una coscienza diversa, dove il valore del prodotto non è più fatto penetrare dall’esterno, grazie al mercato, ma cresce dall’interno della coscienza stessa, con un misto di compiacimento e di tristezza. Si è contenti di quello che si è prodotto e, nello stesso tempo, si è tristi per il fatto che in quella cosa prodotta è entrata realmente, impastandosi con la materia di cui quella cosa è fatta, una piccola parte della nostra vita. Il prodotto fabbricato prima delle rovine aveva il valore di mercato, il suo prezzo, quello che viene fuori dall’autogestione ha il valore di una parte della mia vita, è la mia vita che offro al sistema autogestito di consumo. Non ci sono più casseforti e scrigni, non ci sono banconote e gioielli da accumulare e custodire. Le rovine della pura apparenza sono ancora là – se non le abbiamo fatte sparire – per ricordare questo profondo cambiamento, siamo adesso nella terra dimentica di ogni contenuto commercialmente riscontrabile.
La coscienza diversa fugge dalla cristallizzazione dei rapporti e delle correlazioni di affinità autogestite, vuole che tutto rimanga fluido, vuoto di pesantezze foriere della melma di cui erano colme le rovine, e di tale fluidità ne fa forma essenziale di vita, valutazione e considerazione della realtà. Rassodare tutto questo mondo dalle sembianze nuove, inaudite, nello stampo classico del rispecchiamento – la verità di ciò che corrisponde a ciò che è – avvia verso la calma catacombale. La nuova produzione generalizzata perirebbe così in un clima di esattezza e di compensazione perfetta, essa rigetta invece ogni libro mastro residuato dalle rovine e ancora galleggiante sulla melma.
Effettivamente si resta sopraffatti di fronte a un compito del genere, ma solo se si pensa ancora intatto il mondo vecchio, se si lasciano filtrare ricordi di un passato indegno e speso male, allora gli errori ripiombano anche nel mondo nuovo, ed è una infelicità assicurata. Ma la distruzione totale ha fatto il suo lavoro, adesso non ci sono le cose che nuotano nella melma politica e capitalista nascondendosi nel suo profondo buco nero una all’altra. Non ci si può intenerire per la cancellazione di un obbrobrio di schiavitù e di sofferenza, ed è senza senso fare ciò anche per coloro che hanno soltanto ricordi di godimento. Tutto questo, il bianco e il nero, è stato cancellato, dietro c’è solo la tenebra delle rovine, dove è inutile frugare, non si trovano che cadaveri.
L’immenso sforzo produttivo nuovo esce anche da queste contraddizioni intime, che si dibattono nella coscienza diversa degli uomini del mondo nuovo. Si soffre per un residuo di vecchio, una traccia che tende a sparire e che forse è meglio che permanga ancora, come i beni di sopravvivenza espropriati prima della distruzione totale e messi in salvo. In questa sofferenza c’è un recupero di umanità per quello che è accaduto, che si ripercuote nelle incertezze del futuro e nelle difficoltà dell’intrapresa. Non si tratta di rimorso, tutt’altro, ma nessuna coscienza diversa è sempre monoliticamente certa di sé, sarebbe un blocco di idiozia se non conoscesse e vivesse il dolore, tutto il dolore del mondo vecchio, quello sofferto e quello fatto soffrire. E non si tratta neppure di sentirsi colpevoli di qualcosa. Quello che andava fatto, irrimediabilmente fatto, è stato fatto. Un meteorite è caduto sul mondo e ne ha cambiato il volto.
L’idea dell’autogestione, la semplice idea, ancor prima della sua realizzazione generalizzata, susseguente alla rovina del mondo vecchio, lascia stupefatti. L’uomo nuovo non è il lavoratore che riceve un’eredità dal capitalista, è un essere completamente diverso, con in testa progetti che lasciano attoniti per la loro assoluta mancanza di precedenti. Le lotte e le eventuali esperienze autogestionarie (poche) del passato non sono in questa idea nuova di cui stiamo tratteggiando visionariamente le linee essenziali, più per contrasto che per esame diretto.
In effetti, io sono troppo impaziente, e forse troppo vecchio, per tessere tutta la tela di questa visione, e forse per dirla in giuste parole, sono uomo incapace di fare ciò, ma quello che propongo, non più che un elenco di intuizioni problematiche e contorte, fornisce sufficiente materia per riflettere. Altri potranno, con maggiore attenzione di me e forse con migliore materiale a disposizione, andare oltre nell’intessere la trama completa di tutte le conclusioni produttive autogestite.
Quello che insisto a offrire qui sono condizioni non plausibili nel mondo vecchio, dove resterebbero ipotesi balzane e impotenti, mentre nel mondo delle rovine trovano il proprio scioglimento, se non un impossibile completamento. Quello che c’è di entusiasmante nella nuova, futura, disposizione delle cose del mondo, è la loro irrimediabile mostruosità, ovviamente se considerata dal lato del mondo vecchio, e questa deformità è come qualcosa di ipnotico, di bloccato in formule d’azzardo al confine con l’utopia.
La fondatezza invece la si riscontra subito assumendo con profondità di coscienza l’ipotesi di partenza, quindi accettando di fare proprio il compito immane e terribile della totale distruzione. È questo passaggio che fornisce la chiave di comprensione e che aleggia su tutto l’insieme produttivo autogestito e generalizzato. Non ci sono passaggi laterali, scorciatoie meno costose, concessioni o rese a discrezione da parte dei capitalisti, queste ipotesi sono piantate nella melma politica e risultano infettate di utopia fino al midollo. Non c’è sviluppo lineare né sinfonie polifoniche in grado di aprire la porta del futuro mondo nuovo, occorre ammettere con coraggio la necessità di questo sprofondamento fra le rovine.
Solo così si aprono molteplici scenari tutti intoccati a causa della scomparsa dello sfruttato e dello sfruttatore. L’autogestione sarebbe una incompresa beffa se lo sfruttamento venisse assunto in proprio dagli sfruttati. Su tutta la generalizzazione del progetto autogestionario aleggia quindi una incredibile unificazione umana, incomprensibile per chi vive in un mondo che andrà in macerie. Certo, anche all’interno di questa compattezza mai vista, si creeranno delle differenze, l’uomo è animale non solo maligno ma estremamente vario, non accetta di essere livellato verso il basso, e questo è uno stimolo positivo, produttore comunque di conflitti che non è possibile conoscere o prevenire, anche perché saranno diversi da quelli passati circoscritti allo sfruttamento e alla melma politica che lo rende possibile.
Entrare, da osservatori collocati nel mondo vecchio, in questi conflitti del mondo nuovo, non è possibile. Ogni dettaglio sfuma nell’incomprensibile tensione che si sfiora ma non si può approfondire. Sono scontri che è possibile immaginare in senso verticale, al contrario di quelli attuali che hanno andamento orizzontale. Questa verticalità emerge dalle diversità che si svilupperanno per ogni singolo progetto produttivo autogestito. Non conflitti di interessi finanziari, estorsione di valore e accumulazione di capitale, ma conflitti derivati dalle diverse intensità di collaborazione, di filantropia, di pietà per il sofferente, di affinità, di sogni e di forze creative, di amore e di amori, insomma tutti quei conflitti che pure esistendo nel mondo che ci ospita oggi, non riescono a estrinsecarsi appieno ma vengono bollati a sangue dall’irriducibile scontro di classe.
Il coacervo di questi conflitti è vecchio almeno quanto i sentimenti che l’uomo alimenta dentro di sé, ma il suo intreccio verticale è nuovo, ed è contrassegnato dall’affinità come polo di attrazione, attorno al quale roteano tutti gli altri elementi, l’amore e la pietà, uno contro l’altro in profonda antitesi, in primo luogo.
Partecipare è condizione dell’autogestione, non confliggere, almeno non necessariamente, e per partecipare bisogna condividere il progetto produttivo. Ora, questa condivisione può basarsi sull’affinità in modo totale, oppure avvertire gradazioni diverse di altre tensioni, l’amore e la pietà, come si è detto in primo piano. Questi elementi non sono semplicemente collaterali, essi interagiscono e condizionano l’affinità, per cui il progetto assume un aspetto verticalmente conflittuale. In questo conflitto si annidano due tendenze, contrastanti e complementari, ma che aumentano il piacere del produrre, la gioia di cui parlavamo, l’amore per l’uomo e il prodotto dell’uomo – distinzione ormai molto difficile da fare –, la seconda è la pietà compassionevole per il meno dotato, che può contrastare con la prima o integrarsi a essa. I risultati non sono prevedibili. Basta pensare che il passo tra pietà e abiezione è sempre molto breve e che l’uomo è comunque un animale infido sul quale incide l’educazione in corso di autogestione, ma fino a quanto valida ed efficace?
Registrare questi conflitti che abbiamo individuato disposti in modo verticale, costituirebbe un elenco consistente che risparmio ai miei pochi lettori. In fondo, qui sto entrando nel profondo del territorio oscuro di quello che sarà l’autogestione generalizzata. La distruzione totale, come ricordiamo, avrà causato sterminate macerie di cose e uomini, ma la coscienza diversa, capace di analizzare sensazioni e sentimenti diversi, è costruzione che non fiorisce spontanea sulle rovine, bisogna costruirla, e questo è lavoro lungo e pericoloso. L’uomo è un animale feroce tutt’altro che addomesticabile. In più, distrutto lo sfruttamento e la catena, tutte le deformità del passato si rovesceranno fuori e saranno fuoco e fiamme.
Vista la conclamata sfiducia nell’educazione libertaria, almeno da parte mia, penso che per spegnere questa fiamma senza annientare il fuoco che la genera bisognerà entrare in un rapporto profondamente diverso con questo animale feroce. Arrossire, come ogni benpensante, dei suoi crimini, è stupido. Pretendere di azzerare questi ultimi facendo funzionare la ghigliottina è soltanto un duplicato di ferocia, niente di più.
È ovvio che le mutate condizioni generali renderanno automaticamente impossibili alcune di queste atrocità che oggi tanto ci colpiscono, in primo luogo quelle di chi oggi fa fischiare la ferula dello sfruttamento. Ma le altre? Quelle che la naturale bestialità umana porta con sé? Per queste bisognerà aspettare che l’autogestione si generalizzi veramente, che non solo occupi le braccia e le menti ma anche i cuori e le più profonde pulsioni, anche le peggiori, sostituendo il progetto creativo alla pulsione distruttiva. Non voglio dire che l’autogestione si abbandonerà pacificamente alle trovate di sabotatori folli, del tutto in controtendenza riguardo la conflittualità verticale di cui parlavo prima, si dovranno in questo caso considerare come residui nostalgici del mondo vecchio o come individui irriducibili agli interessi dell’autogestione generalizzata. Ci si difenderà proponendo che autogestiscano nel modo che più aggrada loro il proprio punto di vista, stroncando duramente ogni tentativo di sabotare il processo che non condividono. Non essendoci conflitti orizzontali non si possono permettere intenzioni che vogliano crearli per il semplice gusto di fare una cosa diversamente.
E agli anarchici? E il loro modo di essere contro ogni principio autoritario? Se troveranno questo principio in atto nella società della generalizzazione autogestionaria vuol dire che questo processo non si è attuato e che sussistono ancora conflitti orizzontali, cioè di sfruttamento. In questo caso la loro azione contro sarà più che giustificata, ma siamo ben al di là dell’esempio precedente. Non perseguendo lo scopo immediato di una qualsiasi lotta intermedia, in questo caso gli anarchici avrebbero solo il compito di contrastare lo sviluppo di conflittualità orizzontali, dove lo scontro si accende per un residuo del principio di potere. In sostanza, essendo quest’ultimo fuori del processo autogestionario, può svilupparsi solo mascherandosi sotto forme diverse, non tutte prevedibili.
Scoprire queste nuove forme e dare loro la caccia è sempre compito degli anarchici. Non che questi siano i custodi della morale autogestionaria, cioè di una serie di regole etiche che mettono fuori gioco il dominio dell’uomo sull’uomo. Non c’è nulla da custodire perché non c’è un principio sacro da difendere, che gli anarchici rifiuterebbero per primi. La questione vera è che gli anarchici non si accontentano della forma e vogliono la sostanza dell’autogestione generalizzata, e questa non accetta nessuna logica di potere nel suo concretizzarsi in cose e uomini che quelle cose fanno. Occorre essere chiari in modo dirimente su questo problema, la lotta degli anarchici non si arresta con la distruzione del mondo vecchio, essi continueranno a frugare fra le rovine alla ricerca delle ultime tracce.
Di per sé l’autogestione non è un richiamo all’ordine, sia pure un ordine nuovo. Apre semmai a visioni impensabili prima della distruzione ma non le conclude, non suggerisce un sigillo confortante e definitivo, non è un accadimento solennemente registrato dalla storia, essa taglia corto con le attestazioni e con la storia stessa, che è sempre storia della melma politica e dei crimini del potere. Allo stesso tempo essa non assume su di sé il compito impossibile di fare la felicità degli uomini, destinati quasi sempre a una maggiore infelicità quanto più diventano coscienti di loro stessi, una infelicità diversa dallo sfruttamento, ma sempre melanconica infelicità. Questo è un argomento che abbiamo di già sfiorato, accennando alle nuove forme di gioia, le quali potrebbero comportare proprio questa infelicità di cui parliamo adesso.
Le grandi realizzazioni produttive dell’autogestione generalizzata scuotono l’uomo vecchio e lo trasformano nell’uomo nuovo. Questo straordinario processo non è una banale affermazione utopica, è la conseguenza di uno sguardo panoramico dato alle rovine, dove crescono, qua e là, tra rovi e sterpi, mostruose formazioni mai viste prima. Queste dapprima si incastonano a caso, creando un caos incomprensibile per chi deve viverci e anche per chi, come me, osserva questo continuo fiorire da lontananze siderali. Sono vibranti e sfrontate affermazioni di vita nuova, non unità singole, ma raggruppamenti d’affinità produttiva, dichiarazioni d’amore verso il futuro, verso quello che si riuscirà a fare in futuro, in una rete correlazionale in cui le corrispondenze si risponderanno e si contraddiranno fino a sfiancarsi e tacere. È una guerra nuova, una guerra che non si è mai guerreggiata prima, dove gli scontri non sono tra nemici orizzontalmente diversi, ma verticalmente complementari.
Dietro tutto questo non c’è memoria, non c’è custodia antica o recente di simboli o bandiere per cui farsi uccidere, tutto è stato consegnato al futuro, venali contrasti e dolci tenerezze. La tristezza è qui compagna della gioia e il possesso nasce e si scioglie nel dono. Non ci sono appartenenze reciproche stabili, né personali né produttive, che non siano revocabili attenendo ognuno, prima di tutto, a se stesso. La passione è amore e l’amore è incontro appassionante nella vita, il che è come dire nell’autogestione generalizzata. Non ci sono piattezze che non possano innalzarsi a picchi inaccessibili o profondità che rimangono insondate. E la morte visiterà la vita, come sempre accade, non una sua consorella col sudario addosso.
Tutto questo quadro è una visione delle rovine e delle fioriture, una tensione che cerca di cogliere qualcosa, qua e là, che non può dissociare – come avviene di regola nella logica dell’a poco a poco – pensiero e sentimento. Voglio che almeno, da questo tentativo, si possa cogliere l’atmosfera del mondo nuovo, l’odore e il sapore dell’autogestione, voglio che si possa intravedere ciò che essa può sviluppare, esasperare, sollecitare, spingere, esercitare fino allo spasimo, scatenare, dall’interno di quel buco nero della distruzione totale. Voglio che si possa immaginare quest’onda mostruosa innalzarsi al di sopra delle rovine, coprirle e sbriciolarle per l’ultimo contraccolpo, quello definitivo.
Ogni singolo elemento produttivo adesso si presenta correlato con novità autogestionarie generalizzate che lo rendono incomprensibile all’occhio guercio degli economisti. Io stesso devo fare uno sforzo per mettere da parte questo bau-bau, giocattolo che una volta è stato, millenni fa, la mia professione. Di fronte all’elemento produttivo ora non ci sono protezioni, non ci sono rifugi sicuri, né valori di scambio né equazioni dell’imprenditore. Se lo osservo in modo da isolarlo con l’immaginazione, questo elemento se ne sta appollaiato, solitario e goffo, muto e riottoso a qualunque richiesta di spiegazioni. Non c’è più un palcoscenico dove recitare la sua parte. Mille progetti lo circondano, e mille e mille lo correlano con l’autogestione generalizzata, da solo non è che una suppellettile superflua e silenziosa. Alla fine, se insisto, utilizzando residui della formalistica economica del mio passato mestiere, si sbriciola con una serie di smottamenti. Il terreno logico che una volta, nel mondo vecchio, l’avrebbe sorretto, il consumo di mercato e il valore di scambio, adesso non c’è più. Più che una erosione è un crollo.
O si guarda all’insieme autogestito o ci si muove fra le sabbie mobili, più si insiste e più queste ultime ingoiano il singolo elemento produttivo con un effetto disastroso anche per le altre corrispondenze che ne potrebbero subire il contagio. Ma lo sguardo d’insieme non si ottiene a comando, è prodotto dalla conoscenza e, nello stesso tempo, dalla coscienza di sé. Non c’è un osservatore estraneo, tutti siamo in campo, e le reazioni allo svolgimento del gioco decidono, tutte insieme, l’esito che è in palio. Non c’è qualcuno o qualcosa da esaltare o biasimare, ci siamo noi tutti, nessuno escluso, e siamo noi gli artefici del nostro destino.
Il riverbero del passato è comunque destinato ad affievolirsi. Le rovine testimoniano di qualcosa che non può tornare indietro se non come vicenda occasionale, chiacchiera pruriginosa, schizzo abbreviato e repentino di un tempo che non può risvegliare nostalgie se non in persone legate al vecchio regime e a esso sopravvissute. Amori furtivi e produzioni da sfruttamento sono parimenti materia per favole ormai quasi incomprensibili. Direttori spirituali e direttori di produzione sono morti nella medesima ecatombe. Solo all’interno della coscienza diversa, dove anche la caverna orrida dell’antica melma è stata, per quel che si sa, sepolta e sigillata, potrebbero riaffiorare rigurgiti immondi, pazzi che ancora amano l’apparire all’essere. Non solo pazzi, a dire il vero, ma anche paurosi del respiro profondo, delle onde che si infrangono sulle scogliere inattaccabili, dei percorsi arditi e incerti nella verginità della foresta inestricabile. Ma anche questa genia incorreggibile, prima o poi, scomparirà.
Prima di concludere queste Annotazioni scritte ad Amfissa, nelle condizioni che ho già ricordato, voglio dare un ultimo sguardo d’insieme all’autogestione generalizzata.
Il libro che ripubblico, nella sua terza edizione italiana, costituirà per il lettore uno strumento utile per capire meglio i semi di mostruosità che qui ho profuso a piene mani. Sono di fronte all’inverosimile umano – degradazione e sopraffazione – e questi semi li ho a portata di mano, basta chinarmi a raccoglierli nel fango che copre tutto l’ambiente carcerario in cui vivo, fango di cose e fango di uomini, atrocità e miserie, uno splendido coacervo che, alla mia età e con la mia esperienza di carcere, non avevo ancora visto.
Questi semi li colloco qui senza acrimonia, dopo averli puliti e resi quasi filosoficamente comprensibili. Certo, non sono Annotazioni che tutti potranno leggere, e io non le ho scritte per tutti, le ho scritte per quei pochi che non hanno paura di guardare in faccia l’ignoto. A questi ultimi, che hanno litigato come me con la ragione, raccomando di non chiudersi di fronte all’esempio concreto – che spesso manca –, di non sperare di trovare il teorema economico che non può esserci. Raccomando solo di allargare lo sguardo, di imparare a sopportare la forza delle ondate che si susseguono nel tenebroso oceano dell’autogestione generalizzata. Non ho costruito roccaforti per fronteggiare le forze dell’ignoto, né ho scavato camminamenti fra le rovine del mondo vecchio per facilitare il passaggio al mondo nuovo.
Solo, senza nessun apporto teorico a portata di mano, non potevo scrivere un trattato di economia – e questo, nella mia personale disgrazia, è una fortuna per tutti –, quindi non cercherò di spacciare queste Annotazioni per quello che non possono essere.
Se sono nella realtà – e il languire di cinquanta reietti impazziti me lo conferma – queste visioni possono essere lette come un contributo a qualcosa che è ancora di là da venire. Niente di assestato, di definitivo, di tranquillo, di ripetitivo, né qui, in queste pagine, né nell’autogestione generalizzata. La novità, che è quasi sempre il ripresentarsi del di già visto in forma modificata, non è mai stata tanto nuova.
Che il mondo a venire, finalmente aperto dalla distruzione totale, non ci metta paura. Esso sarà l’assolutamente altro, mentre queste Annotazioni, così estreme, come ritengo saranno giudicate da molti, appartengono al mondo vecchio.
E forse sono un ghiribizzo da vecchio.
Finito ad Amfissa il 31 dicembre 2009
Questo sito, oltre a informare i compagni sulle pubblicazioni delle Edizioni Anarchismo, archivia in formato elettronico, quando possibile, i testi delle varie collane.
L’accesso ai testi è totalmente libero e gratuito, le donazioni sono ben accette e servono a finanziare le attività della casa editrice.
